ANTONIO via Sant’Antonio
Tratto dell’attuale via N.Daste, compreso: tra l’intersezione con
crosa Larga (poi via J.Ruffini nel 1910 ,
attuale via Palazzo
della Fortezza ) e quella con
via della Cella.
A) la chiesa con convento
La strada fu così chiamata per una chiesa di Agostiniani della congregazione di
Genova dedicata al santo (ma che - molto
probabilmente - dalla nascita nel secolo XII, fino agli anni dopo la metà del
1700, era dedicato a sant’Antonino), che esisteva nel punto che adesso è
localizzabile con la parte alta di via A.Castelli; per alcune fonti, a levante (dove esiste un piccolo slargo chiuso da cancellata,
come è desumibile dalla pianta del Vinzoni); per altre, a ponente ( di fronte a villa Gerace) 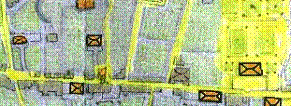 carta
di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in
terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra
nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo
villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa
Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto
l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani
carta
di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in
terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra
nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo
villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa
Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto
l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani
La parte storica del complesso
abbaziale, è descritta in s.Antonino (vedi)
Si
presuppone che i fedeli, perdendo venerazione per l’uno (Antonino) ed
aumentando quella per l’altro (Antonio), andarono a chiamarla col nome di
quest’ultimo, e tale rimase quando si decise di dedicare la strada.
Quindi,
parlando della chiesa, la sua storia si sovrappone a quella di sant’Antonino,
colà descritta. Una certa confusione tra
i due nomi, tra i quali prevalse poi Antonio, è dimostrata da documenti che
attestano che -nel 1798- stesso anno in cui la municipalità sequestrò i beni
ecclesiastici e chiuse molte chiese, nell’imperiosa necessità di reperire
locali da adibire a scuole, “ si constatò che esistevano due corporazioni di
religiosi dell’ordine di sant’Agostino, quella nel convento di s.Antonio e
quella di s.Maria della Cella i quali avrebbero potuto unificarsi
trasferendosi ...(ovviamente solo gli abati di s.Antonio -che poi in realtà
erano di sant’Antonino-) ...i locali rilasciati dagli agostiniani avrebbero
così potuto essere utilizzati a beneficio delle nuove aule scolastiche che
tanto necessitavano per la crescente
giovane popolazione scolare.
Anche
DeSimoni ne “le chiese di Genova”, intitola ed inizia descrivendo una chiesa
in zona Staglieno dedicata a sant’Antonio e poi senza spiegazioni descrive a
lungo i fatti della locale chiesa di sant’Antonino.
B) la
strada appare sia stata dedicata a due tratti stradali ben diversi,
che descriviamo:
=1b=
percorso della strada Centrale (tratto incluso tra
palazzo della Fortezza e via della Cella).
Nel 1757 il percorso
stradale è anonimo.
A ovest la via terminava
incrociando via della Cella (con, nell’angolo,
villa Serra Monticelli) che ancor oggi scende verso il mare, e salita
Belvedere che sale verso il colle e che, nell’angolo, il Vinzoni segna una
proprietà quasi rettangolare (sotto quella dei
Grimaldi - oggi dei Carabinieri; ed a ponente della proprietà Cardinale, oggi
civ.35 di via ACantore), con villa posta nell’angolo alto-ovest del
terreno, e di proprietà (ma che esisteva ancora
nel 1920 come visibile nella foto sotto) di “ab.e Constantino Pinedo”, nome non bene leggibile e
per ora di illustre sconosciuto (la villa è
stata sostituita dal palazzo con i civv. 37 e 39 di via A.Cantore; il giardino,
invece, fu metà a monte occupato da via A.Cantore; e la metà a mare dal civ. 36
di via A.Cantore)
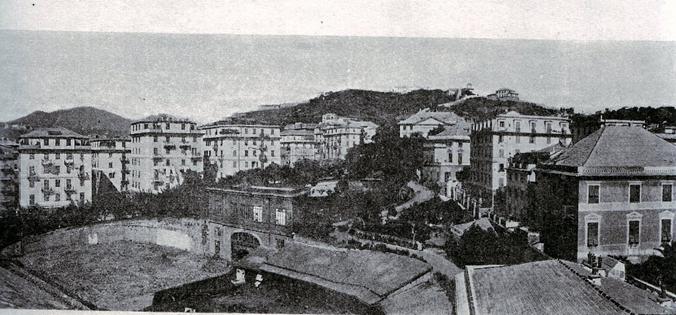
foto 1919: le case a sinistra
appartengono a via GBMonti. L’ovale è la parte bassa del giardino delle suore
della Provvidenza la cui villa ha il timpano davanti, nella parte più alta nel
centrodestra della foto. Sotto questa villa, poco spostata a sinistra la villa
Grimaldi, poi il palazzone attualmente civ.5 e 7 di corso dei Colli (però mi
sembra che quello della foto è meno esteso dell’attuale il quale sarà costruito
forse sul sedime di questo più quello interposto con la villa. In primo piano -a
destra- la villa che nel 1757 era dell’abate Constantino Pinedo.
Nel 1813 viene descritto
essere nel ’vico S.Antonio’ una villa di proprietà Canale
Bernardo (eredi),
munita di cappella privata, sinonimo di una certa distinzione sociale (non si sa quale villa sia, tra le tante; forse - ma
non credo - essendo ‘vico’ e non via - è quello oggi ‘vico stretto s.Antonio’: ma su esso si affiancano –non si aprono- la villa
Crosa e a mare la villa exPretura).
Nel regio Decreto del 1857,
viene citata come strada sant’Antonio il tratto della “strada Superiore, che
dalla casa Grimaldi-Ansaldo (PalazzoFortezza) arriva
sino alla casa fratelli Monticelli della crosa della Cella (villa Serra).
Viene confermata, già così
titolata, in una relazione datata 1867 (sui
casi di colera avvenuti in città: nelle via morirono in casa sei persone, su
107 contagiati in città e 68 morti in tutto).
Al civ. 4, nel 1878
esisteva la tipografia Foschini. Della
stessa famiglia appaiono Carlo, che nella
stamperia editò a fine di quell’anno il “Bibliografo” un periodico unico nel
suo genere contenente bibliografie scritte da valenti critici; e Luigi
Domenico Foschini, che compare a marzo 1878
quale direttore responsabile nonché proprietario del settimanale “Riviera Ligure”,
“gazzetta degli avvenimenti-politica e letteratura
amena-commercio-marina-finanza”, con racconti a puntate dello stesso LuigiD. e
di V.Armirotti; alcuni numeri furono stampati nella tipografia stessa. Riuscì
a pubblicare 44 numeri e poi ad ottobre dovette cedere la proprietà del
giornale ad una Commissione, mentre lui andava a fine ottobre a Sestri a
fondare quale direttore un altro giornale politico-amministrativo-commerciale
intitolato “il Patriotta”; ed infine nell’aprile 1879 quando stampò tre numeri
del settimanale di 8 pagine (domenica) “Giornale
dei comuni”,”ebdomadario, politico,
commerciale, amministrativo. Organo degli impiegati” (conteneva elenco dei
concorsi, fallimenti, aste, appalti, banche ecc.; nacque una polemica sfociata
in insulti, libelli, calunnie ed invio di padrini tra il direttore Augusto
Lopez Perera e LuigiDomenico). Nel lug.
1879 Luigi D. è pure direttore e collaboratore del mensile “Serate magiche”,
giornale di ricreazione e letture amene.
Un altro giornale, pubblicizzando
il “Cosmetico chimico Prussiano”, tintura per capelli, precisa che si sarebbe
potuto comperare presso la sede del settimanale (al
civ.4 di via s.Antonio).
Nel 1887, al civ 2 aveva
sede una società di Mutuo Soccorso, denominata “Emancipazione operaia”.
Sempre in quegli anni, sulla
strada avevano l’ingresso molte ville di nobili cittadini compreso- dove ora
si erge il palazzotto detto della Banca d’Italia - la villa Masnata (a quei tempi Ospedale civile).
Nell’anno 1900 ancora
esisteva questo nome, per il tratto compreso “tra via Larga ed il corso dei
Colli” ovvero tra l’attuale via Dottesio
e cso Martinetti.
Questo tratto negli anno 1918-20
divenne poi “via Generale Cantore” ( ovviamente
subito dopo la fine della prima guerra mondiale; è ancor oggi leggibile il
nome, scritto sul muro dei giardini della villa della Fortezza); ed
infine, sempre presumibilmente dopo il 1930, divenne via N.Daste: ancora nel Pagano/33, al
civ. 2 vi compaiono la sede dell’impresa
trasporti (comprese pompe funebri) dei f.lli Robba, assieme alla
segheria-fabbrica di cornici di Masnata Emilio¨; al 13 la
fabbrica-negozio di conserve alimentari Massardo, Diana e C;
La strada nei primi del 1900 
 l’ospedale in villa Masnata nei
primi del 1900
l’ospedale in villa Masnata nei
primi del 1900
=2b=
corrisponde a salita s.Rosa, inferiore+superiore
assieme.
Tito Tuvo scrive sul Gazzettino
che il 29 maggio 1817 il ‘nuovo Capo Anziano Antonio Mongiardino firmò
un elenco di strade classificate comunali’; tra
esse è descritta una “salita o vicolo ‘Sant’Antonio Superiore’” che porta a
Promontorio (confermerebbe quanto scritto da don Brizzolara (vedi a s.Antonino,
e corrisponde a salita S.Rosa)). Iniziva dalla strada Provinciale e finiva
nella strada trasversale che dalla Pietra porta alla Salita degli Angeli e
questa a San Teodoro e a Genova.
La targa apposta nella parte alta
della salita, scrive “già via s.Antonio”. Il Comune avrà altri documenti che io
non ho visto, per tale asserzione suffragata da don Brizzolara, che non è
poco.
DEDICATO
: più probabile a sant’Antonio Abate detto pure ‘di Tebe’, o ‘Magno’
oppure ‘il Grande’ (per distinguerlo
dall’omonimo padovano).
Nel calendario, è commemorato
il 17 gennaio.
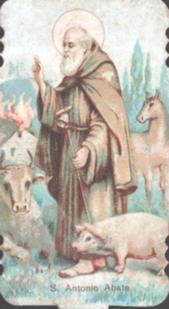 LA PERSONA
LA PERSONA
Nato a Coma (oggi Qemans-el
‘Arous) sulla riva sinistra del Nilo nel medio-alto Egitto nel 251 (altri
scrive 253) da famiglia di un agiato egizio, divenuto cristiano con tutta la
famiglia forse dopo essere venuto ad un primitivo contatto con san Paolo
anacoreta (l’effettivo e riconosciuto incontro
tra i due avvenne quando Paolo già era ultracentenario ed Antonio nonagenario:
dopo questi colloqui, Paolo morì, ed Antonio lo fece seppellire -si dice- nella
fossa scavata da due leoni venuti appositamente: sono i due felini che
accompagnano il santo nella sua iconografia, del Velasquez, Guercino,
Signorelli ed altri come Grünewald).
Questo
accadde proprio in un momento storico difficile, essendo in atto una persecuzione
dei cristiani imposta in tutto l’impero dall’imperatore Decio negli anni 249-51
(e da allora fino al 313 con Costantino, essere
cristiani significava carcere e morte sicura).
A vent’anni ereditò gli averi familiari essendogli mancati entrambi i
genitori. Seguendo l’invito evangelico “se vuoi essere perfetto, và, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo”, vendette
tutto sia per sistemare degnamente la sorella in una comunità e sia per
decidere donare tutto il rimanente ai poveri.
Così, imitando i pii asceti di
cui già aveva sentito parlare, decise infine di dedicarsi alla penitenza in
una celletta nella Tebaide vicino al mar Rosso, forse nel villaggio odierno di
Meimoun, da solo nel deserto libico inospitale.
Sopravvivendo con lo scarso
cibo che riceveva da amici, il deserto significava avere nulla, non poter avere
altro che nulla e quindi dover distaccarsi da tutto: luogo ideale per subire
dopo un po’ le famose “tentazioni del demonio”, contro le quali uscì vincitore
(questi gli apparve sotto le apparenze umane,
angeliche, bestiali, suadenti e tentatrici: carne, oro, tessuti, bevande e
cibi; ma lui seppe resistere tenacemente dando dimostrazione di quella forza di
volontà da lui usata contro il male ma necessaria in tutte le operazioni della
vita, di cui molti si sentono carenti e che lui incentivava a maturare con lo
scontro).
Divenuta famosa la sua
presenza, è’ accertato che suo malgrado, lo stare solo non fu totale: la zona
si popolò di numerosi corregionali per i quali
fondò e governò altrettanti romitori, divenendo il “padre degli eremiti”;
ovvero i molti che, dopo la metà del III secolo, preferirono fuggire e
distaccarsi dalle cose del mondo per ritirarsi nella solitudine penitenziale
fatto di lavoro, preghiera e lettura (è
riconosciuto che però non fu lui l’iniziatore della vita monastica come siamo
abituati, a considerare fosse a quei tempi, e che leggiamo essere stata nel
medioevo: lui non diede organizzazione, né regole né principi (questi verranno
dopo, iniziando nella Tebaide per opera di Pacomio). Il patriarca di
Alessandria lo chiamò fondatore dell’ascetismo, cioè della vita austera, di
sacrificio, di penitenza); ma lui ancora perseguendo il suo scopo di
isolarsi, scelse ritirarsi ancor più, con solo due discepoli Macario ed Amata,
nel profondo deserto, forse sul monte Qolzoum ove restò coltivando un
orticello ed in meditazione e preghiera, per ulteriori molti anni della sua
lunga esistenza.
Tra i seguaci della sua fede
ascetica, viene citato sant’Ilarione palestinese di Gaza (291-371: dopo aver compiuto gli studi ad Alessandria
d’Egitto, si convertì alla nuova religione e, battezzato si ritirò ove viveva
il primo degli abati. Dopo un certo periodo alla ricerca di se stesso, trovò
utile tornare a propagandare la fede in Palestina ricevendo fama di saggio e di
guaritore in tutta l’area mediterranea).
Quando dopo vent’anni di vita
ritirata ritornò al mondo degli uomini, apparve loro come un vincitore iniziato
ai misteri di Dio: il suo nome fu presto in bocca a tanti e da ogni parte fu
raggiunto per essere guidati da lui o per imitarlo (ricchi o poveri, atei o
filosofi, eretici o cristiani). La sua fama si
espanse localmente, come di sant’uomo dall’animo imperturbabile; un esempio di
come ci rappresentiamo Iddio: grande, benigno, forte, che da fiducia,
distaccato dalle cose terrene.
Lo sappiamo nel 308 ad
Alessandria (con imperatore Daia), in
visita ai carcerati candidati al martirio per ordine di Massimiano; ed ivi
ritornò in tarda età chiamato da Anastasio vescovo di Alessandria per
combattere pubblicamente l’eresia di Ario che negava la divina consustanzialità
di Gesù col Padre. Fu lo stesso Anastasio a scrivere una sua biografia, che
però essendo di eccessiva edificazione, lascia dei dubbi sull’autenticità.
Morì vecchissimo, più che
secolare, il 17 gennaio dell’anno 356 (altri
scrivono 355 e altri 358).
Sulla tomba fu eretta una
chiesa con annesso monastero, ma per circostanze non conosciute le sue spoglie
vennero trasferite nell’anno 635 a Costantinopoli, e nel X secolo trafugate in
Francia ove furono collocate a Saint Julien di Arles (a La Motte Saint Didier, località di una tappa del trasporto, fu
eretto un monastero gestito da monaci detti ospitalieri Antoniani, che diverranno
assai famosi nel successivo tempo per il loro interesse alle malattie ed
epidemie).
RELIQUIE Manns scrive che la sua tomba fu ritrovata due secoli
dopo la morte, nel 561; e che le sue reliquie furono portate in Francia nella
chiesa di san Giuliano ad Arles (Cambiaso
scrive vagamente ‘a Vienna, in Francia, nel Delfinato’) al tempo dell’imperatore Lottario II (954-986).
Altrove
si legge che i complessi abbaziali genovesi a lui dedicati ebbero motivo di
maggiore solennità quando, nell’anno 1461, dalla perduta colonia genovese di
Pera di Costantinopoli, venne portata a Genova una reliquia dalla testa del
santo (venerata in una preziosa urna ornata di gemme).
BIOGRAFIA Come già scritto, dieci anni dopo la sua morte, per
additare ai fedeli da convertire il significato del nuovo Vangelo, tradotto
in esempi pratici di persone vissute in santità, l’arcivescovo Atanasio tracciò
una prima biografia che funge da testo promotore per conoscere il santo, anche
se presumibilmente fu forzato nell’intento laudatorio. Comunque è uno dei primi
santi, non martire.
Si
conservano sette lettere scritte da Antonio e giunte sino a noi; e nella
raccolta delle ‘sentenze dei Padri’ si trascrivono numerosi suoi detti dai
quali si possono trarre ampi tratti della sua personalità (in particolare la modestia,
umiltà e fratellanza).
Di
per sé, è un santo bonario, gioioso, infantile quasi nel suo amore e protezione
degli animali. La sua festività cade il 17 gennaio: a seconda degli anni questo
giorno è all’inizio a addirittura a metà del Carnevale, che nei tempi antichi
era festeggiato con danze pubbliche e falò (preparati annualmente
conservando appositamente alberi resinosi seccati).
E’ ovviamente protettore dell’ordine degli Antoniani. Fu istituito a Vienne
(Francia) da monaci agostiniani, sul finire del XII secolo, con acquisita
specialità ospedaliera. Divenne consuetudine offrire loro in elemosina il
maiale, forse ritenuto cibo per poveri e da ciò il proprio principale
sostentamento.
Si vuole sottolineare come
sappia già di miracolo che uno sperduto fellah del medio Egitto, sia riuscito
ad avere sì larga fama internazionale pur non avendo fatto nulla di
storicamente valido.
Così, seppur lentamente crebbe la
fama di Antonio,‘scalzando’ s. Savino onorato nello stesso giorno, fino a
farlo scomparire; fu coincidenza che nel 1593,
Genova travagliata da grande carestia, il 17 gennaio entrarono in porto
numerose navi cariche di grano: l’evento fu festeggiato con grande processione dalla metropolitana a san Marco
e ritorno.
GENOVA La venerazione
del santo si espanse, e - con i naviganti e pellegrini - arrivò anche a
Genova; fatto è che attorno alla sua
figura si sviluppò un ricco folklore popolare, inserendolo nel gruppo
dei 14 santi ausiliatori.
I
primi documenti di una confraternita
genovese a suo nome cresciuta in città, e di una loro chiesa in zona di Prè,
risale al 1184; ma evidentemente ha radici assai più antiche, anche se i
documenti si arricchiscono di ospedali, chiese, oratori a lui dedicati nel 1400
e 1500 in tutta la Liguria. Nella
chiesa di Prè – ove già prima del XIII secolo, in apposite stanze ospedaliere,
si curava l’herpes - veniva commemorato in concomitanza di una processione
generale per la carestia avvenuta nel 1593 e vinta quando nel giorno del santo
arrivarono in porto navigli carichi di grano.
Scriba narra gli avvenimenti riguardanti questa confraternita: la chiesa di Prè
prima del 1250 era sotto la diretta gestione dell’arcivescovo locale che
lasciava a ministri secolari di reggere chiesa ed ospedale. Questi avevano
facoltà di allevare in libertà per le vie della città buona copia di maiali
riconoscibili ed intoccabili perché bollati con il simbolo della abbazia (la
gruccia di s.Antonio foggiata a Tau (o croce egiziana o crux commissa; nei
documenti una T azzurra in campo nero; questa fu considerata simbolo di vita e
quindi ostacolo a tutto ciò che potrebbe rapirla, dal morso dei serpenti alle
malattie. Solo nel 1751 i Padri del Comune, pagando una indennità, soppressero questo
privilegio). Nel 1250 papa Innocenzo IV decretò che a Prè andassero i monaci
della congregazione di Lerino, ma arcivescovo e capitolo di s.Lorenzo
protestarono cosicché le bolle papali rimasero lettera morta; e tali rimasero
anche quando il successore AlessandroIV riprese l’ordinanza. Solo dopo un
secolo, i monaci Lerinensi ebbero la soddisfazione del trasferimento a Pré, lo
testimonierebbe un bassorilievo del 1353 in pietra nera posto nella via
omonima, presso chiesa e cortile?, che rappresenta il santo con in mano un
papiro su cui sta scritto “vox de coelo ad Antonium exclamans: equidem
viriliter dimicasti, ecce ego teco sum”, ai cui piedi è un abate genuflesso con
un pugnale nel fianco (l’herpes), un agnello, una mano con incensiere, un
verro.
Questa confraternita rimase in attività sino alla fine del 1800 quando gli
avvenimenti politici ed una migliore funzionalità dell’ospedale di Pammatone
favorirono la chiusura della sua attività ed il trasferimento della reliquia
che venne affidata all’Oratorio di sant’Antonio in Sarzano, che la conservò
fino poi alla soppressione anche della chiesa stessa .
Anche a Genova, i frati
avevano sia l’incarico specifico della protezione
della salute ovvero di curare - in locali adatti, chiamati ospedali - i pellegrini e naviganti malati (la parola ospedale non corrisponde al significato
attuale, ma a quello latino, di semplice ospitalità, con parziale assistenza
diretta delle malattie; in particolare si
distinsero nell’affrontare due malattie epidemiche similari nel dolore e nelle
manifestazioni cutanee, diverse di causalità. Una - esistente tutt’oggi col
nome di herpes zooster, sappiamo essere una nevrite di origine
virale - ma allora assai più frequente per le precarie condizioni igieniche e
di contagio. L’infezione, nei secoli a cavallo dell’anno 1000 , molto infierì
sia in Francia che in Italia, ed i movimenti di massa legati alle crociate ne
favorirono l’espansione essendo infettiva. A Genova nel 1184 troviamo una
abazia a suo nome, a Prè (dove nel 1461 esisteva una reliquia tratta dal cranio
e portata a Genova da Pera chiusa in un reliquiario ornato di gemme e d’oro:
alla soppressione della abbazia la reliquia passò all’oratorio di s.Antonio in
Sarzano), affidata ai frati dell’ordine Antoniano che avevano iniziato
dedicandosi al servizio degli infermi affetti dal ‘sacro fuoco’. Fu così
secondariamente chiamata popolarmente “fuoco di sant’Antonio” per il dolore
nevralgico che procura e che a volte persiste per anni anche dopo guariti
(quindi sia perché curati dai frati a lui dediti, sia in rappresentanza delle
sofferenze che lui stesso patì nell’isolamento). Seconda, riguardo il “fuoco di
sant’Antonio” è opportuno segnalare che nei paesi dell’Europa del Nord esso era
riferito ad altra pesante malattia: il “St.Antony’s holy fire” o “le feu sacre,
de saint’Antoine”: l’avvelenamento da segale cornuta (una spora di fungo,-
detto sclerozio - parassita del frumento – grano e segale - ricca di una
sostanza che accumulandosi è velenosa, l’ergotina; se infettato il raccolto era
da buttare via, perché nell’uso protratto portava ad un avvelenamento - detto
ergotismo - con aborti, dolori da spasmo viscerale ed arteriolare e conseguente
mortale cangrena ed infiammazione della pelle. In Italia questa malattia era
già stata affrontata dai tempi dei greci e dei romani che avevano capito la
pericolosità dello sclerozio e quindi non importavano grano malato.
E sia la protezione degli animali in genere, specie da stalla e cortile, con lui nell’atto di benedirli tutti, in genere
quelli domestici, mucche, asini, gatti, cani e quelli da cortile. E la sua
effige, così plurisimbolicamente espressa, veniva appesa in tutte le stalle e
nei negozi di macellai, cestai, calzolai e fabbricanti di spazzole. Nelle nostre campagne gli venne affidata la protezione
del bestiame; ritraendolo (sia nelle
semplici immagini popolari che nelle iconografie di grandi artisti) come un benigno vegliardo eremita avvolto in un
semplice saio, con un bastone in mano da mendicante( terminante con una T a guisa di gruccia, da ‘ tau’:
simbolo delle vita futura); con vicino un
fuoco (dell’herpes, ma non meno attinente il collegamento del santo col fuoco
in genere, intendendo lui come novello Prometeo che era andato all’inferno a
prenderlo (con tutte le picche e ripicche coi diavoli) per portarlo sulla terra
e dimostrare la sua capacità di vincere il demoni), dei campanelli simbolici
( continuando un’usanza dei lerinensi, agli animali tutti una volta all’anno
portati in piazza per una benedizione, venivano appesi al collo o alle
orecchie piccoli sonagli, ed offerto a loro pane ammollato nel vino); ed ai piedi o dei diavoli ( a ricordo delle tentazioni subite e vinte) o un porcellino (il suino, che in oriente è animale immondo della cui carne è proibito
cibarsi, rappresenta gli istinti più gretti; in occidente è considerato
animale da cortile completo: costa poco alimentarlo e custodirlo, e di lui -
per il sostentamento - si utilizza tutto. Era quindi definito l’animale della
Provvidenza; e non a caso il periodo della sua macellazione è a gennaio in
coincidenza con la ricorrenza del Santo; e ciò per tanti motivi: non si
lavorano i campi; nel freddo le carni si mantengono di più prima di renderle
durature da dispensa; nel carnevale a venire si potevano mangiare le carni
mentre subito dopo con la quaresima non più;col fuoco in casa di cuociono le
carni; col sangue e sanguinacci – da noi, berodi - si alimentano i bambini
anemici dopo l’inverno.
---Storicamente,
il figliol prodigo era costretto a guardia dei porci: il più basso dei
mestieri; ed anche Dante (Paradiso, XXIX, 124) cita che della stoltezza umana
si “ingrassa il porco sant’Antonio”; cioé si scaglia contro i predicatori di
falsità religiose che approfittano della semplicità-credulona del popolo per
derubarlo. Usa così specifico riferimento a certi Antoniani toscani che aveva
fatto credere che i loro maiali fossero benedetti, promettendo quindi false
indulgenze ed introducendo l’usanza di mantenerli (col frutto delle elemosine
divenute obbligatorie per il popolo superstizioso) ed ingrassarli (col concetto
fossero animali benedetti) per cui, male incoglieva chi li maltrattava;
ottenendo infine non solo fossero tollerati, ma anche nutriti, fin’anche
accarezzati, usando il messaggio cristiano per estorcere benefici personali.
Dall’esempio dei frati, il passo si estende a tutti coloro che con vane parole
promettono fallaci indulgenze)
---A
Genova, in vico inferiore del Roso – angolo via Prè - un bassorilievo votivo
raffigura il Santo con ai piedi un guerriero armato di spada; vi è iscritta la
bolla di papa Innocenzo III che affidava l’ospedale vicino –fondato dagli
Antoniani di Vienne - ai monaci provenzali detti larinensi (dall’isola di
Larino).
---Tra
altre usanze, viene ricordata quella natalizia nel tardo 1700, di inviare in
piazza s.Matteo da parte del monastero di Pré (ove era sorto un ospedale, senza
rapporto con Vienne) alle dame dei Doria, con chiassoso e festante corteo, un
porco ucciso e decorato di ghirlande, frasche e verdure, in cambio di una generosa
offerta (alcune monete d’oro) ed a ringraziamento di donazioni fatte per la
ricostruzione della chiesa o per la precedente festa di s.Lucia. Fochesato
riporta una filastrocca: “sant’Antonio, sant’Antonio, t’æ a barba d’ôu – se ti
ne mandi o vento in poppa, - me se no ti t’arrecordi de noialtri – ti ghe l’è
de stoppa” recitata per ricordare che sulle navi (nel caso, portoghesi e nel
XVI secolo) aveva posto d’onore una statua del santo che veniva venerata se il
vento soffiava in poppa, mentre veniva minacciata, flagellata e declassata di
posto se c’era bonaccia o vento contrario; al ripristino del vento buono,
veniva ricollocata nella nicchia, chiedendo umilmente perdono di averlo
picchiato.
---nel
quadro del ‘Paese della cuccagna’ - di Bruege l- l’animale è frequentemente
riprodotto;
---sempre
a Genova, nella prima metà del XV
secolo, fu legalmente concesso all’ospedale tenere un branco di porci col fine
della sussistenza del complesso; gli animali, lasciati liberi e moltiplicati,
grufolavano scorrazzando per le strade cittadine: da un lato ripulendole
dall’immondizia ma dall’altro creando innumerevoli danni - avevano fatto cadere
da cavallo un nobile (si dice un figlio del re, a Parigi; ma capitò anche a
Giotto, al cardinale d’Aragona, un corteo dei Serenissimi mentre percorreva i 4
Canti di s.Francesco, sconfinavano negli orti, ecc) -. A cicli furono emesse
ordinanze e leggi apposite di limitazione, marchiatura con la T di tau, o
soppressione andate genericamente a vuoto per un sacro terrore, misto di
superstizione, rispetto e scaramanzia della gente a toccare questo abbastanza
lucroso allevamento. I Padri della Serenissima nel 1386, con le Leges Genuenses
dovettero concedere un versamento a favore dell’Abbazia, purché contenesse e
limitasse la presenza degli animali.
-Ancor oggi, particolari
festeggiamenti vengono effettuati al santuario dell’ Acquasanta a fine
gennaio, con benedizione degli animali domestici e distribuzione del ‘pane del
santo’ a base anche di focaccette e frisciêu.
Anche Mele festeggia il 17
gennaio ‘il maiale’: dopo la processione con trasporto della ‘cassa’ su carro
trainato da cavalli, nell’oratorio della Confraternita dedicata al santo
(patrono anche del paese) si vendono parti di un suino, riprendendo così una
antica tradizione col fine di raccogliere fondi per i bisognosi.
A Badalucco di valle
Argentina, la festa trova ancora oggi ampia partecipazione.
L’omonima confraternita di Casella
- che nell’oratorio possiede ricchi argenti antichi (XVIII-XIX secolo) e punzonati (calici,
ostensori,mazze, triboli, ecc) - festeggia il giorno con s .Messa e
successiva benedizione di animali e mezzi di locomozione; incontri culturali (conferenze); tradizioni (le focacce di s.A., che appese in casa proteggono
dal mal di gola; le castagne grasse (piatto dellaa a base di castagne secche
locali e grasso – cotenne e zampini - di maiale);
-
meno probabile, ma oggetto di confusione – favorita dall’ignoranza ed
analfabetismo imperante allora nella popolazione generale - la dedica a sant’Antonio da Padova, Infatti il
Soprani scrive - come già scritto sopra - che lo scultore Gerolamo Pittaluga
forgiò “una ftatuina di s.Antonio di Padova per la Chiefa intitolata del nome
di detto Santo nello stesso San Pier d’Arena”.
Questo
Antonio, era confessore del XII secolo, celebrato il 13 giugno, divenuto uno
dei personaggi più clamorosi nella storia dei santi cristiani, essendo forse il
più noto, più amato, più invocato e rappresentato; veramente “internazionale”.
Nato
a Lisbona nel 1195 circa e battezzato Fernando. Dimostrandosi intellettualmente
assai precoce, fu accettato tra i Canonici regolari di sant’Agostino in una
abbazia sul fiume Tago dipendente da quella di Coimbra. Divenuto sacerdote,
assistette alla traslazione di cinque frati francescani martirizzati in
Marocco; cosa che se era all’ordine del giorno per i missionari, fece scattare
in lui il desidrio di sostituirli: fece trasferimento in quell’ordine, che gli
impose il nome di Antonio, e riuscì a partire per la prima missione in Marocco,
cercando di coltivare la semplicità ed umiltà di frati francescani. Ma una
malattia lo obbligò al rientro, complicato da un naufragio che lo portò sulle
coste sicule. Approfittò per andare ad Assisi e per avvicinare Francesco. Da
lui, dopo aver partecipato ad alcuni Capitoli generali assieme a Francesco,
dimostrandosi intellettualmente superiore, ebbe invece la destinazione ad un
eremo presso Forlì. Qui, per caso, ebbe l’opportunità di pronunciare delle
prediche molto seguite, svelando apertamente la dote oratoria che teneva
umilmente nascosta. Dai suoi superiori fu così indirizzato alla predicazione,
ed allo scopo inviato anche nelle città più ostili ed avvelenate dall’eresia. Tra
i miracoli più eclatanti, alcuni sono chiaramente determinati dalla suggestionabilità
del popolino ignorante che – di voce in voce – ingigantiva e deformava gli
eventi: così per la predica ai pesci nella spiaggia di Rimini: visto che la
popolazione disertava la chiesa, lui si mise a predicare sulla spiaggia e - dalla
pesca abnormemente abbondante - si sparse la voce che i pesci erano accorsi al
posto della gente; e della mula ostinata che, di fronte all’ostensorio si
inginocchiò. Ma a parte queste fantasie, è accertato che la sua oratoria fu
assai spesso accompagnata da fatti prodigiosi e strepitosi nonché da
conversioni altrettanto clamorose.
Recatosi
a Verona per contrastare il crudele Ezzelino da Romano e per difendere i più
deboli, si fermò nel piccolo convento dell’Arcella vicino a Padova fissando qui,
per 4-5 anni, la sua cella stabile (per questo, è noto come ‘da Padova’ seppur
portoghese) anche perché minato nella salute; e qui la sua vita si spense il 13
giu.1231 a trentasei anni.
Apparve
subito clamoroso che in così pochi anni, avesse potuto essere così colto,
operare tanto, e predicare in così vasto territorio: non era passato un anno
dalla sua morte che già papa Gregorio IX, che lo aveva conosciuto
personalmente, lo proclamava santo definendolo ‘l’arca dal Testamento’; e Pio
XII, dopo attenti studi e valutazioni, lo laureava Dottore della Chiesa
universale .
BIBLIOGRAFIA
:
-Alighieri
D.- La Divina Commedia-Paradiso XXIX-v.124
-Alizeri
F.-Guida illustrativa per la città...-Sambolino.1875-pag.652
-Antero
M-Li lazzaretti della città, e riviere-1658-pag537
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale –
Toponomastica - scheda 152
-AA.VV.-dizionario
ecclesiastico- Utet.1953- vol.I, A-F
-Beccaria R.-i periodici
genovesi dal 1473 al ...-1994-pag.75.268.434.537
-Cambiaso D.-l’anno
ecclesiastico e le feste...-SLSPatr.1917.XLVIII-p.106
-Castelli M.-I
Santi-Paoline.2003-pag.24
-DeSimoni
L.-Le chiese di Genova-Ceretti 1948- vol.1 pag. 55-70
-Facchinetti
PV-Antonio di Padova-DonDaste-1929
-Fochesato
W.-Bim bum bà – Feguagiskia’ Studios.2003.pag. 80
-Galella
I.-Brevi cenni di storia e arte Confraternita di sA.Abate-Mele.1991
-Gazzettino
Sampierdarenese : 9/87.5 + 7/93.4 +
-Giardelli
P.-Le tradizioni popolari dei Liguri-Sagep.1991-pag.33
-Il Secolo XIX:
17.01.08.p32 +
-Manns P.-I Santi-ed.Jaca
Book spa-1987-pag.360
-Marcenaro,Repetto-Le chiese
di Genova-Tolozzi-1970-pag.273
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.74
-Morabito.Costa-Universo
della solidarietà-Priamar.1995-pag.450
-Novella P.-Le strade di
Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.8.35
-Pastorino P.-Botteghe e
vicoli-DeFerrari.1999-pag124
-Ragazzi F.-Teatri storici
in Liguria-Sagep.1991-pag.218
-Ragazzi F.-Sampierdarena
1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.143 –
-Scriba G.-Memorie
patrie-Caffaro del 17 genn.1880-Soc.Lig.St.Patria
-Soprani.Ratti-vite de
pittori, scultori...-anast.1769-Tolozzi.1965-II-pag.290
III-pag.93
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag.77foto
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.38.251
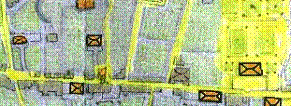 carta
di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in
terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra
nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo
villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa
Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto
l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani
carta
di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in
terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra
nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo
villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa
Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto
l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani 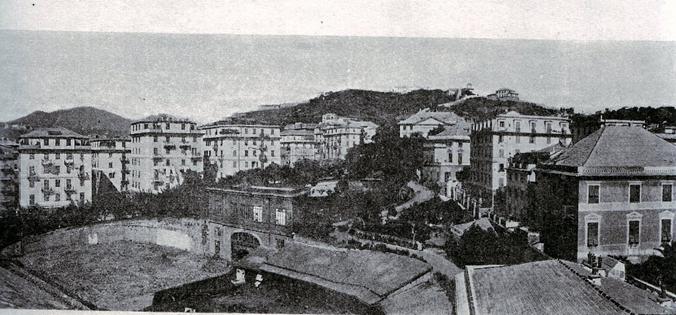


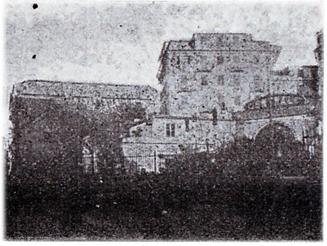 ddell’edificio tale Vincenzo Chiarella, e
tipica era la prevista decorazione esterna, riferibile ai padiglioni
espositivi con gusto esotico (influenza della concomitante guerra libica e -
in quell’anno - del rientro delle truppe tra le quali oltre 200 sampierdarenesi
).
ddell’edificio tale Vincenzo Chiarella, e
tipica era la prevista decorazione esterna, riferibile ai padiglioni
espositivi con gusto esotico (influenza della concomitante guerra libica e -
in quell’anno - del rientro delle truppe tra le quali oltre 200 sampierdarenesi
).

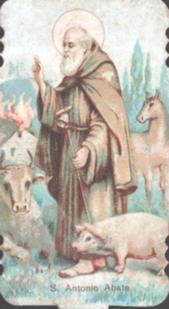 LA PERSONA
LA PERSONA