BALLEYDIER via
Balleydier
TARGA:
San
Pier d’Arena – via Balleydier


angolo con via di Francia

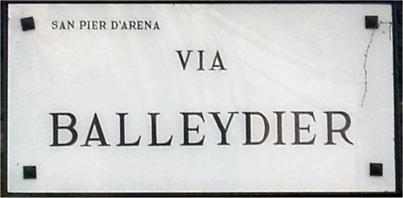


angolo con via Pietro
Chiesa
QUARTIERE ANTICO: Coscia


da M.Vinzoni, 1757. in giallo via Demarini con
da Porro 1835, segnalato “fabbriche di ghisa”
Largo Lanterna; in blu via
della Marina (P.Chiesa)
N° IMMATRICOLAZIONE:
2716 CATEGORIA 2
 immagine tratta dal Pagano del 1961
immagine tratta dal Pagano del 1961

Dal 1998 le aree rosse e blu furono teatro di profonda
operazione edilizia
 in azzurro via Demarini; in giallo
via P.Chiesa; in verde via Balleydier. Il grosso edificio a destra è la Nuova
Darsena eretta negli anni 1980. Da Google Hearth-2007.
in azzurro via Demarini; in giallo
via P.Chiesa; in verde via Balleydier. Il grosso edificio a destra è la Nuova
Darsena eretta negli anni 1980. Da Google Hearth-2007.
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 03600
UNITÁ URBANISTICA: 26
- SAMPIERDARENA
CAP: 19149
PARROCCHIA: s.Maria
delle Grazie
STORIA:
inizialmente,
popolarmente e sulle carte del tardo 1700 venne chiamato Stradone piano
della Coscia (perché aperto nella zona omonima; e come tale
riconosciuto nel regio Decreto del 1857 di approvazione dei primi nomi stradali
di San Pier d’Arena).
Divenne via del Ferro (il motivo di questo nome, è
ovviamente riconducibile allo stabilimento, nato nella prima metà del 1800).
Poco prima dell’anno 1900, fu proposto alla Giunta in nuovo nome di dedica ai
due fratelli (chiamati insieme), e tale rimane tutt’oggi.
Nel 1940, il Pagano scrive che andava da via L Dottesio a via P.Chiesa (ma
edidentemente è sbagliato fosse da via Dottesio).
Dalla fine degli anni 1990, dopo il lavoro delle ruspe nella vicina via
DeMarini-Largo Lanterna, la strada divenne “terra di nessuno e di tutti”:
rifiuti, panni stesi, furgoncini da rottamare e roulottes. Erano un centinaio
di nomadi rumeni, viventi squallidamente in accampamenti improvvisati, autori
di furtarelli e furti, nell’incapacità-impossibilità di inserirsi nel nostro
tessuto sociale. Furono sgomberati nel 2000.
STRUTTURA:
Andava
da via Pietro Chiesa, a via De Marini e quindi a via di Francia.
Viene
descritta essere inclusa nei terreni di proprietà del CAP.
Prima
dello sbocco in direzione mare, sulla sinistra era visibile il fianco di una
antica officina, per lungo tempo abbandonata. L’edificio fu abbattuto nel 1999
causa abuso occupazionale di immigrati; era molto presumibilmente l’ultimo
residuo di un antico stabilimento, in quanto eretto non in cemento ma con
pietre, ed aveva doppio tetto centrale - per la luce e far fuoriuscire fumi e
vapori.
Sino
all’inizio secolo, la targa portava la scritta come oggi, ma con una
sottoscritta che non c’è più: “San pier d’Arena – via Balleydier – dallo
stabilimento siderurgico omonimo”.
CIVICI:
2007
= NERI = 7 → 15 (mancano 1→5 e 11→13). Nessuno pari
ROSSI = 29r →75r
(mancano 1→27, 39→43,
47, 51→55, 63→71; aggiungi 29Ar)
2r → 60r (mancano 4, 14→26, 52, 56,
58; aggiungi 6A, 26AB, 28ABC, 52A)
Nel 1902 il Pagano segnala unica impresa esistente, quella di trasporti
di Bianchetti Sebastiano, tel. 591 (presente ancora nel Pagano/21, assente nel /25)
Nel 1910 , i limiti della strada erano via DeMarini a monte, e
via Galata a mare; ed aveva già civici sino
all’8 ed al 3.
Il Pagano/1912 segnala in più l’esercizio di commestibili di Cabella
Angelo¨ al 20r.
Dal Pagano/1919 (tel.25-63) sino alla loro demolizione, facevano lato
alla strada i Docks Liguri (nel 1940, società anonima con
capitale versato di 4milioni e ‘già docks vinicoli’. Ancora nel 1970, era SpA
con capitale di £.100milioni. Aveva vasto edificio adibito a magazzino e deposito
per merci varie generali, estere e nazionali, tel. 41-178), con - sul colmo del
tetto- delle gru poste su binari, ed affacciantesi nella corte interna,
attraversata dai binari ferroviari, i quali collegavano in modo diretto la
struttura col porto allo scalo del ponte Morosini.
Nel 1921 vi si apriva l’esercizio pubblico della soc.Auto Trasporti
(forse dello stesso Bianchetti del 1908).
Il Pagano/1925 segnala al civ. 1
la filiale-succursale
della soc.an.lubrificanti Ernesto Reinach (ancora presente nel P/1933) di
Milano;--- all’8r il garage (chiamato ‘scuderia’) dell’impresa trasporti Canepa Stefano
e figli (vedi v.CColombo 83);--- al 20r un commestibili di Cabella Angelo;
Nel 1927 era di 4° categoria
Fino al 1933-4 era di 4.a categoria , e congiungeva via DeMarini con
via Pietro Chiesa.
Nel Pagano/1950 è segnalata unica una osteria al 17-21r, di Costantini L.; non
bar
né trattorie.
Nel Pagano/1961 leggiamo al civ. 50 la
casa di spedizioni Lanati & C.; due osterie, di Gualco e di Campominosi; 2
corrieri; un riparat. auto, gommista, riscaldamento, saldatore e rigattiere.
Nel genn.1969, soppresso vico Chiuso,
i suoi civici furono trasferiti a via Balleydier.
Nel 1980, al civ. 3 ancora esisteva una
edicola dedicata ad un santo non facilmente riconoscibile perché già allora
abbandonata e sporca
Ancora nel 1991, si segnalava l’errore del nome sulla targa, lo stesso
riportato nei libri di toponomastica editi nel 1953: Ballaydier.
Infinita la storia della povera gente: nell’aprile 2004 quattro rumeni
avevano ricavato – ovviamente senza permessi né diritti - uno spazio arredato
vivibilmente, anche se precario. Presumibile il loro rimpatrio. Poi, la Romania
entrerà nella comunità Europea con libera circolazione.
Ancora in quell’anno, tutta una serie di imprese artigianali sono state
intimate di sfratto essendo il terreno destinato a grandi progetti di
trasformazione; collocate sulla strada sono una carrozzeria ed un elettrauto
per mezzi pesanti chiamato ‘Elettrodiesel’; ma altrettanto è stato per imprese più o meno grandi, sulle
strade vicino adiacenti.Autrice dello sfratto è la cooperativa ‘il Promontorio’
che ha vinto l’appalto dei lavori in previsione del Piano Regolatore sia del
Comune che del Porto per tutti i terreni dall’elicoidale alla Fiumara.
Si resta in attesa della realizzazione dei vari
progetti che interessano la zona.
Quali che siano nessuno avrà mai la poesia della
Cosca tradizionale.
CIVICI
Proseguivano
da mare verso monte
===civv.
1, 3, 5 furono demoliti nel 1999 (vedi foto, in fondo).
 nella foto: a sinistra il civ. 5; alla sua destra, il civ.3 il cui
nella foto: a sinistra il civ. 5; alla sua destra, il civ.3 il cui
portone era sulla facciata a
mare.
===civ.
7: Nel settembre 2001 veniva
comunicato l’acquisto del palazzo, ultimo rimasto della via, di 5 piani,
costruito nei primi decenni del 1900. A scopo demolizione il Comune, per la
cifra di 750 milioni di lire (lo scarso valore commerciale è legato alla
finalità demolitiva ed al degrado della zona) ha soddisfatto due problemi:
pagare dignitosamente gli ultimi abitanti proprietari (dei dieci appartamenti
facenti parte del palazzo, solo cinque erano ancora abitati) e liberare la zona
alle ruspe. Con la sua eliminazione iniziata nel 2002, finisce un pezzo non da
poco di storia: il rione Coscia.
===civ.7A era divenuto tale nel 1969 quando la strada assorbì
il civ.4 di via Chiusa (essendo stata
quest’ultima soppressa).
DEDICATA
Dei due fondatori si conosce assai poco: due fratelli, Joseph Marie
(1777-1857) e Jean (1779-?) Balleydier fréres, nati ad Annecy nell’alta Savoia
allora italiana da famiglia notabile benestante (Le terre erano dei Savoia torinesi fin dall’anno 1041; in base ai
trattati di Vienna fu confermata al re di Sardegna; ma in cambio dell’appoggio
ottenuto nella 2a guerra di Indipendenza, egli dovette infine ricederla alla
Francia il 24.3.1860); ed al nipote Luigi (1816-1891- figlio di JosephM).
I primi, assieme, avevano iniziato una attività siderurgica in località
Settenex (Ginevra) ma avevano trovato difficoltà di rifornimento delle materie
prime di facile approvvigionamento: un primo esperimento lo fecero in uno
stabilimento aperto presso l’abbazia N.Dame de Tamié introducendo l’uso del
carbone fossile preferito al carbone di legna, estraendolo a saint Jorioz.
Ottennero dal re di Piemonte e Sardegna, il monopolio di fabbricare utensili di
cucina ed altri piccoli oggetti di metallo. Ciò malgrado, e malgrado la
concessione di una miniera di lignite presso Cluses, la concorrenza iniziava ad
essere forte e pesante per una piccola impresa.
Si convinsero che localizzare simile impresa vicino ad un porto capace di
facile approvvigionamento delle materie prime, fosse l’elemento necessario per
avviare una produzione economicamente migliore e vantaggiosa.
Individuarono nella zona della Coscia il
luogo adatto (erano esigue anche le richieste
fiscali del comune). Il 2 giu.1832
dal regio Tesoro del governo di Torino da cui dipendevano, in particolare dal
Ministero Affari Interni furono (in pratica sovvenzionati) “autorizzati a trasportare dalla Savoia nel Ducato di
Genova, in un locale sito in SPd’Arena nel luogo detto Coscia, una fonderia in
ferro di seconda fusione, per fondervi ghisa estera”; le clausole imposte furono: che
entrasse in funzione entro la fine d’anno; usasse solo combustibili fossili;
sottoporsi alle regole dettate dall’amministrazione delle miniere. Un documento
della Prefettura Sarda con questa data, relativo allo “Stato di tutte le
Ferriere e manifatture di ferro esistenti nei Comuni della provincia di Ponente”
scrive esserci una ferriera «dal Lago» a Campofreddo (attualmente Campoligure)
ed uno “Stabilimento di un forno reale per fondervi il minerale dell’Isola
d’Elba gestito dai fratelli Ballendier” (sic).
Sino
ad allora, dai tempi antichissimi, il ferro era pressoché tutto importato
dall’isola d’Elba, e veniva lavorato in forma artigianale: in forni a legna
(fuochi detti catalani) e lavorati con magli di diverse dimensioni. Dalle 2mila
t./anno del medioevo, alla fine del 700 era appena raddoppiato: 5mila t./anno,
dovendo soddisfare il relativo fabbisogno locale (edilizia, navale).
Nell’ottocento, al ferro si aggiunse la ghisa; apparvero le prime legislazioni
nei confronti dell’importazione; iniziò il rinnovamento tecnologico (azionati
da vapore, comparvero forni di ribollitura e laminatoi a cilindri; nel 1882 i
forni MartinSiemens permisero fabbricare lamiere per le nuove navi a vapore. A
metà 1800 la produzione ligure del ferro raggiunse il 40% di quella nazionale,
arrivando alle 35mila t..

lo
stabilimento a fine 1800
Essi crearono (una loro carta
intestata precisa: “sul principio della
strada Vecchia, vicino alla Lanterna”) il primo capannone a carattere industriale
metallurgico-meccanico della Liguria superando fin da subito le modeste
quantità di personale della numerosa presenza artigianale: con l’assunzione di cinquanta
operai -i primi così
tanti insieme in una zona prevalentemente artigiana o di piccole imprese
(sapone, candele, tessuti di seta, costruzioni navali)- fu costruito un corpo di fabbrica
contenente un forno che usava come combustibile la lignite di Calizzano e di
Cadibona, capace di portare a fusione il metallo ed ottenere in due tempi la
ghisa (ferro e carbonio+silicio,manganese,fosforo, zolfo) con la quale si diedero alla lavorazione di oggetti ad uso domestico (utensili da cucina, fornelli, pentole, balconate ed oggetti vari
semplici). Un altro documento all’archivio
Comunale relativo al 1832 scrive ”stabilimento di un forno reale per fondervi
il minerale dell’Isola d’Elba’ gestito dai fratelli Ballendier” (sic per il nome. Non fu la prima in Liguria: altre ne erano già in
esercizio nel 1811 a Rossiglione, Masone, Ronco censite poi dalla prefettura
sarda).
Nel 1833 essi già consumavano 30mila rubbi di
ghisa inglese, 10mila rubbi di coke (carbone vegetale) a cui si aggiunsero
18500 di lignite per la macchina a vapore; e si producevano 18500 rubbi di
ghisa smerciate nel genovesato ed in Piemonte.
Solo nel ‘39, aprirono un forno a carbone coke (di provenienza via nave), capace di produrre la ghisa
stessa direttamente in unica lavorazione
(permettendo la
fabbricazione di opere di più grande impegno, come tettoie; tubi per acqua e
storte per gas illuminante; torchi per uva , per olio, e pasta; ruote
idrauliche e verghe dentate; boe, ormeggi, mozzi di ruote per l’artiglieria,
proiettili di ogni misura, mortai e tutto quanto si potesse formare fondendo il
minerale), sempre conservando dall’inizio la
doppia produzione, metallurgico (fonderia) e meccanico (manifattura), che diverranno alla fine un tutt’uno produttivo (dalla fusione allo scafo, macchine utensili, ponteggi, ecc.).
Già nella prima metà
degli anni 1840 compare il nome
dei fratelli tra quelli desiderosi di investire nel settore ferroviario, allora
ai primi vagiti; ma già dimostra la versatile disponibilità manageriale
nell’aprire officine adatte alla costruzione di materiale ferroso o quantomeno
–nel caso ferroviario- di riparazione del materiale rotabile.
Più tardi si ammodernarono
con la presenza di due forni, con manica di ventilazione, alimentata a sua
volta da macchina a vapore da 8 cavalli (chiamata Kubilot, brevettata dal
Balleydier stesso); questa permetteva ottenere in poche ore oltre 3mila chili
di materiale e produrre strumenti sempre più complessi e difficili come
macchine a vapore (rivoluzionando l’attività
manifatturiera dei piccoli artigiani, specie nei tessili e carta; la difficoltà
prevalente fu la mentalità genovese riluttante ad accettare le innovazioni –di
pensiero, costume e meccaniche dei ‘foresti’-) o ponti in
ferro (uno anche sopra il Bisagno di fronte alla Porta della
Pila: la struttura in ferro fuso fu elaborata dall’ing. Barbavera e realizzata
in tre archi, appoggiati su pietre arenarie di LaSpezia (si vede in un disegno del
P.D.Cambiaso, ove ha però 5 arcate). Ed un altro, sospeso sopra lo Scrivia a Serravalle.
Compreso il meccanismo di copertura mobile del tetto dell’ottocentesco teatro
Politeama Genovese, su progetto di Nicolò Bruno nel 1874; e la copertura di
galleria Mazzini).
Vennero premiati con
medaglia d’oro all’Esposizione dei prodotti e delle manifatture nazionali,
organizzata a Genova nel 1846 (nella motivazione, si fa cenno ai 49 articoli esposti e
prodotti nella loro fonderia).
In un elenco comunale del 1847, risulta nel borgo
la solo loro presenza quale fabbrica di ghisa.
Nel 1857 morì GiuseppeMaria. Subentra alla
direzione il nipote Luigi. Al passaggio di consegne, la fabbrica occupa 10mila
m² di terreno, 350 operai, produce tubi, ruote, lampadari, macchine agricole
(fabbricate e commercializzate) e proiettili
Ancora nel 1870 aveva 3-400 operai (una delle più
importanti fabbriche del nuovo Regno), produceva macchine a vapore capaci di 20
cavalli, ‘pressoi idraulici’ (sic. Evidentemente –come poi anche la corte
piemontese- ancora parlavano francese, essendo un francesismo di
pressoir=pressa, torchio), ecc., utilizzando 3500 t. di materia prima.
Risultano vi fossero
occupati : anno 1833=40-60 operai con salario medio di L.3,20; 1846 =60; 1847= 59; 1857-8 = 180; 1866 = 350; 1874 = 300 (Fu in quest’anno, al restauro del
Politeama dell’ing. Bruno che furono apposte ‘colonne e ringhiere della prima e
seconda galleria, fuse nello stabilimento metallurgico dei Fratelli Balleydier
di San Pier d’Arena alla Coscia’); 1876=280; 1890 = 400; 1896 = 250; con
oscillazioni legate agli eventi bellici (e quindi alle commissioni statali),
all’espansione della rete ferroviaria, all’agricoltura ed i suoi macchinari,
alla partecipazione della trasformazione della marina, dal legno al metallo.
Da questo nucleo iniziale di operai ed in questo torno di
tempo, si iniziarono i grandi eventi di evoluzione sindacalistica, culturale e
sociale durati oltre un secolo a cavallo del 1900: le questioni
dell’analfabetismo, dei salari, orari, rapporti ed accordi con i padroni per
conquistare gradino per gradino dignità, eque misure, salute e diritti (quando in quegli anni un
agricoltore percepiva 8 lire al mese, un operaio ne guadagnava 2 al giorno,
una tessitrice 50 centesimi, una operaia in cartiera 60 cent. (che seppur
iniziando l’orario alle due di notte in un sistema mai interrotto, erano
‘provvedute di lumi, alloggi e di lavoro sempre al coperto’); mentre una pigione di casa valeva 4 lire al mese per stanza). Non esistendo né banche né la mentalità del
risparmio, tutti i guadagni dei bassi ceti venivano consumati in bisogni
immediati, non solo necessari ma anche voluttuari tipo alcool, fumo (usavano i
‘sigarri’), gioco del lotto.
Dei tre, fu Luigi (figlio e
nipote dei fondatori) il più attivo in attività sociali ed per intraprendenza
commerciale, perché il mondo imprenditoriale emergente favorì la
sua generazione. Nato
il 13.2.1816, fu socio palchettista del Modena nel 1857 quando se ne decise
l’erezione; nel 1868 lo leggiamo nel consiglio d’amministrazione (assieme a
R.Rubattino, al sindaco di Genova A.Podestà ed il conte Albini) della ‘società
di colonizzazione per la Sardegna’ nata con la nobile finalità di valorizzare
questa regione del regno; divenne anche sindaco (maire) di San Pier d’Arena
negli anni 1875 (succedendo a N.Montano). Morì l’ 8 apr.1891, quando l’azienda
era in piena espansione, occupando fino a 400 operai. Aveva dimostrato tenace
attaccamento al lavoro; anche sul piano umano, riconosceva che preferiva
lavorare in perdita anziché licenziare un solo dipendente.

Quando avvenne la morte
del direttore -evidente figura trainante- iniziò una lenta ma progressiva
diminuzione produttiva aggravata dalle varie crisi del settore, anche
internazionali.
Don A.Miscio segnala un Ballaydier (con la ‘a’), Carlo; ma la successiva
descrizione si sovrappone a Luigi: morto secondo lui il 9 (non l’8) aprile 1891
(seppur colti, anche i preti possono sbagliare nel dire messa, specie se
presuntuosi); riferisce comunque che alle Grazie si svolsero le esequie con
cerimonia avente “…l’aspetto
di apoteosi, per dovere di ringraziamento ad un uomo benemerito per essere
stato il primo ad introdurre in Italia uno stabilimento metallurgico e a
dirigerlo secondo criteri di efficienza straordinaria e di grande giustizia,
una giustizia che travalicava in umanità, in carità e in responsabilità
insolite. Era un ottimo cristiano. Padre dei suoi operai. Incapace di
licenziare quelli che o per l’età e per indisposizione non erano più
efficienti. Li teneva lo stesso. Si accontentava di quello che potevano fare.
Li pagava lo stesso. A tutti gli operai che lo volessero permetteva prima del
lavoro che potessero fare le loro devozioni in chiesa”.
Una
carta intestata del 1895, reclamizza “Fonderia in ghisa Stabilimento Meccanico
- Balleydier Frères - Sampierdarena presso Genova“, con ovvio riferimento solo
ai due fondatori, forse perché Luigi lasciò loro l’onore del nome aziendale.
La diminuzione dell’attività (dal 1897) divenne sempre più critica ed
estremamente labile negli anni a cavallo del secolo, e fu determinante la
ricerca di essere assorbiti in altre imprese del settore. Dimostrativa
l’assenza, alla partecipazione della grande festa dell’Esposizione colombiana
del 1892. E nel momento particolare, fu la
Wilson e MacLaren che parve interessarsene: ma anche questa società però era
già entrata in crisi, tanto che nell’anno 1900 era già stata a sua volta
liquidata e svenduta (al banchiere privato Pietro Canzini) che nel 1903
delibera lo scioglimento e la cessione dei suoi impianti alla Balleydier.
Dopo un anno di
chiusura totale (nel 1903 –causa fallimento-
lo stabilimento venne valutato 350mila lire, il macchinario ed il materiale
462mila, il capitale era 1,2milioni), ed a prezzo di drastici e duri licenziamenti l’industria
fu rinnovata nell’estate del 1904 con l’apporto di pochi nuovi capitali (2milioni, portato a 5,9 nel 1907)
forniti da un gruppo di
finanziatori genovesi compresi alcuni ‘grandi’ dell’industria (quali Giovanni Tassara, Rosolino Orlando, i fratelli Pastorino Carlo e
Pasquale). Questa boccata d’ossigeno le permise
di durare qualche anno, di fondersi e confluire con i vecchi impianti della
Wilson-McLaren in una nuova gestione chiamata “Società italiana di fonderie
in ghisa e costruzioni meccaniche già Fratelli Balleydier” che fece
conoscere ai tre stabilimenti ancora alcuni anni di impulso produttivo,
usufruendo di commissioni ricevuti dalla marina militare e dalle ferrovie, a
margine dei grandi e complessi interessi e legami del trust
siderurgico-cantieristico.
Ma già nel 1907 (l’aumento del capitale programmato
non fu attuato ed il capitale fu diminuito per assorbire il deficit), dei 350 operai praticamente tutti vennero licenziati (Doria scrive da
410 del 1908 a 127 del 1911) e -con il varo di un ultimo
rimorchiatore in commissione-, nella primavera del 1908 praticamente cessò
qualsiasi attività (il Gazzettino Sampierdarenese dice
assorbita dall’Ansaldo) al punto che nel 1911 aveva
accumulato debiti per circa 8milioni e perdite per 3milioni. Nel 1914 scrive
Doria ancora esistere con un capitale ulteriormente ridotto a circa
1,5milioni, forse relativo solo ai beni immobili e non al lavoro produttivo.
L’esplosione della prima guerra mondiale determinò una
ripresa dell’attività con le commesse belliche, che però non ebbe la forza di
sussistere appena stipulata la pace.
Furono i primi ad inserirsi nel borgo di San Pier
d’Arena fino ad allora votato all’artigianato; e furono seguiti a breve da
altri industriali impegnati nella metallurgia, come Robertson, MacLaren e
Wilson, Taylor e Prandi; portarono per circa 100 anni, lavoro e prestigio che
per San Pier d’Arena venne riconosciuto col fatidico ed insieme disastroso per
l’ambiente, titolo di ‘Machester italiana’
. Innumerevoli furono
le piccole aziende metallifere, autonome o dipendenti per lavori accessori. Tra
tante nella zona della Coscia, un documento datato 2 aprile 1961 contenuto nel
faldone n° 489 dell’ASC, segnala la presenza di un opificio per la
cappellazione del piombo argentifero, con caldaie e ciminiera per vapore,
gestito dai sigg. Massone Lorenzo e Musante Giuseppe, eretto in terreno Bodda
Saccomanno, sito “in regione Coscia, dalla Cappella di S.M. del Primo Quartiere
in luogo isolato, a lato della strada ferrata a cavalli e nell’alto dei sig.
Balleydier”.
 carta intestata dell’opificio
data 1895
carta intestata dell’opificio
data 1895
al centro, in orizzontale il progetto-tracciato di via di
Francia. Tra la Cava della Coscia, via del Ferro e via Vittorio Emanuele, al
centro del disegnato, l’officina metallurgica Balleydier Luigi


 1976
1976

Zone rosse, demolite; via Balleydier in verde. A destra di
essa, in basso ed in rosso, l’area interessata: l’edificio a L a destra, è la
Darsena; la strada sottostante ad essa è via De Marini; a mare dell’edificio a
forma di chiave inglese era l’area dove sorgeva l’officina

in basso, l’elicoidale. In alto a destra, la sommità del
tetto della Darsena

verso il mare: dietro la baracchetta scura in basso a
destra, iniziava -verso sinistra- via DeMarini


edificio-officina, costruito in pietre





cancello che chiudeva quella che era una via ferroviaria
Dal cancello verso ponente. Agosto 1999
sopra il muraglione iniziava via Vitt.Emanuele II


civ.5 - portone all’angolo con via DeMarini
civ.3 palazzo poco più verso il mare
-
nella foto dopo, la facciata laterale


facciata laterale del palazzo precedente La
piazzetta, con il civ. 3 (dietro al camion) ed 1
Dove c’è il camion c’era una piazzetta nella
palazzina bassa.


Stesso piazzale, seguente il palazzo precedente. Santo su
un palazzo abbattuto
Sullo sfondo, le case di via DeMarini


a nord di via DeMarini


alle spalle, la Darsena; a destra, via DE Marini; a
sin. Ancora da bbattere – vedi traliccio
l’elicoidale. Dietro la casa il traliccio luce.
2008

dove le macchine, area dello stesso caseggiato sopra,
abbattuto.
In basso –fuori immagine, via De Marini. Vedi traliccio,
2010
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico del CAP-vol.I-pag.63
-Archivio
Storico comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica , scheda 262
-Autore
non conosciuto-Guida del porto di Genova-Pagano.1954-pag.732
-AA.VV.-Il
mutuo soccorso-Ist.Mazziniano.1999-pagg. 311-314
-AA.VV.-La
consulta dei mercanti genovesi-Camera di Comm.1928-pg.98
-AA.VV.-Scultura
a Genova e n Liguria-CARIGE-vol.II-pag.411
-AA.VV.Annuario-guida
dell’archidiocesi-ed/94-pag.381-ed./02-pag.419
-Bottaro
M.-Festa di fine secolo-Pirella.1989-pag.42
-Bottaro.Paternostro-Storia
del teatro a Ge.-Esagraph.82-vol.I-pag.165nota
13
-Bulferetti&Costantini-Industria
e commercio in Li.-BCI.1966-pag.511
-Ciliento
B.-Gli scozzesi in piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.72
-DeLandolina
GC– Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.29
-Del
Monte G,.l’industria siderurgica in Li.-La Casana 1/63-pag. 3
-Doria
G.-Investimenti e sviluppo ecom. a Ge.-Giuffrè.1969- vol.I-pag 375
-idem
-idem- -idem- vol.II-p.713.748.770
-Doria
M.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-pag.81
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.26
-Falcone
G.-Annuario della Prov.di Ge.1869/70-Ferrando 1870-pag.268
-Gazzettino
SPdArenese: 1/80.3 + 9/80.7 + 1/90.6 + 8/91.13
-Gazzo
E.-I 100 anni dell’Ansaldo- Ansaldo.1953-pag. 44carta intestata.77.188
-Genova
Rivista municipale: ottobre/38. +
-Giotoni&Balletti-Genova
territorio e società-DeFerrari.2002-pag.239.241
-Google-Balleydier-
-Il
Secolo XIX 18.9.01pag.25 + 23.03.00 + 03.04.04 + 9.9.04 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.11
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-Centro Civico SPdA.1986-pag.61
-Miscio
A-La seconda Valdocco.-Elledici.2002- vol.I-pag.137
-Miscosi
G.-Osservazioni e ricordi della vecchia Ge.-Tolozzi 1969-pag.6
-Novella
P.Le strade di Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.16
-Pagano/33.pag.244-
Pagano/1961 pag.73.tav.142
-PastorinoVigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.1985-pag.98
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.52
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.96.187
-Rebagliati,Siri,Dell’Amico-I
120 anni della linea ferrov.-Alzani.’94-p.21
-Revelli
P.-per la corologia storica della Liguria-SocLiStPatr.1948-pag.128
-Stradario
del Comune di Genova edito 1953-pag. 17 (scrive Ballaydier)
-Tuvo
T.Sampierdarena come eravamo-Mondani.1983-pag.251
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.196.214
non citati da
-AA.VV.-Oltre un secolo di
Liguria
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Piastra-Dizionario biografico
dei Liguri
-



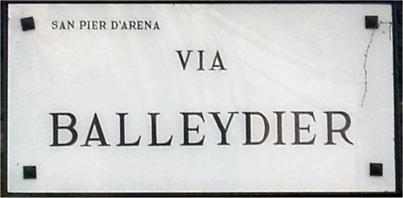




 immagine tratta dal Pagano del 1961
immagine tratta dal Pagano del 1961
 in azzurro via Demarini; in giallo
via P.Chiesa; in verde via Balleydier. Il grosso edificio a destra è la Nuova
Darsena eretta negli anni 1980. Da Google Hearth-2007.
in azzurro via Demarini; in giallo
via P.Chiesa; in verde via Balleydier. Il grosso edificio a destra è la Nuova
Darsena eretta negli anni 1980. Da Google Hearth-2007. 




 carta intestata dell’opificio
data 1895
carta intestata dell’opificio
data 1895 

 1976
1976



















