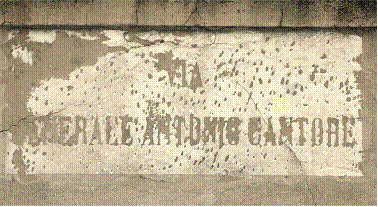CAIROLI via Adelaide Cairoli
TARGA: via - Adelaide Cairoli --- strada privata


QUARTIERE ANTICO: Mercato
 da MVinzoni, 1757. In fucsia, antico e moderno inizio di
salita Belvedere; rosso, ipotetico tracciato di via A.Cantore; celeste corso
AMartinetti
da MVinzoni, 1757. In fucsia, antico e moderno inizio di
salita Belvedere; rosso, ipotetico tracciato di via A.Cantore; celeste corso
AMartinetti
N° IMMATRICOLAZIONE: 2737
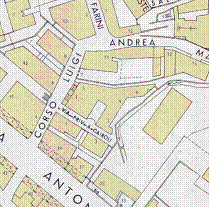

Da Annuario pagano 1961 Da Google Earth.2007 in rosso, via A.Cantore;
giallo corso L. Martinetti; fucsia via N.Ronco.
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 09880
UNITÀ URBANIST ICA: 27 BELVEDERE
CAP: 16149
PARROCCHIA: NS del ss.Sacramento (nel ’61 era di S.M.della Cella)
STORIA: nello stradario comunale del 1910, essa appare già così intestata: ‘da corso dei Colli verso la proprietà Moro’ (non e chiaro chi era questo Moro: se il solito dell’olio o altri; se occupante l’officina che è ospitata nel fondo interposta con corso Martinetti o se proprietario dei terreni ove furono costruiti i palazzi popolari tipici degli anni seconda metà ottocento); il Novella (1900-30) la cita distaccantesi da corso Dante Alighieri.
Nel 1927 era classificata di 5° categoria, ed eguale nel 1933; nel 1950 era migliorata alla 3.a categoria.
STRUTTURA:
Strada che si apre verso levante, all’inizio di corso L.Martinetti; ed in fondo è chiusa.
Lo spazio stradale, delimitato dai palazzi ai due lati, è diviso a metà da un muretto longitudinale. La nostra strada, privata, è la metà a monte che poi curva a 90° per terminare in uno micro-slargo nel retro del grosso palazzo ove si aprono i tre portoni.
La metà a mare, che sfocia in fondo in via N.Ronco, fa parte di corso Martinetti che ha i suoi primi due civici neri dispari in questa rientranza stradale. Il muretto serve a delimitare la proprietà privata da quella comunale; le due procedono verso est gradatamente sempre più slivellandosi in due diversi piani stradali
Consentito il traffico veicolare in doppio senso ma, per ristrettezza, è unitransitabile.
CIVICI
2007= NERI =dal 2 al 6
ROSSI = dal 6r al 30r (mancano dal 2 e 4)
Dal Pagano/1921 al civ. 8-10 (rossi), in angolo con corso dei Colli, inizia la presenza della filiale locale delle acciaierie Poldi, diretta dall’ing. Pizzigoni P.; /1925-33 la stessa, ma al civ. 10-12r, diventa ‘soc.an. ing. Pizzigoni P. interessata all’acciaio Poldi’ (la via principale allora si chiamava corso D. Alighieri).
Nell’ultima data c’era anche la fabbrica di mobili in legno (venduti in via della Cella) di Ambrosini Annibale
Nel 1940 è citata da corso dei Colli con tre civici rossi, 8r=un falegname (Lombardi GB); e 10r, 20r due maglierie.
Civici neri sino al 6. Sino al 1960 esisteva anche un civ.1 nero (assegnato ad una nuova costruzione nel 1949) che in una sistemazione della numerazione divenne in quella data il civ.35A di via A.Cantore.
Nel 2002, attualmente, c’è civico rosso solo il 10r: una bottiglieria e deposito di vino piemontese, gestita da Morino Stefano e figli. Gli altri sono box privati.
DEDICATA :
 Adelaide assieme a Benedetto, Giovanni ed Enrico.
Adelaide assieme a Benedetto, Giovanni ed Enrico.
Milanese, nata il 5 marzo 1806, figlia del conte Benedetto Bono (ricco avvocato nominato nobile e prefetto a Milano durante l’impero napoleonico, deceduto precocemente). Visse con la sorella e la madre a Belgirate sul lago Maggiore ricevendo una educazione rigida e patriottica, sino all’idea del possibile sacrificio personale per queste idee. Ammiratrice di Napolone e i Eugenio Beauharnais nonché fervente antiaustriaca. Collaborò poi con i carbonari aiuando i latori di missive e propaganda e distyribuendo lei stessa opuscoli pro-liberazione. Appena sedicenne ebbe l’avventura di disarmare con un candeliere un servitore ubriaco, che minacciava con un’arma da fuoco la madre indifesa, dimostrando fermezza e temperamento; epperò scioccata dal fatto, fu curata dal clinico Carlo Cairoli docente di chirurgia ostetrica a Pavia, proprietario di alcuni poderi in Lomellina, vedovo con due figli. Tra i due nacque una seria passione, malgrado la differenza di età: si sposarono (lei diciottenne, lui quarantasettenne) nell’apr.1824.
Divenne madre di 8 figli (5 maschi: Benedetto (nato 1825), Ernesto (nato 1832 cadde per primo, nel 1859 con i Cacciatori delle Alpi a Varese, colpito al petto da un colpo di fucile, dopo aver ferito a morte con baionetta un tamburino nemico. Malgrado la forza d’animo, la fede cattolica –per lei era una Santa causa- e l’impegno pericoloso ed attivo, l’impatto con questa realtà fu un fortissimo trauma psicologico. Le scrisse Garibaldi direttamente, ponendo le basi per l’ode che poi elaborerà per lei), Luigi (nato1838, morì di tifo a Napoli –Riccardi scrive a Cosenza- mentre nel 1860 risaliva la penisola con i Mille), Enrico (nato 1840, studente di medicina, morì contro i pontifici a villa Glori il 23 ott. 1867), Giovanni (1842, morì a Pavia nel 1869 dopo lunghe sofferenze durate due anni, di ferite riportate a fianco del fratello, a villa Glori); e tre femmine Rachele (morta trentenne di parto prima del 1970), Emilia (deceduta anche lei precocemente a 29 anni, nel 1856), Carolina (quest’ ultima morta in fasce) ai quali riversò l’educazione di grande amore verso la patria (a quei tempi non ancora unita): Garibaldi accettò da lei un proclama alle donne sicule, stilato il 9 ago.1860, chiamandola ‘reincarnazione di una antica matrona romana’. Pastorino scrive che lei stessa portò i figli ad arruolarsi volontari sia nel 1848 (prima guerra di Indipendenza), che nel 1859 (nei Cacciatori delle Alpi)
In fiorente gioventù, quattro dei figli su cinque seppero morire con comportamento eroico in combattimento nelle battaglie del Risorgimento
Il marito (morto poi nel 1849), ed il figlio primogenito, furono ambedue fortemente attivi ed anche loro combattenti nella lotta armata risorgimentale. Occuparono poi, in virtù dell’eroismo, posizioni di alto prestigio e responsabilità nel governo nazionale (Benedetto combatté nella prima guerra di Indipendenza nelle file dei volontari pavesi (1848); poi partecipò ai moti mazziniani del 1853 a Milano dovendo fuggire in Svizzera; con i Mille fu da Marsala, a Palermo dove rimase ferito ad una gamba, fino a Napoli , dove poi il 17 nov.1878 fece scudo al re Umberto I col proprio corpo impedendo all’attentatore Passanante di pugnalare il sovrano, e rimanendo ferito ad una coscia. Divenuto Primo Ministro del regno nel 1878 e dal ’79-81. Morì nel 1889 unico sopravissuto alla madre).
Adelaide Cairoli si spense a Pavia il 27 mar.1871, nella sua casa ove si era sposata .
Nell’anno 1952 è stato pubblicato un suo ricco epistolario con i figli; in esso si scopre l’alto ed equivalente valore che ella dava alla famiglia ed alla patria.
Ode scritta da Garibaldi ad Adelaide
« Sei mesta tu! Perché sei mesta, o Donna,
sublime esempio delle madri? A Italia,
pascolo infausto delle arpie, il tuo
astro risplende qual brillante faro
al tempestato navigante. E forse
senza di te, credi che la speranza
santa d’esser redenta, a questa patria
darebber le livree, i corruttori
sacerdoti del ventre? La celeste
alza tua fronte, ed ai tuoi piè contempla
queste turbe ingannate! Esse dal tuo
labbro di miele e di virtude un cenno
speran del Vero, i farisei del tempio
e del seggio a travolger nella melma.
Quattro ti orbaron figli! Oh! Dio che figli
ti fregiavan Madonna E tu perduti
credi di averli? Dello schiavo il pianto
dunque non giunse al santuario santo
ove inchianata ti addolori? E quello
cambio non fu della materia? Quello
che morte chiama la volgar gentaglia?
Chi, se non lor sulla venduta serva
d’estranei servi torreggian, fregiati
dall’aureola del martirio, in fronte
della schiera di prodi, per cui rosse
son l’italiche zolle? Accovacciati
invan nel fango si ravvolgon lordi
questi nuovi giudei, urlando: «manna»!
Ma quando il nome dei Cairoli rombi
tra queste vili turbe, insofferenti
le vedrem di servaggio, e in un travolti
impostori e tiranni.
A lungo schiave
regger non ponno le ingannate genti
su questa terra, ove s’innalza, sacro,
il mausoleo di Groppello e dove
inginocchiati – simulacro eterno
delle italiche glorie – impareranno
da te i venturi a non soffrir predoni».
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Com. Toponom. scheda 685
-AA.VV.Annuario-guida archidiocesi-ed./94-pag.388---ed./02-pag.425
-DeLandolina GC– Sampierdarena - Rinascenza.1922- pag. 34
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-‘Genova’ Rivista del Comune : 4/52.40
-Lamponi M.- Sampierdarena- Libro Più.2002. pag. 174
-Morabito.Costa-Universo della solidarietà-Priamari.1995-pg.476 (Rivarolo)
-Novella P:-Strade di Genova-Manoscr.Bibl.Berio.1900-30-pag. 16
-Pagano annuario/33-pag.245---ed/40-pag.224---ed./61-pag.112
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.1985-p.265
-Storia Illustrata – Mondadori - n° 165/1971-pag.12 foto
CAIROLI via Benedetto Cairoli
Il nome fu proposto nel 1901 per la strada che attualmente è ‘via san Giovanni Bosco’; accettato dalla giunta municipale, rimase in atto o in sospeso fino al 1906 quando fu deciso trasferire la titolazione al fondatore del complesso salesiano (non ancora santo).
Questa scelta - anche se mai scritto in nessuna relazione – forse avvenne perché don Bosco era favorito; sia in quanto già il tracciato era popolarmente chiamato “la strada dei preti”; ma sia soprattutto dopo un reciproco scambio di appezzamenti terrieri Comune-Salesiani, utili ad entrambi: in particolare, lungo la strada ed al fine di poterla allargare ad oltre otto metri, fu ceduta una lunga striscia di terreno già giardino della villa Bianca divenuta salesiana; in cambio i sacerdoti ebbero la possibilità di inglobare un equivalente terreno costituito da una stradina che da via A.Saffi saliva verso est, ovvero verso Belvedere, ma tagliando a metà la loro proprietà.
Già questa titolazione appariva a Voltri ed a Prà.
BIBLIOGRAFIA
Archivio Storico Comunale.
CALATAFIMI via Calatafimi
Non più a Sampierdarena, ma in zona Castelletto.
Corrisponde all’attuale via C.Orgero.
Nell’anno 1900 fu proposto alla Giunta municipale questo nome, per il ”vicolo a notte di via Polcevera (via G.Tavani), detto Daste”.
Nel Pagano/1908 (scritto: vico) compare al civ. 8, l’officina di costruzione meccanica di precisione ed incisori di metallo, nonché fabbrica di viti a metallo e rubinetteria, di Clavenna Enrico e Genta. Ancora nel Pagano/1911 e 12 tel.4323, ma dove Genta diventa Genco. Dal 1919 al 1925, c’è solo Clavenna Enrico al civ. 4 sempre come officina e fabbrica di viti e di bolloni torniti di ottone, tel. 41-130)
Nel 1910 è descritto “vico, da via G.Tavani verso nord, a fianco della ferrovia” e già con civv. solo dispari, fino all’11.
Per il Novella la strada era ‘da via Umberto I’ (via W.Fillak) ma l’indicazione non appare esatta perché coesistendo nei suoi indici già via G.Tavani e via Varese, era da esse che iniziava e concludeva (confermato su Pagano/61).
Il Pagano 1925 segnala in più al civ.10 la fabbrica di cordame di crine di Morando Vittoria
Nel 1927 era ancora ‘vico’, e risulta fosse di 5° categoria.
Per l’ufficio toponomastica, il percorso era delimitato: da via G.Tavani a via Bezzecca.
Nel Pagano/1933 è sempre di 5ª categoria e viene delimitata da via G.Tavani e via Varese, con civici neri solo dispari fino all’11.
Compaiono al n° 11 l’officina i Vignolo & Boccardo; al 16 una fabbrica di cordami di crine di Morando Vittoria, e non specificato dove, la fabbrica di acque gassate di Bacigalupo Tomaso
Con decreto del podestà del 19 ago.1935 la titolazione venne soppressa e variata, dedicandola al pittore.
DEDICATA al ricordo dell’omonima località di battaglia, vicino a Trapani del 15 magg.1860. Sbarcati a Marsala, dopo Salemi ove Garibaldi assunse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele II, i garibaldini ebbero qui la prima grande battaglia e la prima vittoria.
I Mille si scontrarono violentemente contro il doppio di soldati dell’esercito borbonico: l’ 8° battaglione guidato dal generale Landi, è asseragliato sulla cima del colle, detto ‘del Pianto dei Romani’, ove anche è il paese. La disputa fu inizialmente assai incerta cercando di studiarsi reciprocamente ma contando i borbonici sul numero (famosa la frase di Garibaldi quando l’esito della battaglia sembrava volgere al peggio «qui si vince o si muore»).
Solo alla sera, i borboni tentarono un attacco in massa; ma, progredendo ravvicinati, furono falcidiati dai Carabinieri e costretti alla fuga. Inseguendoli, si raggiunse la vittoria finale dei garibaldini lanciati all’assalto con la baionetta obbligando il nemico a continuare la fuga.
Così conquistata la città e con il morale alle stelle, si posero le basi per consolidare il successo di tutta la campagna.
Si coprirono di gloria i 43 Carabinieri genovesi - pressoché tutti sotto i trent’anni - comandati da Antonio Mosto, seguito da F.Bartolomeo Savi luogotenente, Antonio Burlando e Stefano Canzio sergenti, Stefano Cervetti e Giuseppe Sartorio caporali – tra essi, possessori di una carabina, anche un veneziano, quattro piemontesi, un palermitano e due lombardi - posti alla testa delle 8 compagnie dei Cacciatori delle Alpi.
Da quel giorno, scrive Abba, essere carabiniere fu titolo d’onore.
182 furono i garibaldini feriti (10 carabinieri); 31 i morti (tra i quali 5 carabinieri: l’avv.Luigi Sartorio (un causidico che aveva lasciato udienze e tribunali, per seguire i garibaldini di Mosto e che fu il primo a cadere nella battaglia); Profumo, Fasce, Casaccia, Belleno Giuseppe (Vigliero dice Bellesio; facoltoso mercante, appartenente ai carabinieri genovesi. E quattro i liguri della truppa: Simone Schiaffino (25enne camogliese che difese con la vita la bandiera donata dagli italiani di Valparaiso ed ora custodita per l’appunto a Camogli); Boggiano, Montaldo, Romanelli.
Nei pressi della città, fu eretto un ossario, monumento a ricordo della battaglia.
Abbastanza famosi nella anedottica risorgimentale, sia un raccontino di Abba, di quando giunse al paese accolto dal popolo festante; e sia la poesia di ASNovaro.
BIBLIOGRAFIA
-Aimonetto L.-Il Risorgimento-Lattes 1958-pag. 182.188.
-Archivio Storico Comunale
-Archivio S. Com. Toponomastica . scheda 694 +
-DeLandolina GC – Sampierdarena- Rinascenza. 1922- pag. 34
-Enciclopedia Sonzogno
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio-1900-30-pag.17
-Pagano/1908 – pag. 873-9---/33-pag.245
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.85-pag.269.
-Pescio A.-Giorni e figure-LEM.1923-pag217
-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.63
CAMBIASA strada Cambiasa
(o dei Cambiaggi, o Cambiaggia)
Nella carta del Vinzoni 1757 appaiono due tracciati: uno di una strada diritta, la quale passava tra il torrente ed i terreni appartenenti ai Crosa (dalla Marina sino al ponte) ed ai Grondona (dalla strada provinciale sino a san Martino); e un secondo, di una strada fatta come a scalini (che poi sarà chianata ‘strada al Ponte di Cornigliano’).
Fu nel 1770 che il doge G.B. Cambiaso volle lungo la riva del torrente ‘la strada del Polcevera’ detta poi ‘strada Cambiaggia’, per arrivare alle sue terre oltre Bolzaneto; pagando personalmente la cifra necessaria (oltre 5 milioni).
G.B. Cambiaso era nato nel 1711 da Giò Maria q.Giò.Batta e da Caterina Roncalli; ebbe un fratello Nicolò Maria –che avrà in discendenza5 figli - ed una sorella Antonia M.Teresa monaca; coniugato con Tomasina Balbi; morì il 23 dicembre 1772).
In pratica ricalca le attuali via Pacinotti, Spataro, Fillak.
Nella primavera del 1773, Giacomo Agostino Brusco (savonese, 1736-Genova1817 , ingegnere militare specializzato in progettazioni stradali: aveva già studiato in proprio, esponendolo in 36 tavole rilegate in volume in possesso alla biblioteca Berio; un progetto di ‘rendere carrozzabile la strada tra Voltri e Savona’) venne incaricato di ‘levare il piano’ di una strada che percorresse tutta la val Polcevera dalla marina fino a Campomorone; nell’impegno era compreso la costruzione di un molo di contenimento del torrente e della strada nel tratto tra Teglia e Rivarolo superiore (progetto che elaborò assieme all’arch. Gaetanpo Cantone, suo collaboratore anche in altre opere pubbliche).
Dalla relazione del 1821 si dedurrebbe che l’inizio della strada era su terreni di proprietà del Doge, ma non si capisce le parole ‘da tempo immemorabile’ quando dal 1770 sarebbero al massimo cinquant’anni.
In questa relazione, viene ufficialmente comunicato al Comune la richiesta di chiusura della strada che dal Ponte di Cornigliano conduce a san Martino, chiesta dai signori Cambiaggi, proprietari. Il Consiglio ribatte che ‘primieramente’ il Comune ha sempe avuto da tempo immemorabile, in mezzo agli orti dei signori Cambiaggi, il libero passaggio, per trasferirsi alla parrocchia di san Martino, e coll’andar del tempo detti signori per togliersi questa servitù fecero aprire, a loro spese e a comodo di questa Comunità, un’altra strada lungo un molo verso la ghiaia della Polcevera in rimpiazzo della prima strada appropriatasi, e questo per comodo dei predetti, che si conservarono gli orti attigui a detta strada. ---omissis—Il consiglio quindi chiede all’Intendente Generale di Genova che non si chiuda la strada”.
La presa di possesso dei Savoia, dopo le migliorie apportate – considerato che arrivava a Torino - le fece cambiare nome in ‘strada Reale a Torino’
BIBLIOGRAFIA
-Quaini M. & Rossi L.-i cartografi in Liguria-Brigati.2007-pag.95
-Remedi A-Gazzettino Sampierdarenese-2/08-pag.19
-TuvoT-Memorie storiche di
SanPierd’Arena-dattiloscr.inedito-pag.95
CAMIONALE piazzale della Camionale
TARGA : piazzale – della - Camionale


QUARTIERE ANTICO: Coscia
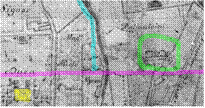 da MVinzoni, 1757. Ipotetica zona del piazzale, con in
fucsia tracciato di via A.Cantore; gialla, villa Spinola
da MVinzoni, 1757. Ipotetica zona del piazzale, con in
fucsia tracciato di via A.Cantore; gialla, villa Spinola
N° IMMATRICOLAZIONE: 2738
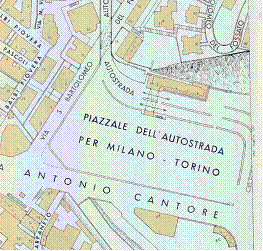
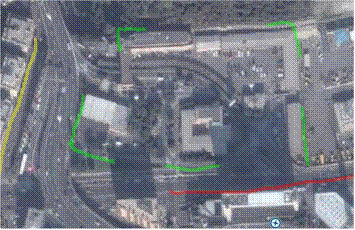
da Pagano/1961 Da Google Earth.2007
in rosso via A.Cantore; giallo via s.B.d.Fossato.
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 10300
UNITÀ URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie
STRUTTURA: da via A.Cantore, all’ingresso dell’ autostrada Genova-Milano (inizialmente chiamata Genova-valle del Po).
Nel 1975 furono erette alcune nuove costruzioni che ebbero i civv. 3, 6 e 7. Nella sistemazione numerica, venne assegnato il 4 e poi, nel 1990, anche l’1.
È servito dall’acquedotto Nicolay
CIVICI
2007=neri = da 1 a 7 (manca 5)
da 2 a 6
===Civ. 2 : la sede della Direzione del 1° tronco dell’azienda Autostrade
area militare (della Polizia di Stato-Autostrade).
STORIA:
Oggi si chiama A7, Milano - Genova.
Nacque nell’ambito sia di una necessità internazionale di aumentare le reti stradali (nel 1931 era avvenuto a Monaco il “VII congresso internazionale della Strada”, dove l’Azienda Autonoma Statale della Strada italiana , nella sua relazione vantava 20mila km di strade nazionali e la realizzazione, per primi in campo internazionale, di costruzione di una autostrada ideata dall’ing Puricelli nel tratto Milano-Laghi); sia dei grossi giochi di interessi tra ministeri statali e finanziatori in cui erano di fronte la amministrazione ferroviaria (che vantava arrivare sempre in perfetto orario! ed essere vastamente rappresentata sul territorio ed a tariffe fissate dal governo; ma non offriva la capillarità del servizio); e sia di una fiorente e sempre più in sviluppo industria di autoveicoli, con la FIAT in prima linea (apparentemente sempre più competitiva delle ferrovie sia per la capillarità che per il prezzo specie da quando la scoperta del diesel permise un notevole risparmio nell’uso del combustibile).
Fu fatta la scelta a favore del trasporto su strada, concependo l’idea di potenziare la rete stradale. Sino allora, per la Liguria il traffico su autoveicoli a quei tempi usufruiva solo, e con non poche difficoltà, della strada statale dei Giovi iniziata da Napoleone nel 1810 ed aperta al traffico nel 1821. È statistica dell’ anno ‘33, il passaggio giornaliero per il passo dei Giovi (posto a 472 m.slm.; a quei tempi con dislivelli del 9% , larghezza 6 m., curve con raggio 14 m., ma soprattutto con metà percorso praticamente all’interno di abitati), di 570 autocarri (367 con rimorchio), 582 autovetture e 90 motocicli (nel ‘28 erano stati rispettivamente 105 (42), 204 e 35).
Era storia antica, aver già cercato dal febbraio 1900, e poi in altre occasioni attraverso le vie parlamentari, di aprire il cosiddetto “quarto varco” (dopo le due tratte ferroviarie e la strada dei Giovi), sempre naufragato per inerzia, per guerra, per problemi economici, impatto ambientale, usanze (soprattutto la ancora, vastamente in atto, trazione animale; al massimo l’esistenza della linea ferroviaria ma valida solo per le lunghe distanze). Così, negli anni ’20, l’ing. Puricelli Piero aveva studiato una specifica strada per veicoli (perciò battezzata ‘auto-camionale’).
Negli anni immediatamente a seguire, il regime aprirà altre autostrade (e non tutte completamente finanziate dallo Stato; ricordiamo la Milano-Laghi nel 1925, e la Milano-Bergamo nel 1927, e subito dopo la Milano-Torino, la Firenze-Viareggio, la Roma-Ostia, la Napoli-Pompei tutte ad uso prevalente automobilistico.
Sul SecoloXIX, Dossena precisa che il Duce aveva scritto il 10.2.32 al prefetto di Genova, esprimendo il suo parere - considerando che qualsiasi sua riflessione ‘doveva immancabilmente coincidere con quanto riflettevano gli italiani’ - (ma forse era vero la richiesta del contrario!), circa la opportunità di preferire una autostrada ad una direttissima ferroviaria; chiudendo la lettera con un ‘mi riferisca’. Alla lettera seguì la presentazione di una decina di progetti ed immediata la scelta.
Così, col beneplacito di Mussolini si diede il via nel febb.1932 al progetto di una autocamionale da Genova a Serravalle, totalmente finanziato dallo Stato: 175milioni di lire, pari a 3,5 milioni/km (quando altre in pianura erano costate 1,1=Mi-Bg; e 2 la Napoli-Pompei (il duce Mussolini, aveva inizialmente voluto chiamare ‘autocamionabile’ l’autostrada Genova-Milano, per sottolineare il fine a cui era particolarmente destinata; il decreto di questi lavori dichiarati di pubblica utilità, firmato a san Rossore il 18 giugno 1932 (anno X), fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno il 4 luglio; ‘a spese dei Lavori Pubblici salvo contributi della città di Genova’. Per il progetto fu istituito uno speciale ufficio del Genio Civile, supportato dalle migliori forze intellettuali: era in moda la corrente culturale del futurismo, e la velocità acquisiva il ruolo determinante e tangibile della volontà di progredire in senso economico e sociale).
Caratteristica innovativa fu che essa era la prima strada che attraversava gli appennini in gallerie, rompendo l’isolamento di Genova. Ma anche a livello internazionale, perché dovevano essere: 50 km di strada a carreggiata nei due sensi, senza interruzioni con le arterie stradali comuni; in forma continua e col tracciato più breve compatibile col terreno; con uscita ed entrata presso alcuni paesi; spartitraffico continuo (solo in alcuni punti diritti, poteva esistere una terza corsia centrale unica per il sorpasso, ma per ambedue i sensi); pendenza non superiore al 4%; curve con raggio non inferiore a 100 m.; larghezza 10 m di cui 9 pavimentati per tre piste di cui una centrale per il sorpasso; limiti di velocità idonei allo scorrere veloce dei veicoli; rettifili pari a 29km sui 50 in totale; massima altezza quota 413 slm; 11 gallerie (la più lunga era quella dei ‘Giovi’, in uso ancora attuale nell’andare verso Milano (progettata di 892m. fu allora chiamata ‘Littorio’; la seconda, di Campora, allora chiamata XXVIII ottobre, di 507m); oggi è di 902 m. di lunghezza e 9 di altezza; fu aperta a minore altezza (59m. essendo a quota 413m. slm) rispetto il passo omonimo della strada statale), 28 viadotti (il Montanesi è lungo 273m ed alto 46), 12 cavalcavia; 112 sottopassaggi compreso le rampe di accesso.
Tutto, oltreché funzionale, doveva essere anche bello ed esteticamente di rilievo, un’opera che doveva dare lustro al regime: l’ingresso delle gallerie, i muri bugnati con squadratura esagonale,decorazioni a suon di fasci littori realizzati in marmo verde di Pietralavezzara; le pietre venivano lavate prima di essere posizionate.
.
Storia. Il 21 apr.1932 (natale di Roma) il ministro dei LL.PP. e funzionari regionali studiarono i preliminari e appaltarono i progetti diretti dall’ing. Giovanni Pini (compresi gli espropri dettati obbligatori per pubblica utilità; i capitolati d’appalto e bandire la gara); il 18 giugno venne la regia autorizzazione previo decreto n° 757; nel settembre viene approvato il progetto definitivo, e - con una rapidità senza precedenti - il 6 ottobre si diede il via ai lavori, con un primo stanziamento di 110 milioni.
Con epicentro a Busalla, furono reclutati 26.882 operai (scalpellini, muratori, carpentieri, minatori, genieri, ecc. ; per le 550mila giornate lavorative necessarie, furono accasati in quindici diverse ‘cascine’; costavano 4,50 lire cadauno di vitto ‘sano ed abbondante’ più £ 1,42 all’ora per un manovale=a £.12,75 essendo la giornata lavorativa di nove ore; di essi 10500 genovesi, 3631 alessandrini, 2189 bellunesi, 784 udinesi, 1725 carraresi, 1533 bresciani, 2184 bergamaschi, 620 trevigiani, 240 vicentini, 197 lucchesi, 3279 da altre provenienze; non utilizzati tutti assieme in continuità, ma a gruppi secondo i vari settori). Il serpentone, fu diviso in 22 lotti, con un massimo d’insieme di 8264 uomini; e fu dato in appalto a 28 imprese –delle quali 16 per i lavori stradali e 12 per illuminazioni ed impianti. Furono usati 124.800 kg di dinamite. A fine, furono adottate come ‘case cantoniere’ cinque edifici, tinti del caratteristico ‘rosso pompeiano’ tanto caro all’ideologia dell’epoca.
I primi due cantieri, iniziarono nel secondo semestre del ‘32; furono per il tratto da Busalla a Genova e da Pietrabissara a Serravalle, per poter spostare la mano d’opera man mano che la strada si completava.
Il tutto comportò un notevole beneficio economico e demografico per tutti i paesi del percorso. Fu vanto anche essere riusciti a traccialo, intrecciandosi ripetutamente con la ferrovia e la statale, attraversando aree abitate e torrenti. Fu chiamata “autocamionale Genova-Valle del Po” o “camionale dei Giovi”, per l’indicazione ed indirizzo prevalente al traffico pesante e di merci, tramite camion da trasporto a nafta, atti a fornire un più rapido smaltimento delle derrate da e per l’entroterra lombardo-piemontese ove poter raggiungere mète sempre più capillari.
Una migliorata funzione del porto in genere e l’apertura di nuovi accosti nel ponente, assunsero particolare rilievo nel decidere l’apertura del tracciato.
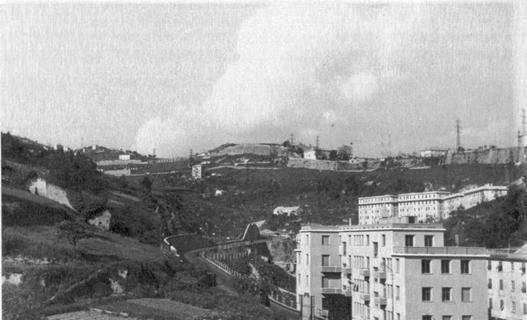
il primo tracciato, nell’aprile del 1937
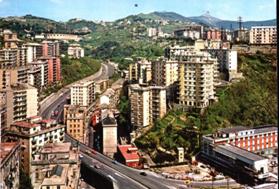

Piazzale. Una volta deciso l’incremento del trasporto su gomma, nacque la necessità di organizzare aree e viabilità idonee a raccogliere e smistare le merci verso questo nuovo canale; e questa esigenza si sommò al progettato sbancamento del colle per aprire la comunicazione tra Genova ed il ponente : divenne unico interesse realizzare un vasto splateamento del colle (già iniziato nel 1927), ed aprire la strada ed il piazzale d’ingresso.


1933
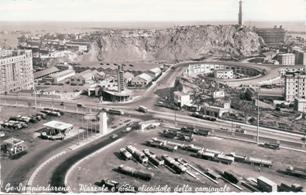
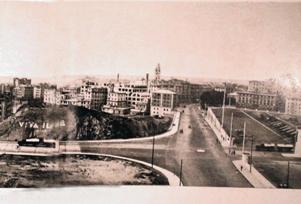
Questo, all’inizio, si apriva solo verso nord al viadotto iniziato, ed a mare con un tratto in discesa che lo collegava con via Milano, ed a cui fu dato il nome di via Carducci. Vasto oltre 5 ettari (440x117 m), fu inizialmente destinato agli uffici ed al parcheggio e servizi dei mezzi pesanti; per realizzarlo dovettero prima demolire le grandi caserme che coronavano il colle in quel tratto (che aveva anche il pregio di essere molto panoramico) e poi eliminare la naturale barriera del colle, che fu aggredita con una cava sia sul versante San Pier d’Arena che Genova dopo averle messe dapprima in comunicazione con una galleria di 196 m., poi scomparsa con la progressiva caduta del diaframma (ad occidente il colle era formato da schisti a contatto con calcari, mescolati, sconvolti e degradati nella zona di impatto orogenetico; e quindi di più facile scavo con gli escavator. Dall’altra parte la roccia era di calcari alberesi compatti, che richiesero l’uso di mine giganti, fino a 2300 kg di dinamite).
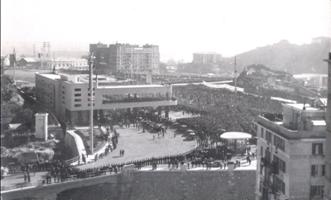
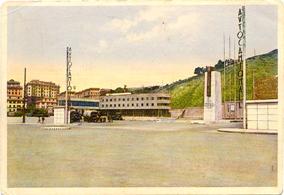
La scarpata a monte e sovrastante il piazzale, nella parte del terreno schistoso, è alta 70m ed è sostenuta da uno spesso muro di cemento armato lungo 150 m. a larghe maglie (l’8 maggio 2003 venne inaugurata dall’assessore comunale alle politiche culturali Bruno Gabrielli, una serie di pitture ‘acrobatiche’ dipinte tra le rocce nell’interno dei vari riquadri, opere di Mario Nebiolo, sponsorizzato dal Comune e dalla soc. Unimar. Questi, arrampicatosi sulla parete ed utilizzando rilievi e scanalature naturali delle rocce dipinse figure umane nell’atto dell’arrampicata a significato di ascesa e desiderio di superamento dell’ingabbiatura di cemento. Nel 2010 le figure sono ancora intravisibili.

L’abbattimento di 1.100mila mc di roccia in gran parte calcarea, fu usato per riempire le acque del porto nascente, utilizzando una apposita ferrovia a 2 binari soprapassante le strade Carducci e Milano, e sottopassante i binari delle linee ferroviarie normali; di questi, solo 50mila mc. furono utilizzati per riempire ed allargare la parte ovest del piazzale, rivolta verso via san Bartolomeo.
Fabbricati Fu, allora, preventivato su disegno dell’ing. Calza Bini anche una stazione, lunga 60m e larga 11 m , adatta ad albergo (anche diurno, lavanderia, servizi (bar, giornali, pronto soccorso, posta, rifornimento), 16 camere a due letti; nel 1950 era di quarta categoria e gestito da Gatti Maria), ristorante (che nel 1950 era gestito da Vasco Tabolini) e bar (nel 1950, gestito da di Nosco Alessio). La spesa fu di 15 milioni e 400mila lire.
Nell’area del piazzale, ha sede il centro operativo della Polizia Stradale (Polstrada), con oltre 50 telecamere poste lungo il tragitto nei punti più significativi e delicati, capaci di ingrandire le immagini di guasti, code, incidenti (e rilevare se ci sono feriti: nei primi dieci mesi del 1997 ci furono 41 incidenti mortali e 1547 feriti), fino allo zoom per il ghiaccio o oggetti perduti sull’asfalto.
Dal Piazzale al mare: l’Elicoidale. Fu demolita ampia parte della facciata a ponente del colle di san Benigno (a ragione quindi è limite di confine attuale) e fu innalzato dal CAP un ponte in cemento armato, in elicoidale, che scavalcasse in unica campata alta 13m e con 40m di luce la nuova via di Francia, e sui pilastri laterali la strada, su lesene di pietra rosa di Finalmarina, fu posto come ornamento un gruppo di tre fasci littori: prosegue verso il mare con curvatura di 50m di raggio, a doppia rampa d’accesso-deflusso larghe 18m., utilizzando 5000 mq di area di proprietà del Consorzio (2800 coperta e 2200 scoperta) a cui di dovette un attivo contributo in idee, progetti e finanziamenti.
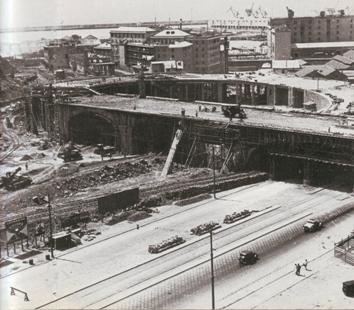
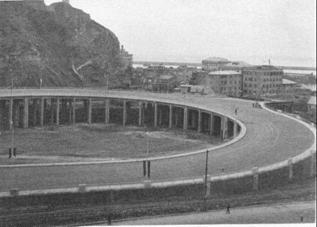
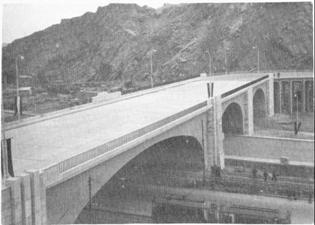
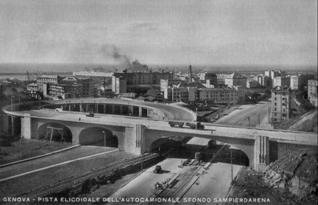
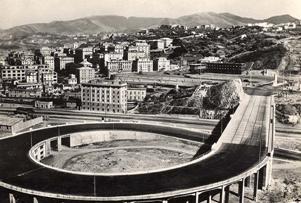
anno 1935

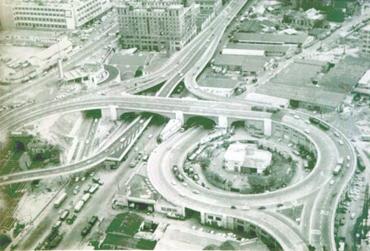
anni 1938 1950
La spesa fu di 10milioni di lire, circa di allora.
Scomparso san Benigno a tagliare il territorio da monte a mare, questa costruzione ebbe peso determinante nel ricreare uno stacco all’assetto della nostra città: ecco questo piccolo mostro contorto che nuovamente ripropone un rilievo, distaccato dal contesto cittadino, separante tutta la zona della Coscia: iniziò così quel processo mentale di ‘non appartenenza’, che poi in seguito si ritorcerà permettendone lo spianamento nell’indifferenza di tutti.
Nella carta allegata al Pagano1940 si rileva che da levante, l’accesso all’elicoidale non avveniva da via di Francia ma dall’attuale via Albertazzi.
Infatti nello stradario il piazzale è raggiungibile da via Milano tramite una apposita strada chiamata “strada accesso Camionale” cha andava “dal Porto (Passonuovo) al piazzale”
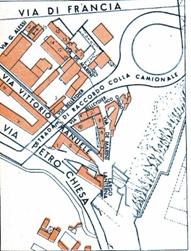
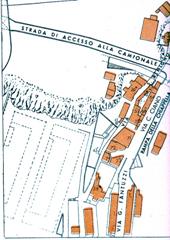 Pagano 1940
Pagano 1940
La parte a levante dell’elicoidale viene considerata il confine nuovo ideale tra Sampierdarena e Genova, corrispondente alla antica ‘facciata’ del colle di san Benigno. Dal 2000, si parla addirittura di abbatterlo col consenso del CAP proprietario dell’area, per aprire a nuove prospettive d’insediamento la zona dell’antica Coscia: i progetti ci sono, ma dal dire al fare…ci sono di mezzo gli euro. (vedi a Passo di Francia). Nel 2000 si parlava aprire nell’area il nuovo mercato del pesce: “lavori urgenti di adeguamento”...”decisa accelerazione”... “entro due anni”; e di nuovo tre anni dopo con lo stesso fine, è stato presentato nuovo progetto da realizzarsi entro il 2005, che prevede anche la eliminazione del ponte sopra via di Francia.


anno 2010 visioni dall’elicoidale: verso ovest e verso nord
Ma a fine 2004, è tutto fermo come prima, escluso le baracche interne all’elicoidale, centrali all’area, incluse come in un grosso anfiteatro in parte sfruttato nelle strutture sottostanti la strada; tutte, nel 2009 appaiono evacuate anche se restano però in piedi lo stesso.
Nell’anfiteatro, per terra, sono incluse delle rotaie rotonde a largo raggio, come se fossero per far girare qualche gigantsca gru, ma della quale non riusciamo a capirne dimensioni ed uso (vedi foto sotto, a destra del piazzale) .

panoramica interno dell’elicoidale anno 2008

Dal Piazzale a monte, il tracciato della camionale scelse il fianco di ponente della valletta di san Bartolomeo: un posto chiamato comunemente “taerapin” dai sovrapposti ripiani a scala, molto favorevoli alle scampagnate domenicali o festivi (25 aprile, 1 maggio, Lunedi di Pasqua, ecc.).
Il primo colpo di piccone d’inizio lavori per la strada, fu dato senza alcuna cerimonia formale, anzi sotto forma prettamente simbolica: a ponente del rio e poco sopra l’abbazia, il mattino del 6 ottobre del 1932 (X dell’era fascista) ad opera del ministro Araldo di Crollalanza si iniziò lo scavo di un solco che diede il via ai lavori, divisi in vari lotti appaltati.
Richiesero tre anni di lavoro, svolto da 30mila operai (dei quali ben 26 morirono in incidenti vari). L’assunzione di così elevato numero di maestranza, fornì al regime anche l’arma politica propagandistica dell’assorbimento della mano d’opera operaia, esclusa da altri settori dell’economia (l’Italia possedeva allora ben 1.129mila disoccupati; una percentuale di analfabeti del 40% ; un calo del consumo annuo procapite di carne e di zucchero). Gli operai, distribuiti in 22 lotti del tracciato, con mezzi meccanici molto rudimentali rispetto gli attuali (perforatrici, scavatrici, martelli pneumatici), costruirono la strada, compresi 11 gallerie e 30 ponti-viadotti.
Dovendomi recare giornalmente ad Alessandria ove svolgevo servizio militare, nel 1964 sino a Serravalle, la strada non era stata ancora duplicata ed era ad unica corsia perm senso di marcia, una in salita ed una in discesa affiancate; ricordo lo sconcerto se, a livello di Bolzaneto avevo davanti un camion con rimorchio: era impossibile sorpassarlo fino oltre la galleria dei Giovi.
Moderna è la barriera anti inquinamento sonoro, posta sulla rampa di accesso nel 1994, costata 3 miliardi e mezzo, costituita di pannelli fono assorbenti ed altri suppletivi inclinati od orizzontali, sempre con identico scopo.
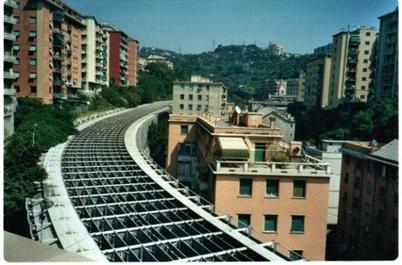

anno 2008
Cerimonia di inaugurazione. Il percorso fu aperto al traffico il 28 ottobre 1935 praticamente in contemporanea con via A.Cantore (la data fu scelta appositamente per corrispondere all’ “alba del XIV anno dell’era fascista”: ognuno era impegnato a salutare l’evento. Così, frenetica fu l’attività per essere in tempo a tutta una serie di inaugurazioni nazionali; grandi come a Firenze ove si inaugurava la stazione ferroviaria di s.M.Novella ed a Roma la città universitaria; più piccole, a Pegli, il raddoppio del binario ferroviario per Voltaggio la passeggiata alle acque solfuree ed una nuova ringhiera di ferro): ad inaugurarlo fu il re Vittorio Emanuele III, arrivato a Serravalle in treno da San Rossore. Partì da Serravalle Scrivia alle ore 8,45 su un’auto scoperta. Con tutto il corteo reale (il cerimoniere fu il conte di sant’Elia), ed i gerarchi fascisti, rappresentanti del contemporaneo governo (il ministro del LL.PP Cobolli Gigli e dal prefetto di Genova s.e.Albini): ad accoglierlo erano le massime autorità militari (il maresciallo Caviglia in alta uniforme comprendente il collare della SS.Annunziata e le insegne dell’ordine militare di Savoia; con i generali Fara, Montuori, Poggi, Bruzzo, Piva, Saibante, Porro, Ragazzoni, e l’ammiraglio Rizzo), civili ( i senatori Reggio, Celesia, Moresco, Pozzo, Bonardi, Cattaneo della Volta, Cogliolo; nonché il primo presidente della Corte d’Appello Bindo Galli, il presidente del tribunale ed l procuratore del re), politiche (il direttorio della federazione fascista al completo, il segretario del GUF dott.Catto, il centurione Carioti capo della segreteria politica, il comandante della milizia DICAT il console Raggio, ed il seniore Passalacqua quale vice segretario federale) e religiose (l’arcivescovo di Genova s.e. Carlo Dalmazio Minoretti, con mons Sanguineti del capitolo metropolitano, mons. Marchesani segretario e mons Incisa cerimoniere). Non mancavano i consoli di tutti i paesi rappresentati a Genova: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Inghilterra, Lettonia, Norvegia, Olanda, Stati Uniti, Svizzera, Uruguai.
Arrivati alle 11,05 al suono di fanfara, ed al grido “viva il re”, al suono delle sirene delle navi e degli stabilimenti, delle campane e del vocio di migliaia di presenti, Vittorio Emanuele III passò in rivista i fanti del 43° e salutò la bandiera; poi - in un silenzio profondo - da un palco toccò un tasto elettrico che scoprì dal tricolore la lapide con i nomi dei 26 operai morti sul lavoro, benedetta poi dall’arcivescovo, alla quale seguì “l’appello”: l’on. Morigi, vice segretario del PNF, chiamò uno ad uno il nome dei caduti, e la folla all’unisono che rispondeva “presente!” (scolpita da Antonio Morera; i morti furono 14 nel 1933, 7 nel 1934, 5 nel 1935; di tutta Italia: Brescia, Como, Bergamo (i più tanti), Belluno, Rovigo, Treviso, Vicenza, Udine, Genova, La Spezia, Milano e Firenze. La lapide, posta su una stele marmorea (leggi sotto) posta all’ingresso della ‘strada autocamionale’.
Si racconta (ma la prima foto sotto, smentisce questa successione dei fatti) che venne rimossa dopo l’ultima guerra nel corso di lavori di ristrutturazione della zona e rimase abbandonata tra i detriti in un angolo del cantiere; e che nel 1993 su iniziativa di un consigliere, fu promesso dalla società Autostrade la rimessa in atto del cippo con lapide. Questo però avvenne subito e, quando fu fatta, in gran silenzio fu posta alla base dello strapiombo, nel fondo del piazzale, fuori vista da tutti forse perché appare contornata dai fasci littorio ed inizia con la scritta “ i lavoratori ai camerati caduti sul lavoro” ed ultimata con la scritta “presente”, ripetuta tre volte.
Nessuno ha mai segnalato l’elenco dei feriti e degli invalidati; si sa che chi lavorò per i tre anni, ebbe la possibilità di guadagnare 10 milioni all’anno dei quali la metà poteva essere inviata alla famiglia lontana).


saluto al Duce; era già a ridosso del muro anno 2008 ; solo spezzata la lama dei fasci
Seguì la visita all’edificio progettato dall’arch. on. Calza Bini, tra l’applauso della folla stipata sul piazzale e sui tetti vicini.
Dopo un discorso di s.e. Cobolli Gigli « Sire, tre anni or sono il Duce ideava l’autocamionale Genova -Valle del Po. Tre anni fa iniziavano i lavori che dovevano rapidamente dotare la Grande Genova, ricca di glorie marinare e fervida di attività commerciali di una nuova arteria che la congiungesse ai principali centri del Piemonte e della lombardia. Nel clima dell’Italia fascista, oggi, gli esecutori hanno la gioia di aver collaborato ad un’opera che unisce al miracolo della rapidità quello della perfezione tecnica . Ed è con sentimento d’orgoglio e di profonda riconoscenza alla Maestà vostra che le maestranze ed i dirigenti hanno avuto la grande soddisfazione di salutare con vivo entusiasmo il Re di Vittorio Veneto sulla nuova via aperta al traffico. L’opera è degna dei tempi nuovi, di quelli di oggi e di quelli che verranno perché essa, come disse il Duce è di “stile romano”. Sia la moderna strada non solo anello indissolubile tra la Grande Genova e l’alta pianura padana, ma tramite per sempre maggiori traffici e più gloriose sorti per questa bella terra ligure che scrisse per l’Italia marinara pagine di gloria e di vittoria. Sire, i dirigenti, le maestranze, il popolo tutto oggi presente, saluta la Maestà Vostra con profondo sentimento di riconoscenza e devozione; Camerati, saluto al Re!»), il re si recò a scoprire la stele posta all’ingresso del piazzale (ancora era lì nel 1975, con la scritta Autostrada in verticale ma alla quale erano cadute delle lettere per cui rimaneva solo: S RAD.

anteguerra
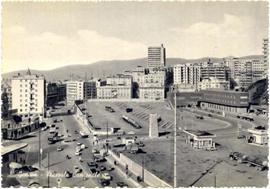

anno 1950 circa anno 1976
Inizialmente alla stele era applicato il monumento eretto per commemorare i lavoratori morti incidentalmente nel lavoro; questa commemorazione fu moncata spezzando la parte più alta e togliendo la lapide perché significative di una mentalità sconfitta) e quindi, il re fu portato in auto verso il porto tramite l’elicoidale e poi al palazzo reale di via Balbi, sempre attraverso due ali ininterrotte di folla applaudente e sventolante bandiere e fazzoletti.
Il giorno appresso avrebbe visitato ed inaugurato le nuove costruzioni in Genova (il palazzo della Questura con la copertura del torrente, corso Italia, le piscine d’Albaro, il padiglione sanatorio Maragliano a san Martino, la casa dello studente). Attraverso corso Giulio Cesare (corso Gastaldi, aperto nel 1933), dalla stazione Brignole rientrò a San Rossore, portandosi in omaggio un bronzo del san Giorgio, riproduzione in piccolo di quello presente della cripta del monumento ai Caduti, ed un album contenente disegni della pittrice Pina Villanis, che illustravano i punti più pittoreschi del percorso svolto (per tale opera, la pittrice fu l’unica donna ammessa ai vari cantieri dall’inizio dei lavori).
Dal Ministero della Cultura Popolare, gli organi di informazione venivano opportunamente invitati a definire l’opera come “... una geniale anticipazione della nostra potenza creatrice, degna dei figli dell’antica Roma !”.
Mussolini era assente, ufficialmente sia perché molto occupato in quanto il 3 ottobre aveva dato il via alla conquista dell’impero invadendo l’Etiopia ed anche per cercare di difendersi dalle ventilate “inique sanzioni”, decretate poi ufficialmente il 18 novembre dalla Società delle Nazioni, per l’aggressione. A voce, si mormorava che non gradiva apparire col re.
Il casello
Il giorno dopo, aperta al traffico normale, la camionale costava come pedaggio anticipato, dalle 4 lire per le vetture, sino a 35 per i grossi veicoli con rimorchio. Tassa che certamente non permetteva coprire le ingenti spese fatte, ma potevano servire per la manutenzione.
Nel dopoguerra fu allargato a più riprese erodendo i fianchi della collina e proteggendo con muraglioni (rifatti) la faciltà di sfaldamento (è la stessa roccia del cimiero sovrastante, che continua a slittare).

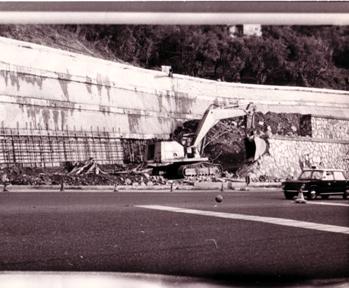
anno 1977
Conclusione dei lavori. Solo con il prolungamento sino a Milano e contemporaneo raddoppio della carreggiata, conclusi nel 1966, si chiamò “autostrada”. Fu data in gestione alla AA.SS (Azienda Autonoma Statale della Strada; che poi diverrà ANAS) sino al 1962. Poi fu data in concessione alla Società Autostrade, con contratto fino all’anno 2018. Oggi, è chiamata “A 7”.
Per il raddoppio si dovette aspettare sino al 1962: iniziarono da Serravalle verso Milano; e tre anni dopo verso Genova, collegandola con la sopraelevata (1965) e la A10 tramite il ponte Morandi sul Polcevera (nato nel 1967).

arrivo a San Pier d’Arena anni 1990
Per allacciarsi all’autostrada dei Fiori, caratteristico fu costruito il viadotto sul Polcevera, iniziato il 1 lug.1961 ed inaugurato il 4 sett.1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Progettato come opera semplice ma stilisticamente e strutturalmente perfetta, tenendo conto dei forti venti e della difficile posizione orografica, dell’impatto ambientale, della ferrovia sottostante, dsu progetto dell’ing. arch. Riccardo Morandi, romano, autore in tutto il mondo di grosse realizzazioni ingegneristiche; ha in Europa il primato nelle realizzazioni in cemento precompresso (secondo al mondo, dopo il ponte sulla laguna di Maracaibo in Venezuela, progettato dallo stesso ingegnere).


1964 inverno – dal Campasso

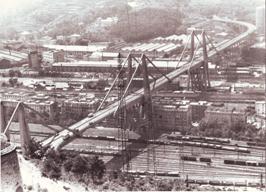
1975

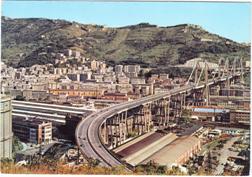
Alto sino a 45 m. dal terreno sottostante (mentre i pilastri si ergono sino a 90 m.); lungo 1102m; largo 18m., a 4 carreggiate; ha tre campate diverse: di 207,88m (la più grande d’Europa), 202,5m, 142,65m.. Nel 1980 furono corrette le prime imperfezioni messe in rilievo dall’architetto progettatore stesso, e fu riverniciato con apposite sostanze atte a proteggere la struttura dai vari insulti; tutto il ponte, compresi i tre enormi doppi tiranti in cemento detti tralli, corrosi dal salino e dall’usura, sono stati negli anni ‘93-7 soggetti a delicato lavoro di ripristino strutturale, coordinato dall’ing. Pisani.
Nel 2003 sono in piena bagarre innumerevoli flash personalizzati: la Soprintendenza presume ci siano i presupposti per dichiarare il ponte manumento nazionale; la Sociatà Autostrade ha classificato il ponte elemento il più pericoloso del paese (il cemento usato, che allora era dato per ‘eterno’, ha dimodstrato non reggere il peso del traffico moderno, con ‘malattie’ che lo rendono in perenne manutenzione; i pompieri giudicano assurdo non aver previsto la corsia di emergenza; il Comune pensa al sottostante territorio da sgomberare per innalzarne un altro cento metri più a nord; si inizia anche a parlare ufficialmente di “gronda” che non interessa direttamente il ponte ma ne coinvolge la circolazione complicando gli interventi: l’Unione europea bacchetta per i soldi; la soc. Autostrade dovrà rifare le gare; rogne per tutti gli svincoli e snodi necessari; Mignanego rifiuta un viadotto; la nuova bretella autostradale da Voltri a s.Benigno, prevede (non più passare sotto il torrente) la eliminazione dell’attuale viadotto a favore di un nuovo ponte, largo 43m., a sei corsie (più altre due per emergenze), posto da 50 a 150m più a nord dell’attuale, demolizione di –da 2 a 5- palazzi, con la A10 divenuta tangenziale urbana; sulle ceneri del ponte e di altri 4 palazzi (in totale 6-8 case, per oltre 220 alloggi, con trasferimento in zona ‘vantaggiosa’ come valore di mercato), nascerebbero giardini e campi di pallone.
Dal 2004 in poi diventa impossibile seguire i progetti, i controprogetti, le dichiarazione e le controdichiarazioni. Resta accertato che nel 2008 è ancora tutto come prima.
Dopo attraversato il ponte procedendo verso levante, alla fine, e cento metri prima di immettersi nella Mi-Ge, c’è una curva a largo raggio ma pur sempre difficoltosa; allo scopo hanno posto un limite di velcità a 40 km/h.
Dalla stupidità di chi affronta questa curva (segnalata!) a cento all’ora, parallela stupidità di chi la pone a 40 che, se potrà essere giusta per i tir che andranno verso Busalla (curva più stretta), non lo è per le auto. È ovvio che chi segue questa assurda indicazione, si becca gli improperi di chi viene dietro: ligio, ma insultato; oppure giusto, ma multato.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale Toponom. scheda 719 +
-A.sconosc.-Guida del porto di Ge.-Pagano.54-p.43.44fot.283non cita E.Porro né V.Capello
-AA.VV.Dove e Chi.-1998-pag.157
-AA.VV.-Annuario-guida archidiocesi-ed./94-pag.388---ed/02-pag.426
-AA.VV.-san Teodoro, un secolo in un sestiere-Tolozzi.1977-pag.90foto
-AA.VV.L’autocamiponale Ge.-valle del Po-MMLLPP.1935- tutto.foto
-Balletti.Giontoni-Una città fra due guerre-DeFerrari.1990-pag.164
-Cappelli.Gimelli.Pedemonte-Trasporto pubblico..-DeFerrari.91-pag.110
-Gazzettino S. : 6/75.18 + 8/75.7 + 9/93.5 + 8/94.13 + 03.04.7 +
-Genova Rivista municipale : 5/32.474.493 + 7/32.663 + 10/32.989foto + 11/32.1089 + 12/34. + 11/35.677 + 9/37.71 foto e disegni + 5/67.5 foto elicoidale
-Il Secolo XIX del 30.3.86 + 29.10.95 + 24.2.00pag.30 + 27.9.00 + 28.9.02 + 16.2.03 + 6.3.03foto + 26.5.03 + 8.5.03 + 18.9.03pag.22 + 19.11.03 + 22/7/05 -Jaja G.-Il porto di Genova-Anonima Romana.1936- pag328schema
-Montaresi M.-Genova, dal borgo alla città-Erga.1990-pag. 62.64-5-6foto
-Pagano 1940-pag.225---/1950 – pag.412
-Pero PA-Il fossato, la sua gente, le sue storie-SES.2005- pag59.
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.36.52
-Schiavi A.-la chiamavano ‘la camionale’- La Casana n.3/06-pag.38
-Stradario del Comune di
Genova, edito 1953-pag.35
CAMIONALE strada Camionale
È una strada che interessa vivamente il tessuto locale ma per tutta una serie di peculiarità non deve essere classificata come strada cittadina di libera percorrenza anche se le necessità di traffico lo augurerebbero.
Questa dizione viene riportata solo su un unico ma autorevole testo stampato dal Comune di Genova; vi appare con n° di immatricolazione 2739, e riguarda San Pier d’Arena, Rivarolo, Bolzaneto, e stranamente anche Pontedecimo (visto che questa delegazione non è coinvolta col tragitto); senza numeri civici.
Esiste sul Pagano 1940 una “via Camionale” che inizia “dal piazzale omonimo” ma non dice dove va; forse, al casello
Questa ‘strada’ non c’è sulla guida delle strade di Genova/ed.1950, e su Pagano/61; e, sulla guida/1950, neppure il piazzale.
Si riparla di questa via dagli anni in cui si progettano raddoppi (del ponte sul Polcevera), ‘bretelle’, nuovi valichi, ‘gronda’ alta, media e bassa.
Il problema è grosso e la scelta è molto difficile. Tutte le proposte sono in fase di progetti su carta e quindi fatti e disfatti in mezzo a polemiche, insurrezioni popolari in vallate minacciate dal disastro cementizio.
Contrariamente a quando fu decisa l’autocamionale e in pochi mesi ci fu l’avvio ai lavori, qui sono già passati oltre quattro anni e non esiste forse nemmeno più il finanziamento per fare qualcosa perché sicuramente andrà rifatto tutto, con prezzi lievitati.
A pagare, sarà sempre la Valpolcevera. A decidere ci sono enti con differenti competenze spesso contrastanti, interessi, mire, programmi politici (tipo i Verdi, ma anche i MM ai LLPP, legati ad una coalizione di governo ove si promuovono le finanze in questa o qualla direzione), l’ANAS, la soc. Autostrade, la Regione, la Provincia, Comune, società di costruzione (tipo COOP7, ecc), comitati, ecc.
BIBLIOGRAFIA
-AA.VV-san Teodoro, un secolo in un sestiere-Tolozzi.1977-pag.147foto
-Il Secolo XIX del 28.9.02 + 26.1.03
-Stradario del Comune di Genova, edito 1953-pag.35-
-Pagano 1940-pag.225
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10-11
CAMPASSO a) via vecchia del Campasso
b) strada del Campasso
c) via nuova del Campasso
d) parco ferroviario
e) vico
Sono tutte dizioni che corrispondono a varie età e date, meglio descritte al nome: ‘via del Campasso’ . Comunque:
a) Il 29 maggio 1817, subito dopo la restaurazione, il nuovo ‘sindaco’ Antonio Mongiardino firmò un elenco di strade locali tra le quali compare scritto «la strada vecchia detta del Campasso: comincia dalla Strada Reale, (seguendo sempre il tracciato attuale di via Vicenza) finisce al Borgo della Pietra, confina con il Comune di Rivarolo» ( in quel tempo Certosa era sotto giurisdizione di San Pier d’Arena).
Tuvo conferma questa dizione, copiata nel “quadro statistico territoriale della comunità di San Pier d’Arena, relativo al 1819 nel quale veniva giudicata “in condizioni mediocri“.
b) Tuvo cita la “strada del Campasso, lunga km. 1,300” come strada considerata ‘vicinale’ del Comune, tale riconosciuta nel 1825 nell’”elenco delle strade comunali e vicinali, sotto la giurisdizione della Amministrazione del borgo”.
Appare poi citata come ‘stradone del Campasso’ nel regio decreto del 22 magg.1857 che approvava con regio decreto i nomi scelti dal comune di San Pier d’Arena da dare ad alcune delle proprie strade più importanti.
Fu ufficialmente nominata ‘strada del Campasso’, con delibera del consiglio comunale di San Pier d’Arena del 17 giu.1867; con percorso da via Vittorio Emanuele (via W.Fillak) a via della Pietra. (ricordando che, il primo tratto iniziava da strada Reale a Torino, poi Vittorio Emanele, poi Umberto I, poi delle Corporazioni, poi Walter Fillak ma corrispondeva all’attuale via Vicenza.
c) Si desume che la “strada nuova” sia il tratto attualmente iniziale dalla ex via Umberto I (oggi via W.Fillak), sino alla piazzetta prima del sottopasso ferroviario.

Nel Pagano 1908 risulta che al civ. 5-1 vi risiedeva la commissionaria-rappresentanza di Clavenna Attilio.
d) esso viene citato, assieme alle strade cittadin, e solo da DeLandolina. Egli precisa: «parco ferroviario... da un campo che prima delle nuove molte costruzioni v’era. In vernacolo ligure sarebbe propriamente l’ingrandimento della parola ‘orto’».
e) Accanto alla strada del Campasso, tra le strade considerate ‘vicinali’ ma pur sempre giurisdizionalmente di competenza del borgo, Tuvo cita anche un ‘vico del Campasso, di m. 200’, che non sappiamo localizzare
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Com. Toponomastica.scheda
-DeLandolina GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.34
-Gazzettino Sampierdarenese : 7/93.4
-Pagano/1908 – pag. 872
-Tuvo T.-Memorie storiche di
SanPierd’Arena-dattiloscr.inedito-pag. 107
CAMPASSO via del Campasso
TARGHE:
via – del – Campasso
San Pier d’Arena – via – del - Campasso
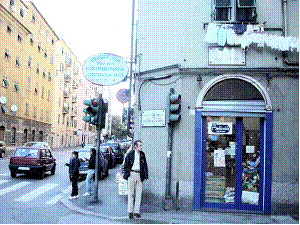
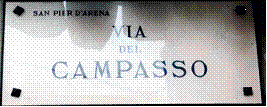
angolo con via W.Fillak


angolo con campetto parrocchiale
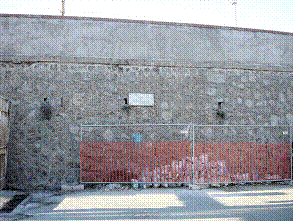
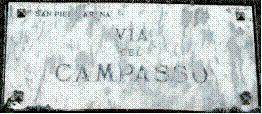
muraglione a lato dell’ex- Mercato dei polli
QUARTIERE ANTICO: san Martino
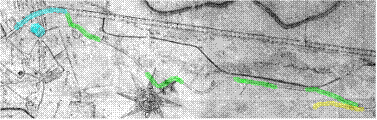 da MVinzoni 1757. In celeste via s.Martino; giallo via
Pietra.
da MVinzoni 1757. In celeste via s.Martino; giallo via
Pietra.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2740 CATEGORIA: 2
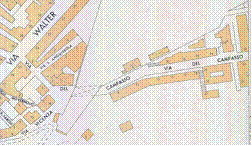
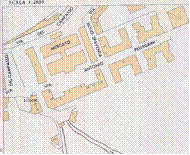 da Pagano/1961
da Pagano/1961
UNITÁ URBANISTICA : 24 - CAMPASSO
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 10480
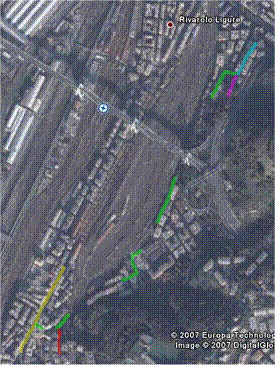
Da Google Earth 2007. Giallo via W.Fillak; rosso via Vicenza; celeste via Pietra; fucsia salita V.Bersezio.
CAP: 16151
PARROCCHIA: dal civ.1 al 5 + 2 e 4 = s.G.Bosco -- dal 9 al 51 e dal 6 al 16 = s.Cuore del Campasso -- 24 e 26 = s.Bartolomeo della Certosa
STORIA:
il rione: ai tempi del Vinzoni, 1757, San Pier d’Arena finiva poco dopo l’abbazia di san Martino, e si saltava passando direttamente all’abbazia di Certosa. Nel 1800, e sino a cento anni fa, il Campasso era una vasta zona di forma rettangolare, avente i lati est-ovest segnati dalla cresta del Belvedere-torrente Polcevera; i lati sud-nord delimitatidalle: salita Millelire -salita Bersezio con la Pietra.
Rimaneva quindi compresa tra la zona Palmetta a sud (quest’ultima corrispondeva a identica parte: dal Belvedere sino al torrente; da via Currò circa, a salita Millelire; con punto focale presso la abbazia parrocchiale quindi in san Martino), ed a nord la zona della Pietra (la quale occupava il territorio tra la salita Bersezio e via Brin, confine con Rivarolo. Anche la Pietra, era sampierdarenese).
Dal dizionario dei toponimi, si rileva che il nome, detto pure “o campassu” oppure “il campaccio”, trae origine da un “terreno usato solo per colture”, ma non di prima qualità come nella fascia a mare, perché acquitrinoso stagnante e pantanoso soggetto alle esondazioni dei torrenti che scendono dal Belvedere e l’acqua stagnante nella piana, laterale al Polcevera. Quindi, evidente conseguenza sia con un sottosuolo che non assorbe l’acqua piovana, e sia quella dei torrenti quando straripano.
Mentre la parola ‘campo’ implica l’idea di un terreno pianeggiante e coltivato, il nostro vezzeggiativo è tendenzialmente - e non apparentemente - spregiativo: sta ad indicarne sia l’ampiezza ma soprattutto le qualità declassate. Da Miscosi veniamo a sapere che, oltre a SPd’Arena, un nome simile è a Sestri ed a Borzoli.
Chiaramente fa riferimento ai torrenti che scendono da Belvedere e che non essendo incanalati – escluso qualche tratto ad uso mulini - lasciavano la zona pianeggiante acquitrinosa, fangosa che si prolungava alle terre altrettanto paludose più a nord laddove il Secca confluisce col Polcevera creando tutta una zona di difficile transito se in tempi piovviginosi.
Sappiamo che ancora sino a metà ed oltre dell’800, molte zone del genovesato erano soggette a malaria (già chiamata “febbre intermittente”, e curata col solfato di china) favorita dalle inondazioni secondarie a straripamenti per ogni piovasco; essi creavano un vasto ambiente malsano per acque putride e stagnanti capaci di rovinare qualsiasi coltura di grano, vino, legumi, ecc. e di rendere sterile il terreno (valeva questo problema per numerose terre liguri: anche per l’ampia piana di Albenga prima di una bonifica; attorno a Savona con interventi anche del Magistrato di Sanità locale; per Cogoleto) contro le quali non bastava l’apparente risanamento nei periodi di siccità, mancando allora l’acqua per l’irrigazione, essendo il terreno ripido.
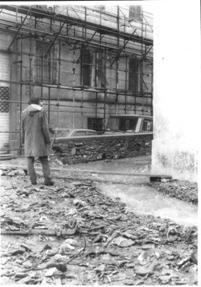


esondazioni del torrente da Belvedere-via Pellegrini, prima dei lavori definitivi
STORIA Al confine, fu eretta nel 1200 l’abbazia-parrochia di san Martino: così isolata forse per nasconderla ai saraceni e pirati che infestavano la costa; però la chiesa pare mai abbia coagulato attorno a sé un centro abitato vero e proprio.
Non è da poco rilevare che quando i nobili genovesi iniziarono nel 1500-1600 ad accaparrarsi terreni per costruirvi delle ville, nessuno andò a comperare oltre via Caveri, là dove erano prati brulli e vasti (ma per lunga parte dell’anno acquitrinosi, con più o meno grossi stagni, e senza strade ben strutturate su cui si affacciavano rare casette contornate dal proprio orto a vigneto e frutta (ricordando che quando non c’era la ferrovia, era tutto aperto sino al Polcevera: qualche vecchio ha decritto l’asinello che, girando la novia*** attingeva l’acqua dai pozzi ancora all’inizio del 1900)); molto gradevoli ed idilliaci forse d’estate, ma poco invitanti d’inverno quando il tutto era esposto alle bizzarrie della tramontana che incanala lungo il torrente il vento gelido del nord; del Polcevera stesso tutt’altro che tranquillo; nonché di quei torrentelli provenienti dal Belvedere capaci perfino di muovere le pale di qualche mulino (come quello nel Chiusone) e allagare la zona (come anche è successo qualche decina di anni fa prima del completo rifacimento dell’incanalamento dei torrenti e delle fognature) tutto si sommava alla scomodità, rispetto le zone più abitate vicino alla marina, alla minor vitalità e giro di guadagni: le carte planimetriche di San Pier d’Arena del Vinzoni, della seconda metà del 1700, arrivate a descrivere la medievale pieve di san Martino, si fermano e non includono la zona del Campasso, seppur indicando che i terreni a nord appartenevano alla famiglia Cicala.
La vicina e primitiva abbazia poteva forse creare conforto e privilegio di agglomerato, ma anch’essa già a fine del 1700 venne considerata eccessivamente decentrata rispetto al centro del borgo vissuto, di traffici, degli abitanti e dei viandanti (che però fin dai tempi romani non passavano dal Campasso, ma risalivano in alto lungo salita Bersezio, o dal centro ma solo per andare nel ponente).
 carta fine-settecento: in rosso il vecchi tracciato con in
verde le due chiese (san Gaetano e san Martino); in orizzionatle il progetto
del nuovo; a sinistra ‘Aree Cicala’ e ‘molino’
carta fine-settecento: in rosso il vecchi tracciato con in
verde le due chiese (san Gaetano e san Martino); in orizzionatle il progetto
del nuovo; a sinistra ‘Aree Cicala’ e ‘molino’
In una carta anch’essa di fine del XVIII secolo, simile a quella stilata dal Brusco, i terreni appaiono in buona estensione di proprietà del un sig. Ponzio (nella zona a mare, dal ponte ferroviario al fondo della discesa davanti la chiesa); e del principe Santangelo (verso nord, nello spazio tra la precdente e la Pietra. Gli Imperiale erano “principi di sant’Angelo”). Questo, mentre l’abbazia era già bella e distrutta con la parrocchia trasportata alla Cella.
Ai primi dell’ottocento (quando gli abitanti del borgo erano in tutto 5345); e dopo, nella prossimità di divenire città (quando allora gli abitanti erano divenuti 13.396), la zona era la meno popolata del borgo, con poche case lungo la strada (cinque o sei), forse qualche osteria-locanda, qualche orto; pressoché ancora abbandonata: genericamente un po' squallida e brulla campagna (anche se l‘Anonimo’ del 1818 che in viaggio da Novi a Genova descrisse lungo la ‘strada della Polcevera’ dopo Certosa (ma probabilmente già in prossimità del borgo): “…Questa bella strada, l’unica che sia nelle vicinanze per Genova per il sensibile colpo d’occhio che procura e per la bella veduta delle dianzi enunziate colline e palagi di villeggiatura, che dai due lati del fiume vedonsi eretti, congiungersi a pié del ponte di Cornigliano alla strada di Ponente…”)
Fu la nascente industria in espansione dopo il 1850, ricordiamo in zona - nei pressi dell’orto del sig. Emanuele Sasso -, l’ officina meccanica dell’ing. Thomas Robertson, che di più importante produce macchine idrauliche; e poco distante una fonderia di Bardin & Ballard (nonché i Wilson&MacLaren, ed il cordificio) che riempirono la zona di operai provenienti da tutta Italia, quasi tutti analfabeti ed abbisognevoli di case e di misera sistemazione della famiglia, creando un misto di campagna e periferia, con le prime case popolari, dotate di numerazione irregolare (tra due civici - ad esempio 7 ed 8 - nascevano il 7a, 7b,...7e, ecc) ed erette senza un preciso piano regolatore; con alcune trattorie - di cui una divenuta famoso ristorante - ma soprattutto con osterie e relativi ubriachi, risse, grida; con depositi di merce mista, eretti a fantasia ed a seconda della bisogna; modeste fabbriche artigianali e magazzini; vissuta da bimbi (i più scalzi) a giocare nei terreni incolti o a rubacchiare la frutta per sopravvivere.
Ma pur sempre rimase zona ‘dimenticata’ dalla civica amministrazione, al punto che nel tardo 1800 si formò un comitato mirante a staccarsi da San Pier d’Arena per aggregarsi a Rivarolo; si presume – visto il niente di fatto - che la sortita riuscì forse a far ottenere dei miglioramenti nella viabilità (però non ancora risolti nel 2003, visto che nessun mezzo pubblico percorre la strada, mantenendo quell’atmosfera di ‘località distaccata’, un paese viciniore e non appartenente alla città.
Tale rimase, finché la ferrovia non attraversò quei prati e – poi, su progetto di quei Vincenzo Capello ed Enrico Porro ai quali la città ha dedicato una strada - si appropriò nel 1906 circa del grosso appezzamento per farne un parco treni. Questi tagliò un largo fuso di terreno nel centro del rettangolo, perpendicolarmente al mare, separando la zona a levante, quella vissuta, tra il muraglione del parco e le falde del colle, e che ha conservato l’antico nome di “rione del Campasso”; ed a ponente dei treni, ove ora via Fillak e Porro sino al torrente ha lasciato una zona che ora è un po' senza fisionomia toponomastica precisa, perché è sempre Campasso, ma nessuno più la riconosce tale.
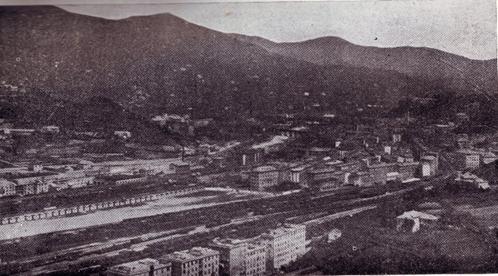
in basso la zona del Campasso, vista da Belvedere, nel 1910 circa.ù
in basso a destra, presumo, la villa dei Ricca
Nel 1964 nacque il primo Comitato di quartiere, alle cui votazioni, con la partecipazione di oltre 550 persone, fu eletto Nacci Gabriele, seguito da Turbati Piero, e DeMartino Luigi. Dal censimento 1997 si segnalano: una popolazione di 9029 residenti (contro i 9350 del 1991 = 3,4% in meno); 4134 famiglie con media di 2,18 componenti; una prevalenza delle femmine in percentuale di 100 contro 91,2 maschi ; 4985 nati nel comune, contro 336 nati fuori; età media 45 anni ( 937 ultra75enni); 3957 abitazioni; 2% di laureati, 17,2% diplomati, 9,2% senza titolo di studio, gli altri con licenza elementare o media .
Nel 2005 la “massiccia invasione di extracomunitari” con differenti abitudini di vita a volta inconciliabili, la presenza di vandali, ladri, ubriachi, fracassoni e TD ha fatto promuovere la nascita di un nuovo Comitato di quartiere supportato da un Comitato Mamme. Per prima cosa, hanno promosso il ripristino dello spazio giochi, del campetto di calcio e dei giardini che salgono a via Baden Powell (ove era franato un muretto)
Attualmente la zona viene chiamata ‘Unità urbanistica Campasso’, che ha una superficie totale di 85,9 ha.; considerata tutta ‘centro abitato’.
Il parco ferroviario, detto anche ‘scalo ferroviario’ o ‘parco vagoni’ del Campasso, venne creato tra il 1900-7 da imprese salernitane ed amalfitane, nel programma di decongestionare il porto ed organizzare i treni per il trasporto delle merci verso il nord, distinto dalla circoilazione passeggeri (sino ad allora il traffico era suddiviso e smaltito da Novi, nel parco di san Bovo).
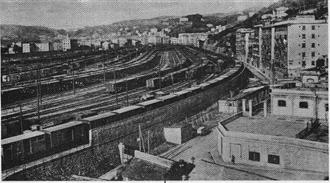
La linea è lunga 2 km. circa; parte da 3 zone portuali, e mediante tre binari e gallerie, confluisce in 2 binari; attraversa la galleria dei Landi e percorre la valletta alle spalle di via Ardoino (terreni una volta di molti proprietari tra cui l’istituto don Bosco, ed a loro espropriati “per causa di pubblica utilità” da parte dell’ Ispettorato Generale delle Strade Ferrate; la proprietà salesiana rimase tagliata in due parti, che furono dapprima riunite attraverso una passerella metallica poi quella a levante della ferrovia venduta dove ora sono le case di via P.Cristofoli: datato 8 giu.1907, l’area di circa 1000 mq aveva allora un valore riconosciuto di lire 22/mq).


foto anno 2008 da sopra il ponte
I convogli arrivano al parco (passando sopra via Campasso): un’area sopraelevata, lunga 1200m, larga 180m e capace di ospitare oltre 2000 vagoni, per poi ricongiungersi – strozzando il centro di Certosa - con le linee normali verso i Giovi.
Questa enorme struttura rialzata, costruita nei tempi in cui le ferrovie ed il porto erano in forte espansione (e quindi con caratteri prioritari di ‘ragion di stato’ rispetto anche il piano regolatore del 1879 – aggiornato nel 1887- che programmava tutto diverso per quella zona) condiziona tutta il territorio, tagliando la parte a monte (a cui è rimasto l’antico nome del Campasso), dalla zona a ponente fino al torrente, che cercò nell’industria e nelle case popolari di acquisire una autonoma denominazione senza però più ricongiungersi né riconoscersi nell’antico rione, né raggiungendone uno nuovo proprio.
La strada = sino a metà del 1700, la viabilità era dipendente dalle incostanti bizzarrie del tempo; preferibile quindi per chi arrivava dalla Bocchetta, by-passare la zona salendo dalla Pietra a Belvedere; se non addirittura provenire a mezza costa da Begato; o passare decisamente alti da Granarolo.
Fino al tardo 1700 il collegamento con Rivarolo attraverso il Campasso era appena appena un tracciato ad uso locale, poco idoneo anche per le rare carrozze che collegavano Genova con la Lombardia, ed a uso prevalente del commercio tra l’entroterra fino alla spiaggia (dove poi trovava vero sfogo per la città e la riviera). Solo allora nacquero i primi progetti, mirati a decongestionare il centro del borgo cercando di rettificare il tragitto dal Canto a Rivarolo (lungo una direttrice che da san Martino si sovrappone alla via W.Fillak).
Così divenne la via principale che dal nostro borgo arrivasse a Rivarolo.
Per arrivare più comodamente in carrozza nei propri possedimenti dell’entroterra (in particolare a Cremeno), iniziò in quegli anni l’interesse del doge GB Cambiaso (19 lug.1711--23 dic.1772- discendente di ricca famiglia veronese ascritta alla nobiltà genovese dal 1731, molto colto, commerciante, finanziatore, protettore del Banco di San Giorgio, doge dal 16 apr.1771. Ancora vivente gli fu eretta una statua nel palazzo Ducale, distrutta poi durante il periodo giacobino). Il 3 gennaio 1772 dichiarò pubblica impresa l’apertura di una strada che avrebbe unito Genova al colle della Bocchetta per Gavi eNovi: tracciandola opportunamente più vicino alle falde del colle piuttosto che nel centro della piana allacciandosi alla strada che, di provenienza dalla Porta della Lanterna portava all’abbazia. Su alcuni testi si scrive che iniziò a partire dalla zona della Pietra (si presuppone che in contemporanea abbia fatto migliorare anche la strada che dal borgo arrivava al Campasso, e da esso (la somma delle attuali via Vicenza-via Campasso) alla Pietra; ma nessune parla di questo tratto intermedio).
Iniziati i lavori l’anno dopo, in tre anni l’impresa fu conclusa sino a Campomorone dove fu allacciata alla vecchia strada per la Bocchetta. ed Per non incidere sulle casse della Repubblica, i lavori furono finanziati a proprie personali spese (5 milioni circa). Quindi prima di quella data non esisteva una strada che attraversasse idoneamente il rione e la viabilità era limitata a mulattiere e tracciamenti come possiamo vedere ancor oggi nelle zone di campagna.
Nel 1818, l’Anonimo descrittore di un viaggio, citato sopra, scrive anche: «…comincia l’altro grande stradone alberato sempre lungo la ripa del fiume il quale protratto negli ultimi anni addita da quel punto l’orizzonte del mare per sua ultima meta».
È riconosciuta ufficialmente nel regio decreto del 1857, quale “ stradone del Campasso”; in quell’epoca si staccava da via Vittorio Emanuele (via W.Fillak) come oggi, ma non nel punto attuale: essendo un tutt’uno con l’attuale via Vicenza, iniziava nel punto dove ora inizia quest’ultima (e dove c’era ‘l’osteria del Gay’ che faceva da punto di riferimento ufficiale; anche se per comodità e per conoscenza popolare veniva chiamata ‘la via della Gina’, dalla trattoria omonima ).
Per il Comune, poco prima dell’anno 1900, era ‘via Campasso’.
All’inizio del 1900 fu aperto il nuovo e largo sbocco in via Umberto I, quale è ora; a questo tratto - fino al sottopasso ferroviario - fu dapprima dato il nome di “ via Nuova del Campasso”.
Subito dopo, su proposta fatta alla giunta comunale a fine dell’anno 1900 da parte un Commissario straordinario appositamente nominato, nel 1901 divenne “via Giordano Bruno “, riunendo sotto il nome del frate la via ‘nuova’ (da via UmbertoI al sottopasso) con quella ‘vecchia’ (dal sottopasso al mattatoio fino alla salita Pietra); e nominando diversamente ( via Vicenza) il tratto dal sottopasso al vecchio sbocco nella strada principale).
Quest’ultimo nome rimase praticamente sino all’unione di San Pier d’Arena nella Grande Genova avvenuta ‘per decisione superiore’ con decreto del 14 gen.1926; da allora, per evitare doppioni, la periferia dovette cedere i nomi doppi al centro; ma nell’elenco delle strade comunali pubblicato dal podestà del 1927 la titolazione è ancora invariata.
Fu appunto per altro decreto del podestà, del 19 ago.1935, che si preferì tornare al vecchio nome semplificato, l’attuale.
I TIR : Un lungo terribile ventennio, tra il 1970-90, ricorda questi enormi bestioni. Dove in via Spaventa era una antica fabbrica di ghiaccio, l’edificio venne trasformato in deposito frigorifero per derrate alimentari provenienti dai paesi scandinavi; l’unica via di accesso a questo deposito era questa del Campasso, con percorrenza giornaliera di grossi camion con rimorchio che, per la ristrettezza del passaggio , per anni crearono non poche difficoltà al traffico, sia nella linea di percorso ma soprattutto nei punti in curva e le macchine in sosta. L’unica novità applicata per favorire lo scorrimento dei mastodontici veicoli, fu la demolizione di un ponte che era stato gettato tra il mercato dei polli e la ferrovia. Nel nov.89 un’ordinanza del sindaco Campart ne aveva sospeso il passaggio; ma un ricorso al Tar la annullò ripristinando il passaggio dopo pochi mesi; questo fino al trasferimento in altra zona del deposito stesso. E’ comunque rimasto un tragitto tormentoso, anche ora che essi non passano più .
STRUTTURA: nel primo tratto, da via W.Fillak (da cui inizia) sino all’ex mercato dei polli, è difficoltoso doppio senso viario; poi al momento in cui la strada passa davanti al mercato stesso la viabilità diventa senso unico: A) per proseguire verso Rivarolo occorre passare per via Pellegrini, via Spaventa, rientrare in via Campasso, percorrere la lunga strettoia affiancata alla ferrovia, sino all’incrocio con salita Bersezio.
B) da Rivarolo l’imbocco della strada è vietato (occorre fare il giro da via Fillak). In questa direzione è senso unico viario, il tratto dall’inizio della strettoia al mercato.
Attualmente appartiene a Sampierdarena sino ai civ. 51a e 16; a Rivarolo dopo il 53 e dopo il 24 (da dopo la strettoia).
Sotto la bitumatura, appaiono spesso i masselli di pietra che costituirono il primo selciato stradale.
La strada è servita da pochi negozi concentrati nella zona centrale e che nel tempo hanno innumerevoli volte cambiato proprietari ed uso: da molte rivendite di vino, oggi vediamo solo due bar, un panificio, elettrauto, tabacchino, giornalaio, un vetraio.
È servita sia dall’acquedotto Nicolay che il DeFerrari Galliera
CIVICI
Nel 2007=NERI= dispari dal 1 al 51a (compreso 29a)
pari dal 2 al 16 (compresi 6a-6b-14a)
ROSSI=dispari dal 1 al 147 (compresi 15a-127c-127d-127n-
mancano 73-77-79-87-89
pari dal 2 al 58 (compresi 16a.16b-18a.18b-54a-
58d.58e.58g.58n.58p
Verso la fine del secolo XIX, a cavallo tra 1800 e 1900 vi avevano casa di proprietà : al civ. 1 , la marchesa Passalacqua ved.Negrotto Cambiaso ; al 4 , Rocca Luigi; al 3a , Ballestrero e C ; 5 e 7 , Tuo (eredi e Luigi) ; 6 e 7 , marchese Catterina ; 8, Venzano GB ; 9, Rapallino eredi ; 9a, Demarchi eredi ; 10 e 18 , marchese Piuma ; 10a , fornace e fabbrica mattoni Carosio (nel 1912 è descritta dei f.lli L.A.) ; 11, Sciallero e Carbone ; 12 , Venturini Giovanni ; 13 e 14 , Ricca Tomaso; 14a , cancello di villa Sibilla; 15 e 16, Figari GB; 17 e 19 Degola Matilde.
(tre marchesi, con altrettante ville!)
Nel Pagano/1902 si descrivono le attività commerciali di : Dellepiane Agostino con deposito di birra e fabbrica di acque gassose;---i f.lli Carosio L.A. hanno una fornace di mattoni (a vapore);---
Nel Pagano/1908’ e /1912° risultano operanti nella via la fabbrica a vapore di mattoni e laterizi vari dei f.lli Carosio L.A.’° (vedi 1900 al 10a); e la commissionaria di Clavella Attilio’ al civ.5-1 (nel 1912 trasferita in via Varese).
Il Pagano/40 delimita la strada tra via della Corporazioni e via della Pietra; vi descrive oltre al civ. 2 il macello civico, 4 vinai, 8 commestibili, 4 fruttivendoli ed altrettanti parrucchieri, tre latterie ed eguali carbonai, un bar, una trattoria, merceria, macellaio, tabacchino ecc. Di industrie la SAIF (soc.an.ind.frigorig.); due di lubrificanti: la Clingoil e la Galtesax Oil Company; la Aracne al civ.37 industria delle calze; la CAICCEA industria delle carni.
Nel dopoguerra,
-il Pagano/1950 segnala la presenza di due bar : al 7r di Cavo M.; al 32Ar di Verrua F.;
-furono costruiti nuovi i civ.37a, 47, 47a. 49 (’49), 12 e 37 (’51) , il 28 ed il 51 (’52), il 41 ed il 16 (’53), il 14 (’56), 14a (’57), 6a e 29a (’61), 24a (’69).
demoliti invece i civv. dal 12 al 20 + 37 e 41(nov.1949), il 41 (1951, sinistrato), il 47 e 47a (1961), il 37a (2000);
variati il 51a e 26a (nuove aperture), il 26a (soppresso nel ‘70) ed il 6b (acquisito da un civ.rosso, nel ’72).
Percorrendo la strada attuale da via Fillak, nel palazzo di destra ove è il civ.1, eretto alla fine del 1800 ed i cui fondi furono inizialmente adibiti a stalle, si vede nell’angolo smusso una grossa (m.1x070) immagine di san Martino, nell’atto classico di tagliare il mantello. Quando fu necessario ristrutturare il palazzo nei primi anni dopo il 1990, l’immagine fu rimossa e se non si interessava la popolazione alla fine dei lavori, probabilmente sarebbe andata... perduta; invece il Gazzettino ed il circolo Nicolò Barabino si fecero portavoce per ricuperarla, malgrado sia definita artisticamente modesta e di scarso valore. Non è scritto se il Circolo ha provveduto a far rifare l’immagine o se quella antica è stata oggetto di restauro: la si intravede ben incorniciata, anche se troppo in alto per gli sguardi fuggenti della popolazione frettolosa.


Nell’angolo opposto, a sinistra, una lapide ricorda il fatto che un gruppo di partigiani - tra cui il diciottenne Edoardo Malacchina - residente a Pegli, comandante di un distaccamento partigiano - il 18 apr.1945 (pochi giorni prima della Liberazione), transitando in tram per via delle Corporazioni (via W.Fillak) con altri compagni, vide due soldati dell’esercito tedesco entrare nell’osteria Beccaria, in via Campasso 4r.; decisero di sorprenderli e provocarli, come si voleva al fine e con l’intento di destabilizzare e rendere insicuri sia i poliziotti che gli arroganti occupanti tedeschi; per cui scesero ed entrarono nella fiaschetteria intimando la resa: ma ci fu reazione, e nel conflitto il partigiano, a cui si era inceppata l’arma, rimase gravemente ferito: morì in ospedale. Per la sua temerarietà ed atto giudicato eroico seppur compiuto pochi giorni prima della definitiva resa dei soldati tedeschi, avvenuta sette giorni dopo, fu riconosciuto medaglia di bronzo al V.M.. Una relazione del commissariato di PS della Repubblica di Salò, confermò che rimasero feriti anche un compagno del Malachina - Ferrando Giuseppe - ed il sottufficiale tedesco (maresciallo Hepsadam, colpito al fegato e ad una mano e ricoverato tramite la Croce d’Oro, all’ospedale con prognosi riservata).

Prima del ponte ferroviario, in uno slargo della via, c’è a destra una cappellina dedicata alla Madonna, eretta - come dice la targa - nell’anno mariano del 1954 dai fedeli del Campasso (anche se essa è in territorio di competenza della parrocchia di don Bosco), e restaurata nel 1994. Vi era ospitata una statua della Madonna, antica pare perché proveniente dal distrutto Oratorio di san Martino: è stata trafugata nei primi mesi dell’anno 2000, da ignoti; rapidamente sostituita l’immagine, rimane la rabbia del furto non certo realizzato per fervore religioso ma per volgare lucro di arte antica. Nel 2005 i Carabinieri arrestarono Marco Ottaggio ricettatore di statue rubate (in casa aveva duecento Madonne, dal XVI secolo in poi, e trecento tele) ma non sappiamo se tra esse c’era la nostra.


anno 2008
===civ.14r : di fronte, a sinistra, era l’ingresso dell’ antica trattoria della Gina del Campasso (“Ginn-a do Campasso”). Sfrattata dalle ferrovie da un locale vicino più antico ed adibito a osteria-cucina casalinga, la Gina (al secolo Caterina Marchese (leggi sotto per la famiglia) già vicina ai settanta, piccoletta tarchiata e robusta, accanita e fortunata giocatrice al lotto) si trasferì nel 1860 in quei locali, chiamandoli “Trattoria della Gina, (Campasso)”.


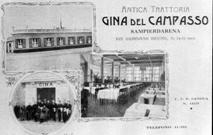
La ‘reclame’ all’inizio la poneva - ed ancora nel 1902 - in “via Vittorio Emanuele, loc. S.Martino”; poi in via Giordano Bruno al 14 e 16 rosso, ricreando dapprima una trattoria di campagna, facendola divenire poi via via un ristorante di lusso, un obbligo da visitare: le mense coperte da fini tovaglie ed allietate da fiori e porcellane decorate, ma soprattutto con la fama di dove si “mangia bene” e si beve del vero Coronata. Le sue specialità erano: antipasti tradizionali; ravioli, lasagne o trenette al pesto; fritto misto (piatto forte del locale, con cervella, carne -di vitello o manzo-, laccetti e filoni, verdure dai cavolfiori ai carciofi, zucchini o melanzane, e latte brusco) o lo stocche in tutti i modi compreso coi bacilli, accompagnati dalla scorsonæa, dai cuculi e crocchin.
Tale lista delle vivande, era nota ‘urbi et orbi’: non solo ai sampierdarenesi, ma a tanti ‘foresti’ (piemontesi toscani e lombardi, perfino cinesi); a gente famosa come il sindaco Mario Bettinotti (sindaco di San Pier d’Arena nel 1919 che dalla Gina teneva spesso discorso, agli ospiti del Comune); Lorenzo Stecchetti (direttore della biblioteca Universitaria); G.D’Annunzio (questi nel 1914 la definì ‘badessa intingola’, titolo aulico, per lei di difficile interpretazione e inizialmente genericamente non gradito... la parola intingolo fu mal interpretata); i congressisti provenienti dalla inconcludente ‘Conferenza della Pace’ (con Trotsky, il più illustre frequentatore); i dirigenti dell’Ansaldo e loro ospiti (tra cui viene ricordato il dr. Federico Giolitti figlio del ministro). La fama era veramente planetaria : dopo una visita al porto o ai caruggi ed alla cattedrale, per riempirsi lo stomaco a Genova non c’era alternativa: San Pier d’Arena era la patria dell’arte culinaria (nel 1920, vi esistevano 27 tra ristoranti e trattorie, dei quali una diecina ‘storici’); una tradizionale mèta di gitanti buongustai (valeva ben mezz’ora di tram da Caricamento!). Marinai appena sbarcati, cerimonie religiose (comunioni, cresime e matrimoni), frequentatori sportivi della vicina piazza d’Armi (detti ‘footballers’), i soci delle società di mutuo soccorso, i portatori di Cristi prima della pomeridiana spirituale fatica in processione, le famigliole in gita o alla spiaggia. Il nipote Luigi, era il sommeiller dei vini (faceva visitare la cantina solo agli amici che la descrivevano ’linda e pulita e senza una ragnatela, lucida e brillante, ove erano scaffali ripieni di bottiglie’. Non certo la Gina, ma la trattoria pare sopravvisse sino a dopo l’ultima guerra.
Due aneddoti ricordano: il pappagallo ammaestrato che vicino all’uscita con divertimento generale avvertiva ‘gh’è gente’ se qualcuno entrava, e chiedeva per chi usciva:”han pagou?”; mentre per gli invidiosi era sulla bocca uno stornello che suonava “la Gina del Campasso, con la sue raviolate, fa i soldi a cappellate”.
Vicino, ormai da immemore tempo cancellate e non localizzabili, prima del 1896, c’erano l’osteria “la Primavera” ed una pista da ballo all’aperto chiamata “Mondo nuovo”, dove la moderna gioventù si ‘bruciava’ in nuovi balli scandalosi, al suono di un organetto; questo divertimento determinò i ‘mugugni’ dei benpensanti per cui fu giocoforza la relativa chiusura da parte della questura; il tavolato della pista del ‘Mondo nuovo’, fu poi mandata a fuoco da sconosciuti teppisti.
===15A : nel 1950 vi aveva sede la ‘Edizioni Musicali’ Vigevani Carlo.
===civ.18r attuale numero - dove era prima la trattoria - occupata a lungo negli anni fine 1900 dall’azienda autotrasporti Cardonetti.
I locali sono stati più recentemente usati da una organizzazione degli immigrati latino-americani (equadoriani in maggior parte) ma furono chiusi d’autorità negli anni 2009, causa eccessi (ubriachi, chiasso notturno, vetri di bottiglie rotte, ecc.). Nel 2010 apare chiuso.
Il ponte, serve a far passare, sopra, la ferrovia che – proveniente dal porto e passante sotto la galleria dei Landi - conduce al parco del Campasso.
Sotto il ponte ferroviario, un’altra lapide ricorda il 15 genn.1945, quando nel posto furono fucilati due partigiani, operai dell’Ansaldo, il diciannovenne Giuseppe Spataro (vedi) ed il quarantaduenne Ernesto Jursé (vedi). Questi, catturati alcuni giorni prima e tenuti nella ex sede dell’Universale (il Secolo scrive ‘da Marassi’; ma ritengo difficile che provenissero da là, che era in mano ai tedeschi, i quali non li avrebbero certo lasciati a facinorosi generici italiani ancorché delle brigate nere, che invece la facevano da padroni in periferia. Tanti prigionieri, prima di essere trasferiti a Marassi, ‘soggiornavano’ nelle sedi locali) dopo essere stati picchiati a sangue, furono condotti sotto l’archivolto ed lì uccisi nella notte (col messaggio simbolico -non ben spiegato neppure da chi visse quei giorni, anche se ripetuto più volte, del panino ed una mela in tasca; si presume, per farli parlare dopo averli allettati con del cibo e con l’idea di un trasferimento in un campo di concentramento. Musitelli spiega che nella seconda metà di gennaio 45 anche a Genova dal IV settore di Marassi, le B.Nere prendevano i prigionieri raccontando libertà e fornendoli di un sacchetto con panino e mela: la colazione del mattino; caricati sui camion di notte, venivano scesi ogni tanto e li fucilavano lascandoli a terra come monito).
Il posto fu appositamente scelto per dare un monito a tutto il quartiere sempre particolarmente ribelle alle direttive del partito nero.
Nel gennaio 2003, poco prima della cerimonia di commemorazione (promossa dall’Anpi “Martiri del Turchino” e dall’Arci “Giuseppe Spataro”) la lapide ed il muro attorno furono imbrattati da uno spay nero con scritta (“S(ilvio).Parodi” nome di una brigata nera, assunto da un gerarca della Repubblica di Salò) e simboli di svastiche (episodi simili erano avvenuti due mesi prima alla Benedicta ed a RivaTrigoso; qui a San Pier d’Arena, dieci mesi prima alla lapide di piazza Masnata, con ovvio interessamento della Digos. (è legalmente proibita l’apologia del fascismo).
 Partito socialista italiano di unità popolare
Partito socialista italiano di unità popolare
dipinta sul palazzo dei turaccioli (leggi dopo) è l’unico residuo di una mentalità politica accesa e convinta degli abitanti del Campasso, orientata compatta a sinistra anche nei tempi del fascismo. E motivo per la fucilazione dei due partigiani, i cui corpi poi lasciati in zona, a inutile minaccia.
Dopo il ponte, un lungo muraglione innalza di oltre un piano le già erte scale delle case popolari, costruitevi alla fine del secolo 1800.
A monte di esse, doveva passare a scendere la strada della Quota 40, ma non se ne fece nulla forse per mancanza di fondi o per non ingorgare ulteriormente la zona, che prima di sfociare a Rivarolo, era già densamente abitata e la strada era divenuta uno ‘stretto budello’.
===civ. 8 dopo la galleria ed un muraglione che sostiene una casa delle ferrovie, con questo civico anizia la parte abiata a ponente della via. Il cornicione contiene la base di una insegna o di uno scritto fascista.


=== un forno fa tornare alla memoria un fattaccio locale: l’uccisione da parte di un fornaio nella strada – non specificato dov - di un giovane orfano al fine di carpirgli un biglietto, vincente una quartina al lotto; l’omicidio fu scoperto e punito: ed è da allora che una leggenda sui campassini tramanda che essi, forti giocatori, non riferiscono mai ed a nessuno le loro vicende di gioco.
===civ.14 : sullo stipite marmoreo, sta inciso “casa Venzano”; un GB abbiamo visto risiedere al civ.8 nell’anno 1900; conosciamo un omonimo cognome titolare di una trattoria negli anni 1919-25 nella strada (allora via G.Bruno al civ. 28; quando a fianco, al civ.30, c’era anche quella ‘del Lillo’).

===civ.20: si chiamava ‘casa Durante’ e vi abitò da prima del febb.1905 ad oltre il 1908 il pittore G.B.Derchi (che morì nel febbraio 1912 (vedi)).Doveva a questa altezza, partire una strada che portava ad orti posti dietro le case -compreso l’attuale civico 14-; cosicché il portone è posizionato non sulla strada principale ma in una rientranza.
===civ.25 : sul muro del palazzo posto di fronte al portone, c’è una targhetta in marmo che segnala “Zona Militare, m. 250”.La targhetta risale alla guerra 15-18 quando i forti erano zona militare e pertanto, dopo breve tratto, era zona invalicabile e delimitata da filo spinato; per raggiungerli ovviamente era necessario l’uso dei muli; e questa rientranza pare fosse l’inizio di una mulattiera che arrivava ai forti soprastanti. Tale targhetta la ritroviamo sulla casa della Nora Torre (in via Pellegrini, 1) e sparsa per la città, come in via alla Porta degli Angeli.
===civ.33 : dopo il palazzo, in posizione arretrata nel declivio del colle, negli anni 1940 di inizio guerra, fu aperta una galleria, ben visibile per l’impostazione esterna in cemento, che doveva arrivare ai Landi, da usare come rifugio nei bombardamenti. Rimase incompiuta dopo 200 metri di profondità, ed in pratica non fu mai usata. Venne utilizzata come deposito di legname; ma questo, nel 1982 andò a fuoco facendo scoprire potenziale pericolosità per chi si fosse avventurato in profondità, per cui fu chiusa.

la galleria, prima del campetto
Segue uno dei tre caseggiati ad uso abitativo, che il libro “un’idea di città” a pag.141 segnala per la presenza di decorazioni esterne con caratteristiche liberty (ne cita tre, ma non precisa a quali numeri civici corrispondono (uno di essi presumibilmente è il civ. 39); sappiamo che uno fu eretto nel 1906 (proprietà ed architetto , Adriano Cuneo), uno nel 1910 (è il civ. 35: proprietà Cazzullo; architetto geom.Pietro Giacomardo), ed uno nel 1911 (proprietà Riccapenna, arch: A.Petrozzani).
===civ 16 Nel Pagano/1908 e 1925 genericamente in ‘via al Campasso (s.Martino)’ sono descritti un deposito di birra ed una fabbrica di acque gassose di proprietà Dellepiane Agostino.
Nel 1936 fu eretto un edificio ad uso della soc. Ifelc, salumificio ed insaccati vari, di Ghezzi Osvaldo, poi di Dardano Giuseppe.
Nel 1970 fu occupato per breve periodo dalla cooperativa Lacas che fallendo, lasciò lo spazio alla FrizzSoda, sempre di Ghezzi (Il Secolo XIX- 2002 scrive essere di Ettore Ceruti), che riprese il marchio della bibita “Gassosa”, abbandonato negli anni ’60 (Il primo stabilimento della bevanda fu aperto al Campasso –non sappiamo dove- e fu una delle prime società per azioni interessate al ramo alimentare, nate a Genova. Venduta in centro ed allo stadio, per una decina d’anni conobbe una impressionante popolarità, divenendo leader dell’industria locale: iprodotta nelle bottiglie con la biglia, nonché acqua in sifoni. Fu anche deposito di birra e lavorazione delle spume).
Rimodernato è divenuto nella parte ad est affacciata sulla strada, prima magazzino di carne macellata, poi deposito frigo chiamato dapprima Biemmezeta poi Avicola Zena, di Barellari e Zunino.
===civ. 26r nel 1950 c’era una ‘agenzia giornali’, di Sanna.
===civ. 39r nel 1950 c’era una trattoria, di Cighè C..
In precedenza esisteva nella via, non precisato dove, ‘in una casa d’angolo poi distrutta da una bomba’, la trattoria “del Lillo” (non nel Pagano/12; si nel Pagano/19 e /25: in via G.Bruno, 30); gestita da uno dei tanti eredi della famiglia Marchese una volta proprietaria di gran parte dei terreni (anche la Gina era con questo nome - leggi sotto). Ancora nel 1950, dei f.lli Marchese gestivano al civ.69r un negozio di legna e carbone (in SPd’Arena ce ne erano allora ben 32 di esercizi similari, di cui 3 al Campasso: civv. 28r e 29r). Vedi al 58r.
===civ.49r nel 1950 c’era uno spaccio di vendita della soc. an. Azienda Autonoma Annonaria.

Lo slargo stradale esistente, esteso alla vicina via A.Pellegrini fu negli anni 20 punto di raduno e partenza del Carrosezzo Sampierdarenese (nel pomeriggio del giorno, una diecina di carri allegorici, variamente addobbati con casette, fiori, uomini mascherati con semplicità, qualche strumento musicale per intonare canti e balli tra lancio di stelle filanti, coriandoli e qualche arancia (alcune maschere sono rimaste nella memoria quale quella di personaggi reali, del Beppe che vestito da balia allattava Cinninini un omuncolo tendenzialmente tonto che vendeva giornali e ruote del lotto; e la riproduzione dei comici di allora (Charlot, Ridolini) e maschere conosciute (Arlecchino, Balanzone, Baciccia o di fantasia propria). Importante era partecipare.
Normalmwente, il corso partiva dalla piazza scendendo in piazza Ferrer (Vittorio Veneto) da cui risaliva via Vittorio Emanuele (Buranello) fino a piazza Bovio (piazza Barabino) per tornare lungo via C.Colombo (Sampiuerdarena) sino al Baraccone del sale o a piazza XX Settembre (del Monastero) per la premiazione e dove si scioglieva. Ma più d’uno potevano essere i tracciati, a seconmda della promozione locale
 carri in via Fillak presso le case dei ferrovieri
carri in via Fillak presso le case dei ferrovieri
A questo punto la strada di via Campasso ruota a sinistra, mentre continua diritta in via Pellegrini ove sono censite la chiesa ed il suo campetto sportivo.
===civ. *** ha ospitato per anni una cooperativa di soci (la cui sede era in piazza Ghiglione vicino a via Currò); Da essi passò al supermagazzino denominato cooperativa Scasa che cessò la attività traslocando in altra sede verso Teglia, nel 1986. Attualmente è detto che funge da deposito comunale di materiale per i periodi elettorali (sedie, cabine, urne, riquadri per i manifesti, ecc) ed è gestito dalla coop. Moro trasporti.

La strada prosegue costeggiando il muraglione del Parco ferroviario. A levante costeggia invece il fianco del mercato

===civ. 58r a ponente invece, fino ancora nel 1950 erano alcune stalle per cavalli, di proprietà di quei Marchese (presumo i fr.lli, carbonai nel 1940) padroni di tutti i terreni ad est della strada, estesa da via Millelire al fondo di via Pellegrini (erano Marchese, sia la Gina che il Lillo; per ultimi negli anni 1950 erano tre fratelli, conosciutissimi in porto perché trasportatori e magazzinieri, solo citati da Franich tra le ditte che si occupavano di trasporti e che possedevano carri e cavalli (“Marchese F.lli – Sampierdarena”): tutte le mattine presto tre carri trainati da due cavalli partivano per il porto e ritorno, facendo una bella sfilata, finché i motori non soffocarono l’attività. Il Pagano/61 cita Marchese Luigi autotrasporti, al civ.35-6, ed al civ.69r Marchese f.lli carbone e legna. Sono ancora dei Marchese le stalle che si aprono in via Spaventa e che ancor ora ospitano dei cavalli, di privati).
MANISCALCHI Da sempre, l’uomo ha ferrato e custodito cavalli; da sempre quindi erano sparsi sulle vie principali i maniscalchi atti a ferrare l’animale e le ruote dei carri (fucina, mantice, martello, incudine e ferri vari). Decine, e poi centinaia di cavalli; e più cresceva la popolazione ed i lavori connessi, diventavano migliaia. Ed altrettanto numerosi i maniscalchi. Alla fine di via Mercato, ove ora è il civico 50 di via Cantore, la zona era tipicamente detta “le stalle”: erano baracchette basse, col tetto spiovente, ed ospitavano cavalli, forse anche muli, fieno e tutto l’occorrente. Alla Coscia, quello che diventò un deposito dei tram, prima era una grande stalla usa anche per il traino degli Omnibus. Ancora nel 1921, sulle quattro strade principali della città V.Emanuele, C.Colombo, UmbertoI, N.Daste, in 24h transitavano 2904 veicoli trainati (carri, carrozze, diligenze, tranvaietti, tombarelli, fiurgoni, ‘stamanoin’. Tanti dovevano essere allora gli stallieri, i fabbri e ferraioli. Vengono ricordate le imprese di trasporti, dei Carpaneto (quello dei dock), dei fratelli Rossi, i Robba, Bianchetti, Bagnasco, Bruzzone, Meirana, Lanati (con ‘il Domicilio’).
 dalla foto non è
possibile collocarli nella strada
dalla foto non è
possibile collocarli nella strada
Tra i tipici –e spesso a conduzione familiare, con i figli che imparavano il mestiere andando a militare come stallieri nelle scuole di cavalleria- vengono ricordati Ferrando Vincenzo, detto ‘Balla’ e poi il figlio Natale che lavoravano prima in piazza Omnibus, punto di passaggio anche per grandi viaggi, in Piemonte, Lombardia ed oltre (poi trasferiti in p.za Cavallotti e poi ancora in via NBarabino) La loro casa era punto di riferimento per i limiti stradali: vedi A pag.79 ; GB Civani detto ‘da o Bocca’, seguito dai figli Luigi e Celestino, con bottega in piazza Tubino e via del Mercato; gli Zuccoli, Dante coi figli; Guarneri Francesco con i figli Armando e Luigi che andarono ad aprire anche in Genova al Carmine.
Solo nel 1937 dovettero unirsi in cooperativa per l’eccessivo sviluppo dei mezzi a motore.
La parte a ponente della strada, ha il muraglione della ferrovia reso intoccabile perché i primi due binari limitrofi, pare siano da essere sempre liberi riservati dalle FFSS allo Stato per necessità sociali nazionali urgenti (guerre, disastri, ecc).
===89r c’era una fabbrica di sughero e tappi, di cui rimane la scritta - insegna ancora leggibile sopra le ampie entrate o saracinesche, Il palazzo ha il portone di ingresso in via Spaventa.

===97r Seguiva l’ingresso della fabbrica di poligrina, lisciva, varechina ed altri materiali per pulizie, di Gallino Severino che poi si trasferì a Rivarolo vicino al campo sportivo Torbella.
===civ. 35 con data 24 gennaio 1910, venne presentata domanda al Sindaco, firmata da Cazzullo Michele (su disegno del geom. P. Giacomardo), divenuto proprietario di un piccolo ‘apezzamento (sic)’ di terreno già di proprietà dei sigg. Scorza e Casanova per erigere lungo via Giordano Bruno una costruzione (=il civ.35) per abitazioni civili (costruiti pare per ospitare gli operai della vicina fabbrica del ghiaccio - che a sua volta era in via Spaventa. La nuova costruzione nella sua parte più a nord era sovrapposta ad un fossato proveniente dal monte a levante). Tra le clausole imposte dalla giunta comunale, c’è che il Cazzullo doveva “…coprire un fosso colatore destinato a ricevere gli scoli della casa in progetto e di quella Parodi (=civ. 37 già presente in quella data, ed eretta su terreno dei Ricca, proprietari della villa soprastante; questo caseggiato appare poi demolito nel 1949 e ricostruito nel 1951); nonché alla sistemazione della strada (mantenuta larga 10 metri) …” : era davanti a questo civico che viene descritta - sino a fine 1900 - l’esistenza di una bassa galleria – scolo fluviale sottopassante il parco ferroviario sino a via Fillak (un tunnel, evidentemente il fossato di cui sopra che raggiungeva il Polcevera e che con la sistemazione della rete fognaria, fu eliminato): nel 2002 la fessura non compare più, ed il muro appare chiuso con massi eguali agli altri da non rilevarsi nemmeno la traccia di aggiustamento rispetto l’insieme.
La facciata fu decorata con disegni di stile tardo liberty.
=== dopo il civ. 37 una rientranza verso est, lunga cento metri, ospita alcuni stabilimenti (che comprendono anche i civv. 37/39) tra cui il ‘Bon Jour industria dolciaria srl’ che aveva iniziato l’attività nella sovrastante

Belvedere (ove sovrasta l’insegna luminosa ben visibile giungendo in autostrada) e che ora amministrata da Emilio Sacco, con poche decine di dipendenti produce brioches e dolciumi, rifornendo supermercati e coop.
===civ. 39 e 41 : furono costruiti su terreno di proprietà Ricca, facoltosa famiglia locale proprietaria della villa soprastante il civ.49. (vedi foto a “Storia della strada, 1910”). Il primo, possiede delle decorazioni liberty in riquadri sovrapposti alle finestre e sul bordo del tetto, riproducenti rami di palma incrociati.
===civ. 43 cancello. Porta ad una casetta soprastante il 41 e raggiungibile-sulla cartina- da una apertura a nord del caseggiato (in pratica si passa dal retro della casa, nella rientranza su descritta).
===civ.49 In fondo alla via larga, limitato da un cancello, si apre -prima del restringimento della strada, percorso fiancheggiato dalla ferrovia- un viottolo che porta ad alcune ville soprastanti. Una, la più in alto e soggiogata dall’incombente ponte autostradale, fu già di proprietà Ricca, poi delle famiglie Carpaneto e Marasso. Fu resa famosa perché usata dalle Brigate Rosse, quando il 19 apr.1974 rapirono il magistrato Mario Sossi, sostituto procuratore della Repubblica, e lì lo ospitarono prigioniero (aveva svolto il ruolo di pubblico accusatore nel processo ad una banda di malviventi , detta “ XXII Ottobre”; fu liberato a Milano il 24 maggio successivo. L’atto, fu il preludio dei terribili e sanguinosi, definiti “anni di piombo”). Fu rimodernata e resa accessibile dall’alto dalla società Autostrade, ad uso circolo dei dipendenti del tratto Genova-Serravalle-
===civv. 51-51a: di altre due case, visibili dalla strada sottostante, una appare una casetta abbandonata di piccole dimensioni; l’altra è un casermone che è stato espropriato dalla soc. Autostrade, e chiuso. Invece è stato sfruttato a lungo negli anni 2001 dagli extracomunitari illegalmente ospiti in Italia, specie slavi e di colore: dopo svariato bliz della polizia, è stata murata negli accessi e cintata; però dal budello per raggiungere via della Pietra è ancor ora raggiungibile scavalcando il muro con una scala. Nella mattina del 30 lug. 2009 infatti, alcuni ‘inquilini abusivi’ son riusciti accidentalmente a dare fuoco alle loro masserizie, causando l’intervento della polizia e dei pompieri (che han fatto ‘piovere’ acqua dal ponte soprastante non potendo raggiungere la casa); due poveretti rifugiati sul tetto, furono salvati –mezzo intossicati- dai pompieri del nucleo di soccorso alpino/fluviale (i Saf).
Dopo la lunga stretta , limitata da due muraglioni che limitano la collina e la ferrovia, le ultime case prima di continuare con via della Pietra, arrivano ai civici 57 e 28.
===civ____la fabbrica di estintori soc.an.Minimax (apparecchi ed impianti contro l’incendio, a mano idrici, a schiuma, a tetra, a polvere a CO2 ), con sede a Genova. Era già attiva nel 1933 (quando si interessava anche di riscaldamento, combustori a nafta, caldaie per acqua calda, sanitari, banchi di stagno per bar e caffè).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio StoricoCom.Toponomastica, scheda 502 +
-Atlante demografico della città-Comune di Genova-1997
-AA.VV.-Contributo di SPd’Arena alla Resistenza.-PCGG.1997-pag.100-1
-AA.VV.-Il don Bosco nella storia urbana-DonBosco.1997-pag.37
-AA.VV.-annuario-guida archidiocesi ed./94-pag.388—ed./02-pag.426
-A.sconosciuto-Guida del porto di Genova-Pagano.1954-pag.274
-A.sconosciuto-dattiloscritto parrocchia s.Gaetano-don Bosco-pag.402.512
-Bettinotti M.-Glorie gastronomiche…-La Casana.2/1965- pag.20foto
-Ciliento B.-Gli scozzesi in piazza d’Armi-DeFerrari.1995-48cartina-9.50.93
-Dall’Aglio GA.-Mille anni di Liguria-Sagep.1999-pag.423
-DeLandolina GC – Sampierdarena - Rinascenza.1923 – pag.34
-Ferro G.-Toponomastica Ligure-Bozzi.1964-pag. 156
-Festa C.-Guida del porto di Genova-Luzzatti.1922-pag.135
-Franich E.-I carrettieri nella storia...-Sorbello.2002-pag.149
-Gazzettino S. : 1/79.5 + 9/79.12 + 6/80.3 + 9/80.7 + 2/82.10 + 7/83.11 + 9/83.5 + 4/89.12 + 6/89.6 + 2/90.1 + 2/92.7 + 7/92.7 + 6/94.13 + 9/95.9 + 1/96.5 + 03/04.3 +
-Il Secolo XIX del 12/01/00 + _/02/01 + 11/7/02 + 13/1/03 + 14/06/05 + 01.08.09 +
-Lamponi M.-Sampierdarena –LibroPiù.2002- pag. 129
-Lamponi M.-la storia di Rivarolo Ligure-Valenti.1975-pag.74
-Millefiore.Sborgi-Un’idea di città-CentroCivico SPdA.1986-pag. 141
-Miscosi G.-Genova e i suoi dintorni.Fabris 1937-pag.280
-Musitelli E.-Genova in guerra-Ass.N.VittimeCivili in Guerra-pag.197
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.17
-Pagano/40-pag.226---/61-pag.115.1123.1545
-Piastra W. &C-Dizionario biografico dei Liguri-Brigati.1992-vol.II-p.419
-Poleggi E. &F-Descrizione della città di Genova...-Sagep.1969-pag. 8
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10
-Rivista de A Compagna - *** pag.34
-Rocchiero V.– Derchi GB-Fassicomo.1987-pag.28
-Roscelli D.-Nicolò Barabino-soc.Universale.1982-pag.150
-Tuvo T. -SPd’Arena come eravamo-Mondani.1983-pag.67 foto parco
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.138
CAMPI via Campi
TARGA: via - Campi
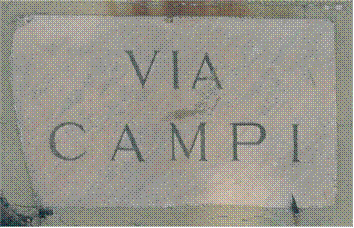


QUARTIERE ANTICO: San Martino
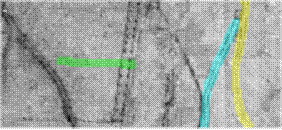
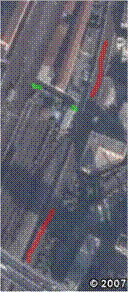
da MVinzoni, 1757. In giallo via Pietra; celeste da Google Earth 2007.
via Campasso; verde ipotetico tracciato di via In rosso via W.Fillak.
Campi
N° IMMATRICOLAZIONE: 2741 CATEGORIA 3
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA -n°: 10640
UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
CAP: 16159
PARROCCHIA: san Bartolomeo della Certosa (Rivarolo)
STORIA: La zona. Nei registri della Curia arcivescovile di Genova, ripetutamente si fa riferimento ad una località - facente parte della antica Curia di San Pier d’Arena negli anni attorno al 1140-60 -, chiamata ‘Glariolum’ (dal latino glarea ovvero ghiaia) relativa alla sabbia del torrente, in zona Campi (dalla stessa parola deriva anche il Geriato, torrente di Molassana).
É conosciuto che anche nei secoli posteriori, il greto del torrente era molto largo, senza argini, irregolare come può esserlo un capriccioso come il Polcevera con campi non coperti da terra ed erba ma da ciotoli, sabbia ed erbacce le più strane ed idrodipendenti
La strada. Il nome ovviamente deriva dal fatto che, per gli antichi abitanti del borgo tutta quella vasta zona - pressoché abbandonata ed estesa da ambedue le parti del torrente - fosse genericamente ‘i campi’. La strada segue un tracciato che dev’essere assai antico; attraversando i prati attorno al greto del torrente, era utilizzata per collegare le due sponde ai commerci locali o forse percorsa quasi solo dai carretti dei minolli e dei ‘massacan’ che andavano sul greto a raccogliere sabbia, e prese quindi così lo stesso nome (che però rimase più radicato nella parte a ponente del torrente, dove si conserva il nome Campi proprio come frazione della delegazione di Cornigliano; difatti quando il Comune di San Pier d’Arena alla fine del 1800 decise riordinare le strade dando un nome preciso a ciascuna, la proposta fu di “ via a Campi”).
Nel luglio 1884, istituita la Parrocchia anche a San Gaetano, la strada si presenta già frequentata e conosciuta, in quanto segnata come confine parrocchiale (presumibilmente perché ai fini parrocchiali interessano le case e non i terreni, i quali in quegli anni ed a nord della strada, erano ancora prati disabitati: “...confinia jam statuta et cognita, quae separabant auxiliaris ecclesiae s.Gajetani distructum a parochiali ecclesia sancti Bartolomaei de Certosa “ (i confini già stabilti e conosciuti, che separavano la chiesa ausiliaria e distrutta di s.Gaetano dalla chiesa di san Bartolomeo della Certosa)..., confini delimitati dalla via provinciale Vittorio Emanuele (via W.Fillak) , e la via “vulgo” del Glucosio (via Campi), oltre lo sbocco dell’attuale voltino, sino all’argine “in aex maedio fluminis usque ad punctum muri viae ferratae ” (dalla metà del fiume fino al punto del muraglione della strada ferrata).
Come sempre il nome a certe strade proveniva dall’edificio o proprietario o struttura che maggiormente richiamasse la conoscenza del popolo: così uno dei primi nomi che appaiono per definirla nostra strada, abbiamo letto essere stato “via del Glucosio” (vedi).
Pochi anni prima dell’anno 1900, il ponte di unione doveva essere già stato eretto, e fu proposto alla giunta comunale il nome di ‘via a Campi’, a “quella strada al Polcevera che da via Vittorio Emanuele lungo casa Bonardi, oltre la piazza d’Armi, porta al torrente”; permetteva il passaggio dei carri dal torrente alla via principale. Esisteva infatti un civ. 1 quale ‘casa Bonnardi’ ed un civ. 5 ‘casa Raggio Carlo’.
Nell’anno 1901 l’impresa Rebora Calvi Barabino, appose la targa in marmo con la scritta “via Campi”, quale è ora.
Nel 1910 c’era solo il civ. 1 (segnalando che “la parte pari è nel Comune di Rivarolo Ligure”). Negli anni prebellici (1910-4) , sul marciapiede di via Umberto I (via Fillak ) - di fronte a dove inizia la strada, a levante del ponte ferroviario ed a ridosso del muraglione della ferrovia - fu posto il gabbiotto del dazio (ma già esistevano vari ‘casotti del dazio’ tutti di proprietà comunale: nel 1890 vengono descritti uno Centrale; uno alla stazione ferroviaria, a porta Lanterna, alla Crociera, ed a Certosa, tutti con peso a bilico; altri presso il forte Crocetta ed a porta degli Angeli)
Essendo in quegli anni ancora il confine posto al “torrente Pietra” ovvero di via Brin dove ora scorre la metropolitana, questo limite daziale può aver favorito lo spostamento del confine a quel punto, essendo anche rimasto confine parrocchiale.
Nel Pagano 1919 si segnalano civv. non precisati l’officina meccanica di Cordone & Garattini – ancora presenti nel 1925; e quella identica di Remaggi Domenico e C. presente fino al ’33.
Nell’elenco delle strade edito dal Comune nel 1927, appaiono due ‘via Campi’: una a S.P.d’Arena (presumibilmente la metà a mare) ed una a Rivarolo (la metà a monte), ambedue di 5a categoria.
Della stessa categoria era ancora nel 1933.
Nel ‘50 era divenuta di 3a. categoria. Nel gennaio di quell’anno fu costruita una casa, per Ernesto Parodi, progettata dall’ing. Petrozzani: non è intuibile quale.
Nel 1946 fu costruito nuovo il civ. 4; nel 1951 il 13a ; nel 1957 il 15a.
Confini con Rivarolo. Attualmente il confine tra le due delegazioni, è misconosciuto a quasi tutti, perché ha perso interesse pratico; forse dovrebbe delimitare il campo di interventi dei Consigli di Circoscrizione ma di essi a San Pier d’Arena, ne sanno ben poco, e nella sede non esiste nessuna carta allo scopo. È comunque accertato che il centro carreggiata di via Campi rimane la attuale direttrice principale est-ovest di tale confine: dalla metà del torrente, alla sommità della collina, in quanto certe strade poste a levante del parco ferroviario e che prima erano parte del territorio sampierdarenese (via Frassinello, via della Pietra, via A.Ristori ecc.), ora non lo sono più.
Ma più anticamente, il confine tra Sampierdarena e la frazione Certosa di Rivarolo, era segnato -con andamento irregolare -, cento metri più a nord di questa linea.
Con l’inizio del secolo 1900, nacque una nuova gabella locale: il dazio. Ogni merce, nel passare questa barriera, doveva pagare una tassa; eluderla era accusa di contrabbando.
Dal Sindaco, nel 1904, venne proposto espropriare per causa di pubblica utilità ai proprietari dei terreni posti al confine, sia una striscia di terreno (al marchese Piuma, i cui terreni già in parte erano stati occupati dal parco del Campasso) atta al passaggio di una guardia daziaria e per porre un reticolato metallico; sia (ai proprietari Degola e Tubino) spazi necessari per costruire i casotti daziari - ad un piano al forte Crocetta per soli uffici, a due piani con abitazione; pare intuire non se ne fece nulla, anche per l’esosità della cifra da spendere.
Nell’ anno 1905 circa, sempre a seguito della gabella del dazio, nacque la necessità di porre una nuova cinta, detta “daziaria”, che rispecchiasse i confini territoriali di ogni Comune. Così, da questa parte della città popolarmente scritta ‘a notte’, un preciso confine - sia con Genova che con Rivarolo -, che dal forte Crocetta arrivasse al Polcevera, passando nella ‘frazione Pietra’, onde contrapporsi - con adeguata sorveglianza e garitte - al contrabbando.
Evidentemente sino alla messa in atto della cinta daziaria, il problema dei confini non era mai prima validamente esistito tra i vari Comuni.
Fu così rispolverato un verbale del 1890, stilato da parte di una Commissione censuaria ove erano stati tracciati i confini tra i due comuni: (‘col fine di un riordinamento della Imposta Fondiaria onde determinare in modo certo e stabile i confini del territorio’; stilato dalla Città di San Pier d’Arena, ed inviato alla provincia di Genova, al Comune di Rivarolo Ligure, alla Commissione Censuaria; furono invitati a presenziare i proprietari dei terreni confinanti; di San Pier D’Arena erano i sigg. Bonardi Giacomo, Degola Narciso, Monticelli Giambattista, Cappellano Luigi; ed i sigg. Raggio Carlo, Malatto Rodolfo, Bonardi Giacomo sconfinanti in ambedue i comuni). Nella riunione del 2 maggio 1905, si covenne che il confine iniziava da metà dell’alveo del torrente Polcevera - passava nel centro di via Campi fino oltrepassato il sottopasso ferroviario che la incrocia a metà circa - appena usciti dall’archivolto proseguiva lungo il muraglione posto a levante della ferrovia orientandosi così verso nord (attuale via Borsieri) - sino alla fine della proprietà Bonardi (la casa Bonardi aveva il civico 61 di via V.Emanuele e poi divenne 58 di via Umberto I; mentre la proprietà, confinava a nord con quella dei fratelli Traverso che si ritrovarono di Rivarolo (è visibile una cartina) - dove girando a levante lungo il muro di cinta posto tra le due proprietà (attuale via Frassinello) arrivava alla via Provinciale. Proseguendo di nuovo verso nord al centro di quest’ultima via (allora Vittorio Emanuele) - all’altezza dell’inizio del vico della Pietra (che portava al fossato omonimo, attuale via L.Ariosto) girava ad angolo retto verso levante nel mezzo del vico per seguire l’alveo del ‘rivo della Pietra’ (detto pure Cappellano, dal proprietario dei terreni confinanti, ed altrove chiamato anche Copello) - sino a dove ora è l’arco a sud dell’entrata della galleria della metropolitana - ed estendendosi in alto verso la sommità del monte fino al punto di origine del rivo, presso forte Tenaglia, laddove si incontrava con quello di Genova (la proprietà di SPd’Arena comprendeva anche una fascia di terreno a nord del rivo (strutturata a bosco, di proprietà demaniale del comune di Sampierdarena ed allora delimitata: a mare dalle proprietà dell’avvocato Filippi Antonio in basso, Pendola Ernesto sopra, e Galleano Pittaluga in alto; a nord –di Rivarolo quindi- dalla prorpietà di Bonino Clotilde in Pisano).
Nel maggio 1906 una prima lite: era appena finita la costruzione della galleria tranviaria che porta a DiNegro: per la sua costruzione era stato necessario spostare il letto del ‘Rivo della Pietra’ e -a lavori eseguiti- riportarlo nella sede primitiva perché linea di confine; nacque un piccolo contenzioso perché al nostro sindaco parve erroneamente che l’ingresso del tunnel fosse in territorio di San Pier d’Arena e pertanto propose porre la linea daziaria a nord di qualche metro dalla bocca d’entrata della galleria, e seguire il ‘fognone esistente in quella località e già detto di Copello’; l’Unione Italiana Tramways Elettrici rifacendosi al verbale del 1890 contrappose essere invece in territorio rivarolese, ed aveva ragione.
Nel marzo 1907, malgrado il verbale del 1890, ancora dovevano definirsi i confini precisi con Rivarolo: evidentemente esistevano delle contestazioni attualmente sconosciute.
Nel 1926, l’annessione delle delegazioni nella Grande Genova, pose fine alla ricerca lasciando strascichi irrisolti se si considera che le pubblicazioni del Comune di Genova, sia del servizio toponomastica edito nel 1950, che della ripartizione anagrafe-elezioni edito nel 1953, suddividendo la città in sestieri, rioni e delegazioni riportano ancora per via Argine del Polcevera essere di San Pier d’Arena dal civ. n.1 al 7 (mentre sono di Rivarolo oltre il 7); via Campi essere di San Pier d’Arena : ediz.1950 i numeri pari (Rivarolo i numeri dispari); ediz 1953 dal civ. 1 al 3 dispari e dal 2 al 6 pari (Rivarolo dal 5 alla fine dispari); per via Frassinello (non per niente anticamente chiamata “via del Confine’) essere di San Pier d’Arena il civ. 4 (di Rivarolo l’1); per via W.Fillak sono di San Pier d’Arena dal civ.1 al 37 e dal 2 al ediz.1950 : 66, edizione 1953 all’80 (di Rivarolo dal 39 e dall’82); per via A.Ristori essere di San Pier d’Arena, edizione 1950 tutta di San Pier d’Arena; edizione 1953 i numeri dispari e dal n.10 in poi solo pari ( di Rivarolo i numeri pari dal 2 all’8); per via della Pietra edizione 1950: a San Pier d’Arena tutta; edizione 1953, tutta la numerazione meno il n. 2 a Rivarolo.
Un po' più sorprendente è la constatazione che la ex circoscrizione comprende un territorio grosso modo coincidente con quello dell’antico comune: ed il confine a nord, segnalatoci dal Settore Statistico del comune, inizia sempre dal torrente a metà del ponte; segue via Campi, risale via W.Fillak verso il mare sino al viadotto dell’autostrada Genova-Savona (incluso, assieme ai civv. da 1 a 33 e da 2 a 80); a questo punto curva a 90° per seguire il tracciato dell’autosctrada verso il monte arrivando a forte Crocetta (incluso), salita al forte della Crocetta (inclusa) e forte Tenaglia (incluso). Facendo parte ora della Circoscrizione II “Centro Ovest” , comprendente anche san Teodoro ed Angeli, il confine attuale prosegue sino a Granarolo (civ. 129 incluso) ed al forte Begato incluso.
STRUTTURA:
da via W.Fillak, sottopassando tre rami delle ferrovie (in corrispondenza di due dei quali la strada non ha più marciapiede ed il pedone è abbandonato all’educazione del guidatore), arriva al greto del torrente Polcevera, nella cui prossimità si incrocia con via Argine Polcevera (vedi) e in direzione ponente si continua su un ponte che, attraversando il torrente arriva nella frazione omonima di Cornigliano (una volta questo ponte era assai trafficato, carrozzabile a senso alternato senza semaforo; da quando hanno aperto la superstrada lungo il torrente, è divenuto solo pedonale, impedite le auto da un alto scalino).


due dei tre sottopassi sbocco in via Perlasca
Doppio senso veicolare anche se con alternanza nei due sottopasso ferroviario.
Nella strada non vi sono negozi eccetto la rivendita di laterizi che però è sul ‘marciapiede’ di Rivarolo.
Appare servita da ambedue gli acquedotti, Nicolay e DeFerrari Galliera
CIVICI
2007=NERI=2-4-6 ROSSI= nessuno
Nel Pagano/40 la strada andava ‘da via delle Corporazioni a via Arg. Polcevera’; con descritti civici neri 2 e 6, 3.5.7.19.21.29 alcuni delle FFSS; e rossi 2,5,7 per rottam.ferro, cartoleria e latteria
Nel Pagano 1950 e 61 sono segnati una sola osteria al 3r di Olivieri R., ed alcune imprese artigianali; non bar né trattorie
===civ. 2 è un grosso caseggiato popolare, senza ‘fronzoli’ tipo terrazzi o decorazioni e probabilmente senza ascensore.
===civ.4 è una piccola casetta, aperta in uno slargo subito dopo il secondo sottopasso, e delimitata sulla strada da un alto muro che impedisce vedere se il retro è prato, orto, o altro.
===civ.6 è un cancello chiuso da lucchetto, tra le cui fessure è visibile una serie di vani tipo box, ad un solo piano, in completo stato di abbandono.
Caratteristica, a fianco del cancello, è una ennesima tomba stradale circondata da tanti fiori finti ed ormai sporchi, ben strutturata con lapide in marmo, croce ed intestazione ad un giovane dal nome arabo-mussulmano ma con simboli cristiani

BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale - palazzo Ducale
-ArchivioStorico Comunale - Toponomastica, scheda 509
-A.sconosciuto-dattiloscritto parrocchia s.Gaetano-s.Bosco-vol.I-pag.83
-AA.VV.-annuario-guida archidiocesi- ed./94-pag.389—ed.02-pag.426
-Belgrano LT-i registri della curia arcivesc.-S.Lig.St.Pat-vol II-pag. 703
-Comune di Ge.-Atlante demografico della città-V ediz.1998-pag39
-DeLandolina GC – Sampierdarena - Rinascenza.1922 – pag. 34
-Genova Rivista municipale: 3/33.
-Lamponi M.- Sampierdarena – LibroPiù.2002- pag.131
-Novella P.-Strade di Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.17
-Pagano/33-pag.245 -- /61-pag.117
-Stradario del Comune di Genova edito 1953-pag. 13.35.77.81.139.153
CANEPA lungomare Giuseppe Canepa
TARGA:
S.Pier d’Arena – lungomare - Giuseppe Canepa – giornalista-politico – 1865-1948
Una prima targa, con sopra tutto la scritta San Pier d’Arena; ed un’altra con solo
“Lungomare Canepa” nell’anno 2010 non ci sono più.

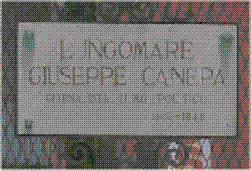
all’altezza di piazzetta dei Minolli
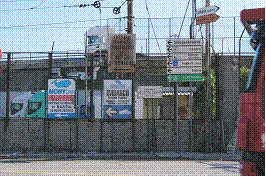

all’altezza della deviazione per via T.Molteni
all’altezza della deviazione per via T.Molteni
QUARTIERE ANTICO: Canto (- Castello) – Coscia
Non riproducibile la carta di M.Vinzoni, essendo il Lungomare sovrapoposto al mare.
N° IMMATRICOLAZIONE: (non assegnato)
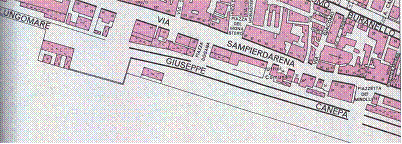 tratto a ponente sino p.tta Minolli
tratto a ponente sino p.tta Minolli
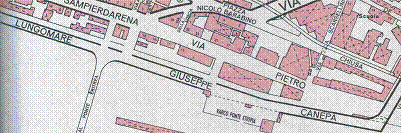 a levante sino rampa per autostrada
a levante sino rampa per autostrada
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 11220
UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 in rosso via San Pier d’Arena; in celeste strada elicoidale.
Da Google Earth 2007.
in rosso via San Pier d’Arena; in celeste strada elicoidale.
Da Google Earth 2007.
CAP: 16149
PARROCCHIA : dal 2 all8 rossi = s.Maria delle Grazie – il resto, s.Maria della Cella.
STORIA non ha storia questa strada, se non che prima di essa, c’era il mare. Nacque con il riempimento del litorale, col materiale conseguente alla demolizione del colle di san Benigno (due piccioni con una fava), processo iniziato una volta deciso di fare il porto davanti a San Pier d’Arena. Operazione tanto utile al porto di Genova, quanto deleteria per la città di San Pier d’Arena che perdette il contatto col mare. Prima di formare la strada, a lungo rimase un largo pianoro, di proprietà del Demanio, utilizzato come scalo merci e sosta autotreni, campo di atterraggio aerei, campo da football. Finché fu recintato e delimitata la strada che appartiene al Demanio ma in usufrutto al Comune per il transito di veicoli.

il primo palazzone a destra, è il retro del civico 4-6 di via SanPierd’Arena; a levante, non c’è ancora il civ.2 palazzina Bertorello; a ponente il palazzo in centro sarebbe il retro del civ.14 con –al suo immediato ponente- la palazzina del ClubNautico=civ.16 e, dietro, l’ex pretura nella piazza dei Minolli. Il palazzo a sin. sarebbe quindi il civ. 14 di via SPdA. Con dietro il campanile della Cella senza guglia= il ché pone la foto a cavallo tra fine 1800 e primi 1900. Da chiarire la casetta a mare
STRUTTURA:
la strada, dirigendosi da Genova verso ovest,
=inizia dalla fine del viadotto elicoidale dell’Autostrada (Camionale) in corrispondenza del varco di entrata e doganale a ponte Etiopia,


la strada, da fare foto 1976 del Gazzettino Sampierdarenese
e procede in rettilineo a monte della recinzione doganale, fino a che permette
=una prima deviazione a destra, per un breve tratto stradale anonimo ma di pertinenza della via San Pier d’Arena che viene intersecata (alla Topogr è scritto erroneamente ancora ‘in via N. Barabino’) per immettersi in via Molteni per la viabilità degli autoveicoli diretti al centro, o a Rivarolo o a ponente.
=prosegue in rettilineo verso il torrente, passando a mare della zona nuova della Fiumara, fino alla corrispondenza del varco al ponte Libia, ove la strada appare terminare, chiusa dall’ingresso di alcune imprese private (quest’ultimo tratto, nella Guida del Porto edita da Pagano nel 1954, è scritto chiamarsi “’via al Ponte Carlo Canepa’, dal termine della via Operai alla testata del ponte Carlo Canepa”).
Tutto il lungo rettilineo, ricalcando il limite spiaggia-mare, non è proprietà comunale ma è incluso in territorio di proprietà del CAP il quale in forma determinata si è posto al di à del muro di cinzione, ma che anche al di qua mantiene una quota di possesso.
È quindi riconosciuta una ‘comproprietà’ (il CAP del terreno ed il Comune dell’uso) - in attesa della realizzazione di un programma preciso riguardante tutta la zona sino al torrente -, che nei fatti
impedisce di gestire il manto stradale ed i bordi (per esempio allargarla, o abbattere quanto di fatiscente o utilizzare quanto già libero).


antiche presenze “al di là” del muro – 1941 campo da football e da atterraggio



i docks sampierdarenesi 1937-foto Pasteris- il muro ancora da erigere
Il traffico diretto a levante, proviene da via Pacinotti: può proseguire diritto per via SanPier d’Arena, o con uno slalom inserirsi nel Lungomare ove - al termine - si biforca (una verso l’autostrada, l’altra costeggiando il porto, passa a mare della Coscia e va verso la caserma dei Pompieri.
Quindi è una strada in rettilineo che consente ai veicoli un aumento della velocità con corrispondente rischio di incidenti gravi; ed essendo in prossimità del porto, è soggetta a parcheggi di grossi automezzi con conseguenze più volte mortali. Innumerevoli sono gli articoli che i giornali quotidiani segnalano in rapporto alla pericolosità della strada; non ultima è una relazione del Comune-Aster-CAP i quali promettono, non appena finita la realizzazione dell’opera fognaria bianca in corso, l’asfaltatura ed una revisione nei pressi di via Molteni. Ancora sul Secolo del 18.4.04 si preannuncia, in previsione del ‘giro ciclistico d’Italia’, per l’indomani, la asfaltatura dall’elicoidale alla rotonda.
Avrebbe dovuto essere coadiuvata da un prolungamento verso ponente della sopraelevata, già portato avanti ed esistente, e previsto sino circa alla zona dell’ aeroporto, ma poi il progetto venne accantonato.
Sono previsti invece importanti modifiche alla viabilità, non appena pronta la zona Fiumara.
==a lato mare scorre lungo la recinzione doganale; si aprono due varchi per entrare nel porto, chiamati: di ponte Etiopia a levante e di ponte Libia a ponente.

varco doganale Ponte Etiopia nel 1976
CIVICI (non tutti sono segnati esteriormente e quindi non è possibile assegnarli alle singole aperture)
2007 = NERI = 3, 55, 59 (mancano 1, 5→53, 57) e 2, 4.
ROSSI = 9r, 121r, 129r, 149r→155r (mancano 11→119, 123→127, 129→147) 2r→8r, 80r, 82r (mancano da 10→78)
Dei civici, risultano: eretto il civ.20 nel 1953 ; divenuto civ.rosso nel 1961) ; e demolito il civ.22 (’62)
=== il centro san Benigno
===civ.3 un grattacielo della Finanza ospitante il Comando nucleo regionale Polizia Tributaria della Liguria.
Si apre in via delle Fiamme Gialle
Così detto perché specifico e totalmente occupato dalla Prima Legione della Guardia di Finanza. Di 15 piani, alto 45m e lungo oltre 50; sorge su area demaniale del CAP di 1164 mq., concessa all’Arma militare e strutturato con i requisiti del “manufatto di importanza militare”, del quale è quindi impossibile avere dettagli perché caratterizzati ”da imprescindibili motivi di sicurezza passiva”). Ha sempre fatto sorridere - nella grandiosità di un grattacielo - l’idea di doverlo salire a piedi: eppure questo è successo nel maggio 2003 assieme al funzionamento dei condizionatori (si scrive per colpa della riduzione delle spese; ma ricevendo l’onore della cronaca).
Di fronte, sul lato di via P.Chiesa, nel 2000 esistevano ancora tracce dei binari ferroviari che percorrevano la strada.
La Guardia di Finanza comprende:
*4 ‘gruppi di sezioni’ Genova per settori tributari, tutti con gli stessi scopi finanziari, ma con particolari incarichi (I gruppo=giudiziari,contrabbando, ricettazione, ecc), II (verifiche alle aziende.ecc), III ( imprese minori, ecc.), IV (imprese maggiori , ecc.).
*il gruppo investigativo criminalità organizzata ‘Gico’;
*il gruppo operazione antidroga ;
*il gruppo repressione frodi e di sezioni .
*caserma dedicata a T. Testero (vedi in via P.Chiesa), costruita nel 1950 sul sedime di vecchi capannoni della soc. Grendi.
Ha sede nel grattacirelo anche il Circolo sportrivo GF diretto da Paolo Tagliaferri di judo facente parte della Federazione Italiana Judo-Arti Marziali
===La strada è fiancheggiata da piccoli edifici di imprese artigiane e piccole industrie, in un decoro di simil-abbandono baraccopoli.

il retro, con gioco bocce, del Club dei Carbonai di via P.Chiesa


dopo il distributore di benzina, che è a mare della “villa Buranello –civ.2” di via SPdArena, primo capannone è della I.F.N. forniture navali. Il palazzo dietro è il civ. 4-6 di via san Pier d’Arena. Foto marzo 2010.


officina aperta di via SPdA tra il civv. 6 e 8 officina, posta nel retro del civ.8 di
foto 2010 via San Pier d’Arena


foto 2010 in angolo con piazza dei Minolli capannone
già dei “Trasporti Ferrini” (non ci sono nei
Pagano); ?-Foggia-Genova-Pescara – Foto 2010


autotrasporti Ferrini in angolo a mare del palazzo Municipale Foto 2007
con piazza dei Minolli

a mare del Palazzo del Sale . foto 2010
===A livello del Palazzo del Sale, la bocciofila ‘soc. Carlo Bottino’ CPS (il professore fondatore del centro petanque sportivo sampierdarenese) forte di 300 iscritti; essi hanno ricuperato con lavoro di volontariato ben diciannove campi esterni per il gioco delle bocce e della petanque (questa si differenzia per l’irregolarità del terreno, dimensioni ridotte delle bocce, minore movimento ma maggiori difficoltà), ed otto campi interni (anche se sono in attesa di regolarizzare la sistemazione all’interno del grosso edificio a cui si appoggiano).
Il Club, fondato nel 1975, paga al CAP l’affitto del terreno: all’inizio la cifra era simbolica ma dal 1985 è un vero affitto precario. Dai campetti, sono emersi campioni arrivati quarti ai mondiali e secondi in Italia nel 1985.





Lungo la strada, dove anche atterravano dei caccia militari, fu aperto un campo di calcio, in sostituzione di quello chiuso nel retro di villa Scassi; e fu intitolato a Bertorello. Anche questo campo fu eliminato per occupazione del terreno da parte delle attività portuali; e il gioco fu indirizzato a Cornigliano determinando che San Pier d’Arena rimase senza alcun stadio, fino all’apertura del Morgavi .
Nello slargo, negli anni dopoguerra e prima che la TV chiudesse la gente in casa, c’erano due ‘arene’ ovvero due baracche con un palcoscenico e poche sedie o panche, ospitanti due comici locali in concorrenza nell’inventare battute per far ridere soprattutto i bambini: Fagiolino e Padella (vedi a Pavanello).


1970 circa - verso levante; a sinistra il benzinaio che stesso punto, verso ponente
serviva nel punto di raccordo con via Molteni
Nel tratto finale, la strada era costeggiata a monte dalla facciata a mare delle fatiscenti costruzioni dell’Ansaldo,

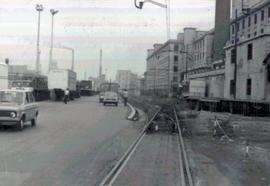
tra i quali anche quello chiamato “proiettificio”. Esso ora è stato completamente rimodernato; la fonderia aveva una grossa ciminiera prospiciente la strada, e di cui fino al 1999 era rimasta solo la base, in attesa della completa demolizione. A metà del 2005 appare in fase finale di ristrutturazione e già parzialmente occupato.





proiettificio con ciminiera residuo 2008


proiettificio, facciata a mare facciata in via Fiumara
===civ.151r Nel 2010, a questa altezza, corrispondente al palazzo col tetto a scala dell’AMGA Energia, la cui ta targhetta al cancello segnalava CAE (Centrale Amga Energia) di cogenerazione, via Lungomare Canepa. Essa, nel 2010 è diventata soc. Iride.

La strada si biforca. Forse ambedue i rami appartiengono al Lungomare essendo anonimi.


muraglione di confine col torrente.Foto 2007
In particolare:
--- il ramo più a monte (aperto definitivamente solo quando nel 2003-4 fu ristrutturata la Fiumara), procede per un centinaio di metri fino ad una aiuola rotonda alla cui destra ci si immette in via P.Mantovani. Procedendo diritti, si costeggiando il fianco del Vaillant Palace (foto c) quando la strada di triforca: la corsia centrale porta ad un terrazzamento dietro il Valliant e finisce in esso; -quella di destra – senso unico - compie un anello verso ovest e ritorna nella terza corsia. Quest’ultima, prima fiancheggia un’area di proprietà delle Ferrovie che è in fase di ristrutturazione (foto a); poi i residui delle quattro arcate dell’antico ponte che poprtava la ferrovia sotto Coronata.


foto a) 2010 spiazzo, posto dietro il muretto rosso della foto b

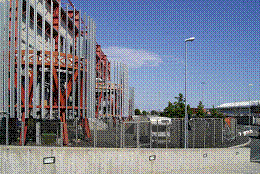
foto b foto c)
---La corsia a mare, dopo un centinaio di metri nei quali costeggia una doppia linea ferroviaria in disuso (foto b), a sua volta si divide in due rami:
-quello a mare va a chiudersi ai cancelli del Terminal dei Messina gestito dai fratelli Gianfranco, Giorgio e Paolo. Così si completa da alcuni anni la strada, arrivando al terminal container; il cui accesso è simile ad un vasto casello autostradale che controlla un traffico di alcune centinaia di camion e treni in entrata ed uscita. Il 21 dic.2000 si segnalava lo storico imbarco del milionesimo container, dall’inizio attività nel 1996.
-quello diritto,
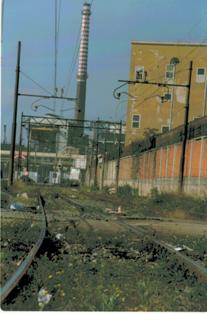

finisce in uno spiazzo che, nel 2010 è ‘privato’ e quindi chiuso alla gente. Ci passano grossi camion della ditta Spinelli che, dopo averla traversata proseguono su un ponte ad una sola corsia, il quale traversa il torrente per arrivare nell’area riservata a questo trasportatore.-Da questa piazzetta ancora nel 2009 (a ponente del muro che delimita la proprietà Messina con il suo ‘casello’), si arrivava al greto del torrente nei pressi della sua foce; a destra si andava sul greto vero e proprio; a sinistra si percorreva una stradina la quale - senza una targa stradale specifica - corrispondeva alla “via Lungo Argine del Polcevera”: passando sotto le arcate di un ponte ferroviario in disuso del quale una parte fu chiamata “strada del Papa” (vedi via AdPolcevera) -sempre per concessione del CAP- avevano una sede (ed ora sfrattati) i numerosi atleti della società ‘UGES Esperia’ (dapprima ospitati in ponte Canepa e poi trasferiti sulla sponda sinistra del torrente ove in alcune baracche hanno gli spogliatoi, le attrezzature, i gozzi, le jole ed altre barche, ma non una palestra; dapprima con ufficio presso il bar Foglino in via Sampierdarena, ora in via Mamiani, 13r; nata l’11 nov 1953 attorno ad un tavolino del bar Lino (o Foglino, ex Monica) al Canto, per volontà di dieci concittadini amanti dello sport del canottaggio, che diedero il via a giovani atleti capaci di vincere innumerevoli trofei tra cui il Torneo dei Rioni nel ‘54 e ponendosi in posizioni da podio nel Palio di san Pietro (primi alla prima edizione), palio del Levante, e con rappresentanti vogatori nel Palio delle Repubbliche.
Vi aveva sede e spiazzo di attracco anche il Club Nautico Sampierdarena e gli ultimi pescatori , i sopravvissuti di generazioni e generazioni di lavoratori che hanno vissuto sulla nostra spiaggia facendo il pescatore professionale senza mutua né pensione sociale: partono da qui per arrivare alla diga o nell’interno di essa, alla ricerca di quella microscopica porzione di mare raggiungibile dalla foce del torrente, per amore atavico dell’onda, della salsedine, dell’antica sfida con la natura, circondati da concittadini molti “foresti”, gli unici a loro agio che del mare non hanno traccia né odore né passione del rumore di risacca. Purtroppo –nel maggio 2005- pare per difetto del depuratore, la foce del torrente è pura fogna, con l’odore e colore conseguente: ovvio per chi mette in mare uno scafo, lo schifo dell’acqua e la preoccupazione anche della “loppa” (scarto finale della lavorazione dell’acciaio, che anni addietro veniva venduta per essere riciclata e che invece ora –pare dalla acciaieria di Cornigliano- venga gettata in mare).
Il rettilineo di Lungomare è la quarta via in orizzontale, che graticcia la città e permette un parziale ma basilare sollievo al traffico stradale, soprattutto per il transito dei veicoli pesanti. Tutta la strada alla sera si rianima, ed è ospite di ‘farfalle’, scaricatori abusivi di detriti, malavitosi in genere, abusivi extracomunitari in cerca di un asilo.
Come già accennato, la strada diverrà oggetto di prossime sostanziali trasformazioni, quando a ponente verranno ultimati il quartiere Fiumara e l’incrocio viario con la Valpolcevera, ed a levante verrà realizzato il transito di attraversamento del centro con un ponte o un tunnel.
Dopo l’ anno 2000, numerose sono le segnalazioni di dissesto stradale concausa di innumerevoli incidenti anche mortali. Nonostante apparenti accordi (5/02, 10.02.03, 15.4.03) tra tutti gli enti, il bisticcio di competenze appare così ingarbugliato che passano gli anni e nulla o a singhiozzo viene fatto in pratica (sindaco, assessori, autorità portuale, aster, c.d.c.), con il classico “la situazione non è sopportabile oltre” (asfaltatura, segnaletica, canali di scolo (non ci sono caditoie), posteggi). ‘Strada da terzo mondo’.
Tutta la strada , nel 2003 è ancora in attesa di realizzazioni a vasto respiro di viabilità. Il progetto (curato dall’Anas con la collaborazione del Comune, Provincia, regione, CAP, ed approvazione verbale del Ministero delle OOPP che però non ha firmato l’autorizzazione) di trasformare la strada in una struttura di smaltimento veloce del traffico, con accessi al porto ed alle strutture limitrofe, è bloccato dalla carenza dei soldi: nel 1993 di fronte ai previsti 144 miliardi di vecchie lire, era ferma alla cifra di 85. Finalmente ai fine aprile03 un giudice stabilì che ‘per pubblica incolumità’: il Comune doveva addossarsi la priorità delle spese della strada anche se di proprietà del Cap (e data da esso in gestione al Consorzio san Benigno). Nel 04.2003 si prevedevano 220mila euro (sic) a carico del Comune e 60mila (sic) a carico del CAP, ma appena convenuto ci si è accorti che la cifra era già in deficit e quindi, da rifare i conti (per 5,5 km. fino a Multedo, verifiche geologiche, due corsie per senso di marcia, corsia di emergenza; svincoli, riorganizzazione ferroviaria: il Comune ha previsto 500milioni di e., di cui uno stanziato dall’Anas per le prime verifiche).
A fine marzo 03 doveva transitarvi il Giro dell’Appennino, ma un sopralluogo della polizia municipale confermava una situazione per cui ‘le voragini di cui è disseminato l’asfalto non garantiscono le condizioni minime di sicurezza’. Lo stesso a maggio subito dopo, quando programmando una tappa del giro ciclistico d’Italia la polizia municipale negò l’autorizzazione al transito per eccesso di pericolosità.
A settembre 03 l’annuncio: ‘via ai lavori’ con un giro di centinaia di migliaia di eutro, tra Autorità Portuale e Comune.
Ancora nel 2004 si scava per regolarizzare lo scarico delle acque bianche: sui giornali –col titolo ‘la beffa’- della strada si parla solo per segnalare gravi incidenti stradali e per i ‘rattoppi’ al manto stradale che rendono pericolosissimo il percorso ai motocicli specie quando piove e le buche si riempono d’acqua. Lunga la polemica e gli scritti dei cittadini, anche di fronte a due incidenti mortali (magari non legati direttamente alla sola pavimentazione ma anche alla segnaletica, al buio, alle vie laterali di immissione ecc). Duro il rapporto della polizia municipale: ‘strada da chiudere perché carente del minimo di sicurezza’. Due recenti sentenze hanno dato torto al Comune, dichiarato ‘responsabile della sicurezza stradale, indipendentemente dalla proprietà’. Scrive giusto il giornalista del Secolo: come nelle soap opera della tv, anche se perdi quattro o cinque puntate, cambia nulla.
Nel marzo 2005 si scrive di un muretto limitante un tetto di un edificio ad un piano, parzialmente crollato e lasciato lì, transennato.
Il nome è stranamente condiviso con una ‘via’ voltrese***; qui, la via fu così denominata con delibera del consiglio comunale, l’8 apr.1952.
La polemica nasce quando hanno deciso di chiamarlo “lungomare” : i miei concittadini dovrebbero partecipare alla rabbia di essere presi ulteriormente in giro: aver distrutto la spiaggia con l’erezione del porto quale necessità pubblica per Genova, non esclude il concetto che per avere un bene, si abbia il diritto di distruggere ed addirittura snaturare nella sua parte più bella la città di San Pier d’Arena: è sempre stata una città di mare, ed adesso col mare non ha più nulla a che vedere, murata lontana da esso dietro una barriera di cemento e mattoni, e che di lungomare ha solo il nome beffardo. I sampierdarenesi sono diventati come i piemontesi: andare a nuotare in piscina (se funziona); ma se vogliono vedere il mare debbono prendere un pullman, anche loro con quella faccia un po’ così… tra il meridionale ed il colombiano...
STORIA:
Da sempre, ma in pratica da oltre mille anni, dalla sua nascita di borgo, San Pier d’Arena visse in funzione della sua spiaggia.
Sull’arenile avveniva praticamente tutto quello che era vita e sopravvivenza: anche se non perfettamente strutturate, c’era ‘tutto come a Genova’:
la natura (Giustiniani (negli Annali,1535) scrive “chi volesse compiutamente narrare l’opportunità, la magnificenza e la nobiltà di questa villa sarebbe necessario forse un volume. Contiene questa Pieve una spiaggia lunga un grosso miglio tanto comoda al varar delle navi che non potrebbe esser più, e par che la natura l’abbia fabbricata a questo effetto… i forestieri…essendo a Sampierdarena credono di essere a Genova…”; GB Gonfalonieri (1592) scrive che era “una vaghissima contrada rurale, in pianura ed in collina, intersecata da bellissimi giardini…”; Accinelli (1774) : “si passa al borgo di Sampierdarena che si estende longi la riva del mare per un miglio, il più sontuoso borgo di tutta l’Italia.”; Bertolotti Davide (1834) “i palazzi di cui si adorna il borgo di Sampierdarena basterebbero a far rimbellire una metropoli…” ;
lo spettacolo Nel 1097 partì dall’Europa la prima vera crociata; gli eserciti di Lorena, di Germania e parte di Francia si riunirono anche qui per imbarcarsi verso la Terrasanta assieme a Guglielmo Embriaco. Il 18 lug.1242, ben 132 galeazze e tre grosse navi armate (Novella dice “83 galee, 13 torride e 3 onerarie, tutte colorate di bianco colla croce vermiglia”) si schierarono lungo la spiaggia e furono passate in rassegna dal podestà genovese Corrado di Concessio, pronte a partire per vendicare un attacco subito dai pisani. Penultimo, Napoleone stesso si ritrovò a San Pier d’Arena per far marciare e far fare evoluzioni su questo litorale a 4mila suoi fanti; ultimo lo stadio da foot-ball, ospitato qui per qualche anno, come già scritto sopra. Meno clamorosi, ma pur sempre ludici, Padella e Fagiolino col loro spettacolo di clown. Ed ultimissimo, lo spettacolo che sta dando la nuova etichetta alla città: farfalle, trans, clandestini, spacciatori, malavitosi...sic transit...
le difese (le 7 torri saracene medievali e le guardie che a ronda sorvegliavano il litorale; poco delle autorità locali alla Lanterna; posta proprio al confine territoriale, è più proprietà di Genova. Ancora ben visibili invece le torri cinquecentesche delle ville dell’epoca posteriore ai guelfi-ghibellini);
le calate per carico e scarico di merci (ad iniziare dalla Cella fino al Calandrino della Coscia);
i capitani di navi famosi nel mondo alla pari dei camoglini. Tra essi i Casanova (sottodescriti); Ratto ( da cap. dei Dallorso, acquistò in proprio uno scafo che comandò e chiamò col proprio nome usandolo per trasporto di ale dalla Sardegna);
Quasi tutti i capitani erano anche gli armatori – o almeno ne avevano in famiglia-.
--degli armatori e capitani =Acquarone Giovanni (del brick ‘Queirolo’ e della nave ‘Cristina’); =Tixi B (del ‘F.Tixi’); =Timossi GB (dello ship ‘Callao’); =DeAndreis T (dello ship ‘Bell’avvenire’); =Gambaro Angelo (dell’Angelo’); =Bertorello (della ‘Nanan’ portata verso Pensacola); =Casale Bartolomeo; nonché dei:
=Dallorso Matellin, capostipite della famiglia chiavarese, trafficando in trasporto ardesie e grano, preferì venire ad abitare a San Pier d’Arena. Ebbe cinque figli (il primogenito nato a Chiavari; gli altri 4 nati qui; tutti capitani di navi): Matteo (che divenne energico direttore di una casa granaria marsigliese); Giacomo (che diresse la casa a Berdiannsck, ove trafficavano in grano ben 40 bastimenti); Sebastiano (che fece il contabile); Pietro (famoso come ‘granatino’ a piazza Banchi); e Salvatore (ricordato per bontà d’animo ed anche quale animatore –con famosi ‘chatillons’-, nello scagno di piazza sanLuca, palazzo dei Brignole). I loro bastimenti furono costruiti pressoché tutti a sestri.
=dei tre fratelli Casanova, Nicolò (anche lui si dovette trasferire a Sestri); Guglielmo; più famoso di essi fu Francesco, 1778-1848, abilissimo lavoratore con l’ascia ed il cartabono. Aveva iniziato a navigare da bambino con uno zio ed imparato il mestiere lavorando a Tolone per conto dell’imperatore. Fu il primo della famiglia a rendersi autonomo nel costruire sulla nostra spiaggia bastimenti di mezza e grossa portata, ed anche ad essere fondatore della famiglia armatoriale. Era volgarmente chiamato ‘capitan giastemma’ perché –seppur mite e di bontà estrema-, non sapeva comporre una frase senza ricorrere –tremendo!- al nome di santi o anche ‘più su’.
il brick ‘Francesco Casanova’ , ‘, ‘Luigi Casanova’. Con cantiere nella ‘zona della Catena’ (vedi via-) , limitrofa alla Coscia, aveva varato i suoi bastimenti che ebbero nome: bombarda ‘San Salvatore’; ship ‘l’Orco’ (affondato in Atlantico, aveva cap. B.Gambaro. vi figuravano vari caratisti).; la polacca ‘Intraprendenza’. A terra, abitava una casa sulla riva del mare, a livello dell’ex proprietà degli Spinola (pag.143); e risulta essere stato il primo presidente della soc. Unione Umanitaria.
Fu capostipite di famosi comandanti di navi, abili lupi di mare che per la loro audacia e capacità manovriere, ebbero più volte risonanza internazionale nella stampa marittima: tra essi i figli Guglielmo ( omonimo dello zio?- i cantieri del padre –quando le redini passarono nelle sue mani- furono trasferiti a Sestri poiché la spiaggia iniziò ad essere invasa dagli stabilimenti meccanici : arrivato sulla cinquantina, verso il 1870 impostò a SestriP. un grande e veloce veliero, il ‘Luigi Casanova’ di 1700 t., da comandare personalmente per rotte verso l’America del Sud, munito di 16 comode cabine per passeggeri di classe, biblioteca, pianoforte e distillatore dell’acqua); LuigiFrancesco (1847-1902, da bambino sulle navi comandate dal padre, studiò nautica a Genova divenendo Capitano di LungoCorso prima ancora dei vent’anni; a 24 anni era già capitano di velieri come il CleliaCasanova, il LuigiCasanova, il Sampierdarena, l’Orco, per 15 anni il BiancaCasanova. Divenne suocero del com. Davide Chiossone), Martino, Salvatore (questi navigò per ltre 47 anni su tutti gli oceani, anche sulla nave ‘Salvatore’ dei Dallorso; comandò lo ship ‘Martino Casanova’ attraversando l’oceano per 5 volte senza mai entrare nel Mediterraneo, tornando a casa dopo sei lunghi anni).
Bastimenti dei figli, molti varati in San Pier d’Arena furono: il veliero ‘Sampierdarena’ (di 1800 t.; partita da Cadice al comando del cap. Lorenzo Canevari, carica di sale, per Buenos Ayres, scomparve nell’Atlantico); lo ship Sorpresa’ che fu comandata da Francesco figlio in persona (effettuò in pieno Atlantico un difficile salvataggio di una nave inglese guadagnandosi una medaglia d’argento al valore, ed un cronometro d’oro con la sigla imperiale) ed anche da Martino (per viaggi nel Pacifico, sia di passeggeri che mercanzie); ‘Bianca Casanova’ (ship divenuto famoso per velocità, fortuna -tanto che era leggenda di marinai avesse stretto contratto con gli spiriti abitanti Capo Horn- e regolarità nelle sue innumerevoli traversate verso il Pacifico. Da S.Francisco di California, portava grano in Inghilterra, ad Amsterdam ed a Genova. Lo comandò a lungo LuigiFrancesco conquistatore di una specie di record di velocità, con gli elogi della stampa marittima); lo ship ‘Caterina Casanova’ (di 1600 t., che viaggiò verso le Indie al comando di Martino e del cap. Gaggero, pegliese); lo ship ‘Martino Casanova’ di 1200 t.; gli ship ‘Barba Luigi’
‘Ausonia Casanova’ ,’Clelia Casanova’ tutti tra i 1200 e 1400 t..
Navi della loro flotta, non varate qui, furono: ‘Angelo Casanova’ ex Mana-Loa; ‘Luigi Casanova’ varato a Sestri.
=i fratelli Devoto furono famiglia che nel periodo risorgimentale, essendo fedeli mazziniani, fecero costruire 4 scafi da 1000 t. coi nomi a chiave: ‘Solo’, ‘Unico’, ‘Scopo’, ‘Giuseppe Mazzini’. Questa successione non passò inosservata e fu oggetto di denuncia al Consolato del mare che li costrinse a cambiare nome all’ultima: essi la battezzarono ‘Speranza’ che però andò perduta in un viaggio verso la Guinea. La prima fu adibita a viaggi verso Pensacola; la seconda andò perduta in viaggio verso Deal; la terza, comandata da uno di loro Luigi (che già all’età di nove anni era a navigare; ebbe una medaglia per eroici salvataggio di equipaggio norvegese) Invece Giacomo (fu capitano del brig. ‘Nettuno’ che trafficava col Brasile); Francesco (viaggiatore verso le Indie, accompagnato dalla moglie alla quale aveva insegnato l’uso dei macchinari di calcolo nautico). Un altro Luigi, probabile figlio di uno dei cinque, divenne un colto avvocato, esperto nel diritto marittimo, con posizione assai onorifica nel Porto genovese. Conoscitore di cinque lingue -latino, franc.ingl,ted,spagn- fu piùvolte arbitro in difficili questioni di diritto internazionale.
Lunghissimo è l’elenco -descritto da Ferrari- dei capitani di velieri, e lunghissimo diverrebbe se aggiungessimo i secondi, i marinai e macchinisti, in un borgo che viveva sul mare. tra essi ne annotiamo solo alcuni rappresentativi per altri versi: un Mosè Galleano che potrebbe essere della famiglia che dava toponimo ad una zona vicino alla Cella o al Campasso; Cipollina, che fabbricò ed abitò il civ. 8 di via Carzino; Giacomo Bove, a cui fu intitolata una strada.
le guerre nel 1527 il borgo fu saccheggiato dagli spagnoli sbarcati dal mare; nel 1684 quando i paesani respinsero un tentativo di sbarco dei francesi di Luigi XIV e ne subirono il bombardamento con discreti danni; nel 1797 e nell’assedio del 1800 la spiaggia era punto dei tentativi di forzare il blocco navale inglese;
i cantieri navali (Genova, da medievale a fine del 1800, non avrebbe potuto essere Genova, se anche San Pier d’Arena non le avesse fornito le navi.
--1248, 15 luglio (Regesti di valPolcev. II. Pag.240) in Genova, Oberto di Camilla confessa a Ottolino d’Alamanno d’aver speso nella costruzione della nave chiamata Bonaventura che costrusse presso Sampierdarena –e nel corredo e nelle necessità di esse- all’inizio della costruzione- £ 300 di reali coronati di Marsiglia, sborsate dalla proprie tasche.
--1254, 29 marz (Regesti vP II p.247) Vassallo Basso di Langasco promette a Lanfranco di Campomorone di fare metà dei pennoni di una galea che costruisce maestro Oberto di Giardino, e promette di consegnarli finiti sulla spiaggia di sampierdarena entro la metà di aprile prossimo venturo.
Gatti scrive “dal XV sec... il centro più importante è da tempo SPd’Arena, dove abita la maggioranza delle maestranze e che è il vero cantiere della capitale sia per le galee private sia per le navi di maggiore dimensione...Varazze è il cantiere più attivo delle Riviere, caratterizzato da una continuità..che lo apparenta solo a S.Pier d’Arena...solo S.Pier d’Arena e Varazze hanno avuto continuità di attività costruttiva capace di sostenere gruppi di maestranze relativamente fissi alle dipendenze di un capo maestro.
Gatti scrive che nel medioevo, “le costruzioni di galee avvengono, si può dire, su qualunque spiaggia disponibile, ma soprattutto a S:Pier d’Arena e nello stesso porto della capitale” (quasi tutte private: il Comune –nella necessità- ricorreva al noleggio). A pag 38, la stessa Gatti, vagamente accenna negli anni 1670 ad un cantiere? di demolizione a S.Pier d’Arena: una grossa nave ‘nata male’ perché -nel cantiere di varo (Varazze)- era stato usato legname non idoneo (cerro, faggio, pino, pioppo), e che marciva (mentre è più forte il rovere). La fornitura del legname, dapprima era nell’ambito della Repubblica ma ben presto ci si avvide che economicamente il trasporto poteva essere più vantaggioso anche da zone più lontane (val Polcevera, che si esaurisce nel 1650; Voltri o Rossiglione fino al 1700; Sassello e Corsica nel 1700).
--1405, 16 gennaio: al maestro d’ascia Bertoldo de Casali, un imprenditore di Portovenere ordina per un prezzo di 165 lire una galeotta da costruirsi in 75 giorni e da vararsi a rischio del maestro, sulla nostra spiaggia. La barca è prevista lunga –da ruota a ruota- 25 goe (18,59m) e larga in coperta 11 palmi e ¼ (2,79m) ed al piano fondo 6 palmi (1,49m); avrà tre timoni: uno poppiere (detto baonense) e due latini ai lati di poppa; due banchi, per quattro rematori a prua e per tre a poppa. Nel contratto si stabilisce che il corpo saràrinforzato da ‘quatuor bonis catenis’ ovvero bagli di ferro; il legname sarà di quercia stagionata escluso la coperta prevista di pino escluso una tavola di quercia che farà da banda presso il trincarino.
--1415, 7 maggio-Leonardo di Campofregoso dice che al tempo del q Antonio DeGoarcho fece costruire nave in Sancto Petro arene; allo scopo tagliò molti alberi ‘in terra Sexini’ ‘pro constructione et fabricatione dicte navis que arbore valebant libras sexcentas Ianuinorum’, Cipollina Regesti di ValPolcevera;notaio FogliettaPaolo a pag. 256
--1449 18 genn. Sempre sul Regesti (II.279), si legge che Sireto da Vultabio di Genova, vende ai genovesi Barbaba e Oliverio Calvi la carena e la ruota di una nave da lui cominciata sulla spiaggia di SPdA, assieme a tutto il legname che dovrà giungere sul sito pel perfezionamento della medesima.
--Un atto datato 1472, segnala che Benedetto deMarini, cofinanziato da due Spinola (ciascuno 25%) fa costuire ‘balenierum unum, sive navem unam’ (il baleniero nel medioevo, era una lunga nave a remi, di origine basca)
--1571 riporta O.Grosso che Gerolamo Sambuceti maestro di navi (ebbe due figli, Leonardo e GioMaria, anch’essi intagliatori) e Niccolò di Pelo si occuparono della poppa della Real Galera messa sullo scalo di Sampierdarena per il re di Spagna, a somoglianza di quelle dei Lomellini e degli Spinola
--1599 una galea pubblica, è incaricata di prestare aiuto ad una nave pronta a vararsi, tirandola dal mare verso l’acqua (‘auxilium in deducenda navi confecta in litore Sancti Petri Arene’).
--Nello stesso anno -a marzo- è in via di completamento un galeone -ordinato il 15 novembre di due anni prima- da Cesare Lomellini, pagato 78.800 lire. Il ‘faber ferrarius’ Battista Ratto (figlio di Defendino, anche lui fabbro ferraio) si impegna a consegnare per settembre elementi in ferro necessari per il timone (‘fulcimenta ferrea que erunt necessaria per fulciendo timone’); la nave sarà battezzata San Francesco da Paola
--nello stesso periodo, 1582 i calafati erano riuniti in associazione, guidata dai maestri che sceglievono a comandare quattro consoli (2 di Genova, uno di SPd’A, uno di Camogli)
--1627, 19 febbraio: viene ordinata la costruzione di un galeone dagli eredi di Giacomo DeMarini. Poiché dovevano esserci altri scafi in cantiere, questo è precisato essere ‘primus in ordine existens a parte occidentalis, prope (davanti) palatium m.ci Georgii Grimaldi..
--1632 il magistrato dell’Arsenale propone finanziare otto galeoni da 2000-25500 salme (475-600 t), da poi affittare a privati in cambio di un 5% annuo delle spese sostenute: di essi le due maggiori da far costruire sulla nostra spiaggia.
--negli anni 1675 lavorava ad una nave del cap. Viviano imprenditore, il maestro d’ascia settantenne varazzino Antonio Fava fu PietroGirolamo ( Fava, fu una famiglia di maestri d’ascia)
--1723: il marchese Antonio M.Montanari fa costruire una fregata -ad uso mercantile-, chiamata Santa Maria e che sarà comandata da Antonio M.Rolla.
--1729 viene citato il maestro Tixe Michele, che costruisce una nave
--1788 vieve costruita una nave a S.Pier d’Arena, battezzata ‘Santa Maria degli Angeli’: per costruirla erano stati necessario del legname (al prezzo di lire 3 al piede), comprato a SestriP e portato sulla spiaggia per mezzo di carri; il cantiere ne aveva ordinato 1800 piedi per farne altre due, la ‘Pace’ e ‘la Speranza’. Erano capo maestro il sessantenne GB Briasco fu Francesco, ed il trentaduenne maestro d’ascia Francesco Savignone di Giuseppe.
Si segnala che nel 1830 ancora ma unica fu varato una bombarda sulla nostra spiaggia, probabilmente di tonnellaggio di poco inferiore a 100t.
Lungo -e forse sterile- l’elenco dei nomi di sampierdarenesi; ma si ricordano quelli dei Coronata; Boccacci; Dapelo; Sambuceti;
--delle società Torriani; Wilson Maclaren; la soc. Ansaldo (praticamente per ultima, prima di trasportare tutti i cantieri a SestriP.); la Coop. di Produz;
i famosi bagni descritti in via San Pier d’Arena e Colombo;
i pescatori ed i minolli (descritti ai corrispondenti nomi), gli artigiani (storicamente ricordati gli intagliatori del legno, necessari sia per costruire le navi sia per abbellirle; ed i fabbricanti dei mezzeri) e le piccole industrie.
 la dicitura descrive “ la strada di accesso e la zona
da colmare, a ponente del bacino XXVIII Ottobre”
la dicitura descrive “ la strada di accesso e la zona
da colmare, a ponente del bacino XXVIII Ottobre”
Il porto. Da quando Genova era lentamente riuscita a sottomettere tutta la Liguria e creare una Repubblica, di formato regionale ma stabile, una delle prime leggi medioevali -ribadita poi nel 1440- fu la eliminazione di ogni attrezzatura portuale lungo la riviera al fine di costringere le comunità a far entrare o uscire le merci solo dal suo porto, ove pagarvi i dazi (è storia, la lunga controversia con Savona e la sua recriminazione verso ‘l’egoismo genovese’, giustificato solo da prevalenti preoccupazioni militari a carattere difensivo, e non solo per i pirati dal mare quanto dalle mire espansionistiche dei piemontesi e dei francesi)
Già nel 1550 Leandro Alberti scriveva che «egli è tutto il lito de’l mare di questa regione da Monaco infino al principio di Thoscana senza porto, benché ritrovinsi alcuni piccioli luoghi disposti a ricevere li navighevoli legni, non però ivi si possono fermare alle ancore».
Rincara la dose all’inizio del seicento Andrea Spinola che, nel descrivere gli approdi nella riviera ligure, pur premettendo che «La parola di porto io qui prendo largamente. Di maniera che ogni seno, o sia cala dove i vascelli hanno riccetto sicuro dalle tempeste, io voglio intender che sia porto». Della nostra San Pier d’Arena neppure un accenno; e per lui ed a quell’epoca, da Genova sino a Savona, il vuoto.(E riconoscere a posteriori che questa politica permise di non costruirne uno a Portofino lasciandocelo abbastanza ‘naturale’, è sufficiente a farci esclamare ‘benomale!’).
Non è da poco riconoscere che costruire un molo e mantenerlo in funzione, per un piccolo centro come il nostro, era sicuramente una operazione fallimentare. Così, se si sfruttavano appendici naturali per favorire un approdo, sino agli anni 1930 non si può parlare di porto.
Questo ovviamente favorì altro sfruttamento della marina, modesto perché di minima portata ma più vicino alla alacre imprenditorialità dei cittadini locali (come il commercio dell’olio) e tale per cui tutte le attività nei secoli mai furono nella misura di rubare alla popolazione tutto il percorso litoraneo, ma lasciavano ampi spazi perché essa godesse quella meraviglia che madre natura aveva regalato e che tutti gli scrittori anche stranieri venuti verso Genova, descrissero con stupore ed invidia.
Così era nel 1800, quando incrementata la popolazione nacquero più capaci cantieri navali, alternati da sedi di ritiro delle barche dei pescatori (la lunga spiaggia era divisa in ‘territori’ di lavoro, sia per le barche che le reti : alla Coscia i famigli del ‘Caporale’; alla ‘scûggiâela’***-accanto ai cantieri Bertorello-,*** le famiglie Cabella, i famigli di ‘Moetti’, ‘Ballin’, ‘Xinne’ ; alla Giunsella i Ricci, detti ‘frae Gillo’; al Comune i Morando della Natalinn-a; alla Creusa di bêu i fratelli Volpino. I veri nomi con cui erano conosciuti, erano in realtà i propri soprannomi : Lasèn, Ostin, Angin u scrolla, Ballon), e a fine secolo infine dai bagni.
Quindi, sino ancora l’anno 1928, al posto della strada lambivano le onde del mare sulla spiaggia a ciottoli e sabbia; e nelle sciroccose giornate di mare mosso le ondate arrivavano ad invadere le case erette a monte della via C.Colombo (via San Pier d’Arena).
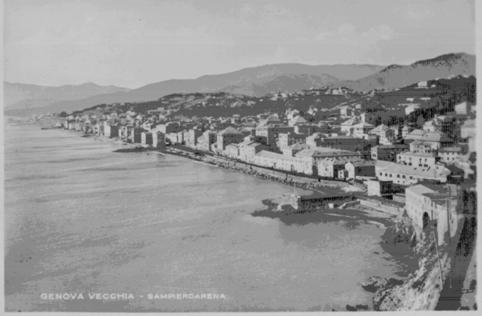


In aprile di quell’anno, su progetto già presentato da Coen Cagli nel 1919 e riveduto nel 1926 dall’ing.Albertazzi, riguardante il bacino che avrebbe coperto la spiaggia di San Pier d’Arena sino al Polcevera ( che prese il nome di bacino XXVIII Ottobre) l’ammiraglio Umberto Cagni diede il via al porto facendo iniziare dapprima la costruzione della diga a difesa, chiamata “ principe Umberto “ e lunga 1850 metri.
Nel sett.1929 successe alla direzione del porto l’ammiraglio marchese Negrotto Cambiaso; questi proseguì il progetto sino al 1942, facendo costruire i cinque grandi ponti sporgenti obliqui -lunghi 400m, larghi 130m i primi due e 150m gli altri, intervallati dalle calate: da levante, ponte Etiopia (1928-31, metri 283 a levante e 391 a ponente ) - calata Massaua (m.160) - ponte Eritrea (1930-9 , m.392)- calata Mogadiscio (m.160)- ponte Somalia (1930-9 , m.397) - calata Tripoli (m.157) - ponte Libia (completato dopo il conflitto, m.390 ) - calata Bengasi (m.157) e ponte Carlo Canepa (1930-9 , m.173 a levante, 397 a ponente) - calata Derna (m.214), sino al molo Ronco (m. 260) sul margine di levante del torrente. Così in pochi anni si realizzò la distruzione della parte più significativa della nostra città, enfatizzati dal trionfalismo di chi –di SanPierd’Arena- non gliene importava più di tanto.
Nello stesso periodo era stata sistemata a terra la rete ferroviaria, sia in via P.Chiesa e via C.Colombo.
Durante il conflitto 1940-45, fu ovviamente un obbiettivo dei bombardamenti: ma personalmente non trovo sufficiente spiegazione se non nella logica del terrorismo, nell’impiego di parecchie migliaia di bombe scaricate su Genova e - di esse - le più, indirizzate sulle case dei cittadini piuttosto che su obbiettivi industriali o militari (Ansaldo e ferrovie per esempio, ed il porto stesso); infatti – bene o male - il porto continuava a funzionare.
Secondo grave pericolo fu vicino alla fine del conflitto quando, per ordine di Hitler il porto doveva essere distrutto: furono piazzate mine per lo scopo, che però non furono fatte saltare per intervento di numerosi fattori: in primis le alte gerarchie militari tedesche non più ciecamente disponibili ad obbedire al fuhrer e - sottoposte a pressioni sia dei comandi fascisti, della Chiesa, delle SAP e delle Brigate partigiane (la zona portuale dipendeva dal Comando Piazza Centrale agli ordini del maggiore Mauro Aloni (chiamato ‘Violino’) politicamente indipendente) - usare l’annullamento dell’ordine come merce di scambio per la propria incolumità di fronte alla evidente imminente disfatta.
Nel 1950, presidente del Consorzio il generale Filiberto Ruffini, fu sistemata con criteri più solidi la recinzione doganale del bacino, con l’erezione del muro con rete, che ha una logica economica, ma a noi sampierdarenesi ha eliminato definitivamente qualsiasi accesso al mare.
I lavoratori sono prevalentemente occupati nelle operazioni da “camallo”: tutto arrivava in sacchi che, attraverso l’uso di un apposito gangio che fieramente ed a simbolo del proprio lavoro portavano appeso alla cintura; con esso agguantavano il sacco per porselo sulle spalle, per il trasloco. Era divenuta consuetudine che alcuni sacchi si rompessero ed era divenuto quasi naturale servirsi del versato. “O loua in to porto” era sinonimo di arrangiarsi, prelevando radio, giradischi, giubbotti, magliette, babane e caffè, e quanto arrivava o partiva. A capo dei camalli, Console della CUMV (Compagnia Unica Merci Varie) era Paride Batini, nostro concittadino perché abitante prima al Fossato, poi in via Ronco. Solo l’uso dei container interruppe l’ “usanza”-.
Il percorso del ‘lungomare’ è quindi sancito non essere più parte della delegazione, ma è terra demaniale, quindi di proprietà del CAP: il confine di proprietà del Consorzio è tracciato ed inciso su grosse lastre per terra, sul lato a mare di via Sampierdarena.
Però è soggetta a pubblico e libero transito dei cittadini: diventa così una ‘strada vicinale’ cioè tra città e porto.
Da qui l’equivoco delle competenze (illuminazione, manto stradale, segnali, controllo posteggi abusivi ecc.) tra il demanio marittimo consortile proprietario, ed il Comune usufruttuario. Complica le responsabilità la ferrovia che ovviamente vanta dei diritti propri poiché sui binari transitano convogli in manovra dal porto all’esterno (e che attraversano obliquamente la strada, laddove –se dovessero persistere- penso basterebbe dirizzarli sul lato mare, liberando la strada da un pericoloso incrocio).
La cinta portuale funge da confine a sud, della città di San Pier d’Arena; e la via rappresenta il “fronte del mare”.
Il piano regolatore del 1997 per questa strada prevedeva sei corsie (3+3) a scorrimento veloce, raccordamento con autostrada,sopraelevata e vie del Polcevera, risanamento da parte del Comune della sfilza di edifici laterali più o meno fatiscenti
Nel 2003 è ancora tutto fermo; la strada che dovrebbe continuare sino all’aeroporto, prevede un ponte nuovo sul torrente, nuova collocazione dei binari, proseguire dentro l’attuale area dell’Ilva di Cornigliano utilizzando corsie anche sotto gli Erzelli; ma le vicende legali tra Riva – proprietario dell’acciaieria - e gli altri enti, minaccia di far slittare i finanziamenti (78milioni di e.) per l’opera, già approvati.
Finalmente a maggio 2005, accordati con Riva - e da lui ceduti a Cornigliano 10mila mq (previo indennizzo di 2,15 milioni di euro che dsaranno pagati dall’Anas)- si darà via ai lavori per formare i by-pass per i camion in direzione Rivarolo; un nuovo ponte sul Polcevera al posto di quello “del Papa” per approdare sulla banchina di Cornigliano dopo bonifica (nel 2008 hanno distrutto -con un boato da esplosione- il vecchio ponte; Lungomare allargato a otto corsie dopo aver trasferito (espropriandole d’obbligo e respingendo le istanze di ricorso) le trenta aziende ospitate ai lati della strada; la cinta del porto che si sposterà di due metri verso monte (per consentire un riuso ed allungamento della ferrovia nello smistare con quel mezzo i contrainers).
Tutte belle teorie, nel 2008 molto spesso presentate sui giornali, ma ancora non realizzate, a parte l’abbattimento del ponte.
Mi rendo conto che il mio pensiero, avverso al cemento invasore, viene espresso con parole nostalgiche che servono a poco o nulla, essendo gli interessi – allora ed ancor oggi - molto alti e necessari (il primo, che tappa la bocca a chi come me ‘mugugna’, è il lavoro). Ma, utilizzando parole di Maggiani, cerco – e non trovo - altri motivi e giustificazioni all’esproprio di beni che (non appartengono alla ‘città’ né allo Stato con i suoi dirigenti politici, ma) sono della ‘comunità’, ed all’installazione di industrie (che si sono sempre dimostrate insensibili alle bisogna ambientali del popolo –ricordate le polveri rosse dell’Italsider e guardate come, crescendo la popolazione- hanno costruito case senza rispetto dei servizi, e quindi poco rispetto della comunità). Le risorse paesaggistiche e quelle naturali in genere, le intrinseche bellezze che sono le spontanee risorse di una città (nonché la parte più redditizia e preziosa di sé, rappresentanti una unicità mondiale) erano da tutelare ed abbellire e non da distruggere in modo non rinnovabile. Ciò che è stato distrutto non è più risarcibile in moneta di natura (il contatto diretto col mare, per primo) e nessuno riesce neanche a chiedere i danni. Ma quello che più mi infastidisce è quella massa di popolo, a cui in contrapposto competeva la responsabilità di conservazione e di non sottostare alla speculazione, e che invece ha partecipato attivamente alla distruzione, nella più becera servitù del padrone al quale mentre gli leccava le mani dall’altra doveva strappare, con profonde avversità, un bricciolo di benessere.
Propongono il turismo come risorsa produttiva degli anni 2000: ma cosa possono proporre a ponente della Lanterna? Nulla! Ed è forse per questo che per Tursi, Genova finisce alla Lanerna e quello che c’è dopo è come una latrina: da tenere chiusa la porta e non fare vedere.
DEDICATA
al politico socialista - e forse, così si legge, anche massone -, nato a Diano Marina (IM) il 15 mar.1865 da famiglia agiata e colta. Laureato in legge all’università di Roma.
Come giornalista nel 1884 era scrittore sul periodico genovese “l’Era Nuova”, organo del partito socialista di cui fu poi direttore fino al 1888 e con il quale collaborò anche Pietro Chiesa. Fondò ad Oneglia nel 1893 il settimanale “la Lima”; divenne fondatore (nel 1903) e direttore (fino al 1938 89.476 dice 1922) del quotidiano genovese tutt’ora in edicola “ Il Lavoro”. Riuscì a preservarne l’autonomia anche nel burrascoso periodo fascista, quando la stampa non godeva più di libertà di scrittura.
Interventista, con l’ideale di partecipare alla “libertà del mondo, pensiero costante col quale nessuno può essere pusillanime”, partì cinquantenne come tenente volontario di complemento nel 90° fanteria alla prima guerra mondiale e il 15 ott.1915 fu ferito sull’Isonzo (nelle stesse battaglie sul Mezrli, dove aveva perduto la vita l’atleta Dante G.Storace) ricevendone una medaglia d’argento al VM.
Come politico, acquisì particolari alti meriti divenendo, per spontaneità, uno dei precursori del socialismo; idea maturata nella consapevolezza del dramma sociale esistente (L’Italia era fatta, ma era stata creata da Mazzini, Cavour, Garibaldi e VEmanuele, senza la partecipazione attiva del popolo, delle masse contadine e operaie le quali se ne sentirono staccate d’interesse anche perché all’unità monanrchiaca si associava ad un non malcelato anticlericalismo profondamente avverso alla base. La plebe era rimasta nella miseria materiale, culturale e morale di prima; anzi, nei primi tempi, la ricerca di stabilità statale creò maggiori pressioni mal tollerate dal popolo (questa era stata una delle ragioni della sommossa genovese di trentanni prima; ma nulla era cambiato nel frattempo).
Sua missione divenne quindi innalzare il popolo italiano al fine di inserirlo nella madre patria: col riformismo, organizzando gli operai (assieme a P.Chiesa, S.Canzio), tipizzando le idee sul ‘Lavoro’ (i suoi scritti, a fianco di quelli di Salucci, Caveri, Pellegrini rivelarono la particolare bravura nell’esporre idee chiare e semplificatrici, nel porlo per tre lunghi lustri quale dominatore della vita politica genovese).
Nella pratica fece parte del Consiglio comunale della sua città, e poi di quello provinciale di Porto Maurizio; si prodigò per superare la crisi economica seguente il terremoto del 1887. Nel 1894 (13 e 14 maggio) organizzò assieme a P.Chiesa ed altri, il primo congresso socialista ligure, tenuto a San Pier d’Arena, in cui lesse una relazione sull’occupazione operaia e contadina. Candidato al Parlamento, non rimase eletto per le prime quattro volte tra il 1895 e 1904; divenne poi deputato dal 1909 per 4 legislature, fino al 1926 (ricoprendo incarichi di sottosegretario all’agricoltura e commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, nel 1917); nel 1911, in occasione della guerra libica, dapprima fu anticolonialista, poi si dichiarò favorevole (il fatto fu definito “revirement di Canepa”).
Partecipò fin dal suo sorgere, al Partito Socialista Riformista (Reggio Emilia 1912) di cui fu solerte propagandista: alla camera nel febb.1923 lesse una relazione - a nome del Partito Socialista Unitario - di opposizione al corso politico nascente fascista per cui subì poi violenze multiple (casa incendiata e saccheggiata, estromissione dalla vita parlamentare, processi e confino).
Alla fine della seconda guerra, sulla ottantina, aiutò gli amici partigiani andati in montagna; divenne dirigente del movimento “per la difesa delle nazionalità oppresse”; partecipò all’ Assemblea Costituente nel 1946; fu eletto senatore nel 1948, anno stesso della sua morte, avvenuta a Roma il 22 dicembre, in seguito ad una caduta mentre correva al Senato ove si sarebbero discussi importanti interessi liguri.
A suo nome è stato chiamato anche un ponte nel bacino di San Pier d’Arena largo 150m, inizialmente concesso alla soc. Ansaldo per allestirvi delle navi.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Com.Toponom. scheda 536 +
-Assereto G.-Porti e scali minori della Rep....-SocLiStPat.1988-pag221
-A.sconosciuto-Guida del porto di Genova-Pagano.1954-pag. 205.732
-AA.VV.–Annuario-guida archidiovesi-ed./94–pag.389-ed./02-pag.427
-Bordogna M.-JunioValerio Borghese e la Xª Flott...-Mursia.07-pag.184
-Cavassa UV.-Ombre amiche- DiStefano- pag. 107
-Comune di Genova-Atlante demografico della città-1998-pag.39
-D’Oria S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.44
-Ferrari GB-Capitani di mare e bastimenti di Liguria-Tigullio.1939-pg.135
-Ferrari GB-L’epoca eroica della vela-Tigullio.1941-pag.135
-Gatti L.-Navi e cantieri della Rep.-Brigati’99-pag.20.39.155-164.188.
-Gazzettino S. : 4/72.15 + 7/73.1.2 + 6/79.4 + 5/78.19 + 2/82.8 + 6/84.12 + 1/86.6 + 6/86.13 + 1/87.1 + 8/87.11 + 4/89.9 + 9/90.3 + 1/91.1 + 4/92.7 + 7/94.8 + 4/96.7 + 7/97.4 + 2/98.5 + 4/98.4 + 05.02.13 + 01/03.5 + 10/03.3 + 04/04.5 + 08/04.6
-‘Genova’ Rivista municipale: 10/37.53foto +
-Genova e Liguria-Dove e chi-2000.pag.72
-Grosso O. -all’ombra della Lanterna-Erga 1968-pag. 94
-Guida del porto di Ge.Pagano.1954. pag.34.68
-Il Lavoro , quotidiano: 27 sett.79
-il Secolo XIX : 20.8.97 + 21.11.99 + 13.10.00 + 15 e 21.12.00 + 18.7.01 + 23.12.02 + 11.1.03 + 08.02.03 + 14.02.03 + 07.03.03 +22.03.02 + 26.03.03 + 29/03/03 + 14.04.03 + 16.04.03 + 04.05.03 + 26.9.03 + 31.11.03 + 25.1.4 + 2.2.4 + 18-30.4.4 + 3.5.04 + 1 e 17.5.05 +
-Lamponi M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002-pag. 41
-Pagano/1961-pag.119.445-467
-Pero PA.-Il fossato, la sua gente…-SES.2005-pag.65
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav. 33.49.50.51
-Ragazzi-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.475
CANEPA vico privato (Canepa)
Nell’elenco delle strade del 1910, si fa notizia della sua esistenza, con il nome Canepa messo tra parentesi e senza specificazione della persona, esteso tra via Umberto I (via W Fillak) e via U.Bassi (via Vicenza). Dovrebbe corrispondere quindi alla attuale vico L.Stallo.
Subito dopo questa data, la proposta di questa titolazione del vicolo fu annullata.
BIBLIOGRAFIA
Archivio Storico Comunale
TARGHE:
S.Pier d’Arena-via-Antonio Cantore-Generale Alpino-Medaglia d’oro al V.M.-1860-1915
via - Antonio Cantore – generale alpino – medaglia d’oro al V.M. – 1860-1915

angolo con via s.Bartolomeo del Fossato (?)

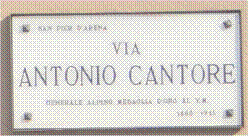
angolo con via Pittaluga


facciata del civ. 31A.

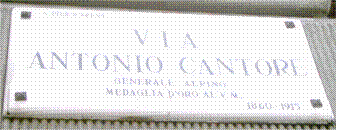
angolo con rientranza ‘dalla sbarra’ presso Calderoni

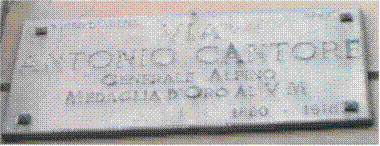
a fine strada, angolo con via G.B.Monti
QUARTIERE ANTICO: Mercato-Comune e Coscia
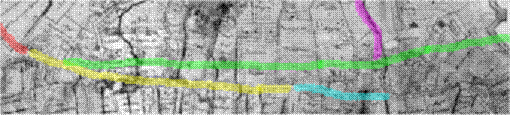 Ipotetico tracciato di via
A.Cantore. Da MVinzoni, 1757. rosso via CRolando; giallo, via NDaste; celeste
via LDottesio; fucsia via sBdFossato.
Ipotetico tracciato di via
A.Cantore. Da MVinzoni, 1757. rosso via CRolando; giallo, via NDaste; celeste
via LDottesio; fucsia via sBdFossato.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2742 CATEGORIA: 1
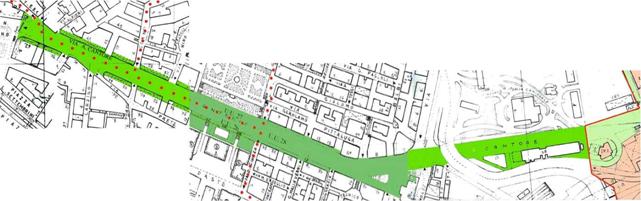
CODICE INFORMATICO DI STRADA - n°: 11640
UNITÀ URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO
26 - SAMPIERDARENA
27 – BELVEDERE
28 – s.BARTOLOMEO

in giallo via P.Reti; rosso lato levante di piazza N.Montano; fucsia inizio via A.Cantore a Genova. Da Google Earth 2007
CAP: in territorio sampierdarenese 16149
PARROCCHIA: dal 7 al 17 + dall’8E al 24 = s.Maria delle Grazie
--dal 15 al 35 + dal 26 al 62 = s.Maria della Cella
--dal 37 al 51 = NS del ss.Sacramento.
STORIA: dai vari piani regolatori dell’inizio secolo 1900, era prevista l’apertura di una nuova strada che collegasse Genova al ponente ed alleggerisse il traffico, sopportato solo da via C.Colombo (via San Pier d’Arena) e da via Vittorio Emanuele (via G.Buranello). Si prospettava o una nuova galleria, o lo sbancamento del colle di san Benigno; la prima idea appariva la più logica e più facilmente adottabile con i mezzi di allora, perché il colle stesso era già stato ripetutamente traforato per le vie ferroviarie e tranviarie.
Riemerse il progetto nel 1920, sia quando si progettò che la strada doveva essere “molto larga e fiancheggiata da costruendi palazzi ‘signorili’ con portici - salvo ovviamente quelli preesistenti -; e sia in concomitante progetto di un elemento nuovo entrato in fase esecutiva: il riempimento portuale; questo fece decidere definitivamente per lo sbancamento.
Malgrado le evidenze, soprattutto legate all’aumento vertiginoso della popolazione e del traffico, un vero piano regolatore stentava a decollare: ancora nel 1924 si discuteva tra una grande arteria centrale larga 24m (con una quota di strada in salita - nel taglio di san Benigno - per superare di almeno 11 m. le gallerie sottostanti del treno) o una circonvallazione a 40m slm.; nell’aprile 1925 il piano regolatore generale studiato dall’ing. Pietro Sirtori venne approvato (con in più un’altra grossa arteria a mare), ma l’assorbimento nella Grande Genova del 1926 fermò ogni iniziativa e rese ancora tutto vano; l’ing. Luigi Connio, trasferito da SPd’A a Genova, seguì le fasi evolutive del P.Regolatore, mentre l’assolutismo fascista ribadiva chiaramente, a scapito della nostra piccola città, l’idea dominante di una Grande Genova ed un grande porto, ma con priorità del centro rispetto la periferia destinata all’industria pesante e quindi all’ovvio degrado (quest’ultimo fece scomparire il nostro arenile, coperto da 2 milioni di roccia, sbancati dalla collina per poter aprire il diaframma che per secoli era stato il preciso confine tra le due città).
Così, solo nel 1930 si riprese il progetto, vedendo interessati per la grande importanza dei terreni attraversati, oltre all’amministrazione civica, anche quella portuale, ferroviaria, militare e privata: foto di quell’epoca dimostra i lavori di ‘gettata’ della strada con il pietrame basale, percorsa solo da un carretto mentre nella piazzetta retrostante la villa Scassi, alcuni ragazzi eseguivano esercizi di ginnastica scolastica.
Finalmente approvato, il progetto verrà reso operativo nel 1934 anche se nel frattempo erano già stati realizzati alcuni tratti della nuova strada centrale, alcuni anonimi come titolazione, di cui il primo fu alle spalle poco sopra e sotto della villa Scassi, chiamato via G.Carducci e, con palazzi ai lati, però non muniti dei portici previsti approfittando del piano regolatore non vincolante perché non ancora approvato. Il primo tratto, iniziante in san Teodoro da via Milano (con varianti, demolizioni e nuova costruzione dell’angolo a levante) fino all’incrocio con via Chiesa delle Grazie fu realizzato d’urgenza dal Comune appunto sfruttando l’antica cava della Chiappella e con ulteriore sbancamento del colle; e fu inaugurato nei suoi 1000 metri nel 1935; questo, passando davanti al novello piazzale della camionale (finanziato dallo Stato), fu allacciato al tratto già pronto che arrivava sino all’incrocio con via Masnata (villa Serra-Doria-Masnata) lungo 350m.: nell’ottobre 1935 gli abitanti di questa via ricevettero l’ingiunzione di sfratto da effettuarsi in quindici giorni perché il palazzo, detto ‘gemello’, il civ.2 era “compreso fra quelli da demolirsi”; i due tratti uniti mantennero il nome di via Giosuè Carducci. Quindi, nel 1935, su 1750 m. complessivi, ne furono aperti ed ultimati 1530 m., essendone già pronti altri 180 m. ancora più a ponente).
Il 19 agosto 1935 il podestà deliberò che la strada si chiamasse “via Antonio Cantore”.
Alla fine del 1936 (anno XV dell’E.F.) rimanevano ancora due interruzioni - dovute alla presenza lungo il tracciato di edifici e terreni da espropriare e demolire: uno di circa 80 metri, costituito dalla proprietà Ronco e dalla ‘casa rossa’ (al quale seguiva verso ponente un tratto di 100 m già pronto dall’anno prima). La seconda interruzione era di 140 metri costituita dall’Oratorio della Morte e Orazione (rilevanti difficoltà furono trovate dovendo abbattere l’Oratorio per la sua natura e le speciali leggi che lo proteggevano e vincolavano; richiese pratiche più complesse per i vincoli della Chiesa e relativi Patti firmati da poco) e da alcune vecchie case vicine poste ai due lati dell’erigenda strada (Gli ultimi 80 metri, davanti alla villa Carpaneto erano già stati liberati e pronti, conservando alcune piante ornamentali nelle aiuole divenute spartitraffico; e con l’augurio che le Ferrovie dello Stato rifacessero la stazione - come da noto progetto - e portassero a livello stradale l’entrata, ed eliminando così la rampa d’accesso).
Tutto, venne completato l’anno dopo: il 15 mag.1938 la strada fu inaugurata ufficialmente con, nel pomeriggio, una grande sfilata militare in occasione della visita di Benito Mussolini alla città: in contemporanea fu completata l’illuminazione delle strade.
La decisione finale venne ratificata il 23 giugno 1939 quando fu delimitata definitivamente tutta la nuova strada, da via Milano-di Francia a piazza N.Montano (denominando: via Milano il primo pezzo di strada da DiNegro, che anch’esso inizialmente aveva avuto il nome unico di via A.Cantore; dopo la guerra si procedette anche alla distruzione delle case nell’incrocio a levante con via Milano, guadagnando per entrambi le strade un allargamento).
Il lavoro (costruzione della sede stradale, impianto di fognature, marciapiedi comunali, pavimentazione a massicciata e coperta da bitume, diversa dalla laterali coperte in masselli di granito) fu eseguito dall’impresa Torriani e diretto dall’ing. cav. GianLuigi Connio; comportò, solo nell’anno XIV, la spesa di 850mila lire.
Divenne così la strada principale della delegazione, scalzando dal ruolo la lunga e tradizionale via N.Daste. Per la sua realizzazione sono stati sacrificati orti e giardini vari: la testata del colle di san Benigno; via san Bartolomeo del Fossato; giardino di villa Spinola; taglio dell’accesso alla villa DeAndreis-Menotti (l’attuale via alla Chiesa delle Grazie); di via Imperiale e giardino della villa Scassi; giardino-orto di villa Doria Franzoniane; taglio di salita s.Rosa; giardino villa DoriaMasnata; viale accesso a villa Ronco; palazzo gemello di via Masnata; giardino di palazzo Bonanni (a me sconosciuto); taglio di corso dei Colli; giardini di villa Serra-Doria-donDaste; Oratorio dei Morti e Orazione; case delle vie NBixio, Mercato e piazza capitan Bove; giardino di villa Centurione-Carpaneto.
Via Cantore è stata per anni (1970-2000 circa), mèta naturale delle ‘vasche’, ritrovo mondano dei giovani basato sull’andare e venire sotto i portici, a ‘cicaleggiare’ o ‘tallonare’ ed imparare i nuovi gerghi ed usanze.
Ma è anche la strada più ‘trafficata’ di tutte: nell’ottobre 69 e nelle ore diurne ( h.7-21) diede passaggio a 31.300 veicoli al giorno. Il 2001, nell’occasione dell’incontro politico internazionale denominato G8, insieme alle diatribe ideologiche, portò dei soldi che permisero la riqualificazione della strada: con la spesa di 1,555 milioni, e quattro mesi di lavori, furono rifatti l’impianto di illuminazione (136 bracci con lampada ad alto rendimento), il manto stradale, le aiole spartitraffico (con annaffiamento automatico e nuove sempreverdi). In quell’anno oltre settanta commercianti diedero vita ad una idea di ‘centro integrato’, detto CIV (facendo nascere un consorzio chiamato ‘via Cantore e dintorni’; ossia iniziative atte ad accompagnare sotto i portici le distrazioni (musica, sport, banchetti, dei passanti).
STRUTTURA :
Iniziando da est, da via di Francia e da via Milano, appartiene a san Teodoro sino ai civ.neri 3 ed 8a; non esistono il 5 e l’8b). Entra in territorio sampierdarenese, in corrispondenza dell’ex fianco di ponente della collina di san Benigno: dall’ 8c al 62 e dal 7 al 51, fino a piazza Nicolò Montano.
In tutto è lunga 1652m, larga da 21 a 24m; raggiunge una pendenza del 4%.
Appare servita sia dall’acquedotto De Ferrari Galliera che Nicolay.
Disegnata a sei carreggiate, con aiuole spartitraffico munite di cespugli ornamentali ed antiabbaglianti, conta otto interruzioni al traffico veloce tramite altrettanti semafori non sincronizzati. Inizialmente fu disegnata anche una corsia preferenziale per i mezzi pubblici, con parcheggi a limiti orari ma continuamente disattesi dalle auto in sosta. Le periodiche e necessarie possibilità di svolta laterale, fanno sì che le corsie non hanno linearità continua, ed obbligando i mezzi a zig-zagare o strombazzare per pericolosi cambi o per errore di corsia, rallentando la marcia (che, in contrapposto, se tutta diritta, potrebbe divenire troppo veloce e causa di più incidenti mortali di quanti già avvengono, con tanto di mazzi di fiori finti attaccati ai piloni centrali o ai palazzi).
CIVICI
2007=UU25* (solo lato monte, dall’angolo di corso LMartinetti all’angolo con via GBMonti)
NERI = da 41 a 51 (escluso 49)
ROSSI = da 153 a 277 (compreso 219ab, 265a, 267a)
=UU26 (solo lato mare)
NERI = da 26 a 50 (compresi 30ABC, 32A, 62???)
ROSSI = da 92r→274r (mancano 128r→132r, e 152r→162r. Compresi 134ABr; 182Gr e 200Ar)
=UU27 (solo lato monte)
NERI = da 17 a 39 (mancano 25, 27. Compresi 29ABDF e 31A)
ROSSI = da 69r a 151r (compresi 75Ar→Lr, 87Ar, 109Br, 133ABCFGr, 135 Ar→Gr)
=UU28 NERI = da 7 a 15 (manca 9. Compreso 11A)
da 8C a 24 (compresi 8EFGH)
ROSSI = da 9r a 67r (manca 11r e 33r. Compresi 29Ar→Gr, 31Ar→Er, 33Ar→Fr, 67Ar→Dr)
da 26r a 90r (manca 30r, 32r. Compresi 34Ar→Or, 44Ar→Qr, 46Ar, 52Ar, 82Br).
(RIASSUMENDO:
NERI dispari da civ. 7→15=uu28; 17→39=uu27; 41→ 51=uu25.
pari da civ . 8C→24=uu28; 26→50=uu26.
ROSSI dispari da civ 9r→67r=uu28; 69r→151r=uu27; 153r→277r=uu25
pari da 26r→90r=uu28; 92r→274r =uu26)
Dai dati sopra rilevati, come costruzioni, San Pier d’Arena inizia a levante, con civv. neri 7 e 8C; e rossi, 9 e 26.
Dal Pagano 40 si rileva: ‘da via Milano a via Martiri Fascisti’; civici neri a privati e, al civ. 16, la chiesa evangelica Valdese; 31, asilo infantile M.Mazzini e la r. scuola di avv. N.Barabino; 32, Banca d’Italia; 34, assoc.naz.Combattenti; 42/4 ist. Palazzi scuola privata; civici rossi sino ai civv.226r e 277r (in particolare al 51 farmacia Saglietto; 165, Gragnani torref caffè; 210 casa d’Aste e Galleria; tra tutti 10 commestibili, 8 parrucchieri, 7 vinai, 5 fruttivendoli, 4 macellai e latterie, 3 bar, 2 trattorie, ecc.
Nel Pagano 1950 vengono segnalati cinque bar: 44r di Quasco M.; 72r di Appino C.; 76-80r bar Miro; 124r di Fochi F.; 180-182r di Ricci D.; un chiosco, di Brusasca Giuseppina. Nessuna osteria né trattoria.
La nuova denominazione di strade laterali come via G.Pittaluga, portò nel 1954 alcune variazioni numeriche nei civv., con scomparsa dei 11a e 11b; di via LaSpezia nello stesso anno, dei civv. 25, 25a, 27; di via N.Ronco nel 1966, con scomparsa dei 33 e 35 abcd; (via G.Pedemonte nel 1973 non apportò modifiche numeriche); acquisizione del 31a dalla eliminazione (1960) di via Masnata .
Furono assegnati a palazzi nuovi : l’ 8e (1953) ; 8gh (1970) ; 11 (1953) ; 29a (1951) ; la scala A del 30 (1955); 30b (1972) ; 30c (1988) ; 31 (1995) e 31b (1964) ; 35 (1968) ; 50 (1954) ; furono invece demoliti il 9a (1954) ; il 35 (1964) ; dal 50 al 58 (1954) ; 60 (1961).
Percorrendola dal piazzale della Camionale, troviamo:
A MARE
===civ. non segnato. Se fosse 8B, per il Comune, è collocato in s.Teodoro. Corrisponde al distributore di benzina ERG: nato dopo un lungo contenzioso con il precedente gestore di lavaggio auto e distribuzione di benzina, di cognome Valente, che dopo lunga diatriba fu sfrattato ed andò a porsi di fronte al palazzo Lancia con solo più moderna attrezzatura di autolavaggio. La Erg è stata la prima in città a rifornire le auto con una organizzazione fai-da-te alla distribuzione e centralizzata al pagamento.
Inizia la UU28-san Bartolomeo.
===civ 8C è il Novotel. Unico hotel a 4 stelle esistente in Sampierdarena, posto di fronte all’uscita dell’autostrada (quando purtroppo, per colpa del nome dato ad essa, abbiamo perduto l’identità venendo chiamati con l’orribile nome GenovaOvest). Recente costruzione monovolume di nove piani in stile moderno tutto vetri, sorta nel 1993 per conto di operatori cittadini della soc.‘Fortune’ del gruppo Gadolla: 224 camere, tutte matrimoniali; l’interno è semplice e prevale il bianco, con frequenti quadri e serigrafie di autori moderni; un piano è pressoché adibito a sale per raduni, attrezzature congressuali, ristorante. Come onere urbanistico l’impresa ha dovuto costruire il passaggio passerella aerea coperta, a ‘bruco’, di collegamento tra via A.Cantore-Matitone raggiungibile mediante ascensore e v.D.Col; più un autosilo nella sottostante via di Francia, libera a tutti i cittadini

===a mare dell’albergo, si vede una imboccatura di entrata della via ferroviaria che forò la collina: l’ingresso è a testimonianza di dove era la facciata del colle di san Benigno, e della sua base.
Residuano infatti come in una profonda gola, altre vie di accessi ferroviari, posti a livelli più bassi. Tra essi la via ferrata che provenendo dal parco del Campasso, iniziava la famosa galleria di san Benigno, esplosa nel 1944.
Sopraelevata A.Moro
===civ 8G ed 8H sono due corpi in una struttura: formano il grattacielo, detto “torre Cantore”. Fu ultimato nel 1968, costituito da una torre alta 24 piani adibita ad abitazioni, più altri 80 mini appartamenti da affittare già ammobiliati e chiamati ‘meublé‘, e servizi. A mare, una parte più bassa di 7 piani, adibita ad uffici, collegata alla torre con servizi centralizzati.
Nella zona, c’era prima l’oleificio Moro e prima ancora era terreno di ville, a giardini ed orti.
 il grattacielo visto dall’elicoidale
il grattacielo visto dall’elicoidale
Via Pittaluga
==il tratto finale della discesa, in corrispondenza sul lato a mare con la sopraelevata via A.Moro, ha creato un falso sovrappasso, con i palazzi sottolivellati: corrisponde all’antico tracciato del rivo proveniente dal Fossato (esso praticamente scorreva pochi metri davanti alle imboccature ferroviarie, ma lo spianamento del piazzale dell’autocamionale e l’ingresso autostradale posto sul fianco a ponente del Fossato stesso, obbligarono gli ingegneri a spostare il letto del rio un po' a ponente rispetto il suo naturale decorso). Tutti i civici sino al 24 sono sottolivellati rispetto il manto stradale perché nati prima della strada: dove lo sbalzo divenne più evidente e vicino all’asse viario si dovette provvedere tramite un muretto di rialzo e ringhiera.
===dove è stato per tanti anni un distributore di benzina, esso fu costruito su uno dei primi spiazzi ove giocavano al pallone della nostra città, detto popolarmente “campo dê moneghe” per la vicinanza di un collegio di suore: arrivava, verso mare, alla villa Spinola circa, ed a nord con una villa DeAndreis (usata come punto di riferimento, non è riportata in nessun libro e non si sa quale sia; evidentemente abbattuta nello spostare l’apertura a via san Bartolomeo del Fossato. Lui, di nome Gottardo, probabilmente è lo stesso la cui fabbrica di lavorazione della latta, era in via Cassini); non aveva le dimensioni precise ma sufficienti ad ospitare la Sampierdarenese nei suoi primi incontri. Si ricorda che nel 1920, la squadra nazionale italiana di ginnastica artistica vi fece un saggio prima di partire per le Olimpiadi di Anversa: dei venti atleti, ben sei erano della nostra “Ginnastica Sampierdarenese”.
Via Bottego
===civv. 10 e 12 sono compresi in doppio isolato: il primo inizia col 46r, comprende gli uffici delle Poste ai civv. 50-54r., e finisce col 60r che fa angolo con le scalette che scendono a villa Spinola. Il secondo inizia con un cancello che da adito al civ. 14, seguito da civici rossi dal 62r al 70r; questo ultimo palazzo offre la sosta ai bus in transito verso Genova.
===civ. 14 : Palazzo del san Giorgio. Fu costruito nel 1926, con ingresso sul fianco a levante; ed un altro speculare a ponente, che però è il civ 3 di via Chiesa delle Grazie. Sulla facciata, all’altezza del 5° piano, centrale, c’è una gigantesca statua di san Giorgio che uccide il drago; sotto di essa, c’è un grosso riquadro riportante versi di G.Carducci: “Io vo vedere il cavalier de’ santi, il santo io vo veder de’ cavalieri“ (similare affresco con stessa dedica è nel cortile di palazzo sGiorgio; sono il 7° ed 8° verso del sonetto XIV delle Rime Nuove scritte nel 1886 col titolo originale di “Ripassando per Firenze” e poi pubblicato col titolo definitivo “San Giorgio di Donatello”. E quindi sono anteriori all’esperienza genovese del poeta:









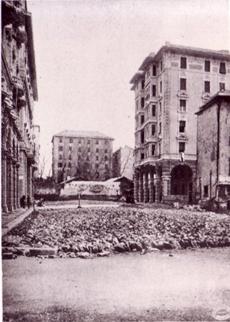



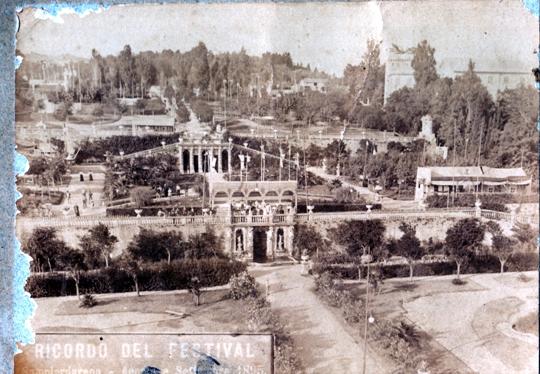
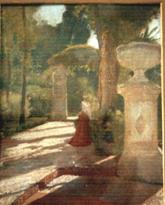

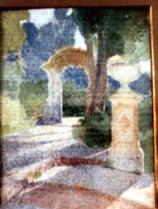
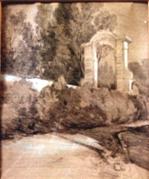
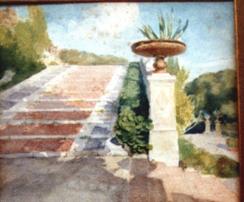
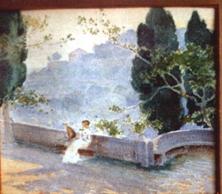
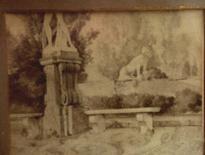
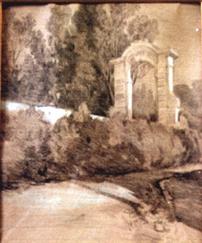



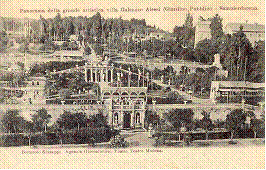


















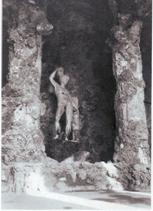









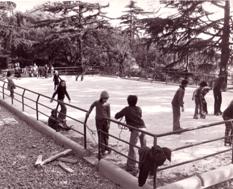







 Dalla genealogia risulterebbe essere quel
Dalla genealogia risulterebbe essere quel 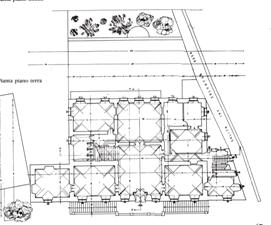

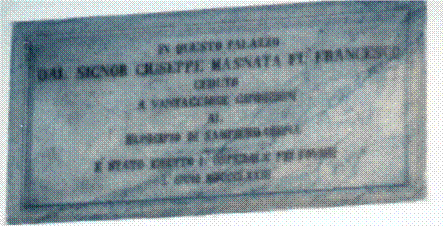 lapide
nell’atrio
lapide
nell’atrio


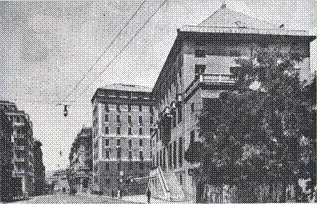




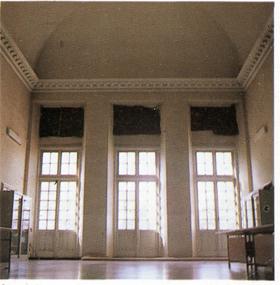


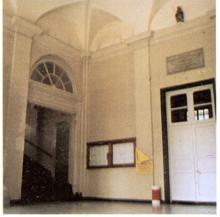







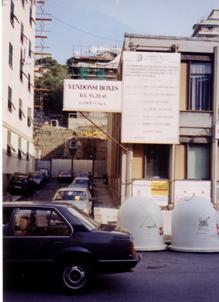











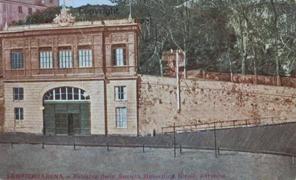
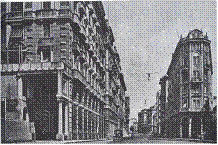


 Una relazione rilasciata da
un fante presente
Una relazione rilasciata da
un fante presente