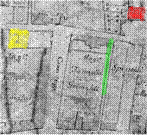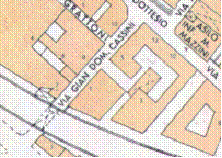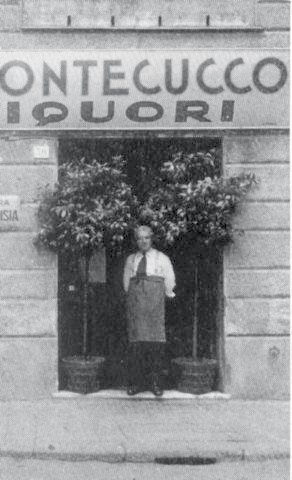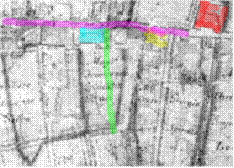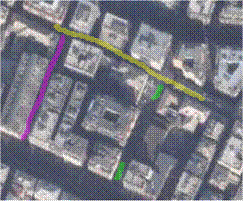CANZIO via
Stefano Canzio
TARGHE:
via
- Stefano Canzio – antica “crosa dei buoi” – già via N.Barabino


angolo p.zza VVeneto

particolare; non più leggibile in basso a sinistra
l’incisione “già via N.Barabino”.

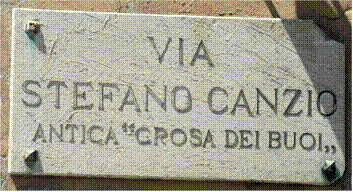
angolo con via san Pier d’Arena
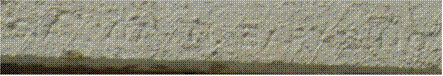 particolare
particolare
QUARTIERE ANTICO:
Canto
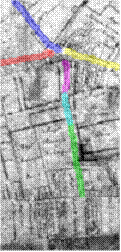 da MVinzoni, 1757. In celeste zona
dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;
rosso via AScaniglia
da MVinzoni, 1757. In celeste zona
dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;
rosso via AScaniglia
N° IMMATRICOLAZIONE:
2743 CATEGORIA: 2
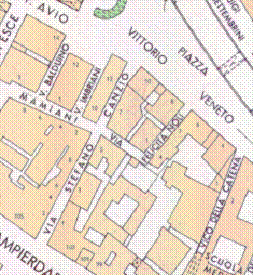 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 11680
UNITÀ URBANISTICA: 26
- SAMPIERDARENA
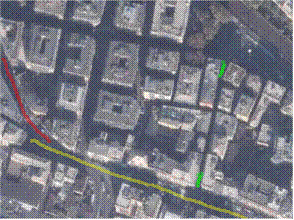 in rosso, via Pacinotti; giallo via
san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007
in rosso, via Pacinotti; giallo via
san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007
CAP : 16149
PARROCCHIA :
s.Maria della Cella
STORIA: la strada è
ubicata nel pieno della ‘zona del Canto’, spiaggia di pescatori e di lavoratori
dell’attracco portuale locale (quelli che
avevano trovato la Madonna, ora esposta in via Bombrini, che dovettero cedere
spazio ai cantieri dell’Ansaldo, che dovettero soccombere all’imperativo del
porto, che oggi sopravvivono spiazzati fuori dell’antico ruolo del rione).
1)
Il primo nome
acquisito dalla strada fu “Crosa dei Buoi” (vedi): come tale è citata nel regio decreto del 1875 quando il
Comune di San Pier d’Arena chiese a Torino l’approvazione per la nomenclatura
delle vie ma titolazione risalente a vari secoli prima, fors’anche al medioevo.
La strada andava diritta, dalla marina a via Mercato (sino al cinfine di
levante del palazzo Centurione-Carpaneto di piazza N.Montano).
Non è dato con sicurezza il perché di questo nome; con la
mentalità di tre-quattrocento anni fa, quando le zone venivano indicate
secondo l’evento od il personaggio più conosciuto dai più, le versioni offerte da vari studiosi i più accreditabili cercano
spiegazione nella presenza di questi animali, le varie ipotesi formulate sono
però inconsistenti: o per trainare carri – i tombarelli (dalla/alla marina- con merci da
caricare/sbacate via nave o con sabbia), o perché di lì passavano per
andare al macello (difficile
perché neanche è tanto pensabile che la popolazione facesse così largo uso di
carne da giustificare un intenso traffico di bestie) o al pascolo (difficile, perché non ne
esistevano ma era zona solo di orti). Assai improbabili anche le
spiegazioni date dagli storici del Gazzettino (11/81), ricalcanti le ipoesi su
descritte: di buoi - avviati al macello del Campasso (in altro numero del giornale, i
macelli sarebbero stati alla Lanterna) attraversanti
mezza città, perché scesi ad uno scalo ferroviario posto alla Crociera (in
altro numero, alla ‘stazione fronteggiante Piazza Omnibus’): assurdo, sia
perché il nome precede di secoli i macelli e la ferrovia; e sia perché appare improbabile
che - anche se ‘a gruppetti’, si facesse fare loro il giro dal Canto (via
Pacinotti), e scendere lungo poi la crosa dai quali prenderebbe il nome, per
attraversare il centro cittadino onde arrivare al Campasso; al limite, fosse
vero, sarebbero passati per via Spataro, o scenderli addirittura nel parco del
Campasso. Per l’altro numero del Gazzettino, “smistati” alla Lanterna, dove
però nessuno cita ci siano mai stati macelli.
Due altre ipotesi
le propongo io: là c’era anticamente una grossa stalla dove non solo si
ospitavano questi animali, ma anche si potevano affittare gli animali per i
lavori più vari (tanti
ne avevano bisogno, il Comune per primo; mica tutti possedevano stalle, bestie
e carri propri); oppure che gli animali c’entrano per nulla e bovi proviene dalle barche
usate per trasporti marittimi.
Alla prima ipotesi, porta vantaggio anche la vicina ‘via
della Catena’, quasi a confermare che da quest’ultima – essendo vicina ad una
casa di signori - non dovevano passare, mentre da quest’altra, si; e,
considerato che a quei tempi tutto il traffico - e con lui tutta la vita del
borgo - si svolgeva via mare, tra i tanti anche l’opera indispensabile e
continua dei minolli nel trasportare la sabbia alle navi A svantaggio, che a
quei tempi i carri erano prevalentemente trainati da muli, più raro da cavalli
e buoi (i quali, più lenti, divenivano anche
facile preda dei tanti invasori a caccia di cibo).
2) la seconda mia
ipotesi deriva da un attento controllo della carta vinzoniana; essa
 fa leggere in corrispondenze della strada, la
definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della
parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi
imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,
sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco
inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,
era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci
e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un
bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a
sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento
dell’impavesata) poi tonda. L’avvento
del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.
fa leggere in corrispondenze della strada, la
definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della
parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi
imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,
sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco
inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,
era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci
e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un
bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a
sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento
dell’impavesata) poi tonda. L’avvento
del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.
Con l’instaurazione della ferrovia (1853) e
dei primi impianti siderurgici o comunque industriali già si iniziava a
delineare quello che poi definitivamente venne riconosciuto nei primi anni del
1900: la destinazione ad un ponente industriale, un entroterra mercantile (per il cimitero, mercato, gasometro era stata scelta la zona della val Bisagno) ed un levante residenziale.
Sino all’apertura di via Vittorio Emanuele (1853),
che dalla Lanterna attraversando il borgo arrivava sino a Rivarolo, la vecchia
‘crosa dei Buoi’ dalla marina arrivava quasi in rettilineo, sino a levante
della villa Carpaneto (in piazza N.Montano). La nuova strada longitudinale,
parallela alla ferrovia, creò la piazza Vittorio Veneto e spezzò in due la
vecchia crosa.
Ancora vivente il pittore N.Barabino (1832-1891), la municipalità decise di
dedicargli una strada; e scelse questa nella sua metà a mare, cambiando
l’antico nome di ‘crosa dei Buoi‘ in via Nicolò Barabino. Lui rifiutò l’onore; ma alla sua morte, fu
riproposto la titolazione e, nel 1910 appare già eseguita e vi appaiono
già presenti civici sino al 14 e 7. Nel 1933 ancora era tale.
Fu deciso infine, negli anni tra il 1933 ed il 1940, di trasferire il
nome del pittore alla ex via C.Colombo
(poi divenuta infine via San Pier d’Arena), e concedere quella in nostra
considerazione al garibaldino S.Canzio.
Curioso ricordo personale di
un abitante in zona: durante il periodo bellico 1940-1945, segnala lo
sbarramento della strada con un muro fatto erigere da parte delle autorità
tedesche e col passaggio limitato ad una porticina posta sul lato a ponente.
Evidente zona di traffico d’armi e dei ‘banditi’ come descritto sotto al civ.7
Il Pagano/40 pone la via tra ’piazza V.Veneto e via N.Barabino’,
con civici da mare a monte: neri e rossi.
Nel 1950 il Pagano cita esistere due osterie: al 10r di Pisterna Romolo
ed al 43r di Rava T.; un bar al 23r di Ramolfo Francesco; nessuna trattorie.
CIVICI
2007
= NERI = da 1 a 7 e da 2 a 12
ROSSI = da 1 a 53
(manca 41) e da 2 a 56
(aggiungi 14A)
=civ.
1r, è la ‘premiata pasticceria Lorenzo Balocco’. Balocco fu un pasticciere venuto da
Cuneo ad abitare di fronte al negozio, subito dopo le docce. L’apice della fama
venne raggiunta il 5 giu.1905 in occasione dell’inaugurazione in piazza del Monastero,
del monumento a Garibaldi: la regina, venuta a Genova e di passaggio in
carrozza davanti alla pasticceria, fu invitata ’al volo’ ad assaggiare gli
amaretti qui prodotti; piaciuti, ne ordinò altre confezioni che il proprietario
si affrettò a regalare all’augusta sovrana. Dopo pochi giorni, il Balocco
ricevette una missiva da corte, che lo autorizzava a fregiarsi del titolo di
‘fornitore della real casa’, degli amaretti da allora ‘della regina’.
Nel Pagano/1911 cita il Balocco, ma alla voce “liquoristi” e
“pasticcieri”, non come “caffettiere”. Nel 1919 e 25 è “caffè-offelleria già
Ballocco (sic) Lorenzo ora Garrone e Reverendito” (ed è preferita, come
principale, l’entrata di via N.Barabino). Quando tra il 1911 e ‘19 cedette
l’attività (non è chiara la successione: si dice andò ad una sua nipote ex
dipendente delle poste che si chiamava Pedemonte C. (confermato nel Pagano) Nel
/1931 si vantava essere la più vecchia nel ramo dei servizi nozze e soirée.
Nel Pagano/33 non risulta più. Ricompare nel /’61 affermando che ha già ceduto
l’esercizio). Altrove si scrive che fu rilevata (probabile in affitto) da
Isnardi, Gambino & Mazza (tra loro soci, i quali nel 1933 risultano fossero
anche in via C.Colombo all’1r).
Tipico, oltre gli amaretti, era il pandolce genovese, da
loro prodotto. Caratteristica l’insegna: in città unica scritta su piastrelle
di ceramica in stile liberty; molto elegante, colorata, raffinata con caratteri
flessuosi, in un fascione posto sopra le vetrine e che anticamente appariva su
ambedue le strade essendo d’angolo (mentre le piastrelle ai bordi della
striscia sono bianche lisce, quelle della linea centrale sono singolarmente
decorate con un ripetuto disegno di una pigna stilizzata, circondata da lunghe
foglie ad ago, di pino).
===civ. 1: una edicola sopra il portone con la
Madonna Immacolata a braccia aperte.
===civ.5: una edicola sopra il portone. Un vetro ed una grata
impediscono un migliore riconoscimento di una Madonna col bimbo in braccio e
due putti sovrastanti.
Al
5r vengono ricodati i fratelli Barazzoni, lattonieri e stagnini negli anni ’30
circa.
===civ.
7: viene descritta l’esistenza di
una galleria, che dai fondi-cantina del palazzo, correva sottoterra parallela
alla strada, sino a via San Pier d’Arena, nata non si sa a quale scopo (sicuramente utilizzata in guerra
come rifugio antiaereo e come via di fuga da alcuni partigiani; ma da secoli
era di interesse anche dei contrabbandieri: la Dogana genovese, si trovò
sempre in accentuate difficoltà a controbattere la piaga del contrabbando sulla
spiaggia: il Ministero delle Finanze il 10 ottobre 1800 approvò una restrizione
delle zone di imbarco e sbarco delle merci nel tratto tra la crosa Larga e dei
Buoi (specie come il vino, carbone e legna); venivano esclusi i pescatori). Caratteristica il sopraportone: due volute
floreali laterali pongono nel centro un leone accucciato sorreggente uno stemma
che ha banda laterale trasversa ed è scalpellato in due direzioni diverse a
significato di differente colore non riproducibile nel marmo (o gesso).
===gli
ultimi civici pari, hanno i balconi delle finestre con belle e lunghe
inferriate che sembrano riportare ad un primitivo unico progetto o proprietario
===45r
negli anni 60 era in attività il fotografo-ottico Massa Italo, tel. 43741
===civ. 47r la farmacia Centrale. Si scrive sia stata rilevata
nel 1880 –quindi già esistente da prima - dal dott. F.Sommariva,
subentrando ad un dottor Delpino Angelo che sappiamo però essere ancora
in attività nell’anno 1889. Il negozio allora, non era sulla strada ma nella
piazza oggi V.Veneto. Infatti quando a questi subentrò il dottor Pizzorni
Giuseppe (che nel
1919, chiamato Pizzorno, divenuto titolare della farmacia chiamata col suo nome
(servizio notturno), era ancora localizzata in piazza Ferrer;
e nel 1933 in piazza Vittorio Veneto, 58).
Nel 1940 appare in via S.Canzio e intestata sempre al Pizzorni quando però
questo farmacista non esiste più nell’albo professionale di quell’anno. A
tutti, subentrò infine la dott.sa Pedemonte Anna.
Catalogata
nell’elenco delle botteghe storiche, si scrive che così arredata sia nata nel
1910, con mobili in stile liberty (credenze con vetrine, bancone in legno,
credenza a ponte con specchi, soffitto con stucchi a cassettoni e rosone
centrale, porta-vetrine-insegna originali. Nonché vasi in vetro, che all’epoca
contenevano le varie preparazioni
===Posti
nella strada, si ricordano antichi e vecchi negozi tipici : i Traverso-Moretto nell’angolo a ponente a mare.
Era cartoleria cancelleria, e loro anche lavoratori vetrai e di
porcellane di produzione propria; gestivano anche commesse per finestre di
interi palazzi, lampadari di Murano e cornici (civ.2r).
Il Traverso, era un attivissimo repubblicano,
divenuto anche consigliere comunale locale: fu uno degli incaricati di andare a
raccogliere a Pisa le spoglie di Mazzini ed accompagnarle a Genova.
Il
ristorante Tamburelli e la trattoria ‘Lisin’ il cui proprietario andava
a pescarsi i pesci personalmente. Un cinema (piccolo, con non più di cento posti e vissuto
poco); vicino ai Danieli famosi per materiali elettrici (civ.14r). Un negozio di tessuti chiamato ‘la città di
Genova’, gestito da Bartolomeo Parodi, e poco dopo il caffè Elvetico (civ.51r) gestito dai fratelli Fossati chiamati popolarmente ‘u
velenu’ l’uno, e ‘a burrasca’ l’altro. La pasticceria Giacometti; le
sorelle Costa (civ.7r) di frutta e
verdura con le primizie; la salumeria fratelli Prato, con specialità la
torta pasqualina e poi credo divenuta Benassi (civ.54);
il Banco di Chiavari (civ39r); droghiere Colosso (civ.42r); gli
idraulici f.lli Barazzone (civ.27);’alla città
di Trieste’ tessuti
(civ.18r);
la lavanderia con l’onnipresente (ancora nel 2003) Argia Semino Morre (lei,
sofferente di bronchite cronica, è sempre in negozio; scherzosamente le si
diceva: forse… è nata li dentro); il tabacchino Grondona (civ.34r) non più aperto dagli anni 2000 perché lui in
pensione; Picchio salumiere (civ 17r), Capriotti
Manlio, costruttore di apparecchi radio e loro accessori come valvole,
amplificatori, dischi, ecc.; nonché ottica, frigoriferi (civ 32r), Rossi ombrelli (civ 56r).
L’elenco non finirebbe più. Ma la memoria
‘vede’ anche un parrucchiere, strumenti
musicali Alberti, calzaturificio, osteria, giornalaio, coltelleria profumeria,
ottica Massa, friggitoria, calzolaio, merceria, trattoria Ratto , cappellaio,
orefice; in cento metri
tutti i servizi: un pre-super market completo!
La strada, dagli anni dopo l’ultimo conflitto mondiale,
ha subito dello spostamento del centro vitale, dalla piazza Vittorio Veneto a
via A.Cantore; e contemporanea agonia commerciale della marina (destinata al
traffico pesante e di scorrimento), subendo un decadimento di movimento e di
interesse, dalla proibizione di sosta dei veicoli.
STRUTTURA: senso
unico veicolare, da piazza Vittorio Veneto a via San Pier d’Arena.
Strada
comunale carrabile, lunga 129,5 metri e larga 4,2, con due marciapiedi larghi
1,5 metri; con 12 bocche dette ‘di lupo’ per parte, per la raccolta di acqua
bianca piovana.
Una
disposizione di fine 1998, ha decretato il divieto di posteggio per tutta la
via, creando all’inizio strada una “strettoia”, obbligata da uno slargo del
marciapiede sormontato da due paletti. Questa pedonalità non ha creato, a mio
avviso, beneficio ai negozi ancora presenti.


le
case a sinistra sono il retro della nostra strada; a destra si intravvede il
palazzo delle Poste. Nel mezzo la casupola e due punte come di un ex cancello;
fa ricordare antiche proprietà nel terreno non conosciute.
DEDICATA ad una
delle più grandi figure garibaldine. All’indomito militare di non comune
coraggio, divenuto poi uomo politico, ed amministratore attivissimo e
perspicace.
 1870 con la moglie Teresita
Garibaldi.
1870 con la moglie Teresita
Garibaldi.
Nato a Genova il 3 genn.1837, da Michele (poliedrico geniale ed arguto personaggio artista:
decoratore, pittore, scultore, architetto ed infine anche impresario. Vedi a
via Daste-villa Scassi) e da Carlotta
Piaggio (figlia di
Martin, grande nostro poeta dialettale).
Cugino, fu Michele Novaro, il musicista del nostro inno nazionale.
Crebbe, indirizzato quindi agli studi artistici, studiando al ginnasio Doria, a
cui sembrava portato per l’ereditata estrosità, senso dell’umorismo ed
irrequietezza comportamentale (come, -costantemente calato sul capo- un personale e caratteristico
cappello a staio di vistosissime proporzioni), e per lo spirito (goliardico, gioviale, estroverso, eccentrico, iperattivo).
Pare però che da giovane ottenesse risultati culturali poco brillanti.
Perché il destino aveva deciso diversamente per lui. Frequentando Antonio Mosto
ed Antonio Burlando (creatori
dei Carabinieri genovesi, sorti dalla società di tiro a segno) a 22 anni si arruolò con loro come soldato semplice
volontario, carabiniere genovese, per la II guerra di Indipendenza. Subito si
distinse, sia a san Fermo (vicino a Como, 27 mag.1859 dove Garibaldi vittorioso poté
annettere il territorio e subordinarlo al governo di Vittorio Emanuele II) ove fu nominato sergente; sia a Varese (dove, assieme a altri 48 volontari
dei Carabinieri Genovesi, compì miracoli di valore respingendo gli austriaci
del gen. Urban: le nuove carabine aprivano vuoti spaventosi nelle fila
addossate dei soldati nemici avanzanti – e quindi facile bersaglio - con
l’inquadramento dell’epoca napoleonica).
L’anno dopo, partecipò all’organizzazione, e partì con i Mille (con l’impegno di corrispondere al
giornale mazziniano genovese “Movimento” le notizie della spedizione). Combatté fino a Palermo, ove meritò i gradi di
ufficiale (tenente), ma dove fu ferito da una fuclata alla clavicola sinistra
nella conquista del Ponte dell’Ammiraglio e fu sottratto al fuoco nemico da un
carabiniere genovese – Pietro Damele di DianoCastello- che rimase pue egli
ferito. Per questa - da lui definita - ‘potentissima frustata’ poté raggiungere
i suoi soldati quando essi già erano giunti in Calabria; in tempo però per il
Volturno, ove per meriti sul campo, fu
nominato capitano e per entrare in Napoli a settembre con Garibaldi.
Dopo Teano, seguì fedelmente il suo comandante, quando questi si ritirò a
Caprera; qui conobbe la diciasettenne (Badinelli scrive 16enne) Teresita - figlia
del generale e di Anita -: «dunque voi amate la mia Teresina? Ebbene, sia
vostra sposa. Nessuno meglio di voi è degno di lei...».
Così,
lui ventiquattrenne, si sposò il 25.5.1861, celebrante il parroco della
Maddalena.
Divenuto genero di Garibaldi, ancor più si sentì fedele braccio destro e
luogotenente (succedendo
nell’incarico a Francesco Anzani).
Irrequieto come l’ Eroe, lo seguì a Sarnico; ad Aspromonte (’62); a Bezzecca (3.a
guerra d’Indipendenza, ove meritò i gradi di maggiore, tant’è che venne
chiamato ‘il vincitore di Bezzecca’, per aver ripreso la città al nemico; ed
una medaglia d’oro al VM la cui motivazione dice : “nel momento in cui i nostri, sopraffatti dal numero dei nemici
piegavano in ritirata, egli raccogliendo intorno a sé parecchi ufficiali,
diresse l’azione, animò coll’esempio e, ordinato da ultimo l’attacco alla
baionetta, contribuì specialmente all’esito fortunato della giornata. Bezzecca
26 luglio 1866”).
Nel ’67, riuscì a far evadere Garibaldi da Caprera con il suo “beccaccino”:
impresa quasi da romanzo e che richiese invece audacia e freddo calcolo per
sfuggire il blocco navale della marina piemontese. Riorganizzati, partirono - suocero
e genero, e lui nel vestito con i rendigote ed il bislacco cilindro - per la
battaglia di Mentana (1867 ove meritò i gradi di colonnello), nello scontro
salvò pure la vita a Garibaldi calcandogli sul capo il suo cilindro ed
impedendo che i francesi, armati di carabine a ripetizione (i famosi
chassepots’), lo riconoscessero e lo prendessero di mira.
Nell’anno 1870, a fronte dell’apparente sociale
tranquillità, per i patrioti repubblicani erano invece tempi di persecuzione
fino all’odio per la loro avversione ai Savoia e l’insaziabile sete di Patria
unita: perquisizioni e stretto regime poliziesco erano all’ordine del giorno.
Il 23 marzo, Mazzini arrivò a Genova da Lugano e, all’ultimo piano del civico 6
di via san Luca, si fermò a parlare con il comitato rivoluzionario (comprendente oltre A.Mosto, altri otto ed il Canzio;
appreso il fallimento dei moti di Pavia e Piacenza, stigmatizzò la prosecuzione
dell’agitazione e l’impegno di ‘o Roma, o morte’). Bloccato così da
questo primario impegno, con i volontari italiani inquadrati nella I e V
brigata, andò a combattere in Francia nella guerra franco-prussiana, coprendosi
di gloria in ogni battaglia (a Présnois caricò
il tedesco sul fianco sinistro sbaragliandolo; personalmente si distinse perché
condusse l’attacco e la carica dei “chasseurs à cheval” che aveva racimolato,
seguiti dai suoi fanti, con la solita stranezza di non vestire la divisa ma
la palandrana rendigote e sul capo il cilindro, senza armi ma solo con un
frustino in mano. A Talant, ove resse per dieci ore di seguito ad un
cannoneggiamento dell’artiglieria tedesca e poi infine avendone ragione. Al
castello di Pouilly dove in gara con i
“franc-tireur” di Ricciotti riconquistò per tre volte la posizione finché
costrinse il nemico alla fuga. Ed a Digione (qui, trentaquattrenne, fu nominato
generale sul campo perché concluse per tutti la battaglia che durava da tre
giorni, con una carica risolutrice della prima brigata; con i soldati di
Ricciotti conquistò l’unica bandiera che in quella guerra si riuscì a togliere
al nemico. Nel monumento a Garibaldi eretto in questa città, il suo nome è
scolpito sul piedistallo)). Il diario dell’impresa è custodito
all’Istituto Mazziniano. Con questa
campagna francese, si concluse pure il ciclo delle nostre guerre di
Indipendenza.
Ritiratosi
allora a vita civile, venne ad abitare in via Assarotti, 31 (ove è apposta una lapide
“nell’ottobre MDCCCLXXX/ fu ospite in questa casa/ presso la figlia Teresita/
Giusepper Garibaldi”; La lapide fu rifatta nel 1948 perché andata distrutta
durante il regime fascista, aggiungendo pertanto “Il Comune di Genova/ in
memoria / MCMXLVIII”). Grazioso episodio
di questo soggiorno è raccontato da Maria Vietz sul Bollettino della A
Compagna: sua nonna, era a servizio dei coniugi Canzio; un giorno a tavola
Stefano notò un piatto non ben lavato ed altezzosamente chiese che lo
cambiassero. Il cuoco in cucina ci sputò sopra e dopo averlo asciugato lo fece
riportare a tavola ottenendo l’approvazione del padrone.
L’usuale
bellicoso guerriero non si sottrasse al nuovo tipo di combattimento. Avversando
i falsi reduci ‘che potevano vantare solo la cicatrice...ombellicale’ o ‘la
campagna...in villa a san Cipriano’ proseguì però la sua lotta repubblicana in
forma alquanto diversa: accettò l’impegno in politica non schierato da una
parte ma affrontando tutti i problemi che a suo personale avviso si
presentavano da risolvere. Nel 1872 fu incaricato da Garibaldi con un
telegramma di rappresentarlo ai funerali di Mazzini (morto a Pisa il 10 marzo), portando alta la bandiera dei Mille (era stata confezionata dalle donne di Napoli nel 1860 e
consegnata in custodia al Comune di Genova l’anno dopo). Capitanò i moti popolari genovesi, per cui fu anche arrestato e
condotto nelle carceri di sant’Andrea con l’accusa di ‘attività sovversiva’ (Durante la commemorazione mazziniana
del 10 marzo 1879, avvenne un conflitto a fuoco tra la polizia ed alcuni
esaltati repubblicani: subì un processo e fu condannato ad un anno di carcere,
ridotto a tre mesi dalla Corte d’Appello; così fu arrestato nella sua casa e
tradotto in sant’Andrea. Garibaldi, seppur invalido per l’artrite, cercò di
venire a Genova ma cercarono di impedirglielo anteponendo intoppi burocratici
imposti dal governo; allora, col solito cipiglio arrivò in lettiga ed inaspettato
via mare il 4 ott.1880: col prestigio del suo nome e la deferenza di tutta la
popolazione accorsa, ottenne per il genero una amnistia e la scarcerazione.
Destino volle che Garibaldi in quei giorni concitati, conobbe la giovane
Francesca Armosino nutrice dei nipoti: se la portò a Caprera per sposarsi la
terza volta, non senza una certa avversione della figla).
Nel 1884 ricevette un’altra medaglia d’oro al
valore civile, per l’opera attiva
durante l’epidemia di colera.
Due figli del Canzio nel giu 1885 furono giudicati colpevoli assieme ad altri
per aver picchiato a morte un operaio cattolico durante una sfilata religiosa; la pena (mitissima, non superando
tre mesi e sei giorni di carcere) fu interpretata quale frutto della sottile
campagna di odio verso la Chiesa (a Genova era arcivescovo mons.Magnasco; papa
era Leone XIII) e comunque anticlericale da parte del governo sabaudo con
pretta vocazione laicista. Il commento cattolico fu “i figli d’un padre della
patria non potevano che finire nelle patrie galere”. Uno dei due, di nome Michele divenne insigne
architetto, e partecipò all’ornamento della villa Scassi e del Municipio
locale.
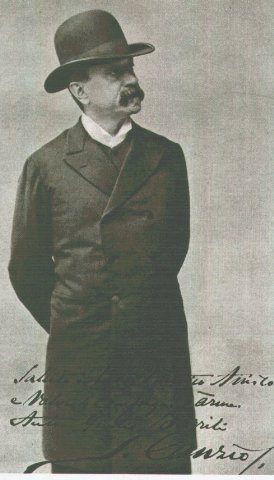
Fu eletto deputato nel 1891, ma il 4 lug.1903 rinunciò all’impeno romano
preferendo la carica di Presidente del neonato Consorzio Autonomo del Porto di
Genova (vedi disegno si ‘san Teodoro pag.35-dice agosto-). Con questo incarico
di comando - allora chiamato anche ‘sommo magistrato del porto’ oppure
‘generale’ - il Canzio guidò per primo il CAP con la solita identica carica
impetuosa ma aggiungendo oculata capacità, alta responsabilità e squisito senso
tattico. Si scrive che di fronte alla minaccia di una rivolta sulle banchine
dovuta alle sue prime decisioni, esclamò «vogliono il
sangue?
ottimamente, da un bel pezzo non ne vedevo scorrere». Il porto era arretrato
rispetto le nuove regole internazionali sia per gli imprenditori, sia sui moli
che sulle navi (da vela a motore; da legno a ferro). Riuscì così, malgrado vive
opposizioni ed aspre contrarietà, a imporre una legalità basata sul potere di
un ente autonomo che se rappresentava lo Stato, non doveva rendergliene conto;
uno stato nello stato: palazzo s.Giorgio amministra il territorio, stabilisce
le leggi, codifica il lavoro delle categorie con piena giurisdizione, senza
controlli superiori. Per primo, si fece
riassegnare il palazzo del Banco in cui stagnavano – per mancanza di soldi - i
lavori di restauro guidati da D’Andrade; e si fece carico del completo
prosieguo dei lavori.
Su sua richiesta furono apportate solo queste modifiche: inversione di
orientamento dell’edificio con apertura dell’ingresso sulla facciata a mare, e
costruzione ex novo del relativo scalone interno che porta alla Sala delle
Compere e commissione al pittore Lodovico Pogliaghi di ridipingere le facciate
deteriorate (dapprima eseguì un bozzetto, dopo che due pittori Ferdinando
Bialetti e Gaetano Cresseri avevano fatto studi sui graffiti e sulle cromie
rimaste) e nel 1913 completò l’opera.
Poi,
riuscì a coordinare amministrativamente categorie di lavoratori incolti ma
eccitabili e fortemente coalizzati in interessi settoriali, a modificare leggi
eccessivamente burocratizzate in materia di navigazione di trasporti, di scambi
ormai internazionalizzati e non ultimo di programmare nuovi impianti,
consorziare i servizi basilari e sollecitare i grandi lavori.
Signorilmente povero, in corso Magenta ove era andato ad abitare, morì il 13
genn. 1909 per polmonite poco prima delle ore 23,15 (per altri la data di morte è il 14
gennaio, forse giustificati dalla tardissima ora del decesso; per altri è
addirittura il 29 luglio; la malattia – pare una polmonite - fu contratta per essersi buttato in mare per soccorrere un portuale
durante un incendio sulle calate. Gli successe interinalmente il
vicepresidente comm. Natale Romairone (dal 15 genn. al 18 aprile 1909 quando
fu eletto l’ing. grande uff. prof. Nino Ronco, già rappresentante il Comune di
SanPierd’Arena in seno all’Assemblea Generale).

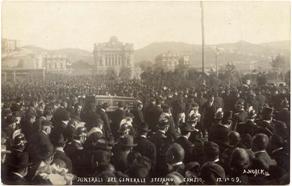
Fu sepolto nel Famedio di Staglieno (Pantheon, t.LXX). La lapide dice “Stefano
Canzio / 1837-1909 // fiera tempra di soldato / come Nino Bixio / ebbe di
Garibaldi l’affetto / e ne impalmò la figlia // opposto per indole al genitore
Michele / la sua vita fu tutta una battaglia / illuminata da passione di Patria
/ combattuta dovunque / il nome d’Italia / splendesse sui labari / e sulle
speranze”.
Dolcino riferisce di una pubblicazione che fa del Canzio un appartenente alla
massoneria genovese, in una delle logge del Grande Oriente d’Italia.
Nel 1904 un curioso episodio riguarda il cerimoniale navale: ospite come
presidente del CAP sulla nave francese Jena, non fu salutato con le dovute
salve di cannone; dalle rimostranze consolari ottenne, ad una successiva visita,
che l’ammiraglio Barnaud ne ordinasse 13 in suo onore, come dovuto.
In particolare per noi, l’evento più eclatante del suo ultimo impegno avvenne
il 25 ottobre 1905 quando con grandiosa solennità (presenti i reali d’Italia, e le squadre navali
italiana, francese, inglese, americana e germanica) venne
calata in mare la prima pietra della grande diga esterna foranea (che sarà lunga 1700m.: un enorme macigno di 40t. tratto dalla cava
della Chiappella con scolpita in rosso la data) a difesa del nuovo bacino del
Faro riservato al movimento del carbone (o della Lanterna; ma che all’epoca, l’Assemblea del
Consorzio aveva assegnato il titolo ‘bacino Vittorio Emanuele III’) che poi sarà inizio della diga verso
SanPierd’Arena. I lavori avranno corso regolare dal 1906 secondo il progetto
dell’ing. Inglese, poi modificato.
Mentre l’opera più grande è l’aver dato con intuito geniale il primo serio
ordinamento al lavoro operaio nel porto superando le più vive ed aspre
opposizioni. Il regolamento ripartiva i lavoratori in categorie (merci varie, carbone, ecc ...); a loro volta suddivise in compagnie (ad esempio, i carbonieri erano a
loro volta suddivisi in facchini, scaricatori, pesatori, ricevitori); all’interno di ogni compagnia, i portuali potevano
costituire cooperative di lavoro per strappare via via l’esclusiva delle operazioni
di carico e scarico.
Gli è dedicata una calata nel porto.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 810
-A.sconosciuto-Guida
del porto di Genova-Pagano.1954-pag.28
-AA.VV.Annuario-guida
archidiocesi-ed./94-pag.390---ed./02-pag-427
-AA.VV.-Enciclopedia
dei liguri illustri-Erga.1970-pag.509
-AA.VV.-Guida
alle botteghe storiche.FeFerrari.2002- pag.128
-AA.VV.-1886-1986Oltre
un secolo di Liguria-SecoloXIX.1996-pag.144
-AA.VV.-Novant’anni
con “il Lavoro”-Basile.1993-pag.13
-AA.VV.-Pozzi
E-a G.Mazzini,inaugurandosi…-Sordomuti.1882-pag.105
-Bertuzzi
L.-Tra i Mille...e non solo...-La Berio n.2/2010-pag.83
-Cabona
D-Palazzo sGiorgio-internet- //B:\genova/sangiorgio.htm|
-Carozzi
& D’Aste-Il Secolo XIX quotidiano del 11.02.03
-Casa
Ferdinando-Ponente ligure-Finalpia 1959-pag.52
-CuneoM&GPSicardi-Vocab.parlate lig.-lessici
spec.2-II-ConsultaLig.1997-pag 105
-Dolcino
M.-I misteri di Genova-Pirella.1976-pag.50
-Dolcino
M.-Storie di Genova-Frilli.2003-pag.75
-Festa
C.-Guida del porto di Genova-Luzzatti.1922-pag.42.110.
-Gazzettino
S : 4/74.6 + 6/80.3 + 9/80.7 + 11/81. + 1/84.13 + 7/92.6 +
-Genova-
Rivista municipale : 4/37.30 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.101
-Massobrio
A.-Storia della Chiesa a Genova-DeFerrari.1999-pag.99
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA-1986-pag.72.105 --Morabito.Costa-Universo della
solidarietà-Priamar.1995-pag.182
-Novella
P.-Le strade di Genova-Manoscritto Bibl.Berio.1900-30-pag.18.9
-Pagano
edizione/33-pag.245—ed./40-pag.232---/61-pag.125
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.311 foto
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995- tav.33-34
-Terrile
Vietz M.-Racconto di mia nonna- Bollettino ACompagna-3/2010
CANZIO piazza Stefano Canzio
Il lavoro di Novella, riferito
alle prime decadi del 1900 cita esistere allora, la “Nicolò Barabino (via), da
via Cristoforo Colombo (già via Buoi)” , ed una “Stefano Canzio (piazza), da
via Cristoforo Colombo“.
Dopo il 1910 all’elenco delle
vie edito dal Comune fu aggiunto a mano: “piazza Stefano Canzio, di fronte al
Casotto del Dazio centrale, con civico 2“.
Nel 1927 intestata al patriota
ufficialmente c’era ancora solo la piazza.
Il Pagano del 1933 conferma
che a quella data, l’attuale via S.Canzio
si chiamava ancora via N.Barabino; e che la “piazza S.Canzio” era ‘da via
C.Colombo al mare’, che aveva un civ. 2; ed era di 3.a categoria. Purtroppo
non è intuibile a quale slargo si riferisca, solo che il dazio era a ponente
del baraccone del sale.
Per delibera del podestà, del
19 ago.1935, la piazza fu cancellata ed inglobata in via N.Barabino (via San Pier d’Arena dal 1954).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio S.Comunale
Toponomastica - scheda 811
-DeLandolina GB – Sampierdarena-
Rinascenza .1922 – pag.35
-Novella P.-Le strade di
Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-p.18.19
-Pagano ediz./1933-pag.245
CAPELLO via Vincenzo
Capello
TARGA: via - Vincenzo
Capello – 1856 – 1920
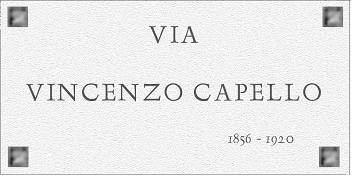
QUARTIERE ANTICO: san
Martino
Non descritta la zona nella carta del Vinzoni, 1757.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2744 CATEGORIA: 2
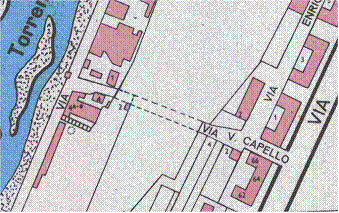 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 11720
UNITÀ URBANISTICA: 24
– CAMPASSO
 da Google Earth 2007
da Google Earth 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA:
s.G.Bosco
STORIA: posta in
piena zona dell’antica Piazza d’Armi,
nacque con la costruzione di via Porro e delle sue case per i ferrovieri; per
iniziativa delle FF.SS.; ed in quanto privata, inizialmente non sottoposta a
scelte comunali.
Infatti,
la Guida Pagano/33, la cita “privata, da via UmbertoI (via W.Fillak) al torrente
Polcevera“, senza civici. Anche la scheda 813 della toponomastica e la guida
Pagano/61 la pongono tra via W.Fillak e via Argine del Polcevera, con due civv.
rossi.
A
quel tempo quindi comprendeva il sottopasso della ferrovia, oggi chiuso
al pubblico perché privato delle ferrovie; fino a dopo l’ultima guerra mondiale
era aperto e transitabile; durante l’evento bellico una bomba esplosa troppo
vicino, uccise due operai ivi corsi per ripararsi dal bombardamento. Nel
Pagano/67, dalla cartina si vede il tracciato di questo sottopasso, che andava
a sbucare in via Argine del Polcevera a livello del civ. 4A-B; dalla stessa
cartina si rileva che allo sbocco c’era anche un civ. 1; e, di fronte, un
altro civico definito A (ma forse anch’esso 4A)
CIVICI
Numerazione
senza rossi e neri. Dal 2 al 92 (compreso 2b)
(mancano 8 e 78)
===civv. 2 e 4, furono eretti nel 1970 sul
sedime di altri palazzi demoliti in quello stesso anno.
===il
2B fu assegnato nel 1985 ad una
porta allora senza numero.
I
civv. pari dal 10 al 92 furono assegnati negli anni 1995-98 all’edificio
industriale ristrutturato.
STRUTTURA: strada
chiusa, doppio senso veicolare, da via W.Fillak, ad un sottopasso (chiuso
dalle FF.SS.) sotto il muraglione della ferrovia.
A
metà, dalla destra, si stacca verso nord via E.Porro.
Non
ha negozi.


Appare
servita da ambedue gli acquedotti cittadini (Nicolay, De Ferrari G.)
DEDICATA al primo
Capo compartimentale delle FF. SS., quando nel 1905 fu instaurato questo
ufficio. Era in atto di programmazione l’esecuzione e riempimento del vasto
parco ferroviario del Campasso, entrato in funzione l’anno dopo. Ed a lui,
assieme al Porro, ambedue probabilmente con la laurea in ingegneria, si deve
anche la progettazione e realizzazione delle case per i ferrovieri erette nella
zona (da ciò, la targa probabilmente imposta dalle Ferrovie stesse).
Lamponi relaziona di una lettera del Capello datata 13 ottobre 1907 che
ringrazia la P.A.Croce d’Oro per l’intervento in un incidente avvenuto nella
stazione ferroviaria, e che premiò allegando la ragguardevole cifra per allora,
di 150 lire.
Viene citato un ‘sig. Cappello’ (in alcuni testi, con 2
‘p’) in quanto che, il giovedi 17.XII.1931, fu inaugurato un refettorio
dell’ONMI (opera nazionale maternità e infanzia) in uno splendido antico
palazzo di via Bosco, messo a disposizione dal proprietario, il quale - oltre a
questa concessione - si è sottoscritto a versare annualmente 8mila lire per
sostenere il centro. Il palazzo era munito di uno scalone marmoreo e ricco di
vasti ed ariosi saloni affrescati e decorati con sobrietà e buon gusto. Si
tratta ovviamente della villa del XVI secolo, che nella pianta vinzoniana del
1757 apparteneva a GioGiacomo Grimaldi; poi divenne dei Cristofoli; fino a
passare in mano agli inizi del 1900 a questo Capello (con una ‘p’, da ‘le ville
del genovesato’) che nel 1937 – Dio lo perdoni - la fece distruggere perché in
stato avanzato di degrado.
Ma per il Pagano/33 a San Pier d’Arena unico ‘costruzioni
edili’ era Capello Filippo, sito qui in via Pastrengo (mentre a Genova ne
esiste un altro, Giuseppe, in v.Rovare).
Citato da tutte le enciclopedie (E. S.; E. M.; E.
Treccani; internet) si trova solo un omonimo, generale del mare, veneziano del
XVI secolo , che partecipò (nel 1538) alla campagna guidata da Andrea Doria,
contro lo strapotere navale del turco Barbarossa.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale della Toponomastica - scheda 813
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi- ed./94-pag.390---ed./02-pag.427
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-pag.106
-Genova
Rivista municipale : 1/32.84
-Pagano
edizione/1933 pag. 245---ed.1961-pag. 125
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10
non
citato da Encicl.Motta e Sonzogno; Novella; Liguri illustri
CARDUCCI via
Giosuè Carducci
Attualmente questa titolazione
non è più a San Pier d’Arena. É a Genova, parallela a via XX Settembre, in
Portoria.
Corrisponde al primo nome
dell’attuale via Antonio Cantore.
Prima di aprire il tracciato,
la zona era pressoché tutta ad orti o giardini. Furono necessari espropri di
terreno più o meno coatti, demolizioni di alcuni stabili; ma soprattutto
sacrificare con noncurante spregio e lucroso vantaggio di alcuni, tutte le
ville della zona che risultano oggi collocate in maniera snaturata (soprattutti
villa Scassi di cui si ammira il retro del palazzo, e la villa Spinola
soffocata dai palazzi eretti attorno) ed alcune addirittura successivamente
abbattute a favore della nuova edilizia con i portici.
Fu ideata come quarta grande
arteria longitudinale, e programmata perché divenisse la più ampia, comoda ed
importante per la città di San Pier d’Arena.
Il primo piano regolatore, che
porta la data del 1899, prevedeva l’apertura di una grossa ‘nuova
strada di comunicazione tra Genova e Sampierdarena’. Ma tutto rimase nei
progetti. Ed ancor quando poi fu aperta via
di Francia, riemerse il bisogno di un’altra grande arteria centrale da
porsi parallela a via Vittorio Emanuele (via G.Buranello); ma il progetto rimase fermo perché si doveva
o passare sotto la collina di san Benigno, o abbatterla. Comunque, fu tracciato
il tragitto e le caratteristiche: doveva avere ‘24 m. di larghezza, e misurare
2070 m da DiNegro al Ponte’. Dal 1910, prima ancora che il piano stesso
- rivisto più volte - diventasse definitivo, alcuni imprenditori iniziarono a
costruire palazzi (il Pagano 1912 inserisce nuova, la farmacia, di Anselmo)
seppur lasciando adeguato spazio per la strada, la quale, con le case prese
forma: così nell’elenco delle vie edito dal Comune nel 1910 si legge aggiunto
posteriormente a mano “Giosuè Carducci (via) grande arteria tendente al taglio
di S.Benigno”.
Queste iniziative corrisposero
quindi solo alla prima parte di levante della lunga arteria; infatti, il primo
tratto costruito anteguerra (del 1915-18): fu di 125 metri, racchiuso
tra la villa Spinola (vedi in foto Carducci1 parte del
parco ancora esistente) e vico
Imperiale di fianco-est alla villa Scassi (via Malinverni), delimitato a ponente dal campo sportivo (posto retro la villa Scassi); ed a lui fu
ufficialmente affidato il nome di ‘via Giosuè Carducci’.
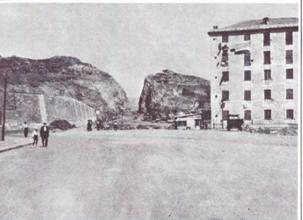

il
taglio in prossimità della camionale la villetta, prima a
destra, potrebbe essere la
residenza dei DeAndreis
Il campo
sportivo Dapprima non esisteva un
vero e proprio campo specifico: chi voleva giocare doveva arrangiarsi a cercare
spazi nei prati, disponibili ai primi che arrivavano, e contendendoseli con i
tamburellisti (allora per la maggiore in quanto lo sport più seguito ed i
nostri atleti campioni d’Italia:quindi sportivi seriosi); con gli studenti
degli istituti viciniori in cerca di una partitella; con i giocatori della lippa;
con i militi della Croce d’Oro in necessità di esercitazioni; ecc.


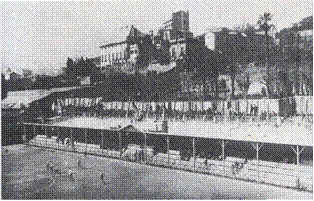
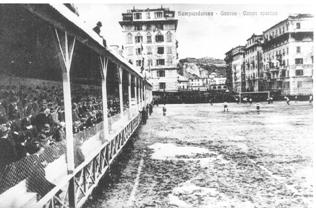
Di
tali campetti restano famosi quelli nella Piazza Galoppini (vedi); nella
zona della Fornace (vedi); ed in Piazza
d’Armi (vedi) ed alla Marina.
Il
primo aperto con velleità specifiche fu nel 1919 il “campo delle monache”, ospitate in palazzo Spinola e quindi posto nei
giardini, nel retro della villa, ove oggi scorre via Cantore (il progetto della
strada era appena stato varato e si attendeva la messa in opera: cosicché fu
vissuto per un solo anno, quando iniziarono a costruire i primi palazzi della
via G.Carducci (vedi); tanto bastante però perché fosse anche sede di
allenamento per i nove (su venti in totale) atleti della Ginnastica
Sampierdarenese facenti parte della Nazionale Italiana prossima a partire per
le Olimpiadi di Anversa –1920 -; ebbero anche il tempo di comporre un saggio
ginnico dimostrativo).
Più
perfezionato, quello aperto nel retro di villa
Scassi, spianato nel 1920
dall’impresa Stura e che andò a sostituire il precedente provvisorio campo in
considerazione del grosso ‘boom’ che aveva ottenuto la nuova disciplina
sportiva nell’attenzione del pubblico. Anche qui lo spazio era assai limitato,
tanto da offrire la battuta di essere chiamato ‘scatola da pillole’ (definizione
del giornalista Carlo Bergoglio); epperò regolamentare per giocare a 11. Era
limitato dalla facciata posteriore della villa, dai rialzi dei giardini, dal
muro delle Franzoniane e a levante dai ‘palazzi nuovi’. I giocatori, tutti
‘nostrani’ dilettanti, chiamati quindi per nome, richiamavano folto pubblico
divenendo centro di attrazione per le signore civettuole, madri o fidanzate dei
giocatori.
Nel Pagano 1920 al
civ.2 si era già insediato il demolitore di navi Bertorello G.B. (c’era ancora
nel 1925), tel.5584.


già
‘staccata’ la villa Scassi dai suoi giardini da tagliare la proprietà
delle Franzoniane

in
fondo alla strada il muro di cinta delle Franzoniane
Nell’aprile1925
l’Ufficio Tecnico del comune di San Pier d’Arena diretto dall’ing. Luigi
Connio, elaborò un ennesimo Piano in cui si prevedevano tre strade principali
(quella a mare; una centrale: via Carducci (per
essa, il Pagano1925 segnala al civ.50 Profumo Cesare ha merceria, fabbrica di calze, commercia ingrosso
maglierie e chincaglierie;--- senza preciare il civico: la “Farmacia Internazionale”; evidente primo nome
della attuale “Cantore”); ed un’altra a monte mai realizzata). Ma con
l’annessione del 1926, tutto venne bloccato per essere ridiscusso e
riesaminato (l’ing.L.Connio venne trasferito a
Genova, mantenendo l’incarico di seguire i lavori). Comunque la “via
G.Carducci”, l’anno dopo appare nell’elenco ufficiale del Comune, ma presente
sia a S.P.d’Arena che a Rivarolo ed in Centro. Nell’ott. 1928, trasferito
il campo sportivo, il giorno 28 fu inaugurato l’allungamento verso ponente di
altri 100 metri. In contemporanea furono restaurati i giardini di villa Scassi
e concessa l’edificazione di due palazzi con i porticati.
Nell’anno 1930 (VIII
dell’era fascista) fu aperto in gran fretta il
tronco genovese dalla Chiappella (da via Milano) fino al tratto già fatto nel 1910 (essendo prossima l’inaugurazione della camionale
che altrimenti non avrebbe trovato sfogo verso Genova; il Prefetto decretò
l’espropriazione urgente delle proprietà, per 420 metri a partire dall’incrocio
della via Chiesa delle
Grazie, seguendo il progetto dell’ing.
Connio e con una spesa di 1,2 milioni di lire; fu appaltata all’impresa
Ferdinando Savio, mediante trattativa privata, essendo andata deserta la gara
d’appalto per l’aggiudicazione): mediante comoda curva, si risaliva al
piazzale della camionale e da lì la strada fu allacciata alla via G.Carducci (a ponente ancora ferma al confine ovest della villa
Scassi) a tutto il tratto fu fatto assumere lo stesso nome anche se già
era in programma di cambiarlo. Fu con questi lavori quindi, che avvenne il
taglio trasversale di ‘via san Bartolomeo’, la cui parte a monte divenne via san Bartolomeo del Fossato; e che il
palazzo (che nel 1961 ospitava l’impresa edile Stura & figli ed alcune aziende di
autotrasporti, e che invece ora ospita un grosso centro di vernici e
tappezzerie) che ha il portone aperto sulla direttrice di quella antica
strada (il portone si offre infatti a ponente)-
divenne l’8E di via A.Cantore.
Nell’anno 1931, sempre
sotto la direzione dell’ing. Luigi Connio, si aggiunsero altri 252 metri, sino
alle Franzoniane con i previsti palazzi solo muniti di portici ed alti non
sopra i sette piani (furono scavati 11.000 mc di terra; corrette le fognature
ed i rivi; costruita la scala per ascendere salita san Barborino; chiusura di
parte della proprietà Franzoniane con cancellata (impresa
Aldo Casadei in cambio di terreno ceduto dalle suore il 15.XII.29 ed accettato
dal Comune in data 6 mar.1930).


“nuovi
palazzi” foto Pasteris,
1937
Nell’agosto 1932 fu
prevista una spesa di 287mila lire per aggiungere facilmente in 4 mesi e con
l’opera di 20 operai, altri 25 metri – espropriati da una proprietà Dellepian e-,
per arrivare così presso la salita Salvator
Rosa davanti al primo complesso ostacolo costituito da un caseggiato di
via G.Masnata che dovette essere svuotato e poi completamente abbattuto.
L’operazione appaltata nel febbraio 1933, previde una spesa di
2milioni50mila lire e l’impiego da 70 a 90 operai per 12 mesi.
Man mano che la nuova strada
si allungava, conservava sempre il nome del letterato; infatti il Pagano/33
pone ‘via G.Carducci’:“ da via regio Istituto Tecnico a via N.Daste”,
cioè: dalla scalette che scendono alla villa Spinola, al punto di incrocio con
via Daste dove si erano già inserite le strade adiacenti (Mameli e Rela) e dove
era l’ultimo ostacolo da abbattere, l’Oratorio. Il
Pagano-1933 cita al civ. 144 r il tappezziere Caorsi Giovanni.
Vengono
descritti al civ. 5 un panificio; la presenza dell’attuale farmacia Cantore, a quel tempo ‘farmacia Chiappori’, ma già del dr.
Saglietto Francesco; al civ.47r una sede dell’azienda autonoma Annonaria per la
vendita di generi alimentari a prezzo minimo.
Classificata
la strada , di 3.a categoria. Contati i civv. a partire dal 10 al 40 e dal
13 al 47 ( se fossero uguali ad oggi, corrisponderebbero da via Pedemonte all’incrocio con corso L.Martinetti ovvero
sino all’<ostacolo> Oratorio della Morte ed Orazione, da demolire) . In
quest’anno furono erette una casa sulla strada progettata dall’ing. R.,Bruno
per il sig. Masnata Emilio, ed il fabbricato progettato dall’ing. Stura e ad
uso scuola dell’istituto M.Pie Franzoniane
Abbattuto l’Oratorio, nel 1938
si aprì finalmente in forma totale la nuova arteria; fu inaugurata con un nuovo
nome: via Antonio Cantore, anche se la
nomina era già stata deliberata dal podestà il 19 ago. 1935. Ed allora la
titolazione al poeta scomparve.
C’è un però, non chiarito: il Novella negli anni 1900-1930, descrive la strada:
“da via Generale Cantore”, la quale, a quei tempi era il tratto
dell’attuale via N.Daste compreso tra palazzo Fortezza e via della Cella:
quindi come se al tratto iniziale di 125m fosse aggiunta anche la trasversale a
scendere. Ipotesi: forse allora via Carducci essendo chiusa ai
due lati, comprendeva anche via Malinverni o v.Damiano Chiesa.
DEDICATA Al poeta, critico
letterario, mazziniano repubblicano, che unanimamente è stato giudicato
‘grandissimo’. Nel 1940 sulla targa stradale era “poeta della IIIª Italia”
Nato a Valdicastello (Lucca)
nel 1836 (E.Zanichelli scrive: 27.7.35).
In polemica con i monarchici,
fondò a Firenze la ’Brigata degli amici pedanti’. Ottenne la cattedra di
letteratura italiana a Bologna. Gli eventi che miravano all’Unità d’Italia,
dopo un incontro con Margherita di Savoia, lo fecero ‘convertire’ alla
monarchia, divenendo così poeta ufficiale della nuova nazione per le poesie a
carattere sorico-patriottico; e, nel 1890, senatore.
Nel 1886 aveva scritto il
sonetto XIV de Le Rime Nuove, nel quel si parla del san Giorgio di Donatello.
Nel luglio 1889 intervenne per la conservazione del Palazzo del Banco di
SanGiorgio genovese, abbozzando una poesia intitolata “Palazzo di san Giorgio” che
non assunse mai completezza né autonomia di poema perché rimase un frammento,
pubblicato come “aggiunta” alle “Odi Barbare - Rime e ritmi”:
Palazzo
san Giorgio – aggiunta di poesie – XVII – luglio 1889
«Stava su gli archi vigile vindice
«il grifio: sotto l’artiglio ferreo
«la lupa anelava, parea
«l’aquila stridere, franta l’ale.
«tale i nemici di Genova infrangere
«usa: diceva la scritta...
(dove
si nota che il Poeta usa volutamente il termine “grifio” spiegato con un
appunto di sua mano a lato “simbolo di Genova, preme un’aquila stemma
dell’imperatore Federico, ed una lupa stemma di Pisa”, scambiando però la
volpe con la lupa)
Nel 1906 fu il primo italiano
a ricevere un premio Nobel.
Morì a Bologna il 16.2.1906.
Donò in testamento alla regina Margherita la sua grandiosa biblioteca. Ella nel
1922 la rese pubblica.
Scarsi i suoi rapporti con
Genova; nulli con San Pier d’Arena se non la scritta sulla facciata del palazzo
detto ‘del san Giorgio’(vedi v.Cantore).
Un suo busto è esposto nei
giardini di Villetta Di Negro.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica scheda 870 +
-DeLandolina GC – Sampierdarena
- Rinascenza .1922 – pag. 35
-Enciclopedia Zanichelli
-Gazzettino Sampierdarenese.
-Genova Rivista municipale: 10/31.878-9foto..884 + 2/33.127 +
4/33.362.365.367.407 + 2/35.114.117foto +
-Grosso O-Il palazzo san Giorgio-Sagep.1968-pag.52
-Museo s.Agostino-archivio toponomastica:
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.19.20
-Pagano/1933-pag.245.1091---/40-pag.234--/1950 – pag.35
-Tuvo T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani1983-pag. 79foto
CARPANETO G.B. via
G.B. Carpaneto
TARGHE:
via
– G.B. Carpaneto
via
- G.B. Carpaneto – industriale – 1821-1884 – già via s.Bartolomeo

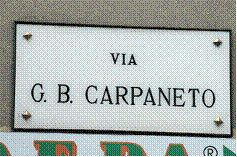 angolo ovest via L.Dottesio
angolo ovest via L.Dottesio

 angolo est via
L.Dottesio
angolo est via
L.Dottesio
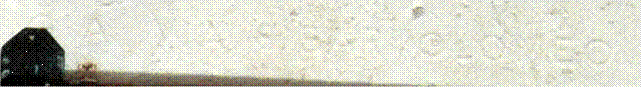
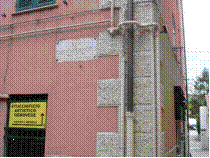
 angolo scala a v.
A.Cantore
angolo scala a v.
A.Cantore
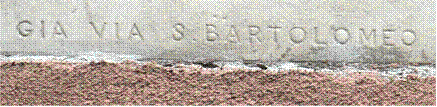
QUARTIERE ANTICO: san
Martino
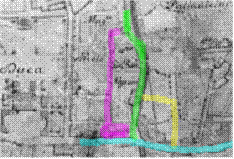 da MVinzoni, 1757. In celeste via
LDottesio; giallo vico Cibeo; fucsia villa, giardino e all’apice, torre di
GBNegrone. A sinistra, villa del duca Spinola.
da MVinzoni, 1757. In celeste via
LDottesio; giallo vico Cibeo; fucsia villa, giardino e all’apice, torre di
GBNegrone. A sinistra, villa del duca Spinola.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2745 CATEGORIA 2
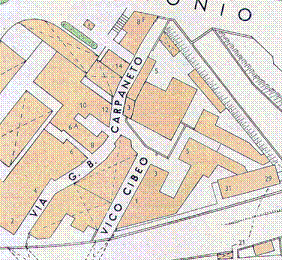 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 12900
UNITÁ URBANISTICA: 28
– s.BARTOLOMEO
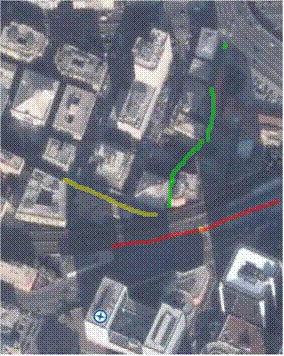 Da Google Earth 2007.
Da Google Earth 2007.
In giallo via L.Dottesio; rosso, via di Francia.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria
delle Grazie
STORIA: fin dal 1200
– da quando fu eretta la vecchia abbazia di san Bartolomeo - la strada
corrisponde agli ultimi metri dello stradone di san Bartolomeo prima del naturale sbocco, nella allora unica via
principale, Centrale, poi De Marini (oggi Dottesio).
Quindi la linea diritta del torrente era dalla abbazia a questa strada e
diritto al mare.
Dalla mappa del Vinzoni del 1747, i terreni su cui fu tracciata, sono
ascritti all’ecc.mo GioBatta Negrone,
proprietario della villa all’inizio strada che fiancheggiava il torrente, il
cui ingresso oggi si apre in via G.Pedemonte (e non come ha scritto Lamponi alla villa Pallavicino,
che era affiancata a ponente di questa).
E tale era ancora seicento anni dopo, nel 1838 (carta del Porro).
Nel 1933 circa, la strada era delimitante a levante la vasta proprietà
della raffineria di olio d’oliva dei Moro
che aveva inglobato tutto il vasto appezzamento intorno.
Negli stessi anni avveniva la costruzione del piazzale della camionale: da
esso, per poter accedere al tracciato stradale verso nord - che scorreva sul
lato sinistro del fossato - fu necessario allargare lo spiazzo verso ponente.
Questo obbligò a sovrapporsi e quindi coprire il tracciato sia della antica strada
di san Bartolomeo che del torrente: ambedue
vennero spostati, di poco ma sensibilmente verso ponente. Cosicché il torrente
fu interrato, deviato e fatto scorrere sotto via Pedemonte (o via Bottego); la
strada, anch’essa spostata di alcune diecine di metri, fu tranciata dalla
novella via A.Cantore. In pratica, mentre lo stradone prima arrivava sino
all’attuale via Dottesio, il taglio di via Cantore ha generato il nuovo inizio
della via sanBartolomeo; mentre il moncone distale della vecchia ed antica
strada -rimasto sottolivellato rispetto la grande arteria trasversale - fu ad
essa collegata con una scalinata (che aiuta a ricostruire l’antico andamento
del terreno).
Con delibera del podestà, del 19 agosto 1935, il tratto già di via san
Bartolomeo che dalla nuova via A.Cantore arrivava a via L.Dottesio prese il
nome del Carpaneto, che era divenuto ricco proprietario dei terreni (nonché di altre proprietà nella
città di San Pier d’Arena), prima della
cessione all’oleificio.
Con la nuova denominazione, in corrispondenza non
furono variati i numeri civici già della vecchia san Bartolomeo: dall’ 1 e 1a
sino al 5, e dal 2 al 14 rimasero uguali, ma della nuova via.
Nel Pagano/1940 va ‘da via L.Dottesio a via
A.Cantore’; al civ. 4 nero c’è l’oleificio Moro e figli; rossi: due osterie,
due commestibili, una soc.an. lavorazione della latta Solertia.
Il Pagano 1950 segnala
esserci stata due osterie: nel 3-5r di Falchero P.; nel 14r di Pigollo E.. Nel Pagano/61 c’è sempre l’osteria Falchero, la sede della spa
Frizzsoda, tre officine meccaniche e la ‘cromature Sampierdarenesi’-
STRUTTURA: da via
Dottesio, la prima strada comunale carrabile a destra, dopo il sottopasso
ferroviario; doppio senso ma senza sbocco veicolare, perché chiusa in fondo;
solo una scala la collega –a baionetta - con via A.Cantore.
Lunga
168,25 metri e larga 4,6 , ha due marciapiedi larghi un metro .
A metà percorso, si collega con vico Cibeo.
Risulta servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera


civ. 1
civ. 10
CIVICI
2007=
NERI = da 1 a 7 e da 6 a 14 (mancano 2, 4. Compresi 6A, 10a)
ROSSI = da 1r a 15r (manca 11r)
e da 2r a 46r (mancano 4r→8r, 10r. Compresi
16ABCr, 28Ar)
nel
2003 appaiono :
===civ.
1 caseggiato per abitazioni con, sulla facciata, sul retro e fianchi,
delle finestre solo dipinte



civ.1 con
finestre dipinte sulla e dalla stazione ferroviaria
facciata
in via Carpaneto
===civv. 2 e 4: non esistono più
(il primo murato nel 1973 e l’ultimo demolito nel 1966)
La
villa, posta al lato ovest dello sbocco stradale, appartiene ed è descritta in
via Pedemonte al civ.3.
È
la villa Negrone (-ni) - Moro; fu costruita non si sa da chi, nè quando
(però lo stile la colloca nel periodo tra il prealessiano e l’alessiano, quindi
nella seconda metà del 1500.
Con
l’avvento della ferrovia (1850), l’edificio ha rischiato la demolizione,
passando questa con diritti di priorità a pochi metri dall’angolo sud-est; in
quegli anni circa divenne proprietà del Carpaneto che poi la rivendette agli
inizi del secolo a Moro Tomaso: questi ne fecero parte di un grosso complesso
industriale di raffineria, che fu eliminato verso gli anni 1960.
La
villa, acquistata da una società di navigazione (compagnia italiana marittima
aeronautica, CIMA), fu da loro soggetta a completo restauro interno, esterno e
giardino, con ovvi adattamenti interni ad uso uffici, senza però alterarne la
pregevole struttura esterna.
Nel
2010 appare appartenere alla “Edi Software – soluzioni gestionali”
Ha
una entrata da sud che era il principale; ma oggi l’ingresso principale
è rivolto a nord, prospicente un giardinetto che faceva parte della villa e che
allora si prolungava verso il colle oltrepassando di poco la torre ancora ancor
oggi esistente, di cui la villa era munita; con l’eliminazione dell’oleificio e
bonifica del terreno, anche il giardino ha riacquistato una minuta sistemazione
ad aiuole e, vicino alla villa è stato ripristinato anche il ciottolato
bianco-nero.
Appare
piccola, perchè troppo stretta tra moderne costruzioni; ha invece notevoli
analogie con la villa Pallavicino-Gardino di cui è contemporanea, posta di
fronte sul lato mare. Sul lato levante si vede l’esistenza di una
loggia vicino all’angolo con una elegante colonna ionica centrale; e sul lato
ponente i resti di un corpo a terrazzo che univa questa villa a quella
contigua (Pallavicini Moro); sul lato nord la tipica disposizione delle
finestre al piano nobile (tre centralizzate, e due lateralizzate) e la
balconata retta da mensole arricchite da mascheroni cinquecenteschi.
La
torre (vedi sotto al civ.10),
L’interno, tripartito, ha due grandi atri centrali ciascuno
relativo ai due ingressi; le rampe dello scalone sono in ardesia e portano al
piano nobile in corrispondenza della loggia (aspetto tipicamente genovese); i
pavimenti delle stanze con ottagoni di ardesia ed i pianerottili con quadrati
di marmo
Tranne
in una saletta del piano nobile, sono scomparse le decorazioni sui soffitti .
===civ.
6a assegnato a nuova costruzione nel
1951
===civ.
7 nuovo aggregato alla via nel
1960, sistemando la numerazione di via di Francia
===civ.13r negli anni
1950 lo stabilimento della spa SOLERTIA,
fabbrica e lavorazione della latta, con recipienti e scatole anche litografati
===civ. la sede
delle Pompe Funebri ‘la Generale’, con il loro deposito e parco macchine
===civ. la casa, ed attualmente studio professionale di Franco Malerba (si dice che lo studio,
arricchito di sei antenne paraboliche, sia sede di rappresentanza di società
con interessi internazionali). Nato a Busalla nel 1946 -ove visse sino all’età di 10 anni essendo il
padre capostazione del luogo-, si trasferì in San Pier d’Arena nella residenza
dei nonni materni; e qui crebbe ed abitò fino alla laurea in ingegneria
elettronica ed un’altra poi in fisica, all’incarico di ricercatore
scientifico, alle nozze nel 1985 con una giovane francese, alla nascita del
figlio.
E’ stato il primo astronauta italiano: scelto nel 1978 in
una rosa di 248 candidati europei per il programma ‘space-lab’, superò tutte
le selezioni, tests, e prove , cosicché il 31 luglio 1992 a bordo di uno
Shuttle Atlantis, assieme ad altri sei astronauti partiti dal centro
aerospaziale USA di Cape Canaveral, stette per una settimana nello spazio.
Compirono rilevamenti e studi, compreso il tentativo di un ‘satellite al
guinzaglio Tethered’ di progettazione italiana, la cui missione però non ebbe
successo per colpa del cavo. Dedicandosi alla politica, fu eletto divenendo
europarlamentare; in questa veste svolse i ruoli di : membro della commissione
ricerca tecnologica e energia; supplente nelle relazioni esterne economiche;
supplente nella commissione per i problemi economici e monetari; membro della
delegazione UE-USA.
===civ.10 la torre unica
ottagonale della villa Neurone-Moro, di aspetto cinquecentesco (potrebbe essere un falso
cinquecento, più recente; comunque c’era al tempo del Vinzoni 1757; la scala di
legno la ripropone formalmente tale); oggi
è ormai disgiunta e avulsa dalla villa a cui apparteneva: in origine – carta
Vinzoni - era posta isolata in fondo al giardino di proprietà; difficile,
valutarne la funzione collocata com’era fuori logica d’uso, ovvero così lontana
dal mare e altrettanto dalla via Centrale (via De Marini-Dottesio-Daste); con
l’aspetto poco guerriera e molto decorativa: ottagonale, forse unica in tutta
Genova. La lottizzazione ottocentesca, l’ha poi completamente separata dalla
villa da cui dipendeva; è stata così affianata da altri edifici ottocenteschi e
forse anche più antichi ancora; comunque che tutti la nascondono come entità
urbanistica. Conserva le scale in legno.
===civ.7 è una casa di proprietà delle ferrovie,
composta di tre appartamenti, posizionata sopra due gallerie del treno (scalo
porto-parco del Campasso), contornata dalla galleria san Lazzaro
(Principe-Sampierdarena) e dalla sopraelevata (dalla quale sono già caduti sul
tetto, una vettura ed... un carico di prosciutti); nel 1980 era munita di
orticello con galline.

===civ. La DEPA
La strada termina chiusa; cento metri prima, raggirando il palazzo ha una breve
scalinata che
accede in via A.Cantore; alla
base di essa, una pietra posta a basamento, porta una scavatura a cono da cui
parte -verso il muretto- altra lunga scanalatura che interessa tre pietre; il
tutto senza un apparente utile logico se non -forse - un cancello.
DEDICATA
all’impresario e industriale vissuto 1821-1884, possessore di magazzini in
località Coscia, (cioè
all’inizio est di via Galata (via P.Chiesa) proprio sotto Largo Lanterna),
e dei magazzini-officine dalla cui distruzione nacque via F.Avio. Erano
depositi di merci, nonché empori commerciali, scuderie e vasto deposito di
sale.
Miscosi racconta (però, non specifica di quali magazzini si
trattasse, ma è significativo che essi erano a San Pier d’arena e vicino a
piazza della Lanterna) di un commerciante svizzero esportatore che si trovò,
negli anni venti del 1900 a dover portare in America delle castagne secche,
molto richieste (provenienti dalla Campania (Avellino) e da Cuneo, contenute in
casse da 60 chili). Allo scopo andò a ritirarle al magazzino del ‘cassaio’ e,
avendo fretta pensò di raggiungere la nave attraccata passando nel tunnel del tram, poi rinunciò e prese la strada verso il faro, facendo fatica
perché l’animale non riusciva a portare il peso in salita delle cento casse.
Con la evidente generosa rendita, divenne ricco e riuscì a porsi nella
Sampierdarena benestante e manageriale di fine secolo 1800, pur senza
conosciuti impegni sociali o politici.
 i
vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori
‘sale’, alla Coscia
i
vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori
‘sale’, alla Coscia
Negli
anni attorno al 1850, divenne proprietario della villa che affianca la strada a
ponente (detta villa
Negrone-Moro (vedi via
G.Pedemonte) che poi
sarà venduta ai Moro assieme alla affiancata villa Pallavicino (quest’ultima poi distrutta negli
anni del 1970 lasciando di essa solo la facciata sulla via Dottesio) nelle prime decadi del 1900, i
quali vi aprirono una raffineria di olio e produzione di olio d’oliva, sapone e
derivati). Alcuni danno per sicuro che
nel 1875 traslocò, essendo divenuto proprietario della villa di piazza
N.Montano (oggi conosciuta appunto prevalentemente con il nome di villa
Carpaneto, ed acquistata in quell’anno dalla fam.Tubino).
Nel 1906 la sua azienda partecipò alla prima esposizione internazionale aperta
a Milano in occasione dell’inaugurazione della galleria del Sempione; con molte
fotografie – allora un evento ancora agli inizi - dimostrava le capacità della
impresa di trasporto.
Nel 1933 appare ancora a suo nome (o di un omonimo) la proprietà della
ditta-magazzini di deposito, in via C.Colombo,115. Ed erano di un Carpaneto i
depositi dove ora ci sono via Molteni ed Avio.
Carpaneto-Carpeneto, era pure uno che gestiva ‘le stalle’
ove ora è via Rela-via N.Bixio (cavalli, carri ... depositi; sono tutti
inerenti allo steso tipo di lavoro: facile sia stato un clan, di tipo
parentela). Favretto cita un Carpaneto; ma, a parte che è segnalato quale
proprietario di una fabbrica di conserve alimentari, è anche “uno dei maggiori
commercianti di guano” (cosa possibile, possedendo vasti
magazzini di stoccaggio merci, quindi più che un commerciante, uno della catena
di importazione; in conseguenza di quest’ultima attività, probabilmente
utilizzando il magazzino che aveva alla Coscia, lo stesso autore cita una
«lettera firmata dai “Ballaydier Freres”, i quali fanno presente
all’amministrazione comunale che le sostanze organiche in decomposizione,
derivanti dalle lavorazioni e scaricate nei canali della zona, potranno
“arrecare danni ai pozzi dove si preleva l’acqua” e si ricordano i “tristi
casi” di colera che si sono verificati nell’estate precedente»).
Nel Pagano 1940, un Carpaneto GB possiede magazzini generali (soc.an.) in
Largo Lanterna ed abita in via Scaniglia al 2
BIBLIOGRAFIA
-Almanacco
di Epoca-1992-pag102
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 907
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi- ed./94-pag.391—ed./02-pag.429
-AA.VV.-Catalogo
delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag.147
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-pag.23foto
-AA.VV.-1886-1996
oltre un secolo di
Liguria-Il SecoloXIX.1996-pag.666
-AA.VV.-stradario
Guide Gallery
-Favretto
G-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.163
-Gazzettino
Sampierdarenese : 5/73.4 + 6/76.4 + 1/78.__ + 7/92.1
-Il
SecoloXIX-quotidiano-31.7.2002
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.14
-Lunario
genovese del signor Regina ammo 1889-pag.541
-Miscosi
G.-Genova e i suoi dintorni- Fabris 1937-pag.133
-Pagano/33-pag.1848--/40-pag.
1424--/61-pag.130;
-Poleggi
E &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.51
-Tringali
S.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.189
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.78
-
Zerbini P.-Genova e Liguria , dove & chi-ediz.1999.pag.35
-non
citato dal Novella né dai Liguri Illustri
CARREA
via
Bartolomeo Carrea
TARGA: San Pier
d’Arena – via Bartolomeo Carrea – scultore – 1764-1839 (la nostra targa ha la
data di nascita sbagliata)
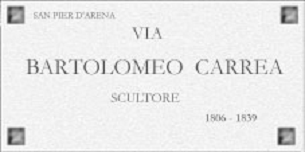
QUARTIERE ANTICO:
Promontorio
N° IMMATRICOLAZIONE:
.
posteriore
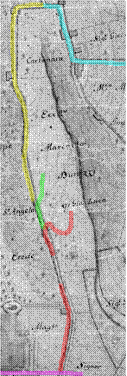 Area di via BCarrea,
Area di via BCarrea, 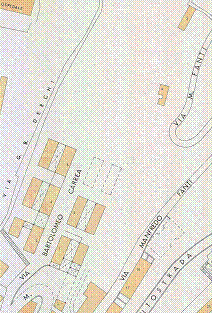
da MVinzoni, 1757. In fucsia, via OScassi;
da Pagano/1961
rosso, via MFanti; giallo via GBDerchi
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA n°: 13040
UNITÁ URBANISTICA:
28 – s.BARTOLOMEO
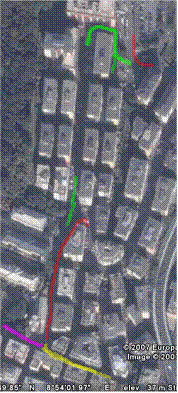 in fucsia via O.Scassi; giallo via
B.Piovera; rosso via M.Fanti.
in fucsia via O.Scassi; giallo via
B.Piovera; rosso via M.Fanti.
Da Google Earth 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA : Cristo
Re
STORIA: Al catasto,
ed ancora nel dopoguerra, la proprietà di 50 mila mq era censita come cascina
con vigne, di proprietà del genitore di Giovanni
Agnelli (proprietario
della Fiat) e del cav. Cottino Paolo:
alla loro morte, il terreno fu diviso in 36 lotti e - mediante sorteggio -
divisi a metà, tra gli eredi delle due famiglie. Gli Agnelli utilizzarono il
terreno per edificare; e si avvalsero di una legge amnistia del 1970 per
mettersi al riparo da accuse di eventuali violazioni; le eredi Cottino, in
parte edificarono nel 1953-4, escluso due lotti che furono ceduti in secondo
tempo nel 1973. Quest’ultima operazione fece scattare la reazione del ‘Comitato
Promotore’ che, vedendo svanire ogni possibilità di spazio verde o sportivo o
quantomeno sociale, promosse inutilmente guerra.
La
erezione degli stabili fu definita ‘la perla delle speculazioni italiane’,
generando fiumi di inchiostro sui quotidiani; mugugni; critiche a chi deteneva
il potere; discorsi politici con promesse non mantenute; ricorso alle vie
legali con finale intervento della terza sezione penale di Cassazione che
formulò assoluzione dei proprietari in sede penale e trasferimento della
pratica al Tar per quella civile.
Il 19 ottobre, visto il contemporaneo tacito avallo del Comune, scattò la
contestazione civile che però fu dichiarata legalmente scorretta e con torto
trattandosi di aree destinate per legge all’edilizia. La civica
amministrazione, per tenere fede all’impegno dato dal sindaco Cerofolini,
inviò all’impresa una ingiunzione di sospensione di ulteriori costruzioni, in
attesa di formulare un piano di migliore urbanizzazione (che ovviamente, rimase lettera
morta).
La denominazione fu decisa dal consiglio comunale il 7 mar.1958.
Sono tutti caseggiati di ultima costruzione in
delegazione, disastrosamente edificati uno vicino all’altro, senza spazi
alternativi di verde, né posteggi; con rari servizi.
STRUTTURA
E’ – viariamente- a senso unico in discesa; ad anello inizia in alto
proseguendo via M.Fanti, e finisce nella stessa via M.Fanti in basso. Mentre la
numerazione dei civv. segue il senso inverso, dal basso verso l’alto. I civv.
neri arrivano sino al 11 e 12.
Nel dic.2003 compare nell’elenco delle ‘vie private, di interesse
pubblico’ aperte al pubblico senza vincoli o divieti. In programma di divenire
municipali (passaggio di proprietà gratuito, in cambio dei servizi e
manutenzione (cassonetti
Amiu, rete fognaria, servizio Amt, illuminazione, ecc)). Nel 2004 ancora se ne parla; nel 2010 non è stato
fatto nulla e non se ne parla più.
CIVICI
2007=
NERI =da 1 a 11 e da 2 a 12
ROSSI =da 3r a 99r
(mancano 1r, 5r. Compreso 83Ar)
da 2r a 152r
(mancano 66r, 86r, 88r. Compresi 97Fr→Vr)
Tutte
recenti costruzioni: il 2 (1958); 1 e 4 (1959); 3 e 6 (1960); 5 (1961); 7
(1965); 8 (1966) ; 10 e 12 (1969); 9 e 11 (1974).
===civ. il circolo
Endas “La cumpa”, fattosi conoscere nel nov.2004 perché soggetto a furto di
attrezzature.
===civ.
8/13 nel 2008 ha recapito la soc. Twin Car Olympus (Carrasi AMaria) facente
parte della FCI (Federazione Ciclistica Italiana).
===civ. 11r il Club
sampdoriano C.Mura
DEDICATA allo
scultore nato a Gavi (AL) il 29 mar.1764, da Giovanni e Caterina Picollo.
Cresciuto
a Genova, divenne allievo dell’ Accademia Ligustica, formandosi come artista
alla scuola di Nicolò Traverso (indubbio caposcuola nel periodo neoclassico
genovese); con il maestro divise progetti, lavori ed onori, al punto che
diventa difficile distinguere i singoli interventi, vivendo assieme lo stesso
clima artistico e culturale, imperniato sulle imprese di Napoleone.
Carrea,
divenuto Accademico di merito e direttore della scuola di scultura
dell’Accademia Ligustica, (e tale incarico gestì per lunghi periodi: 1802-8,
1814-17, 1836-7, impegnandosi anche in lavori pratici sia con stucchi (nel palazzo Pallavicino di piazza
F.Marose, in collaborazione con Giuseppe Gaggini; nel coro di s.Stefano;
‘bellissimi bassorilevi in plastica’, nella sala vecchia del Consiglio a Tursi), o con bassorilievi e marmi (tombe; la figura della Speranza
nella nicchia destra sulla facciata della chiesa di san Siro (1820); le Tre
Grazie -ora collezione privata-; la figura della Concordia sulla facciata del
ed un bassorilievo con “la commedia”, per il Carlo Felice (1828); ed altri), ed anche statue lignee (l’Immacolata, per l’altare maggiore
della chiesa della SS.Concezione di Padre Santo).
I
lavori studiati per l’apoteosi napoleonica appartengono al periodo che viene
definito “effimero”, per la rapidità con cui si svolsero gli eventi del Corso
(dall’ascesa militare alla restaurazione). Anche l’amministrazione cittadina,
burocraticamente lenta e priva di una programmazione (preventivi, costi, scelta di un
oggetto artistico, sua collocazione)
non faceva a tempo ad ordinare agli artisti opere pregevoli, raffinate ed a
volta anche spettacolari, che tale sclta era già travolta dalla storia
cambiata e sconvolta.
In questo frenetico mutamento, merita un rilievo la celebrazione della venuta
di Napoleone a Genova (30.6.1805;
o venne in carrozza o probabilmente fu sbarcato sul litorale di San Pier
d’Arena, perché fu accolto alla Porta della Lanterna dal maire Michelangelo
Cambiaso, che gli offrì le chiavi della città -che furono cortesemente
rifiutate- e pronunciò il discorso di omaggio): fu programmato un grosso impiego di arredi, dalla decorazione di
interi palazzi, ad un tempio galleggiante nel porto, ed altre iniziative che
rimasero di ovvio limitato sviluppo. Nel tempio, da collocarsi vicino alla
Lanterna, doveva esserci un arco trionfale in legno disegnato da Carlo
Barabino, e per il cui arredo il Carrea fu chiamato a partecipare con quattro
grosse aquile coronate (pagate
con 420 lire) e due statue, una
dell’imperatore seduto coronato dalla gloria, ed un’altra allegorica della
Storia.
Altro episodio, risale al 28 ago.1808, quando il Senato Ligure decise di
sostituire le statue dei Doria (di Andrea e Gianandrea, gravemente danneggiate nei moti popolari di 5
anni prima), da porre su due piedistalli
prospicenti il ‘Palazzo Nuovo’ (il Ducale), con altre due: di Andrea Doria e di
Colombo; di esse quella di Andrea affidata al Nostro (tentò di ricuperare usando quella
di Napoleone già praticamente fatta, solo modificandola nell’effige; l’altra
raffigurante Colombo, fu affidata a Nicolò Traverso); le opere - seppur già pagate - non furono
utilizzate perché per opportunità politiche dopo breve il Senato aveva già
cambiato parere, scegliendo un gesso di Andrea Doria.
Per
l’arrivo di Vittorio Emanuele I a Genova nel 1815, fu chiesta la collaborazione
ordinandogli la figura allegorica del fiume Po, con cui arredare una fontana
da porre alla Zecca, disegnata dal Barabino.
Sposò una pittrice genovese Rosa Bacigalupo (1794-1854) della quale alcune opere sono alla biblioteca Berio,
all’Accademia Ligustica, in san Lorenzo.
Morì
a Genova l’ 8 gen.1839 (Lamponi
scrive che fu tumulato nella antichissima chiesa di santa Maria del Prato
(Albaro - piazza Leopardi); il Dizionario delle strade non cita la tomba e
scrive che nell’anno dell’assedio, 1800, la chiesa fu chiusa e “venne dagli
austriaci ridotta a scuderia. Riaperta dopo alterne vicende…”).
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Notizie dei professori del disegn..-Sambolino1864-vol.I-p.432
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 915
-AA.VV.-Enciclopedia dei
liguri illustri-Erga.1970-vol.III-pag.4
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.391---ed./02-pag.429
-Gazzettino Sampierdarenese
: 3/79.5 +
-Genova
Rivista Comunale : 5/33.770 disegno dell’arco + 9/33.770 + 1/34.8
-Il
Secolo XIX del 25/11/03 + 23 /8/04 + 18.11.04 +
-Lamponi M. –Sampierdarena –
Libro Più.2002- pag.174
-Pastorino-Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.365foto
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.23.35
CARROZZE piazza
delle Carrozze
Citata solo da T.Tuvo nel
Gazzettino Sampierdarenese.
Nome popolare, non ufficiale,
usato nella prima metà del 1800 per indicare la prima sosta in San Pier d’Arena
di chi giungeva dal ponte sul torrente Polcevera , sia proveniente dalla
riviera che dalla Bocchetta .
Era ubicata nella zona della
Crociera; quindi presumibilmente dove ora è ‘largo
Jursé’ .
Lo slargo era così già da
allora, divenuto un punto di riferimento e di incrocio abbastanza ingorgato per
il traffico intenso, per gli arrivi e partenze per l’entroterra, il Piemonte,
Lombardia, riviera o Genova stessa.
Non corrisponde alla piazza
Vittorio Veneto, a quei tempi non ancora esistente perché inesistente o in fase
di strutturazione sia la ferrovia che la via Buranello; (questa ultima piazza andrà a sostituire la funzione di
sosta e capolinea delle vetture, ma per la sosta dei
primi tram avrà come primo nome ‘ piazza Omnibus’) .
In un documento del
24 lug.1861 si segnala la presenza di una officina dei f.lli Bardin, sita
“presso la Crociera, mandamento di Rivarolo, a
tramontana e ponente dei fratelli Cambiaso, a mezzogiorno di Torsegno Paolo, a
levante della strada comunale e dipendenza della stazione delle strade
ferrate”, adatta per la preparazione di acido solfidrico, nitrico e
cloridrico.
Già conosciamo un Bordin come
il creatore principale, nel giorno di Natale 1851, della società di MS “Unione
Fraterna”. Ma non corrisponde essendo questi dipendente di una officina
metalmeccanica. A confonderci un po’ di più Favretto scrive notizie che
combaciano con quanto sopra, ma non in tutto: conferma che la Bardin & Ballard era una fonderia sita poco
distante da via s.Cristoforo, la quale sappiamo che nel prosieguo del tempo
cambiò attività dedicandosi alla distribuzione del gas (e così, forse, anche
alla produzione chimica di cui sopra) per cui potrebbe essere la loro quella
definita dallo stesso Autore “Ancora più pericolosa risulta la fabbrica chimica
in cui lavora dal 1823 l’acido solforico, nitrico e cloridrico nonché
altri prodotti chimici “alla Crociera” presso il ponte sul Polcevera». Ma anche
Scerni lavorava quel materiale nelle vicinanze.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale faldone 489
-Favretto G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo
e...-Ames.2005-p.163
-Gazzettino Sampierdarenese : 1/96.5
CARZINO
via Alfredo Carzino
TARGHE:
via - Alfredo
Carzino – “Milio” – caduto per la Libertà – 1899-22-XII-1944
via –
Alfredo Carzino – caduto per la Libertà
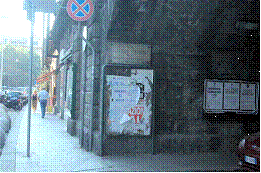

angolo
piazza Vittorio Veneto

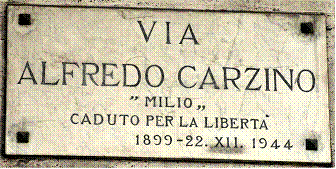
nella
rientranza, presso il civ. 2

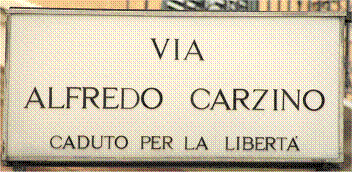
angolo
ovest via A.Cantore

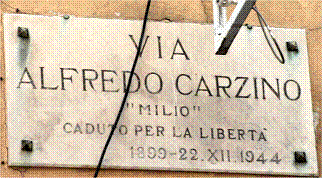
angolo est,
vie N.Daste-A.Cantore
QUARTIERE
ANTICO: Castello
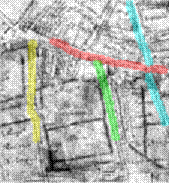 da MVinzoni, 1757. In giallo la Creusa dei Buoi; rosso via
NDaste; celeste, via della Cella e antica salita
Belvedere
da MVinzoni, 1757. In giallo la Creusa dei Buoi; rosso via
NDaste; celeste, via della Cella e antica salita
Belvedere
N° IMMATRICOLAZIONE:
2746 CATEGORIA: 1
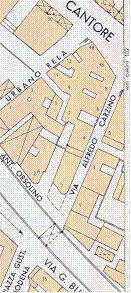 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 13180
UNITÁ URBANISTICA:
26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007
da Google Earth 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria
della Cella
STRUTTURA:
senso unico viario dal confine via A.Cantore-via N.Daste, al confine via
G.Buranello-piazza Vittorio Veneto.
La numerazione prosegue iniziando da via Buranello.
Strada
comunale carrabile, lunga 139,90 metri e larga 6,05; con due marciapiedi
larghi 1,62.
La
parte a ponente è adibita a posteggio auto
E’
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
STORIA: Essendo
stato un sacerdote col titolo di principe Centurione a vendere la casa a don
Daste, va de sé che tutta la strada è sorta nel terreno - una volta - di
proprietà della nobile famiglia, residente nel palazzo omonimo in piazza del
Monastero (anche il
sottopasso ferroviario, nei tracciati schematici delle Ferrovie, adeguandosi
viene chiamato dapprima ‘Centurione’, poi G.Mameli’, poi A.Mussolini, infine A.Carzino).
È storia non comprovata da documenti, che Teresita – figlia di Garibaldi e
sposa di Stefano Canzio (figlio di Michele, stuccatore di grande fama) -
abbiano abitato nella via. Un dipinto del Vernazza (al Monastero) rappresenta
Teresita assieme al marito all’inaugurazione dei giardini di villa Scassi (chiamati
‘passeggiata G.Alessi’), nel 1890.
Alla fine 1800-inizi del 1900, la strada era dedicata a Goffredo
Mameli (ora a Genova in Castelletto), anche se popolanamente la località era chiamata ‘in
scià Providensa’ per l’attiva presenza di don
Daste e del suo richiamarsi ad essa per il futuro delle sue opere, nonché
dell’Universale che aiutava i soci in difficoltà, con le sue sovvenzioni.
In quegli anni, nella strada esistevano sette civici di cui : all’1 la Soc.Universale di
MS ; al 2 casa Pittaluga Bartolomeo; (il 3 è saltato); al 4 casa Cipollina,
Paolucci e C; al 5 e 7 casa Chiesa Lagorara e C ; al 6 Ist. della Provvidenza
.
Nel 1910 la via Goffredo Mameli,
che collegata via V.Emanuele con via
N.d’Aste (sic), appare con civici sino all’8 ed al 3.
Tale rimase, sino a quando sotto il regime fascista, dopo delibera del podestà
del 19 ago.1935, fu deciso il cambio nome con “via Popolo
d’Italia”; nome tratto dal titolo del giornale
quotidiano che Mussolini aveva fondato a Milano nel nov.1914 (dopo aver diretto per due anni il
giornale socialista l’“Avanti” ) e che
cessò la pubblicazione il 25 lug.1943.
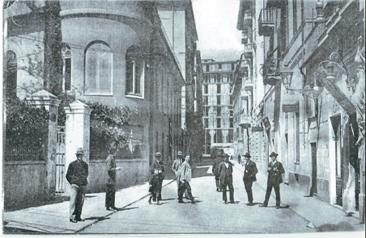

anni 1935. Stanno finendo il palazzo in via
Cantore anno 2008
Dopo il conflitto mondiale, su delibera della giunta comunale del 19 lug.1945,
la strada fu dedicata al partigiano.
CIVICI
2007:
NERI = da 1 a 7 e da 2 a 8 (compresi 2ABC)
ROSSI = da 5 a 45
(mancano 1 e 3;
compreso 13AC –manca B)
da 2 a 30 (compresi 2ABCD)
Nel Pagano/50 si segnalano: al 43r l’osteria Bigozzi M.;
ed al 2Br il bar dell’Universale.

=La numerazione è progressiva da
mare a monte
===civ.
2a: Si apre non direttamente sulla
strada, ma nel retro della società Universale. Inizialmente si apriva in via
Prato. È detta ‘casa Stefano
Frugone’ (chiamato
‘il Tigre’ e primo proprietario del vicino cinema Splendor); fu eretta su un terreno che faceva parte dei
giardini della soc. Universale e che gli fu ceduto per
scambio di possibilità di soprainnalzare anche la casa del fascio. Così,
sulla scia, anche la palazzina fu sopralzata - pare abusivamente e grazie a
legami di partito tra i proprietari ed il PNF nel 1933 quando l’Universale era
occupata dai neri; l’archivolto corrispondente venne chiamato col nome del
fratello del Duce, Arnaldo Mussolini. Finita la guerra sorse una causa legale
gestita da De André per riappropriarsi del terreno e del palazzo sopraelevato
giudicando averlo concesso illegalmente (il padre del cantautore e vicedirettore dell’Eridania), fino ad arrivare ad un compromesso.
Nel 1948 c’era la sede del “Gruppo Anarchico «Era
. Malatesta» Errico Malatesta, 1853-1932 è
stato conosciuto politico anarchico; aderente alla Prima Internazionale;
collaboratore di Bakunin; fondatore della federaz. Anarchica Italiana; più
volte arrestato; esule a Londra; antiinterventista e contrario ai socialisti; fondatore
1919 di un giornale “Era nova”; fu agitatore politico con moti (in Lunigiana,
Milano,Sicilia e ‘settimana rossa di Ancona, 1914) sino all’avvento del
fascismo.
Nel 1950 c’era una soc. dipendente dal CONI chiamata ‘l’Edera Sportiva’. E pure una società, al primo
piano, “Fronte della Gioventù” di giovani che vivevano l’espierienza del dopo
guerra.
Nel 2002-3 ospita l’Ente di formazione professionale IAL telefono 010 645.73.79 che a fine
corso fornisce un attestato di qualificazione nell’area commeciale: addetto
alle vendite e al magazzino; impiegato di amministrazione (addetto al lavoro di
ufficio); turismo-alberghiero.
Nel 2010, all’int 1 e 2 dove
era lo studio del commercialista iacchino Pollicino, c’è lo studio del nipote avv. Ravera. All’interno 3, dove fu il
radiologo prof. Massimo Lertora ora c’è la sede
della Terza età. All’int. 12 una casa famiglia.
Non
confermato che nel 2009 in appartamento di 400 mq, vi si era inserito un nuovo
ufficio della CNA (confederazione nazionale artigianato e piccola/media
impresa) per pratiche fiscali, consulenze di lavoro, contabilità, rapporti con
banche, sindacali, ecc.
===civ. 2, la palazzina della Società Operaia Universale.
All’esterno dell’edificio, in un grosso riquadro nell’intonaco, campeggia la
scritta “associazione Operaia Universale - 1851“: rappresenta simbolicamente tutta la lotta compiuta dal popolo -dopo
i più eclatanti episodi francesi della Bastiglia e delle guerre risorgimentali,
ma non per questo meno faticosi e sudati- per acquisire la dignità e
soprattutto la libertà di poter decidere di se stesso.

E non è poco, se sino ad allora da secoli, aveva comandato
e deciso unilateralmente la classe ricca, o aristocratica, o armata (ed in
Italia, pressoché sempre, straniera). Ed ancora, in quegli anni seppur
emergente la classe borghese, l’operaio era pur sempre tenuto in soggezione
sociopolitica di postulante e senza diritti.
Quello che ogni
cittadino gode oggi, chiunque lavori, nacque qui, da questa gente.
Dal 1815 Genova fece
parte, volente o nolente, del regno di Sardegna. Dell’atavica Repubblica
conservava però forte e ribelle lo spirito.
Il popolo era dunque frastornato da due sentimenti
concomitanti: da un lato l’amore dell’antico spirito repubblicano (con la propria autonomia democratica, fomentata anche sia dalle idee
mazziniane, sia da un ribollire internazionale mirato a sovvertire l’
<ordine>, e sia anche da quei folli ribelli –genericamente malvisti e
psueudobriganti- che fomentavano disordini chiedendo inutilmente appoggio alla
popolazione); e dall’altro lato il forte freno
delle idee conservatrici (della Chiesa, innanzi tutti, per la
quale l’idea di dover combattere contro il Papa era da negarsi a priori e
quindi non facile da assimilare; della massa indifferente che viveva alla
giornata e non capiva le proiezioni future contiunuando a subire come sempre;
ed infine di quelli che nutrivano speranza
che la monarchia li guidasse all’unificazione e facesse nascere un orgoglio ed
un amore di Patria).
Nel caos iniziale ideologico, il sangue e le sofferenze
furono un tutt’uno: il re perdeva le prime guerre ed i patrioti rappresentavano
una dolente spina nel fianco, per cui andavano o
in esilio o processati e –da lì- in galera, o –i più arditi- fucilati (tra i
primi e più carismatico Bartolomeo Savi, garibaldino e direttore del quotidiano
mazziniano ‘Italia e Popolo’ : fu condannato a 10 anni di lavori forzati per
aver partecipato al moto del 1857).
Ma alimento indispensabile per i futuri programmi del re
furono proprio quei suoi apparenti avversari, usati poi per l’accrescimento
graduale anche se contrastato della Nazione –sfruttando il loro sangue ed il
loro sviluppo maturo e responsabile dimostrato con iniziative “fai da te”
quali l’Associazionismo-. Le guerre di Indipendenza e la mèta di una patria
unita, furono così il collante tra la agognata repubblica e la sopportata
monarchia.
L’Italia era ancora da unificare, e già dal 1848 (fallimento delle prime campagne militari e promulgazione
dello statuto), iniziarono a
manifestarsi sempre più apertamente in Italia - ma in Genova in particolare -
idee comunitarie ed associazionistiche, mirate a migliorare le condizioni
economiche e sociali in genere, e soprattutto l’istruzione degli operai, i più
dei quali, analfabeti.
Mazzini
fu il promotore di questi programmi che - se giusti ed ovvi nell’ottica di oggi
- erano scandalosamente rivoluzionari e da respingere a quei tempi. Le sue
idee espresse quando il potere decisionale era ancora appannaggio di troppo
pochi, riuscirono a sopravvivere sia per aperta dimostrazione delle loro virtù
e bontà, tramite, per esempio, l’ Associazionismo concesso dal nuovo statuto
Albertino del 1848, ma sia per maturazione culturale ed intellettuale dei
sudditi -stante la necessità storica- obbligati a mantenersi inizialmente nel
nascosto, nel ‘carbonaro’, nelle ‘società segrete’, nella massoneria.
Storicamente accettato che il primo movimento associazionistico-cooperativo fu
nel 1844, inglese (a Rochdale nel Lancashire).
In Italia il primo fu piemontese, nel 1849 (ma da porre in un piano diverso da
quello genovese, proprio per una diversa visuale, sia rigurdante le modalità (in Piemonte, create dagli
stessi padroni o comunque da elementi moderati ligi al governo e mirate a
‘tenere buoni’ gli operai proponendo solo svolte prevalentemente salariali;
quindi la sola assistenza degli operai, che permetteva ampia tolleranza e
partecipazione da parte del governo e dei ricchi o benestanti) e sia le finalità (a Genova, tanto da contare
prioritariamnete avversità da parte delle autorità locali e torinesi, da poco,
il 16marzo1848 i minolli con i marinai e barcaioli, a San Pier d’Arena avevano
violemntemente tumultuato; due giorni dopo i facchini applicarono una rumorosa
dimostrazione di piazza; il 23 marzo 1849 erano state erette barricate anti
Savoia con la soppressione eseguita dai bersaglieri di LaMarmora; l’idea repubblicana
mazziniana e di indipendenza era fortissima; iniziavano a nascere ‘i rossi’ con
tendenze sovversive. Quindi Genova era pericolosissima per l’intendente
Generale Antonio Piola: laddove i propositi di assistenza in realtà
nascondevano priorità politica democratica: rivoluzionaria, repubblicana,
mazziniana in genere, unitaria e di indipendenza; la stampa - La Strega, il
Balilla, l’Italia Libera, L’Italia - erano veicolo di idee tendenzialmente
sovversive).
In Liguria nacque
l’anno dopo, 1850: dapprime
a Imperia (prima a
Oneglia e subito dopo a Porto Maurizio);
Sono del 1851 (sempre in Liguria: a Sanremo, PietraLigure e Chiavari; a Genova con la
iniziale disapprovazione e sanzioni della Curia, il 9 febbraio nacque la prima
associazione di Mutuo Soccorso nell’oratorio de’ ReMagi, presieduta da don
Giuseppe Piaggio prevosto di sanDonato, aperta da artigiani (specie
dell’Associazione Tipografica Genovese e la Società Filantropica Lavoranti
Sarti), da borghesi inseriti nel mondo del lavoro e da aristocratici, con
carattere di assistenza generale; il giorno 24 si inaugurò la seconda, diretta
da BartolomeoFrancesco Savi prevalentemente operaia ma anch’essa molto
eterogenea, studenti, fornai, maestri, farmacisti ed altre 50 categorie (due
anni dopo si uniranno in Confederazione; rappresentava le varie qualità
prevalentemente dell’artigianato: falegnami, muratori, sarti, fabbri, facchini,
tipografi, barcaioli). Nel genovesato
infine =dopo la prima
associazione voltrese (a
gennaio la sms ‘Dio e Umanità’; recenti ricerche la anticiperebbero al 1846!) nata a gennaio; seconda creata da operai, laica, il 5 ottobre di
quello stesso anno vide la luce a San Pier d’Arena (quando il borgo aveva circa 9.079
abitanti, non più servitù di aristocratici in villeggiatura ma, i più, occupati
nell’artigianato e nel commercio; poche decine nell’industria, pesca, minolli;
pochissimi nel porto perché ancora distante ed agricoltura) una società di Mutuo Soccorso, che fu battezzata ’soc.Unione Fraterna’
(V.Armirotti in una sua
relazione letta il 26 sett.1886 in occasione del 35° anno di vita, pone prima
nata nel 1851 la soc. Unione Fraterna; e seconda -1852- “un’altra associazione”
non nominata ma che poi si intuisce essere la Umanitaria. L’idea fu attuata dal
medico Parodi e da un gruppo di operai (capeggiati da Francesco Bordin -Tuvo scrive che si chiamava Ainé Bardin-
il quale assieme ad un fratello e ad altri colleghi di origine francese o
savoiardi, tutti accomunati dal lavoro in una fonderia ed officina del gas (vedi
a ‘Carrozze’), a conoscenza delle esperienze nazionali di associazioni già
fiorenti, il giorno di Natale del 1851 seduti ai tavoli della trattoria
Cagnarin nella crosa dei Buoi diedero vita a questa Associazione, ben accolta
da altri soci italiani, strettamente tutti di fede repubblicana. Ovviamente
l’inizio fu stentato ed osteggiato). Tuvo
segnala dei bilanci dell’Unione Fraterna: anno 1858: capitale sociale
£.314,80-entrate £. 680,80-uscite £.880,60. Anno 1859:
9,29-730,20-950,86. Anno 1860: 362,72-969,00-606,25. 1861:
1458,15-1594,10-747,00.
Il movimento nasce con enormi difficoltà (non solo la
mancanza di soldi –la vita dell’operaio era al limite della sopravvivenza e
troppo spesso mancavano i mezzi da distornare per una quota associativa; ma
anche ostilità governativa che vi legge la base più dura dell’opposizione
rivoluzionaria (sequestri, chiusura e scioglimento, arresti o esilio); e per
l’assenza di protezione da parte dei benestanti ancora mentalmente portati a
finanziare beneficenza).
Separatamente, qualche
mese dopo nacque nel borgo
un’altra associazione: col nome di
“S.M.S. dell’
Unione Umanitaria”. La prima sede di riunione fu un
locale a capannone posto all’inizio a monte della stessa strada di oggi in zona
Mercato (facente
parte delle proprietà della fam.Rolla, la cui casa-villa privata era alla
Fiumara) e gestito da ‘Baciccia de mûin’ (GB dei mattoni).
Primo presidente fu Luigi Casanova -aiutato dal cap. Devoto Francesco, dagli operai Testa
Angelo (detto û Zuetto), Ferrando Giuseppe (detto û –ma si scrive ‘o’Ratella),
Pittaluga GB (detto û Carubba) e Pavese Pietro- il quale, sia inesperto, sia vessato dall’incomprensione tra le
nuove idee (laiche, e con Mazzini che era
riconosciuto all’unanimità socio fondatore) e
quelle conservatrici (religiosi: la Curia del tempo, rimase stranamente
perplessa, preoccupata, e concluse per un parere sostanzialmente negativo) promosse delle attività imitanti più le
confraternite ed i cerimoniali tradizionali anziché proponenti quello spirito
innovativo che diverrà poi la caratteristica forte della Associazione.
Il seme era stato
gettato: il nome stesso se implicava “operare con umanità e moralità” nel
campo del lavoro, implicava il concetto di unione al fine di autoemanciparsi,
come poi anche “sovvenire ai soci resi malati ed a quelli che per infermità,
vecchiezza, saranno divenuti inabili al lavoro”. É questo il vero miracolo
della loro nascita: non aver fatto una rivoluzione o sommossa, ma aver reagito
all’inglese da “self made man”: con dignità, acume ed autonomia, in quanto i
problemi di fondo della popolazione, gradatamente in aumento non erano
affrontati né conosciuti dal governo centrale torinese: immigrati
poveri, ignoranti, impreparati (e quindi
soggetti al facile abuso del padrone), pieni di figli (la mortalità infantile era altissima), spesso
malati (tubercolosi, malaria, alcool,
denutrizione; comunque per i più la prospettiva di vita non superava i
55-60’anni). I primi bilanci dell’associazione dimostrano un disctreto
interesse: 1858: capitale
2271,70-entrate lire 1456,19. Anno 1862
capitale 2438,07-entrate lire 1267. Come sempre all’inizio, tale
iniziative furono appannaggio di pochi; e pochi, inizialmente legati solo da
una grande sensibilità; non certo favoriti da cultura, ampiezza di vedute
politiche, contatti con altre associazioni
per confroni e produzione di idee (i marinai informavano sulle iniziative
anglosassoni dopo vari mesi di navigazione; Parma, Pavia, Milano erano
all’estero e con esigenze diverse); rispetto invece la massa che inerte e
potenzialmente povera, era vesseggiata nei servizi senza calmieri dei prezzi (e
di rimando e molto presumibilmente- soggetta agli usurai), senza igiene né
assistenza sanitaria né ospedale, senza scuole né attività ludico sportive per
i giovani; Mazzini stesso –allora cinquantenne, era da tempo in esilio e
comunicava con lettere non ufficiali (altrimenti soggette a censura) che
impiegavano settimane a pervenire e quindi lui stesso non diretto organizzatore
ma solo lontano ideologo di una vaga chimera rivoluzionaria che poi ciascuno
cercava di realizzare mettendo in pratica ed agendo secondo il proprio buon
senso ed iniziativa.
Nel 1854 le due
associazioni favorirono assieme l’apertura di un terzo centro, chiamato “gabinetto
di lettura e di cultura” aperto in ‘via dei Banchetti’, in una grande sala che era comunemente
chiamata ‘Zane’ dal nome di un marionettista
che in vernacolo vi lavorava col suo teatrino, con celato ma ovvio indirizzo
politico, ovviamente senza satira né ironia non ancora concesse. Questo centro,
sia per la propaganda che per il laicismo, fece scandalo; ciononostante gli
operai più colti e vicini alle vicende italiane ed europee, riuscirono a
coinvolgere sempre più alto numero di giovani che desideravano uscire dall’ignoranza
ed isolamento. Nel 1854-8 fu da loro promossa una coraggiosa propaganda e
partecipazione per le imprese di Carlo Pisacane (partecipe con lui fu Carlo
Rota, che finirà prigioniero), Nicotera e Rosolino Pilo.
Due anni dopo le due società (con 250 soci) iniziarono a palazzo Boccardo (una ex-villa dei
Centurione in via del Mercato 11, oggi distrutta, posta all’altezza di via
A.Cantore civ.51) l’attività delle scuole
serali per operai: enorme
era a quei tempi il numero degli analfabeti: si proposero corsi di
acculturamento anticipando l’ apertura di scuole pubbliche, sia con l’
istituzione di biblioteche che corsi elementari, disegno meccanico ed
ornamentale, ma poi anche attività ludico-sportive (ginnastica, scherma e tiro
a segno con carabina; la ginnastica darà vita alla Sampierdarenese; le altre
due furono curate da Mosto con allievi Galeano, Quirico Moggia, Meronio ed i
Canepa, senza celato scopo di preparare futuri combattenti capaci di imporsi
al nemico usando le tecniche delle nuove armi da fuoco. Si posero così le basi
per la nascita dei Carabinieri intesi -non come oggi arma militare- ma come
esperti nell’uso della carabina, che praticamente tra pochi anni faranno
vincere le battaglie a Garibaldi nella spedizione dei Mille, facendo da lontano
vuoti spaventosi nelle truppe borboniche ancora strettamente inquadrate). Infatti, dei Volontari tentarono di partire
verso il meridione, nel 1857,
sul piroscafo Cagliari, con Carlo Pisacane. Tra loro Carlo Rota, che poi fu
fatto rpigioniero e incarcerato a Favignana
Di
nuovo nel 1860 con
Garibaldi ed i Mille: ma per disguidi Stefano Lagorara, Lorenzo Castello, Michele
Davovaro e altri, non giunsero in tempo all’appuntamento di Quarto cosicché
autonomamente raggiunsero poi la Sicilia con Medici, Cosenz, Pianciani e
Nicotera. dopo aver raccolto (e nella fonderia Fossati addirittura si fabbricavano) armi e munizioni da portare o inviare per le loro
operazioni di guerra. Nel 1861
si fondò un giornale cittadino intestato ‘l’Operaio’.
Dopo nove anni di intensa attività volontariale socio economica, nel 1862,
aderirono all’ ‘Emancipatrice’ fondata da Garibaldi avente carattere
provinciale seppur espansa in tutta la penisola (assieme alla soc. Volontari italiani’).
Ma il 9 marzo 1862, dalle
autorità fu decretato lo scioglimento forzato di tutte le società di MS.: la
polizia non sempre trovava le prove che andava cercando con perquisizioni
massive dei locali (in
effetti nell’ambiente giravano sia personaggi che scritti, allora giudicati
sovversivi; e –come detto- anche armi, sino a veri e propri arsenali,
teoricamente disponibili per i vari patrioti, tipo quelli attivi a Sarnico ed
Aspromonte nel 1862; nel Friuli, 1864; in Tirolo, 1866; nell’Agro romano e
Montana, 1867). Dovettero tutte seguire
la stessa sorte, chiudendo.
Ma i soci sampierdarenesi (i suddetti Devoto Francesco –capitano lupo di mare-, Bardin, Pittaluga,
Testa Angelo (o Zuetto), Ferrando Giuseppe (o Carubba), Casanova Luigi, Pavese
Pietro assieme a Dellacasa GB, Morando Giovanni, Botto Pietro, Romairone
Natale, ed altri non ricordati) subito
convocati, fusero le due società e costituirono una nuova “Associazione Generale democratica” di mutuo
soccorso ed istruzione degli operai di San Pier d’Arena”. Con un gruppo iniziale di 200 soci,
praticamente trappresentanti due diverse categorie: più numerosi quelli che
lavoravano nelle industrie di quelli con mestieri diversi, come facchini,
trasportatori, negozianti, ricamatrici e contadini. Per autosostenersi
organizzarono anche esposizioni d’arte o industriali o manifatturali. Tutti
ferventi assertori delle idee mazziniane e apertamente seguaci delle sue
dottrine (“i diritti non sono altro che il portato dei doveri compiuti: fate
sempre il vostro dovere e poi reclamate –non solo, ma vogliate- il vostro
diritto”. Queste erano comunemente al vaglio
degli iscritti, supportate con riunioni, lezioni, discussioni ed anche
sottoscrizioni volontarie pro-Mazzini: ufficialmente una associazione di
carattere assistenziale, ma con più o meno aperta attività politica a favore
del movimento repubblicano),
erano quindi sotto continuo stato di controllo poliziesco per subodorata (ed
effettiva) attività antirealista piemontese ed antitemporale del Papa.
Quindi, seppur elogiati
dagli amministratori pubblici ((quasi sempre a loro volta iscritti
all’associazione) per le iniziative a carattere sociale specie per le calamità pubbliche,
le malattie individuali, i casi di invalidità (specie da lavoro), per
l’educazione dei giovani operai. Tipico il periodo del colera del 1854-5 : in questa
occasione, il Municipio della città istituì un comitato cittadino di soccorso
ed assistenza presieduto da due iscritti V.Armirotti e N.Barabino, ai quali fu
poi riconosciuta una medaglia d’argento al valore civile, che i due vollero
estesa a tutti i collaboratori e che il Barabino volle sul petto alla sua
morte; sostennero anche economicamente uno sciopero degli operai di Lione;
rifiutarono di inviare al governo i dati statistici con i nomi degli iscritti;
appoggiarono lo sciopero dei cordai raccogliendo fondi per essi) furono altrettanto ostacolati per l’impegno politico (non espresso apertamente, ma fermamente avverso alla casa reale
regnante: i Savoia furono sempre poco sopportati dagli iscritti, se non come
unico mezzo per arrivare ad un bene superiore che era l’indipendenza nazionale).
Double face quindi: da un lato a
cospirare (in ordine,
prima contro l’invasore straniero, poi contro i Savoia e monarchi regionali,
poi -per ultimo e con minore accanimento- contro il potere temporale della
Chiesa), da un altro li vediamo attivi
in tutti i campi sociali, messi in evidenza dall’enorme massa di operai
immigrati (tutti poveri
ed analfabeti), in seguito
all’esplosione industriale, ed illuminati da personaggi come Rota, Stallo,
Armirotti, Meronio, i 4 fratelli Canepa, Roncario, Molinari, Derchi, ecc.
Così, anche se spesso praticamente “fuori legge” (l’aiuto decisivo ad organizzare la
partenza dei Mille; nel raccogliere fondi per propagandare le idee repubblicane
in tutto il regno, in appoggio anche ai famosi Saffi, Quadrio, Campanella;
nell’adunare uomini e raccogliere armi per le imprese di Sarnico, Aspromonte,
Friuli, Mentana, Digione e la Repubblica romana) e perciò strettamente “sotto controllo poliziesco” (nell’organizzare attività sindacali,
riunioni, scioperi, ribellioni alle gabelle; in un momento sociale di grande
trasformazione, con viva esigenza di migliori condizioni di vita sociale,
economica, culturale, logistica, per svincolandosi soprattutto dal concetto di
ricevere per elemosina e creare invece il concetto di diritto al miglioramento,
inizialmente tramite la reciproca organizzazione. Erano tempi in cui l’operaio
lavorava 18-20 ore al giorno. Erano in pochi a ribellarsi: non tutti capivano
e partecipavano alla lotta; anzi i più e più spesso erano i rinunciatari
sfiduciati, mal guidati dal clero conservatore, spaventati dalle iniziative
bellicose e dalle idee allora giudicabili antisociali e rivoluzionarie); “apertamente” diverranno nel 1866 la “Società Generale Democratica” nella quale
conversero le tre iniziative (Società Umanitaria, Unione Fraterna e Gabinetto di Lettura) sino ad allora tenute separate anche per evitare
azioni repressive di polizia.
Molti
furono i volontari attivi nel frattempo: in occasione di Mentana, troviamo a
combattere CRota, VArmirotti, CMeronio, LStallo
La lotta la lotta all’ignoranza fece maturare i tempi perché l’Associazione
producesse altri servizi utili al popolo, come favorire i primi abbozzi di Cooperative per
l’acquisto a prezzi più miti dei beni primari (nasceranno più tardi, 1864 -da questi semi- le Cooperative vere e proprie, specie quella di Consumo (vedi in via C.Rolando; con un primo
spaccio in via A.Doria)
e Produzione (vedi via Ulanowki): da esse nel 1901 l’Alleanza Cooperativa Ligure che –in
SPd’A- univa le due più la Consumo fra Lavoratori e la Consumo tra Ferrovieri;
e nel 1902 la Federazione delle cooperative
comprendente carbonai, elettrici, calzolai, bottai, scalpellini ed i calderai;
e nel 1903 l’UnioneRegionaleLigiure di tutte le Assoc.-Mutue-Leghe-Cooperative). Con esse l’erezione di case popolari
sane e munite di impianti igienici ed acqua ancora esistevano le cisterne alla base dei palazzi, per la
raccolta dell’acqua piovana e l’uso dei lavatoi e fontanelle esterne¸ specie
dopo l’epidemia di colera; per iniziativa della Ass.Operaia MS Universale,
nacque la prima cooperativa per la costruzione delle case popolari per persone
dette ‘meno agiate ‘ - vedi via Masnata -: il primo caseggiato in città venne
inaugurato nel 1878 ed nel teatro Modena avvenne l’estrazione dei destinatari;
nel 1882 il secondo, nel 1887 il terzo di 30 appartamenti; nel 1906
all’Esposizione internazionale svolta a Milano in occasione dell’apertura della
galleria del Sempione, Osimo Augusto incaricato della Cooperativa fece parte
della giuria che offrì unpremio in concorso al miglior progetto di case
popolari operaie per l’Italia settentrionale: il Comune di San Pier d’Arena – presente
con un padiglione proprio sul tema - partecipò con un progetto di casa con 200
appartamenti (700 persone) dotati di gas, elettricità, fogne; il risparmio costituendo sempre nel 1864 una
propria banca, chiamata ‘Banca Popolare di
Sampierdarena’, aperta con i contributi della famiglia Gambero (importatori e commercianti
all’ingrosso di cereali, con interesse nell’edilizia e cotonifici) nella via Vittorio Emanuele, presso
la neonata piazza ancora senza nome ufficiale e quindi popolarmente conosciuta
come piazza degli Omnibus: oggi pza Vittorio Veneto; se
c’erano a Genova 4 istituti di credito di grosse possibilità di capitale
(milioni), molto modesta era la nostra: 50mila lire nel 1866, portate a
100mila l’anno dopo ed a 250mila nel 1889, con aumenti di capitale sempre
modesti pari al 4-5% contro il 15-20% nazionale. Poi nel 1925 confluì in quella
di Novara; le attività
ludiche (la
filodrammatica ed annesso teatro); non
ultimo l’aiuto anche nella salute (con l’apertura di farmacie (la Operaia, inizialmente nell’attuale via SPd’Arena nei
pressi di via T.Molteni, poi in via Molteni, oggi in via Avio; e nel 1902
anche la vicina farmacia Popolare Sociale), di una cassa mutua
(per i malati) e finanziamenti pro Ospedale come
diremo tra poco).
Nel 1868, raggiunta
l’unità nazionale, cessò la spinta patriottica e tese a prevalere l’attività
sociale e politica: l’Associazione partecipò attivamente al 1° congresso delle
SMS liguri, sollecitando un congresso nazionale ed aprendo una sottoscrizione
volontaria mensile di 5 cent. pro Mazzini (questi ringrazierà per aver ricevuto 47,25 lire).
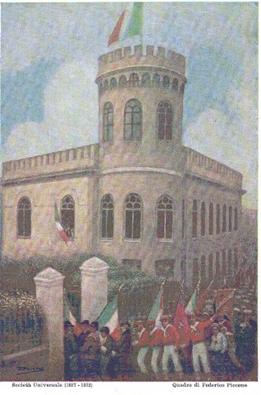

quadro di Federico Piccone foto del 1893
in occasione del raddoppio dei binari, da2a4
Nel 1869-70, i soci
effettivi salirono a 500: non molti, per un centro operaio così numeroso, ma
pur sempre uno dei solidalizi più forti ed attivi, osteggiato dai benestanti e
dal clero per l’atteggiamento progressista ed anticonservatore, e sempre
tenuto d’occhio dalla polizia con perquisizioni per i più banali motivi (ad esempio la lettera di
ringraziamento di Mazzini, pur sempre un fuorilegge, trovò in quegli anni l’occasione per ispezionare, sequestrare
materiale, porre i sigilli anche alla biblioteca, controllando i passaggi alla
porta della Lanterna e nel teatro Ristori),
fino all’ obbligo - decretato dal Ministro G.Lanza e firmato dal Prefetto - di
scioglimento del gruppo (17 maggio 1870).
Però V.Armirotti segretario, ed i consiglieri -Meronio Carlo, Rota Carlo, Roncallo Angelo,
Morando GB, Botto Pietro, Grondona Giovanni, Morasso Nicola- si riorganizzarono immediatamente (21 maggio),
cambiando nome anche se similare: “società Operaia
Universale di Mutuo Soccorso di San Pier d’Arena”, ed adottando sia
lo stesso statuto sociale precedente che le cariche dirigenziali. Questa scelta
non venne accettata né dal questore né dal prefetto, ed ovviamente quindi
osteggiata ulteriormente. La sede era sempre in via del Mercato 11,
in palazzo Boccardo, con una
rappresentativa in via C.Colombo (v San Pier d’Arena, civ.17 - casa Delucchi, a fianco del teatro Ristori, 4°
piano). In contemporanea venne inaugurata la fabbrica di pasta alimentare (che
nel 1890 vincerà diplomi d’onore, medaglia d’oro e d’argento alle varie
Esposizioni nazionali)
Nel 1871 partecipò economicamente alla
ristrutturazione dell’ospedale della villa Masnata, contribuendo con la grossa
cifra di 200 lire; propose
una cassa per gli inabili al lavoro, per le vedove e gli orfani dei lavoratori
che si realizzerà solo nel 1876; iniziò
ad interessarsi anche degli asili, organizzandone l’apertura e l’utilizzo;
partecipò in primo piano al XII congresso delle Società operaie (delegato Valentino Armirotti); protestò con manifestazioni, contro gli
imprenditori che cercavano maestranze all’estero.
Nel 1872, alla morte di Mazzini a Pisa (10 marzo), viene decretato lutto per un anno, e viene comperato
un ritratto da porre nella sede. Venne aperto finalmente ma tra i primi in
Italia, un Circolo Operaio Femminile.
Nel 1874 si inaugurò una lapide dedicata
a Carlo Meronio, socio dirigente caduto combattendo con i garibaldini in
Francia nel 1870. I soci sono mille ed il capitale raggione 88.600 lire.
Nel 1875 nasce la Cooperativa di
Costruzione case popolari per i Meno Agiati. Estrazione /ruota) al
Modena. 1700 i soci.
Nel 1876 venne
istituita la prima cassa di quiescenza per gli inabili al lavoro, vedove ed
orfani. Tutte iniziative che supplivano l’inettitudine del governo, e che
anticipavano di molti decenni le assistenze ai lavoratori e suoi familiari .
Nel 1877 fu votato lo statuto
definitivo.
Nel 1878 i soci erano saliti ad oltre
1500. Nel 1880 si schierò apertamente contro un attentato a Napoli
contro re UmbertoI “considerando la sacralità della vita umana, sia del più
umile che di un re“.
Nel 1882 200
soci (in primis i Botto, durante e dopo uno sciopero all’Ansaldo con
licenziamenti; essi iniziano la fondazione della prima Cooperativa di
produzione meccanica
(soc.an. Cooperativa di Produzione, Officina Meccanica e Costruzioni Navali in
San Pier d’Arena) che riuscì a fiorire
dando lavoro a questi operai altrimenti disoccupati.
Nel 1883 ospitò nei locali, per le
proprie riunioni, la S.M.S. dei carrettieri e mulattieri (già nata nel 1864). La
Coop.Produzione si trasferì in via B.Agnese.
L’Associazione aderì al ‘Fascio della democrazia’.
Nel 1885 la Coop. Consumo ha 1700 soci, 117.000lire di
capitale, un mulino, macchinari per pastificio, nove spacci.
Nell’ottobre 1886, col socio Valentino
Armirotti eletto parlamentare (primo deputato italiano operaio; poi nel 1900 verrà anche P.Chiesa: la
loro elezione sottolinea l’acquisizione di un potere degli operai), la società prese possesso della sede di via
Mameli (via Carzino). Alla cerimonia furono
presenti 82 associazioni consorelle (il terreno, ancora a prato era stato acquistato dai soci per
16mila lire; l’edificio non si sa da chi progettato, ed un poco più piccolo
dell’attuale, ne costò il doppio nel preventivo ma il quadruplo alla fine. Fu
uno sforzo immane, sostenuto praticamente da soli e con l’appoggio della
cittadinanza tramite iniziative multiple).
Nel 1892, all’esposizione di Genova,
ricevette una medaglia d’oro di merito sociale (entrate 40.900 lire; uscite 35.000
di cui 7300 lire per medicine e 15.000 lire per sussidi ad ammalati).
Nel 1898
divenne Ente Morale, legalmente riconosciuto. (nel “titolo I” dello statuto societario è scritto che
l’associazione fu disciolta una seconda volta nel 1898 : penso sia un errore di
data riferendosi al 1870).
Nel 1899 il 29 aprile, l’Associazione fu
legalmente riconosciuta con decreto prefettizio e dal Tribunale di Genova (registrata alla Cancelleria del
tribunale il 17 mag.1899 con n.ordine 788, trascrizione n.513, società n.1708,
fascicolo n. 3059). La SMS diede
ospitalità al Partito Repubblicano Italiano, ed alla Camera del Lavoro.
Il PNF: vedi a
Fascio (Secondo fascio d’Italia).
Il maturare e degenerare delle nuove ideologie
politiche contrapposte, determinò che il commissario prefettizio dettò leggi
restrittive relegando l’attività sociale di tutte le SMS al minimo vitale, in
poche sale, obbligando l’Universale all’ultimo piano, diffidandola dallo
svolgere attività o iniziative.
Forse fu lassù che nacque il Teatro del club ‘Ritrovo
sociale’ inaugurato nel 1924 (si sa
solo che fu “un grazioso teatrino” collocato nella sala del vecchio club.
L’inaugurazione viene tenuta dalla compagnia dell’attore Riccardo Pittaluga che
vi rappresenta la commedia farsesca dialettale di Davide Castelli ‘o testamento
do scio Lumetti’).
Nel maggio 1926 il Duce venne a San Pier d’Arena per
visitare sia l’Ansaldo che questa sede del PNF sampierdarenese, qui alloggiatosi
dopo essere stato nella vecchia ‘stalla’. Aumentati di numero e ringalluzziti,
come temuto, il 30 novembre di quell’anno le stanze dell’Universale furono
occupate dalle squadre nere. Ben presto a livello nazionale furono varate leggi
specifiche che legalizzarono il gesto determinando lo scioglimento obbligato
di tutte le associazioni ed organizzazioni, riunendole in strutture del
partito e cambiando loro nome.
Impossessati della palazzina e corrispondendo al IV°
anno della rivoluzione delle Camicie nere, dopo il discorso del gerarca vice
segretario del partito prof. Arturo Marpicati, venne celebrata la distruzione -
tramite defenestrazione e rogo - degli incartamenti, arredi generici,
biblioteca, busti di maestri di vita repubblicani, di due arazzi - questi
segretamente ricuperati ed ora ospitati nella scuola del Monastero - e degli
stemmi e bandiere conservati nella sede.
Un socio, Federico Piccone (1882-1963-vedere Gazz.SPd’A
12/90.8), divenuto - da giovane barbiere - un apprezzato artista e maestro di
disegno nella ‘scuola di perfezionamento per i lavoratori’, avendo vissuto
quegli anni, riuscì a salvare parte delle memorie che gli permisero di
ricostruire la storia dell’associazione e la biblioteca.
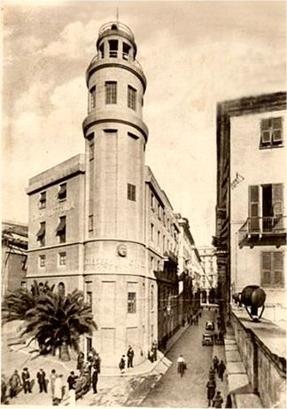

la casa Littorio
com’è ora – a destra la torre della Croce d’Oro
Subito iniziarono gli studi preparatori della
ristrutturazione; seguiti dai lavori veri e propri (su progetto e direzione
dell’arch. Raffaele Bruno, la soc. Stura la sopraelevò in cemento armato di due
piani e modificò la torre (ebbe la sostanziale sopraelevazione di 8-10m. sino
all’apice della torretta, una campana (come in uso per tutte le case Littorio,
e da rotonda e merlata divenne quella attuale). Nell’interno, con decorazioni
curate dai pittori Antonio Canepa ed Ernesto Massiglio; sul muro della casa fu
incisa la frase “nel dodicesimo anno della rivoluzione delle camicie Nere. Chi
è col popolo è con il Duce”.
Fu battezzata il 4 novembre 1933,
anniversario della Vittoria, come casa del Partito Nazionale Fascista e sede
del “secondo Fascio d’Italia” dedicandola al
fratello del Duce, Arnaldo Mussolini.
Ufficialmente la sede
venne chiamata “Casa Littoria” (così diceva la grossa scritta posta
tra il 3° e 4° piano all’esterno sulla facciata a mare; e sulla base
semicircolare della torre- venne riproposto il motto mussoliniano “credere, obbedire, combattere” con al centro, il volto di Arnaldo,
opera dello scultore Ruggieri. L’interno (con riscaldamento, illuminazione elettrica e servizi igienici) vedeva a piano terra la casa del custode, il bar-caffè, 5 locali per l’Opera Nazionale
Dopolavoro ed infine aperte anche in via Mameli gli uffici con sale d’attesa
per le Commissioni Assistenziali. Al primo piano il grande salone preceduto dagli uffici rilasciati alla Società
Universale (era previsto nella programmazione iniziale la concessione di questi
spazi all’Universale, ma alla inaugurazione evidentemente il progetto era già
mutato, relegando i repubblicani tra gli avversari politici). Si scfrive che
qui insegnavano musica la famiglia Gasparini
(vedi in via Mameli)
Al secondo piano fu demolito il tetto a padiglione dando più spazio aereo
al salone sottostante fatto in ceramica;
nelle stanzette dell’intermedio furono collocati gli uffici
dell’Associazione calcio Sampierdarenese, mentre al secondo piano facente parte della sopraelevazione
alloggiarono gli uffici del gruppo Fascista A.Mussolini (del fiduciario,
segreteria politica ed amministrativa, fascio femminile, cultura, biblioteca,
stampa e sala riunione). Al terzo piano il Fascio Giovanile di combattimento, Artigianato, milizia, madri e
vedove dei caduti in guerra, ufficiali in congedo ed associazioni reduci. Nell’interno della torre la scala per accedere ai piano e sulla sommità una campana battezzata
‘Vittoria’ e che aveva inciso la frase “il mio bronzo freme di amor di patria –
l’eco possente dei miei rintocchi -. si diffonderà negli spazi lontani per
celebrare – le glorie del fascismo . suscitare la solidarietà e la fede –
affermare nel nome del duce la potenza invincibile – XXIX ottobre MCMXXXIII .
Anno XII era fascista”.
Non è precisata la data, ma è probabile dopo queste ristrutturazioni, che
l’immobile appare vincolato e tutelato dalla Soprintendenza per i beni
architettonici della Liguria, come “ex Casa del Popolo ora sede Ass.ne SOMS
Mazzini”).
Hockey - La sera del 24 nov. 1936 nella Casa Littoria, dalla Federazione
Ligure di hockey (dipendente
dalla nazionale, associtata al Pattinaggio a Rotelle) fu presentato a dei giovani sampierdarenesi un
tecnico svizzero di hockey (Kurt Reber, ex giocatore del Zuricher He), determinando la nascita del primo gruppo genovese
di detto sport (previsto
per le Olimpiadi del 1940, con Roma candidata). Sono
ricordati perché molti divenuti nazionali: Franco Adorno, Stefano Baschieri,
Alberto e Remo Beltrandi, Cipriano Cuneo, Umberto Dondero, Franco Neumaier,
Pier Vittorio Pampuro, Filippo Vado, Giovanni Zanelotti (1910-1993) Era stato fiduciario della stessa FGC sampierdarenese
divenendo campione d'Italia nel 1938, e vincendo col GUF Genova il primo
scudetto della storia dell'hockey su prato italiano. Divenne medico a SPdA, descritto
‘fascistissimo’ perché si era fatto -come volontario- la guerra di Spagna a
fianco dei falangisti di Franco; nel 1945 ebbe guai di ritorsione, superati sia
per la professione, sia per conoscenze, sia per aver saputo far intendere
‘essere sceso dal treno’ nel momento giusto. Negli anni 50-70 era molto noto
sia per l’alto numero di mutuati, sia per il carattere brusco ed autoritario, e
sia per una non nascosta ‘disinvoltura’ nel fare comparaggio); allenamenti bisettimanali; incontri casalinghi nel campo in terra
battuta della Centrale Latte di Teglia (soprannominato Cajenna come il bagno penale nella Guaiana;
terreno che era stato utilizzato anche come aeroporto). In ottobre furono inquadrati nel GUF di Genova (il ‘malocchio’ verso ciò che era
della ‘perfida albione’, fu superato sia grazie all'autarchia di Starace per la
quale, sui giornali l'hockey divenne «óchei»; eppoi ai programmi del regime:
dopo le Olimpiadi di Berlino del '36, era stata proposta Roma quale sede per i
Giochi del 1940 (e apposta si realizzò il quartiere dell'EUR), e –di
conseguenza- si voleva che l'Italia partecipasse in tutte le discipline
sportive; il regime spinse le Federazioni regionali a dare incremento anche all'hockey
su prato, che da noi non aveva tradizione, a chiamare dall'estero
degli istruttori; così nacquero le prime squadre e i primi campionati.
Poi, in realtà, le Olimpiadi vennero assegnate a Tokio, e il sopravvenire della
guerra ne impedì l'allestimento e lo svolgimento: ma questa è un'altra storia).
Alla fine del secondo conflitto mondiale 1940-45 (atto di nascita il 1 luglio 1944) divenne anche sede di un comando militare
delle “brigate nere” e di un circolo politico fascista (i due corpi
politico-militari della RSI erano la GNR e le B.N.).
Da loro, la sede di via Carzino (un’altra, era a Pegli) fu
attrezzata anche come carcere per primari interrogatori e detenzione di
prigionieri e da essa partivano per fare rastrellamenti, perquisizioni e
gratuite e tracotantri violenze sugli inermi: l’abuso di potere, la malvagità,
e soprattutto la violenza cresciuta a spirale inarrestabile, resero quelle
celle di detenzione tristemente famose perché si arrivò quale estremo di
perversione alla tortura fisica e morale. Alla guida di Franchi e Criscuolo (temuti e crudeli personaggi, si distinsero per ferocia
contro i prigionieri specie quelli politici, per carpire
informazioni; i due –a fine guerra- furono giudicati, Pastorino P scrive “in
sede idonea” ove furono condannati a morte da un tribunale per crimini di
guerra, e fucilati). Gli interrogatori si concludevano
con il trasferimento alla sez.IV di Marassi in mano alle SS con destinazione
deportazione o fucilazione. Tra i tanti malcapitati portati in questa sede,
ricordiamo Giuseppe Spataro, Ernesto Jursé, Giuseppe Malinverni. Per fortuna, a
lenire le loro sofferenze, il capitano medico riconosciuto ufficialmente in
quella caserma dalle BB.NN. era il dottor Lambò Giuliano (infiltrato, perché in realtà
combattente antifascista, collegato con il PCI e con gli agenti dell’Intelligence
Service inglese, chiamato in codice ‘Isacco 313’).
Le B.Nere di Genova, costituitesi anch’esse nel 1944 con 460
iscritti (divenuti in
un anno 1018) furono
comandate da Livio Faloppa (riuscì a fuggire all’estero); con vice Spiotta Umberto (a Chiavari- fucilato nel 1946); e Benedetto Franchi (39enne comandante la compagnia di
Sampierdarena-fucilato il 30 gen.1946). Avevano la titolazione ad un loro martire Silvio Parodi (alto ufficiale delle GNR, morto a
Savignone in un agguato nello stesso anno). Portavano la divisa col distintivo del teschio.
Il 23 aprile 1945
furono ritirate verso nord, in colonna dalla Camionale intercettata nel decorso
a Valenza dai partigiani. Molte BN, specie anziani, non capirono la gravità
della situazione e rimasero in città pensando non essersi gravemente
compromessi, ma vennero coinvolti nel ciclo delle vendette (punire i fascisti che potevano
sfuggire alle sanzioni dei tribunali) e della guerra civile (che durarono anche fino al 1947).
Solo il 24 apr.1945,
l’associazione rientrò in possesso dei locali, assumendo il definitivo nome di
“Associazione Operaia Universale G.Mazzini, Società di mutuo soccorso
e di cultura popolare”, inserendo il nome di Mazzini quale primo socio
onorario, e col proposito di proseguirne il sacro apostolato, per il
miglioramento dell’Uomo e per l’educazione dell’Umanità (coerentemente in quegli anni di ripresa sociale, fu
data ospitalità al PRI, all’APP (assoc.perseguitati politici), all’AR
(associazione reduci), al circolo Risorgimento Musicale, al Risveglio (circolo
mandolinistico), l’Università Popolare); in
contemporanea fu battezzata la nuova bandiera sociale.
Dal 1996 è
iscritta al registro regionale delle associazioni che operano in campo della
mutualità e della solidarietà sociale, con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Lo scopo è la realizzazione del fondamentale binomio “Pensiero e
Azione”, con iniziative prestanti assistenza ai Soci; si promuovono iniziative
culturali, artistiche e sportive; si ospitò RS1 (radio Sampierdarena); si
trasformò la sala al primo piano in palestra per scuola danza, sempre
cementando e diffondendo l’amore della Patria e dell’Umanità ed attendendo ai
problemi dei cittadini .
nel 1991 un’altra lapide fu affissa sui
muri a memoria e monito contro la violenza : “140° ANNIVERSARIO DELLA S.O.M.S. UNIVERSALE - SU
QUESTI MURI - VOLUTI DAL POPOLO PER IL POPOLO - TESTIMONANZA DI SOLIDARIETA’ -
UNIVERSALE CHE UN REGIME - FOLLE TRASFORMO’ IN PRIGIONE - OGGI CHE ALFINE
CROLLANO IN EUROPA - LE FORZE DELLA TIRANNIA - FISSIAMO QUESTO MARMO -PER
RICORDARE QUANTI COMBATTERONO - E MORIRONO IN NOME DELLA LIBERTA’ - E PER
SALUTARE L’AVVERARSI - DEL VATICINIO DI GIUSEPPE MAZZINI - 1851 - 1991“. Il 28 gennaio 1998,
all’esterno fu posta una targhetta indicante “proprietà SOMS Universale
G.Mazzini”; e
Tra gli iscritti di particolare rilievo, ritroviamo quali soci “ad onorem “ (le persone che per la loro cultura e
le loro opere arricchiscono il patrimonio ideale dell’Umanità) sia G.Mazzini che G.Garibaldi, V. Armirotti (primo deputato-operaio al Parlamento
italiano), N.Barabino ( dapprima iscritto come socio
ordinario, ed allora era ‘o Nicolin’, fu poi eletto a socio onorario quando -17
apr.1861- la sua fama iniziò ad essere di livello nazionale, e divenuto ‘o sciü
Nicolin’ ; nel 1887 il pittore, affidò donandolo alla società (facendolo
pervenire per posta da Firenze) lo storico dipinto-allegorico della ‘Libertà’ ,
rappresentato da un volto femminile cinto di foglie di quercia (notevole fu
l’iniziale delusione, alla vista di quella grande testa forse …enorme, con un
naso sproporzionato che divenne simbolo nei detti popolari nei confronti di chi
aveva l’appendice anche solo un po’ fuori misura) ; egli stesso volle
completarlo e collocarlo nella sala ove pensava nessuno avrebbe mai più osato
spostarlo, essendo emblema-messaggio dell’ideale dell’associazione, proponente
che solo attraverso il rispetto della libertà altrui, si può esigere la
propria. L’idea fu disattesa quando “la allegoria della Libertas” fu rimossa
dal salone per essere relegata in una stanza più modesta, pur restando simbolo
del patrimonio culturale, sociale e spirituale della città di Sampierdarena.
Ovviamente dopo la guerra ha ripreso il suo posto nel grande salone, ora
adibito a palestra e scuola di danza); e non dimenticando
Carlo Rota, Dante G.Storace, A.Carzino.
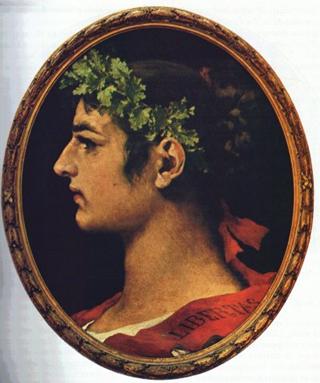



Nell’interno, si trovano gli uffici
dell’Associazione, un bar, la biblioteca ricca di un migliaio di volumi, e la
sede di una radio locale (R.S.1
ovvero Radio Sampierdarena Uno
ricevuta sul canale FM-100,450 mghrz. Unici a trasmettere tra loro erano i
radioamatori. Quando sul mercato nacquero i CB (citizen band, ricetrasmittenti a basa frequenza;
erano vietati, ma la polizia non se ne curò purché non invadessero la loro
banda; le radio libere dal dic. 1975 in pochi mesi divennero oltre 2600,
occupando le varie frequenze senza regole e senza riverenze), su iniziativa di alcuni giovani (Bellico Mauro, DellaDucata Francesco, Gregianin Enrico, Savio Antonio
e Savio Giovanni, più un sesto rimasto anonimo, coordinati da Rino Baselica,
Danieli Angelo e Vallebuona Renzo) nacque la nostra, nel lontano 1976
circa, al Morgavi di Belvedere e poi trasferita in via Carzino nel 1978;
le trasmissioni ascoltate regolarmente dagli entusiasti 150 ed oltre
sostenitori, prevedevano musica (canzoni genovesi; dal jazz alla sinfonica), parlate dialettali (Pingas ovvero il Giuseppe che
andava nelle case a leggere i contatori del gas), religione (don Walter), telefonate, dibattiti e dialoghi locali con sapidi “ciaeti”; nel 1987
avvenne una scissione con mantenimento di RS1 (gestita da Olivari, ma che chiuse fallendo nel 1990
circa), e con la
nascita di Radio Lanterna City
gestita da Rino Baselica, trasferita in via Gioberti sino al 2005,
capace di trasmettere da Savona a Nervi usando un vecchio mixer degli anni '70.
Veniva chiamata
"indipendente" perché nel frattempo e per necessità di automantenersi
oltre il volontariato, erano nate le radio private fino alla nascita dei
network nazionali che fagocitarono le radio più piccole. Citiamo alcuni nomi conosciuti, di quelli che conducevano i
programmi: Marco Terreni, Lucio D’Atri, Alba Olmi, Giannetto D’Oria, “Giuan do
Porto”, Giuliana Barzaghi, Mauro Litterini, Paola Conti, Francesca Frixione,
Roberta Paita, “zia Milvia”, Felice Girolamo, e -per ultimo- Claudio Gambaro.
Al primo piano il “salotto Universale”.
Per perseguire il programma educativo, una attività organizzata iniziò dopo
una ristrutturazione eseguita nel 1978, per
iniziativa dell’attore Mario De Martini (compagnia teatrale),
del regista Mino Ventura, e di Germana Venanzini (gruppo teatro genovese moderno) con rappresentazioni di commedie dialettali,
cabaret, musica e teatro popolare; attivissimo negli anni 1980f u istituito un
“Premio Letterario” (comprendente poesia, poesia dialettale, teatro
dialettale, narrativa per ragazzi). Attualmente viene utilizzata come sala di
scuola di danza.
===Civ.2Ar: nel Pagano
1950 si segnala la sede del grossista di medicinali Gallareto Pierino—all’interno
12 la “Frugone Ant. (dadi Wuhrer)”.
===Civ 2Br: A piano terra c’è una palestra dove
si esercita la ‘thay (=da Tailandia, significa libero) box’, chiamato Tiger
Kick Boxing. In origine chiamata Moai Tai (antichissima arte del combattimento
a corta distanza, in cui si arriva subito al corpo a corpo; praticabile già
dall’età di 4 anni e mezzo. In Italia c’è dal 1988 portata dal maestro Moïse
plurimondiale del karate. La scuola sampierdarenese si è sempre imposta in
campo nazionale, europeo ed internazionale, riportando per più anni
(1999-00-01) il titolo mondiale.
===civ.3: prima della costruzione del palazzo, esisteva un
prato dove frequentemente si fermavano i ‘baracconi’. Fu nel 1914 circa, che
l’impresa Capello diede inizio alla
costruzione del palazzo; ma arrivati a fine del 1915, con l’esterno completato (ricche decorazioni liberty sulla
facciata e nel portone protomi femminili, floreali, in un cartiglio sovrastante
il portone è inciso l’anno in cui fu finito: 1920) l’Autorità Militare requisì lo stabile non finito (ancora grezzo, senza porte né
finestre, per adibirlo a caserma). Non
specificato quando ma si presume appena finita la guerra, fu sgomberato
dall’Esercito e poté essere completato negli interni. Sconosciuto il nome
dell’architetto. Lo stemma con la scritta F.C.*** rappresenta probabilmente la
sigla dell’imprenditore Capello che finanziò la costruzione.
Durante
l’ultimo evento bellico, nel piano terra del palazzo, sostavano gli uomini
dell’UNPA, con patetici secchielli di sabbia, maschere antigas e lanterne
antioscuramento.
===civ. 4: nel giorno 1 maggio 1930 vi aprì la
sede di spedizioniere il 34enne Macor. Inizialmente una piccola azienda, la ‘Placido Macor & C.‘ è divenuta nel tempo una
tra le cinque più attive nello scalo genovese. A conduzione familiare, dai
tempi dei carretti trainati da cavalli ai moderni elaboratori elettronici,
sempre con modestia e specializzazione, a dimostrazione di lavoro serio,
intenso e professionale. Nel 1980 il titolare fu nominato cavaliere al merito
della Repubblica.
===civ.5-1 nel 1950 aveva sede una ditta Cavalli Umberto di materiali metallici
===civ.
7: all’angolo con via Daste, in
piena zona Mercato, c’era sino al 1920-21 la casa della Provvidenza, di don Daste: la sua
vocazione sacerdotale era iniziata più tardi del solito, ma quella
assistenziale delle fanciulle orfane e sole nacque quando nel 1867 madre Angela
Massa delle suore Franzoniane, dovendosi trasferire in altra sede, lasciò al
prete l’incarico di assistere dodici ragazze che lei aveva sottratto alla
strada per fornir loro assistenza ed educazione. Da una sede provvisoria in via
san Bartolomeo, trasferita poi in via
Goito (via A.Albini), poi in
piazza Bove (via V.Alfieri), finalmente era arrivato in via Mameli (via Carzino). Con l’assunzione
del gravoso incarico, era comune vedere per la città il prete che girava per
raccogliere tutto quello che poteva servire, dalle sedie, alla legna per il
fuoco, dal cibo alle elemosine dei più sensibili.
Un giorno, il principe Centurione, proprietario dell’immobile, sfidò la
Provvidenza -’stampella del prete’- offrendogli a prezzo assai vantaggioso la
possibilità di non essere più sfrattato e di poter acquisire per le ragazze una
sede stabile. Gradatamente, con l’aiuto della amministrazione comunale (per primi i sindaci Dall’Orso Pietro e Federico
Malfettani ai quali il sacerdote si rivolse dal 1887 affinché
elargissero un aumento del sussidio (in atto dal 1871) ed eliminassero la spesa
obbligatoria del dazio per introdurre i cibi necessari al pio istituto; nonché
il pittore Carlo Orgero assessore (che per
primo lo chiamò “l’uomo più grande di San Pier d’Arena”) e di privati (di
spicco ricordiamo V.Armirotti, allora già deputato, fece incontrare il sacerdote con il re UmbertoI
nel 1892 all’esposizione per il centenario colombiano, quando le orfanelle
erano arrivate a 87, facendogli così ricevere un importante contributo dal re
stesso; ed il comm.Bombrini,
divenuto provvido
sostenitore dell’istituto) il prete
poté inaugurare nel 1878 la sua “casa della Providenza”, suscitando l’affetto e
l’ammirazione di tutti quelli che lo contattavano, creandosi un’aura di
semplicità, benevolenza, mitezza, ma enorme forza d’animo.
Non potendo gestire da solo il complesso istituzionale, il prete si fece
affiancare da alcune suore, che assunsero il nome di “Figlie
della piccola casa della divina Provvidenza”. Ovviamente nella casa
esisteva un locale adibito a ‘cappella privata, a solo comodo e conforto delle
ricoverate’
Dopo la morte di don Daste avvenuta il 7 feb.1899, fu deciso
dall’Amministrazione comunale accettare una lapide che si vede
tutt’ora sopra il portone, regalata da un comitato di cittadini (descritta in via G.Mameli).

Questa casa restò attiva sino al 1920, quando - sia per l’aumento delle
ragazze: nel 1925 erano 150 - sia per vantaggiosa offerta - il complesso si
trasferì nel palazzo Serra-Doria, in salita Belvedere civ.2, ove tutt’ora sono.
L’edificio - in rappiorto all’assenso cncesso per applicare la lapide sulla
facciata – si presume divenne proprietà delle signore Clotilde Pavan, Apollinia
Dellepiane, Maria Dellepiane, Maria Morasso quali comproprietariedello
stabile.
Della statua della Madonna, posta in una
nicchia nell’angolo smussato della casa – angolo Daste-Carzino - non ho
notizie; la sua presenza è segnalata dal Remondini nel 1882: poco si intravede
attraverso un vetro ed una grata, per risalire almeno ad una dedica. Sembra una
Madonna Addolorata. Si narra sia una statua scolpita per un paese dell’entroterra
e da loro rifiutata considerandola mal scolpita: ricuperata dal prete fu posta
a protezione della sua casa.
Il palazzo fu ristrutturato ad appartamenti privati, salvo una parte occupata
dal ‘Circolo cattolico G.Borsi’ (non sono sicuro si tratti di Giosuè
Borsi, Livornese 1888-1915, scrittore ed autore di opere narrative
testimonianti una sofferta conversione religiosa, le più pubblicate dopo la sua
morte in guerra) che per lungo tempo usò
per la propria sede e per un teatrino da recite filodrammatiche domenicali di
attori locali.
===civ.
8 fu finanziato a fine 1800 e poi
abitato – all’inizio per intero stabile - dal comandante Cipollina Giuseppe nato 1853 (prima stava nel
‘palazzo dell’Orologio’), grande navigatore, uno dei primi a capitanare una
nave a vapore (la ‘san Gottardo’) dopo secoli di sola vela. La fortuna
economica, raccolta in avventurosi viaggi, passò alle due figlie e via via si
disperse con i nipoti. Oggi ogni famiglia che abita l’edificio, forse nessuno
ha rapporti con il comandante (ultima, lontana parente, è stata la signora
Cordano Ester, abitante all’ultimo piano fino al 2005 circa).
===civ. 17r i Pittaluga Giovanni & Giuseppe si interessavano di
pianoforti negli anni 1950.
===civ. 19r dal 2000
è l’entrata autonoma dell’albergo Modena.
Da tanti anni si accedeva tramite l’affiancato portone civ. 3
===civ. 24r la farmacia Popolare Sociale. Compare per la prima
volta nel Pagano 1919, in via Mameli al
civ.8 e col nome “alla Cooperazione” (il nome, e la vicinanaza dell’US
Universale fanno pensare che -come i forni e negozi alimentari, la banca, le
case popolari, le sedi sportive-, fosse una dei tanti settori delle cooperative
degli operai). Nel 1933 compare sempre
eguale, facente da recapito ai medici dott. Gandolfo Peone (poi sindaco socialista negli anni
1908-15), Gandolfo Nicolò, Lanza Sebastiano, Bonanni Carlo (assessore
comunale), Roncagliolo Italo, Steneri Giovanni (ginecologo). Solo nel Pagano 1953
(ma mi manca il controllo dei precedenti: probabilmente da dopo la guerra),
compare il nome come l’attuale, in via Carzino, 26. Gli ultimi proprietari furono i
dottori Roncagliolo; Belletti (o Balletto) Luciano; dal periodo dopoguerra
Rigacci Laura, e dal 1969 l’attuale
Prato Giulio dal quale è passata alla figlia.
===
civ. 7-11r*** l’ex cinema Alessandro Volta
inaugurato nel 1909 (altri scrive 1914). Molto
piccolo, aperto solo alcuni giorni alla settimana (giovedi, sabato e domenica) fu ospitato in un palazzotto costruito apposta
come cinema forse ma
molto probabile, nel posto ove ora sta la sala da ballo.
Pare
sia rimasto aperto sino al 1917 quando per
volere di Stefano Pittaluga pioniere del cinema italiano con stabilimento anche a Torino -allora
la prima mecca della nuova arte, sorse nuovo,
nell’area attuale delledificio, usando lo spazio a fianco del primitivo (che sino ai primi anni del 1800 era
stata proprietà e giardino dei Centurione della villa del Monastero, e che veniva usata come giardino). Il
nuovo edificio, che in
quegli anni il Pittaluga possedeva in comunione con un certo Molinari, eretto su
progetto di A.Spinola, fu caratterizzato da una tipologia architettonica
definibile ‘eclettica’ (perché caratterizzata da un post-liberty strano,
modificato, ed aggiornato ai tempi della costruzione; aveva pavimento in
graniglia alla veneziana).
La
sala fu poi ristrutturata, con strutture portanti in cemento armato e tetto
calpestabile; ingrandita, migliorata a teatro, e chiamata come la strada che lo
ospitava ‘cinema Mameli’ definito grazioso, con un bel
vestibolo, senza alcun segno d’arte escluso sulla facciata esterna ove erano ai
lati due ‘evanescenti scolpite figure muliebri’; come teatro, ospitò compagnie
di rivista famose, quali vengono ricordate anteguerra di Petrolini e Bambi.
Tale rimase negli anni del dopoguerra 40-45 ,
con rappresentazioni di avanspettacolo (personalmente ricordo solo Rascel e
Dapporto, ma tanti altri devono aver calcato quelle scene), fino a quando
divenne nel 1961 il “cinema Astoria“. Rimodernato del 1974,
in cui fu tolto il
palcoscenico, nel 1989
–di proprietà Pozzo e Calcagno, fu gestito da Renzo Calcagno; classificato di
seconda categoria; con 740 posti a sedere, dei quali 580 in platea e 160 in
galleria; poltroncine in legno e rivestimento in sky; impianto monofonico;
aspiratore; proiettore da 35mm.
Infine
dal 1990 circa ad ora, è sede di un supermercato.
===
13r : nei fondi del cinema è ospitata una sala che inizialmente venne usata
quale ‘accademia di biliardo Diana’; poi fu trasformata nella discoteca ‘Boomerang’
prevalentemente indirizzata ai giovani; dal 1990 col nome ‘il Coccodrillo’
vi viene suonata sempre ad indirizzo giovanile musica che spazia dal reggae ed
afro, alla sud americana, al rock. Prima del 2000 la discoteca si chiamava ‘Fabrika’
il cui nome scritto trasgressivo la dice sul fatto che il locale era meta
frequente della polizia per risse ed anche accoltellamenti. In quell’anno
cambiò gestione divenendo ‘il Tempio’ nome che ha sostituito il
precedente anche puntando su balli moderati come il liscio e sulla presenza dei
giovanissimi. A luglio 2002 sopra l’ingresso è il nome ‘VIRGO’, che
tutto dice sulle intenzioni parrocchiali degli attuali imprenditori.
===33r nel periodo dopoguerra
’45, vi era il negozio “Foto Impero”, tel. 43 321, sviluppo, stampa, ingrandimenti.
DEDICATA al
partigiano sampierdarenese nato l’11 ott.1899, anno reso famoso perchè ultima leva di richiamo
militare nella grande guerra. Fin da
giovanissimo fu iscritto al partito repubblicano e, quando subentrò il fascismo
ne divenne immediato acerrimo nemico, iniziando con propaganda e cospirazione
(sia quando era operaio alla SIAC (a Campi), che poi quando alla FIAT a Torino,
ove faceva parte nel periodo bellico del lug.1943 della commissione interna).
Dopo l’8 settembre, scelse far parte delle SAP, divenendo prezioso elemento
nell’organizzazione della 4.a brigata Mazzini. Individuato per delazione,
dovette fuggire in montagna, ove divenne attivo col nome di battaglia “Milio”,
dapprima nelle Langhe e successivamente nella VI zona, controllata dalla
brigata garibaldina Cichero.
Durante
un rastrellamento nella Fontanabuona compiuta dalla Wehrmacht e dagli alpini
della Monterosa, in località Centonoci, vicino a Favale di Màlvaro (Ge), venne
colpito mortalmente il 22 dic.1944 assieme ad altri 5 partigiani, mentre tentò
una sortita da un casone dove si erano trovati circondati (un sesto compagno
fu solo ferito).
Gli
fu conferita la medaglia di bronzo al V.M., alla memoria.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio S.Com.
Toponomastica - scheda 922
-A.sconosciuto-Dattiloscritto
parrocchia s.Gaetano-s.G.Bosco-pag.341
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.391—ed./02-pag.429
-AA.VV.-Contributo di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1997-pag.65foto.148
-AA.VV.-Il Mutuo
Soccorso-Istit.Mazziniano.1999-pag.109.110.367
-AA.VV.-Mutualismo e
solidarietà-Reg.Liguria.2001.pag.27.110
-AA.VV.-Strutture dello
spettacolo-Regione Liguria-PCGG 1989-pag.100
-Balletti.Giontoni-Una città
fra due guerre-DeFerrari.1990-pag.11foto
-Bettinotti M.-Vent’anni di
movimento operaio..-ANS.1932-
-Bottaro.Paternostro-Storia
del teatro a Genova-Esagraph1982-pag.162-3
-Cereseto E-La ‘Casa
Littoria’ del Fascio Secondogenito-Unico1933 (XII)
-Costa E.-Valentino
Armirotti-Quad.Ist.Mazziniano.2001-pag.180
-Costa E.&Fiaschini G.-Oltre
il confine-Sabatelli.2003-pag.153
-DeLandolina
CG-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.22
-Doria G.-Investim.e
sviluppo econom. a Ge.-vol.II-Giuffrè.1973-pag.748
-Ferrari G.B.-Capitani di
mare e bastmenti-Tigullio.1939-pag.143
-Fiaschini&Icardi-Società
operaie e cooperative in Li.-Sabatelli2005-pag.15
-Gazzettino
S.: 6/73.4 +
2/75.3 + 6/75.10foto + 7/76.5 + 8/78.3 + 9/78.8 + 4/80.9 +
5/80.9 + 7/80.7 + 9/80.7 + 10/80.13 + 2/81.12 + 7/82.3 + 1/87.12
+ 1/88.12 + 3/90.2 + 9/90.8 + 9/91.22 +
-Gimelli
G.-Cronache militari della Resistenza-Carige.1985-vol.II-pag.162
-Il
Giornale quotidiano del 3.6.88
-Il
SecoloXIX del 04.09.05 + 16.06.09 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002-pag.46
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.54
-Miscio
A.-La seconda Valdocco- Elledici.2002-vol.I-pag.105
-Morabito.Costa-Universo
della solidarietà-Priamar.’95-pag. 333.369.390
-Pagano/1933-pag.1091---/1950-pag.233.674.---/1961-pag.445.588.1136
-Pansa
GP-Il sangue dei vinti-Sperling&Kupfer.2003-pag.170
-Pastorino
P.-Viaggio sentimentale nella GGenova-DeFerrari2007-pag.79
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.’85-66foto.368
-Poleggi
E. &C-Atlante di genova-Marsilio.1995-tav.34
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-226.233
-Remondini
A &M -Parrocchie dell’archidiocesi di Ge.-vol.11.1897.p.73
-Rivista
Municipale Genova : 9/33.796 + 11/33.941
-Roscelli
D.-Nicolò Barabino-Soc.Universale.1982-pag.216foto
-Simonelli N.-Giacomo
Buranello-DeFerrari.2002- pag.104
-Stradario del Comune di
Genova, edizione 1953-pag.43
-Tuvo T.-SPd’Arena come
eravamo-Mondani.1983-pag.38foto
-Tuvo&Campagnol-Storia
di Sampierdarena.D’Amore.1975-pag.240-249foto
-Zanolla V.-Genova capitale
dell’hockey-LaCasana 2/09-pag.43
CASSINI via Gian
Domenico Cassini
TARGHE:
via Gian Domenico Cassini –
astronomo – 1625-1712 – già via Manin

 angolo piazza N.Barabino
angolo piazza N.Barabino
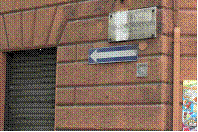
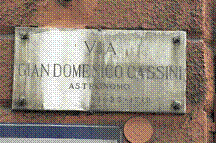 angolo via L.Dottesio
angolo via L.Dottesio
QUARTIERE
ANTICO: Coscia
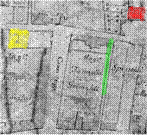 da MVinzoni, 1757. In giallo la Fortezza; rosso villa del
duca Spinola
da MVinzoni, 1757. In giallo la Fortezza; rosso villa del
duca Spinola
N° IMMATRICOLAZIONE:
2747 CATEGORIA 2
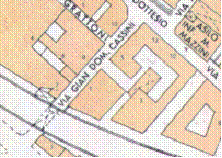

Dal
Pagano/1961 Da Google
Earth 2007
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 13900
UNITÀ URBAMISTICA:
18 - s.BARTOLOMEO
CAP: 16149
PARROCCHIA:
s.Maria delle Grazie
STORIA: non si
conosce perché all’origine si chiamasse “crosa delle Catene“; ma
poiché tutta la zona fino al 1850 costituiva un quartiere (o ‘regione’) pure
lui chiamato ‘Catene’ (confinante
ad est con quello della Coscia ed a ovest con quello di Crosa Larga; e compreso
tra il fossato della Crocetta di N.S.della Vista ed il fossato di san
Bartolomeo), si può pensare che ambedue
traessero il nome dallo stesso motivo. Unica interpretazione è desunta
dall’esistenza della villa Spinola san Pietro, che fu costruita al di
sopra della strada principale (allora detta semplicemente ‘comunale’, oggi via L.Dottesio) sulla quale si apriva con un bel giardino
antistante ed un grosso portale; ma la proprietà terriera si estendeva
prevalentemente oltre la strada, sino al mare. Questo vasto appezzamento di
terreno, possedeva al centro una strada diritta che arrivava appunto sino alla
spiaggia; e per impedire che questa stradina fosse di pubblico uso, soprattutto
il transito dei carri di privati - essendo coltivata ad orti, vigneti e
frutteti di prima qualità -, fu chiusa agli estremi con una catena.
Evidentemente - nella fantasia popolare - faceva più notizia la presenza di
questo sbarramento che la suntuosa villa soprastante.
Potrebbe essere legato al nome di una famiglia Catena (come:
via Bombrini o Ballaydier o DeMarini), ma appare improbabile visto che anche
W.Piastra.pag.135 del Dizionario Biografico non ne cita alcuna ligure con
questo nome; non so dove Gri1lo-pag.309 l’abbia trovata per includerla nei nomi
di persona.
Nel 1843, alla pianificazione della ferrovia che avrebbe tagliato
trasversalmente tutti gli orti, i terreni degli Spinola cambiarono
proprietario; rispetto la stradina centrale: quelli a ponente (estesi sino al fossato della
Crocetta di N.S. della Vista) appaiono
dei fratelli Derchi fu Antonio (sig. Giuseppe e sac. Emanuele, con un pozzo e la casa (o baracca) di Casanova Francesco al limite verso il mare); quelli a levante (sino al confine con la proprietà dei march. f.lli Pallavicino fu
Domenico) di proprietà delle sig.re
Gioannina Cambiaso e Geronima Carlotta sposata con l’avv. Cambiaso Carlo.
In contemporanea - l’apertura della piazza N.Barabino - le mozzò il tratto
finale verso il mare.
Alla fine 1800-inizi 1900, venduti gli orti, la stradina appare già divenuta
autonoma ed edificata con case erette nei bordi degli ex orti. Le venne dato
dal Comune un nome ufficiale, dedicandola al patriota veneziano, ma non come
via, ma come “piazza Manin, da via Vittorio Emanuele“ (ma probabilmente però potrebbe
essere un errore del Novella); vi avevano casa dei Danovaro, Pittaluga, Timone, Carbone, Sanguineti, Bertorello (con ‘magazzeno scoperto’), G.De Andreis e Giacomo Casanova (forse figlio del Francesco su descritto; vedi anche sotto).
Un “Piano d’ornato e di abbellimento del paese”, quale primitivo tentativo di
Piano Regolatore stilato
dall’arch. Angelo Scaniglia durante l’amministrazione GB Tubino nel 1852 circa, fu messo in atto trent’anni dopo. Quindi nel 1880
circa, tra le altre cose, fu ampliata questa strada che –popolarmente- veniva
chiamata anche “strada NS della Vista”
in quanto conduceva alla cappelletta omonima (vedi via Dottesio)
Nel 1910 divenne (o
lo era già da prima ma non in forma ufficiale) via Manin, e possedeva civici
fino al 4 e 9.
Divenne invece “via Daniele Manin” nel 1933
(quando via
Dottesio era ancora via De Marini) .
Fu cambiata la titolazione nel nome attuale con delibera del podestà, il 19
ago.1935, trovandosi
p.za Manin ora a Castelletto, nel riordinamento delle vie della Grande Genova ,
onde evitare doppioni.
Il Pagano/40
descrive: ‘da piazza
N.Barabino a via Dottesio’; al 6 nero la SAG De Andreis G. casanova, lavor.
Latta’; nei rossi al 15 la farmacia Bassano ed al 28 Montecuicco G. vini.
STRUTTURA: strada
comunale carrabile, senso unico viario da via L.Dottesio a piazza N.Barabino
compreso il sottopasso ferroviario.
Civici
neri fino al 5 ed il 10; rossi fino al 27 e 26. Lunga 100,96 metri, larga 4,45;
ha due marciapiedi larghi 1,37.
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera


CIVICI
2007= NERI = da 1 a
5
2
10 (mancano 2 e 6)
ROSSI = da 1 a 27 (compresi
1A→D, 3ABC, 5A,7A,9A)
2 30
(compresi 12 da A→F e N)
===civ.1: Nel 1950 vi
aveva sede la ‘I.E.G.’ imprese elettriche generali, produttrice e distributrice
di elettricità. Fu demolito nel 1953 e ricostruito nello stesso anno
===civ. 2 e 6:
furono soppressi nel febb.1970, perché demoliti.
===civ.3 anche esso, decorato a mascheroni dello
stile tardi liberty, dava adito a qualche fabbrica, visto le finestre tipiche
dell’uso, al primo piano. Ora è adibito ad abitazioni. In tutta la
facciata, sono due accessi affiancati che furono decorati con mascheroni e
decorazioni, riuniti sotto una figura geometrica semiellittica: depongono per
una costruzione dell’inizio secolo 1900. La decorazione però non ha
nessun’altra attinenza con la restante facciata, lasciando presupporre o una
personalizzata diversificazione di un negozio; o un portone decorato dopo da
solo, in edificio abitativo inizialmente ideato con due portoni; o un edificio
completato posteriormente ma rimasto senza i mezzi finanziari per completare la
decorazione.


civ. 3
la facciata del palazzo De Andreis con scritta
===civ.
5 al primo piano erano ambulatori medici, di proprietà – dal 1970, comprati
da Giuseppina Bertorello- della farmacia Bassano.
===Al
6 abitavano (vedi sopra) ed
avevano sede la “soc.an. Esercizio stabilimenti riuniti DeAndreis-Casanova” fabbrica,
lavorazione e litografia della latta per inscatolamento e conservazione di
pesci e conserve alimentari. Alla prima esposizione internazionale realizzata
in Italia, a Milano nel 1906 (in
occasione dell’apertura della galleria del Sempione), l’azienda DeAndreis fu presente nel padiglione San
Pier d’Arena: ebbe onori e particolare attenzione per lo stile geniale della
sua arte litografica, dai colori vivaci e disegni di stile liberty riportati
sia sulla latta che su barattoli portamercanzie. Nel 1933 era ancora una delle
12 esistenti in città ma con produzione cos’ dimunuita che fu costretta quasi a
chiudere; comunque nel 1950 era una delle 13 ancora presente sul mercato. Lo
stabilimento rimane dietro –a ponente- la fila di case che aggettano sulla
strada, e nel 2005 appare ben ristrutturato:
alto 5 piani, con conservate due ciminiere e con –sulla facciata- la grossa
insegna in muratura). I De Andreis abitavano in via G.Carducci (poi A.Cantore
ove oggi il civ. 11) nell’angolo con via s.Bartolomeo del Fossato, in una
villetta immersa tra gli alberi; presupponiamo quando nel 1935 fu costruito il
piazzale dell’autostrada (che costrinse a spostare il piazzale verso ovest con
invasione dell’antica strada e del fossato verso ponente (vedi ‘Camionale’)).


davanti al campanile le due ciminiere della ex-fabbrica;
fabbrica de Andreis vista
alla sua destra il tetto bianco di villa Spinola
dal treno
===civ.4r nel 1941
esercitava la cartoleria-tipografia dei fratelli (uno era Oreste) Palmieri
fu R.
===civ.5r la sede di
una “chiesa cristiana evangelica”
===civ
8: palazzo dell’inizio 1900 di cui
non si conosce l’architetto né la data di costruzione: la decorazione fu
impostata usando elementi tardo liberty, più moderni, tipizzati da cornici
curvilinee sopra le finestre, abbellite ed ingentilite da cordoni floreali .
===civ.12:
il negozio di ferramenta Storace, che viene
catalogato tra le botteghe storiche cittadine: l’apertura risale al 1922 e
conserva i primitivi arredi degli anni 30: scaffali a muro con cassetti in
legno, bancone rifasciato, bilancia in legno della ditta Grasso (antica ditta genovese, famosa per la
precisione dei suoi attrezzi).
===civ.12r: L’antica
entrata nello stabilimento DeAndreis che si apre ancor ora dietro la fila delle
case; ha ospitato per anni la soc. DEPA, che
vendeva pezzi di cicambio di auto (ora trasferita in via Carpaneto). Al posto di quest’ultima nel 2004-7 esiste un silos auto di due piani, escluso il piano terra a
mare che è occupato dalla soc. Gynnastic Club
trasformata in negozio (12E rosso).
Nel
retro dell’edificio, quindi a ponente di esso, uno stretto corridoio lo separa
dal retro delle casupole presenti al civ.5 di via Palazzo della Fortezza;
strada raggiungibile anche da una rientranza affiancata alla ferrovia, chiusa
da cancello.
===civ. 12Cr una
targa segnala la sede del “Monstre Club”.
===civ. 14-16r il
bar, che nel 1950 era di Biancardi V.
=== civ. 26r-30r:
antica osteria Tubino, attuale bar. In una città che ha sempre manifestato
“voglia teatrale autonoma”, la bottiglieria ospitò dal 1922 per una trentina
d’anni la prima discoteca locale: una sala chiamata Auditorio Montecucco (di Montecucco Giacomo, nato
a Cassano Spinola, e residente a Genova dal 1920).
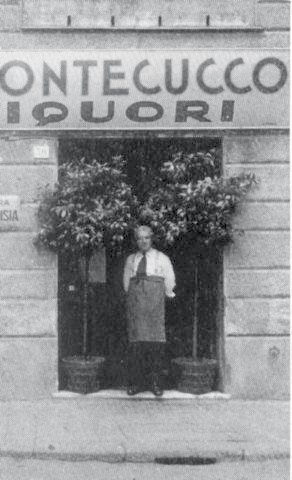
Questo personaggio, grande entusiasta
amante della musica classica lirica e sinfonica, era conosciuto nel mondo di
quest’arte; amico di grandi autori e di cantanti con i quali si ritraeva in
foto con dedica appese alle pareti del locale, aveva raccolto più di 12mila
dischi, arricchendo ed aggiornando continuamente la collezione con acquisti in
tutto il mondo, specie tramite le navi dagli Usa, raccogliendo la migliore
produzione mondiale, sia in senso tecnico che artistico (i dischi erano ancora quelli a 78 giri, letti dal grammofono con una puntina di acciaio, da
doversi cambiare praticamente ad ogni suonata per non rovinare il solco rappresentavano,
praticamente
tutte le romanze, sonate, pezzi d’opera conosciuti, e cantati o suonati dai più
diversi artisti; alcuni di essi erano
autentici gioielli di rarità ed antiquariato: sui giornali venne definito
‘l’apostolo del disco’; ed il locale ‘l’antro armonioso’, ’il regno di
Euterpe’, ’l’osteria musicale’ divenne meta di visita dei più quotati artisti
lirici in tournée a Genova). Così, nella saletta lunga e stretta ancor
oggi esistente, con una passatoia centrale ed i tavolini rotondi disposti ai
lati in un ipotetico loggione di sedie sparse, ospitava all’ascolto la
popolazione e gli artisti, in quell’epoca in cui il grammofono non era ancora
un bene comune e l’audizione risultava l’unico svago lirico per tanti
sampierdarenesi: serate dedicate ad un cantante, o ad un compositore, o ad un
periodo musicale, con la migliore riproduzione, attraverso un complesso di
strumenti ancora regolato dalle valvole. Il titolare fu insignito di medaglia
d’oro, quale benemerito della cultura musicale genovese. Cessò la sua attività
nel 1961 per ‘raggiunti limiti di età’, dopo 41 anni di lavoro nello stesso
locale; tutto il materiale fu trasferito nell’abitazione in piazza N.Barabino
civ. 10 ove offrì agli amici ed intimi i suoi concerti fino al decesso avvenuto
nel 1972.
Nel campo della musica, Genova
vantava in quei tempi il singolare primato di possedere le più ricche
discoteche d’Italia (degli Zillichen, Gambino,
Pittaluga); ma l’unica di cui potevano goderne tutti solo degustando
del buon vino od un caffè serviti nell‘ “intervallo”, e quindi la più
conosciuta ed amata era quella del Montecucco, ove il buon Giacomo “eseguiva”
un concerto e faceva gustare la voce di Caruso o di Schipa, regolarmente due
volte alla settimana, con autentica professionalità artistica e culturale .
===civ. 15r.
Sull’angolo del palazzo con via Dottesio, un insolito e caratteristico bassorilievo rappresenta in un ovale centrale (con
due larghe bande laterali a cartiglio) una figura femminile, drappeggiata,
con le braccia avvolte dalle spire di una serpe e reggente in mano una coppa;
elementi simbolici-decorativi e di richiamo della vicina antichissima farmacia Bassano:
è quindi una insegna pubblicitaria, tipica della fine dell’800. Facile
l’attribuzione ad Ave Bassano, scultore e probabile parente del farmacista;
anche se dal Pagano emerge l’esistenza di un altro Bassano, Luigi, scultore
pure lui, residente nella strada.
Molto
antico anche questo negozio, che si fa risalire al 1898. Prima di rinnovare
tutto l’interno, era gestito negli anni attorno al 1933 (la strada allora si chiamava via Manin) dal
dott. Bassano GB (con
il cui nome ancora nell’anno 2003 viene normalmente chiamata) ma che dal 19 dic.1951 era stata venduta al dr. Carlo
Perasso (27.2.1911--9.12.1985) e rimase a lungo arredato con i mobili antichi,
molto belli e caratteristici ma obsoleti ed inadeguati.
=== civ.*** il
negozio di ottica-fotografia apparteneva a Zino Claudio, un valente sportivo
figlio e fratello di sportivi sampierdarenesi.
===civ. ha per
tanti anni ospitato una grande impresa di forniture per auto, chiamata DEPA,
dal 2000 trasferita in via GB Carpaneto.
Popolarmente
nella strada vengono ricordati sia una tipografia Palmieri; sia il
negozio di rivendita di granaglie il cui proprietario fu organizzatore di una società
sciistica locale chiamata (anni 1970) 3G; sia dell’abitazione di una Serafina che per il
figlio, chiamato Checco u panetté: a quei tempi in cui non esisteva
l’illuminazione civica, per il suo rientro che lavorava di notte, lasciava un
lume acceso indicativo di dov’era la casa; ne nacquero le prime rime di un
modesto ritornello popolare cantato da un chansonnier locale (“o Baccicin
vattene a cà, te moae a t’aspeta, e t’a lasciou o lumme in ta scaa, e a porta
averta…”), che poi il famoso cantante Mario Cappello assieme ad Attilio
Margotti (quelli del ‘Ma se ghe penso’) completarono in una canzoncina che
divenne assai famosa e che inizia appunto con quelle parole.
DEDICATA all’astronomo
imperiese, nato a Perinaldo, Ventimiglia (allora compreso nella contea di Nizza; ora nella valle
Crosia della provincia di Imperia; a 572 m. slm, primo contrafforte delle Alpi
Marittime salendo da Bordighera. C’è casa con lapide, biblioteca e museo di
strumenti astronomici: Michero sottolinea che la chiesa romanica dedica a alla
Madonna del Poggio Reale è stata collocata sul punto di passaggio del meridiano), il 8 giugno 1625 da Giacomo (aver dato al figlio la possibilità
di studiare, significa che non era di umile origine; in più, abitando in una
casa con cinquanta stanze; presumibilmente corrisponde ad un gentiluomo locale
– nobile quindi - dipendente dal marchesato di Dolceacqua) e da Giulia Crovesi, primogenito di nove (otto, scrive Michero) fratelli.
Uno
zio materno, gesuita e dilettante astronomo, curò le sue prime e precossime capacità
culturali, soprattutto - a quell’età - quelle poetiche (in latino: pubblicò nel 1646,
a 21 anni una raccolta di poesie latine: faceva parte dell’insegnamento di
allora, esprimersi in versi e, per i colti, nell’antica lingua).
Quindicenne,
venne inviato – come
consuetudine tra i nobili della riviera -
a studiare a Genova, presso i Gesuiti, ove insegnavano teologia, etica, diritto
civile; ma lui amando preferibilmente la poesia e l’astrologia, e – di quest’ultima - specie quella
mirata alla giustizia ed all’arte indiziaria o divinatrice (essa era una
scienza ‘in espansione’ il cui abuso portò a interpretazioni assurde. Un
anatema fu lanciato anche da Pico della Mirandola, dichiarandola “falsa
scienza”, perché era arrivata a pretendere di divinare il futuro degli uomini
con precisi oroscopi. Queste controversie fermarono gli iniziali ardori del
giovane verso questa disciplina, che però tanto lo appassionava: gli astrologi
erano assai spesso interpellati alla stregua degli antichi oracoli capaci di
predire il futuro attraverso il movimento degli astri).
Conclusi
gli studi venticinquenne, nel 1650, fu proprio in quella veste, di matematico, geometra ed astronomo, che gli venne proposto di
trasferirsi a Bologna, allora città seconda solo a Roma per cultura e abitanti; due avvenimenti vengono narrati come decisivi per questo trasferimento:
(fonte
a)= ‘sponsorizzato’ dal marchese Cornelio Malvasia (1603-1644; anche lui infatuato astrologo; senatore bolognese; generale
d’artiglieria; possessore di un castello a Panzano presso Modena, circondato a
180 ubertosi poderi. Egli
lo aveva conosciuto nel 1648 quando il Nostro aveva appena 23 anni, e ne aveva intuito
la genialità: lo aveva voluto includere nella propria specola, confermando così
sia il primo istintivo giudizio).
(fonte
b)= era stato interpellato per predire come sarebbe finita la guerra tra il
papa (Innocenzo X) ed il duca di Parma Ranuccio II Farnese: lui predì che il comandante le
truppe pontificie – il genovese Ottaviano Solio – avrebbe vinto: e così avvenne
generando ammirazione e consensi.
Il
Senato bolognese accettò la sua immissione nella prestigiosa università.
(prima vera università italiana ed allora, la migliore del
mondo; in particolare il Cassini fu interessato agli scritti di Pico della
Mirandola il quale aveva scritto un trattato ’Contra astrologos’ che servì a
ridimensionare i suoi ardori in materia divinatoria, dando invece un indirizzo
più scientifico alle sue ricerche astronomiche.
Quindi,
riavvicinato agli studi di astronomia, fu così prolifico che l’anno dopo 1651,
il Senato di quella città gli affidò anche l’incarico universitario, prima, di
astronomia (detta cattedra
universitaria era divenuta vacante per la morte del famoso padre Bonaventura
Cavalieri (1598?-1647), alunno di Benedetto Castelli, a sua volta allievo di
Galilei; copernicano quindi, che aveva dettato le basi del calcolo
infinitesimale). poi dall’anno dopo
anche di matematica in quanto, assieme al Malvasia, aveva studiato
una cometa.
Nel valutare il suo lavoro, non dobbiamo dimenticare da
quali basi esso iniziò: i mezzi erano primitivi ed artigianali; più che
cognizioni comuni, molte erano geniali intuizioni personali; non da poco come
ostacolo, era l’Inquisizione, pragmatica nelle sue decisioni. Il fatto che nella sua vita non ebbe
guai (come invece Galilei), lo dovette sia alla sua indubbia ed innata capacità
diplomatica, ma sopratutto all’aver espresso le sue idee mai discostandosi
ufficialmente dalla concezione in atto, specie riguardo il sistema solare (Copernicano).
Come docente universitario, si protrasse per 61 anni,
escluso l’anno 1665-6).
Tra
i suoi primi lavori, si ricordano una opzione diplomatica tra Bologna e
Ferrara circa lo sfruttamento del Po (leggi sotto); il
progetto di risanamento dei terreni paludosi attorno al fiume Reno; il
perfezionamento della meridiana (o meglio, eliometro)
tra i colonnati della basilica di san Petronio durante il suo ampliamento (migliorò el 1655 la meridiana che
era già stata tracciata nel 1575 dal domenicano Egnazio Danti, 1536-1586,
matematico del granduca di Toscana, predecessore di Cassini. Il Nostro la
perfezionò ampliandola e ricorrendo ad artifici ingegnosi come far passare i
raggi solari da un foro rotondo nel tetto permettendo la lettura tutto l’anno. Risolvette
un grande dilemma dell’astronomia di allora, il presunto ma non dimostrato
rallentamento del sole d’estate (ché dura di più) ed il suo ingrandimento di
diametro. Per due secoli permise ai bolognesi di conoscere l’ora; e regolare su
essa il loro tempo); numerose perizie
di questioni idrauliche (come
nel 1656 il corso del fiume dell’Emilia-Romagna Reno, di 210 km.; la
navigazione sulle acque del Chiana e del Po in qualità di Sovrintendente
Generale delle Acque, da meritarsi gli elogi pure del Papa interessato alla
disputa tra Bologna e Ferrara; in seguito gli affidò altri impegni sui corsi
d’acqua e fortificazioni nello stato pontificio); studi di
entomologia, sulla riproduzione degli insetti (mentre era in trasferta per i corsi d’acqua, notò e
studiò gli imenotteri presenti nelle galle delle querce; allora si reputavano, dai
tempi di Aristotele, spontanei e non soggetti a metamorfosi. Cassini affermò
che gli insetti non si generano dalla putredine dei tessuti ma da un uovo, e
che poi subisce una trasformazione. Il concetto sarà ripreso poi ufficialmente
da entomologi qualificati come Redi); sulla trasfusione
del sangue (di cui fu pioniere-scopritore; il
primato in Italia è attribuito a Geminiano Montanari nel 1667 in casa di
Cassini; quest’ultimo riprese gli esperimenti usando due agnelli, coronati da
consolanti successi –e dalle sue lettere spedite ad altri studiosi su questi
esperimenti, si rilevano date anteriori a quelle del Montanari-); sulla costruzione di fortezze (nel 1663 ebbe da Alessandro VII la sovrintendenza
del fortilizio ‘Urbano’ (da Urbano III) a nordest di Castelfranco Emilia, uno
dei più poderosi e temuti dell’epoca; lo stesso a Perugia).
Dedito soprattutto agli studi astronomici, perfezionò le tavole solari;
misurò la parallasse del sole (problema ritenuto impossibile da Keplero e Bovillard); scoprì la rotazione (allora chiamata vertigine) di Marte, Venere e Giove (editò un libro nel 1668, sul frutto
delle sue osservazioni, titolato “Le effemeridi dei satelliti di Giove”: per il
solo pianeta Giove poi, il quotidiano controllo della posizione delle sue
macchie fecero intuire la rotazione; e l’ombra dei satelliti fece definire il
tempo di rotazione in 9h, 56’); scrisse
un trattato su una cometa apparsa nel 1652 e seguita a Modena, e dei
giudizi sul calendario indiano. Si dilettò pure di umanistica, poesia
latina e volgare; di fossili.
Gli epistolari scientifici dimostrano come il nome di Cassini fosse noto universalmente
al di qua ed al di là delle Alpi: allora era già membro della Royal Society di
Londra e dell’Académie des Sciences di Parigi (nata nel 1666 per ordine dato dal re Sole, Luigi XIV su suggerimento del
primo ministro JeanBaptiste
Colbert (controllore generale alla corte di
Luigi XIV, il Re Sole).
Questi, era stato suggerito a sua volta dall’astronomo Picard. Tanti erano i
pensatori invitati dall’Académie: Pascal, Racine, Molière, Fenelon. Prima di
‘assumere’ Cassini, che allora aveva 40 anni e da 15 insegnava a Bologna, lo
usò, dapprima, come socio corrispondente e poi nominò membro dell’Académie, volendolo
fisso a Parigi. Allo scopo, Colbert usò astuzia per non contrastarsi col Papa
Alessandro VII Chigi – e dopo il giu.1667, con Clemente IX Rospigliosi - che
volevano il Nostro a Roma: nel 1669
Colbert lo chiamò come diplomatico “in missione temporanea” per la quale ebbe
l’assenso del Papa stesso e del Senato bolognese; una volta a Parigi gli offrì
servigi tali per i quali quello se ne restò in Francia di ... sua volontà. E quest’ultima è verità, in quanto
fu usato in senso inverso: venne in Italia per missioni temporanee, ma sempre
se ne tornò a Parigi).
Infatti una volta a Parigi, le circostanze favorirono che il breve periodo si
trasformasse in definitivo, sia perché, colmato di onori e di cospicuo
stipendio, allora valutato in livres,
assunse nel 1673 la cittadinanza francese (anche se tutte le sue successive scoperte furono
descritte in italiano e latino; sempre ebbe difficoltà col francese) ed anche perché nello stesso anno sposò Geneviève
Delaître, ricca proprietaria di vasti beni a Thury.
Una volta divenuto ‘francese per sempre’ (ma parlava pressoché sempre in italiano, ma scriveva e
relazionava in latino), fu
organizzatore-fondatore del nuovo Osservatorio parigino, costruito
secondo i suoi suggerimenti (e del quale il titolo di ‘direttore’ lo ebbero
solo i discendenti): dotato di apparecchiature prodotte in Italia (con non poche polemiche con gli
invidiosi locali); con esso scoprì la
divisione in due parti, separate da uno spazio scuro oggi chiamato ‘divisione
di Cassini’ costituita da una nube, dell’anello di Saturno (che da allora porta il suo nome) e la presenza di altri tre satelliti (che chiamò “ludovici” in onore al
Re Sole: Dione, Rhea, Giapeto; il primo, Tethis, era già stato segnalato da
Huygens nel 1655. Oggi sappiamo che in totale sono 9).
Divenne Accademico di Francia, fu frequentemente ricevuto a corte, ricevette
numerosi riconoscimenti ed onori, stimato come amico e consigliere del re il
quale fece coniare una moneta con l’effige dello studioso e la scritta “Saturni
satellites primum cogniti”.
Nel proseguio, altrettanto grandi risultati furono (collaborando con un suo assistente
inviato a Caienna a 10mila km di distanza)
la determinazione precisa della distanza tra la terra e Marte (il che permise conoscere subito le
dimensioni delle orbite di tutti i pianeti) e tra terra-sole; la misura dell’arco di meridiano che passa per la
Specola di Parigi (il
“meridiano di Francia”); le leggi della
rotazione lunare; la spiegazione scientifica del fenomeno della luce zodiacale (1683); il completamento di una meridiana parigina (iniziata da altri 15 anni dopo
quella sua bolognese, e mai completata).
Scrisse numerose relazioni accademiche durante il
soggiorno parigino, su numerosi rilievi astronomici, edite nelle “mémoires de
l’Accadémie des sciences de Paris” che furono pubblicate postume, ed un libro
di Memorie per la storia delle scienze .
La Francia per merito suo imparò la costruzione dei pozzi -come in arte
a Modena da secoli-, ma universalmente conosciuti col nome di ‘artesiani’ come
se fossero nati nella regione di Artois.
Nel 1695 tornò in Italia col figlio Giacomo suo assistente, visitando Perinaldo
e Bologna (ove ‘avevano
bisogno di lui’ per la meridiana, perché nel frattempo era stata abbassata la
volta, chiuso il foro sul soffitto e falsato il livello del pavimento. Il pontefice
Clemente XI Albani lo incaricò di fornire alla ‘Congregazione del Calendario’ i
dati necessari a revisionare la riforma gregoriana per l’anno 1700: detta
riforma prevedeva per quell’anno l’annullamento del 29 febbraio; e la data
precisa era indispensabile per datare la Pasqua e le altre feste mobili. Per
l’occasione Cassini si era portato dietro il nipote Giacomo Filippo Maraldi,
figlio di Angela Caterina, sorella di GDomenico, e quindi anche lui di
Perinaldo, e così bravo da essere chiamato a Parigi, allievo e astronomo dello
zio).
In vecchiaia -come Galilei- soffrì di irreparabile perdita progressiva della
vista, senza però perdere la grinta della ricerca e della conversazione (in
francese, latino, italiano).
Morì praticamente cieco, ultra ottasettenne, a Parigi, il 14 settembre 1712
(alcune fonti dicono
apr., altre nov.).
Suoi errori scientifici comprendono l’aver negato
una legge sulla gravità dei corpi (l’errore nacque dall’aver determinato, si
chiama geodesia, la “grande meridiana di Francia” triangolando il territorio da
Dunkerque a Perpignan; e su questi dati aver stilato nel 1668 la “carta
Cassini”. Quest’ultima forniva valori, consacrati per buoni, che impedirono per
dieci anni a Newton di formulare la sua legge sulla gravitazione perché “non
gli concordavano i dati”. La verità fu accertata nel 1735 quando la
triangolazione fu effettuata ai due poli (Perù e Lapponia), accertando che la
terra è ‘schiacciata’ – mentre per Cassini, per effetto centrifugo, doveva
essere allungata – con ragione di Newton, anche se postuma per entrambi. Nonché
la natura delle comete tanto studiate, considerate pianeti.
Come omaggio allo scienziato, Parigi gli ha dedicato una
grande strada, e sia Sanremo (nel 1860) e poi Genova (dal 1923) gli intitolarono i rispettivi licei.
Suo figlio Giacomo
(nato a Parigi nel 1677
e morto a Thury nel 1756: col padre prolungò la misurazione del meridiano da
Parigi a Canigou e poi sino a Dunkerque, sostituendolo nella direzione
dell’osservatorio); il
nipote Cesare Francesco (nato a Thury nel 1714 e morto nel
1784, iniziò una completa descrizione topografica della Francia,
che fu completata da suo figlio omonimo del Nostro); il pronipote Gian Domenico (1747-1845, pure lui divenuto
direttore dell’osservatorio; durante la rivoluzione fu imprigionato e privato
di ogni incarico pubblico perchè legato alla monarchia, ma Napoleone lo
reintegrò nominandolo senatore e conte),
tutti seguirono la sua
scienza e divennero valenti astronomi e geodeti nell’università parigina,
proseguendo ed arricchendo le conoscenze aperte dall’avo, e formando la gloria
della locale Accademia delle Scienze. La famiglia si estinse con Alessandro (figlio di G.Domenico, 1784-1832 ,
che si dedicò alla botanica divenendo anche magistrato e pari di Francia).
Dai primi anni del 1990, a Perinaldo di Imperia (capitale
degli astrofili), l’Osservatorio è intitolato a G.D.Cassini. Da esso viene
seguita attentamente la sorte della sonda sottoscritta.
Il 6 ottobre 1997 fu lanciata verso Saturno la sonda
Cassini; regolarmente c’è arrivato ai primi di luglio 2004 entrandoci dapprima
in orbita e poi rilasciando il modulo Huygens che è sceso sul satellite Titano.
I rilievi dati dal modulo (passando vicino a Giove e Venere ha chiarito di esse
situazioni a volte sconosciute e ritenute l’oopoisto) hanno chiarito la natura
degli anelli composti dal 99% da acqua ghiacciata in continuo ondeggiamento ed
‘inquinata’ da uno strano smog (ghiaccio nero) in un ambente a meno 90 sotto
zero.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toiponomastica scheda 969
-A.sconosc.-Uomini
d’arte e scienza a Sanremo-Congresso UMEM.1977
-AA.VV.-annuario-guida
archidiocesi- ed./94-pag.392—ed./02-pag.430
-AA.VV.-Enciclopedia
dei liguri illustri-Erga.1970-vol.III-pag.66
-AA.VV.-Guida
alle botteghe storiche- DeFerrari.2002-pag.129
-Beer
S.-Un tricentenario di ...-rivista Civitas Sancti Romuli, 1987-p.23
-Bottaro.Paternostro-Storia
del teatro a genova-Esagraph.1982-vol.II.pag.3
-Busacchi V.-il Ligure GDC-Uomini d’arte e di scienza a
S.-Casabianca 1977-p.53
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Favretto
G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p-165
-Gazzettino
S. : 1/73.10 + 5/81. da vedere per farmacista)
-Guelfi
F-il Liceo Scientifico GDCassini n°1529.14.71 +
-Genova
Rivista comunale: 12/38.23 +2/50.28locandina + 10/57.27foto montecucco
-Il
Secolo XIX del 16.10.1998 + 12.7.04
-Lamponi
M.-Sampierdarena-Libro Più.2002.pag.23
-Michero
C.-Gian Domenico Cassini-La Casana 3/84-pag.36
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-C.Civico SPdA’86-p. 54.56f.102foto.104
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio-1900-30-pag.18
-Pagano/1933-pag.247--/40-pag.
240--/1961-pag.136.588
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.386foto
-Pescio
A.-I nomi delle strade di Fenova-Forni.1986-pag.83
-Poleggi
E. &C-Atlante di genova-Marsilio.1995-tav.51
-Rebaudi
S.-.GianDomenico Cassini-Rivista de ACompagna n.9/30-pag.4
-Tringali
S.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.189
-Viazzi C.-Mario
Cappello-DeFerrari.2002-pag.14
CASTELLI via Agostino
Castelli
TARGHE: San Pier d’Arena – via - Agostino Castelli –
mazziniano


angolo via
A.Cantore


angolo via N.Daste


angolo via
Buranello
QUARTIERE ANTICO: Castello
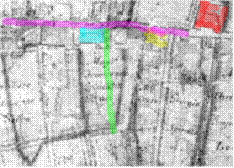 da MVinzoni, 1757. In rosso villa Doria-Franzoniane; giallo
villa Crosa; celeste villa Grimaldi-Gerace; fucsia, via NDaste
da MVinzoni, 1757. In rosso villa Doria-Franzoniane; giallo
villa Crosa; celeste villa Grimaldi-Gerace; fucsia, via NDaste
N° IMMATRICOLAZIONE:
2748 CATEGORIA 2
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 14240
UNITÁ URBANISTICA:
26 - SAMPIERDARENA

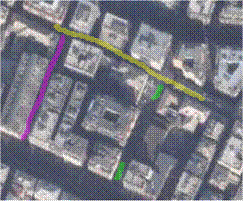
1960
Da Google Earth 2007 fucsia,
via . . G.Giovanetti;
giallo, via N.Daste.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria
della Cella
STORIA: Prima
dell’anno 1850 e della ferrovia, la strada non esisteva ed il terreno era di
privati -localizzato nella ‘regione –o rione- del Comune’- e si estendeva dalla
via Comunale (via Daste) al mare,
coltivato ad orti, vigneti e giardino.
Non concordo con Lamponi quando afferma che la strada è stata aperta nei
giardini di villa Crosa: la strada risulta a spese dei giardini della proprietà
a ponente dei Crosa, allora del mag.co Francesco Grimaldi di Geraci (attuale via Daste 24). Questi terreni, dal limite dei
Crosa, arrivavano alla facciata occidentale della propria villa ed estesi verso
il mare.
Dalla carta vinzoniana (1757)
la villa della famiglia dei “mag.ci Crosa” è posta sulla strada Comunale (via Daste) ed il suo giardino era molto stretto
-fiancheggiando a ponente vico sant’Antonio ed a levante il limite stesso della
costruzione- ed era anche breve perché neanche
sbucava ove è via San Pier d’Arena avendo specularmene lo altrettanto stretto
giardino della villa Cambiaso (ex Pretura) affacciata sulla marina. Cento anni dopo, nel 1847 circa
-dai rilievi degli ingegneri incaricati dell’esproprio per erigere la ferrovia,
la villa Crosa appare di proprietà di
Bartolomeo Parodi fu GB (che
occupava in base ai loro rilievi anche la villa Cambiaso, ed il terreno era
usato solo a giardino di confermate dimensioni limitate avendogli sottratto una
superficie di m.19x19, quindi 20-30 m. di larghezza circa).
Lo
spazio a ponente dei Crosa -in quella data 1847- apparteneva a Pasquale
Dellepiane fu Antonio coltivato ad orto e decisamente più vasto vedendosi
sottrarre dalle ferrovie ben 1008 mq.; la proprietà era ancora immodificata
rispetto quello dei Geraci: era estesa a forma di L speculare (perché proseguendo la strada a
ponente, la villa Centurione (aperta sull’attuale via Daste,28) aveva dei
giardini assai limitati che non arrivavano al punto di passaggio della ferrovia).
Subito
dopo eretto il viadotto -appare in uno spaccato di tracciato ad uso
ferroviario- che il sottovia che schiude la nostra strada verso mare, veniva
riconosciuto col nome di ‘sottopasso Dellepiane’ perché egli possedeva officine o depositi a levante
del sottopasso stesso. Pertanto la strada è interamente a spese del Grimaldi
poi Dellepiane (nella parte più vicina alla ferrovia
la proprietà di questi due, si allargava verso ponente sino a confinare con
quella di Aretina marchesa Pallavicini del fu Lamba Doria che abitava la
Serra-Monticelli (via Daste, 34) che, a sua volta confinava a ponente con la
crosa della Cella).
La strada nacque quindi dopo il 1930 quando proprietario dei terreni non
sappiamo chi fosse, forse gli eredi Dellepiane ma presumibilmente era già in
mano ai fratelli Galoppini. E seppur nata in
territorio privato, fu conservata ad uso pubblico per la necessità da parte
degli operai di raggiungere le fabbriche aperte su un lato (e svagarsi, sui
prati di fronte alle officine ove ora i civv. 2 e 4).
Ancora nel 1933 era chiamata “via privata san Benigno”, collegante via Vittorio Emanuele (via G.Buranello) con via generale Cantore (via N. Daste); ed era di 4.a categoria, con i
civv. 2 e 4.
Nel tratto a nord della strada, fino ancora a questa data salita Salvator Rosa
terminava direttamente in via N.Daste; l’apertura di via A.Cantore, tranciò la
parte distale della salita lasciandone solo un pezzetto, a mare della
stessa grossa arteria; questo breve tratto fu poi allargato e perdendo il
nome originale, venne inglobato in via A.Castelli (rimane compreso tra due palazzi
eretti ai lati, il cui portone si apre in via Cantore. Di questi, l’ultimo fu
terminato nel 1972; da allora -per due anni sino a fine 1974- questo pezzo di
strada (ex-sal.Inf.SRosa, e non ancora via Castelli) rimase chiuso al traffico
veicolare mediante una catena posta dalla soc. edile Sant’Antonio che l’aveva
avuta in concesione per edificare, al fine di riconcordare il passaggio di
proprietà, al Comune. Tutto fu ottenuto poi, con lo scambio di poter costruire
in salita S.Rosa).
Divenne intestata come oggi nel 1940 (ma nel Pagano di quest’anno, non c’è ed è presente come via privata s.Benigno -vedi) e deliberata definitivamente dal commissario prefettizio
il 24 mag.1944.
Da tanti, è conosciuta come piazza Galoppini, nome risalente agli anni 1930, non ufficiale nella toponomastica
cittadina e quindi a solo uso popolare, legato alla presenza nella strada
dell’omonima fabbrica di recipienti di latta per conserve alimentari, e che
rilevava (non sappiamo se con altri intermediari) le proprietà Dellepiane. La
fabbrica, il cui lungo edificio ancora delimita il lato ad est della strada,
appare ancora funzionante negli anni 1960, i cui titolari erano appunto i
fratelli Galoppini (fiancheggiava lo stabilimento Diana, posto sia a monte che
parallelo ad est fino al vico Stretto sant’Antonio). Ed era ‘piazza’ perchè non esistendo i civv. 4 e
6, era tutto uno spiazzo, dalle ferrovie riconosciuto come ‘piazzale privato
Galoppini’ lasciato libero al defluire dei tanti operai verso le vicine
trattorie ed osterie o per giocarci; e per le ferrovie, il sottovia ferroviario
divenne anch’esso ‘f.lli Galoppini’.


carta del 1887 – al posto del civ. 1 la fabbrica anni
80, con catena
di sapone di Oneto GB. Archivio di Stato
STRUTTURA: strada
comunale carrabile. Collega via G.Buranello con via A.Cantore; con senso unico
viario (già dal 1984 si
chiedeva l’inserimento del senso unico)
favorevole per chi viene dal mare, anche se deve voltare a sinistra in via
N.Daste, perché il breve tratto tra via ACantore e via NDaste è senso unico in
opposto.
Appare lunga 157,16 metri e larga 11,87; ha un solo marciapiede largo l,85, ma
per un tratto di soli 65 metri.
Nella parte a levante, è utilizzata a libero posteggio auto.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera


anno 1979 anno
1975



anno 1976 circa, prima dei restauri
e dopo; in estauro villa Crosa
CIVICI
2007:
NERI = da 1 a 7 (mancano 3 e 5) e da 2 a 4 (compreso 2A)
ROSSI = da 1r a 23r
(compreso 7a)
da 2r a 58r (mancano 14, 42, 44r; compresi
14ABCDE, 16AB, 22A, 26A)
===civ.1: vecchia costruzione, di tipo popolare-operaio,
senza decorazioni né terrazzi, della fine dell’800. Nelle scale, tipiche
ringhiere in ferro battuto. Al primo piano una palestra.
===civ.
6: costruito dopo il 1935, quindi
con decorazioni tardo liberty detto ‘modernistico’; il sottotetto era decorato
con affreschi che si stanno cancellando; nel piano terra (anche del civ.4), per
anni vi furono ospitati uffici delle PPTT; ed ancora negli anni 1960 ospitava
l’Istituto Palazzi tecnico-commerciale per geometri e scuola media
(erroneamente nel Pagano/1950 si conferma l’istituto al civ. 6 ma scrive
‘palazzo Grimaldi’).
===
civ. 9-11*** ospitava lo stabilimento Galoppini e parte di quello Diana. Non
esistendo i palazzi di fronte, nel largo prato-spiazzo andavano gli operai
–nell’intervallo mensa- a giocare e prendere aria.
Ancora
nel 1942 i fratelli Diana oltre a produrre lavorati del latte (con sede in via
Buranello), qui in via Castelli lavoravano il tonno (cotto a vapore ed
inscatolato sott’olio; nella villa di via Daste abitavano. A metà 1974 la ‘Diana spa’ chiuse la produzione perché impossibilitata
a far fronte alla concorrenza più moderna).
Negli anni 1979 fu progettato utilizzare il terreno per costruirvi un nuovo
centro postale (che poi
venne realizzato in via U.Rela).
===Dal
lato a ponente offre il fianco la villa Grimaldi di Gerace che si apre in via
Daste (nel dopoguerra, essa
fu ristrutturata ad appartamenti conservando dell’antica villa solo l’aspetto
esterno).


la villa Grimaldi di Gerace
===civ.
lo studio del notaio Morello, uno dei più noti sulla pizza essendo di seconda
generazione (lo era anche il padre, molto conosciuto).
=== civv.15r e 17r: ristrutturati nel 1998-2000 con rifacimento del
tetto e pittura della facciata, con tendenza a conservare l’antico aspetto
dell’immobile che possiede le caratteristiche del primo 1800 e forse anche
antecedente. Da molto prima (tipo 1890) ed ancora ai tempi dell’opificio Diana
e Galoppini, Stefano Ercole detto “Steva” gestiva una osteria-trattoria ove
andavano a mangiare gli operai
DEDICATA Al
repubblicano, nato a Sestri Ponente il 13 ott.1822 da Pietro e da Maria Gaggero,
di umili origini e lavorante come cocchiere presso i conti Benedetti di Barcola
a Lerici.
A 27 anni, a casa dei suoi di Lerici, partecipa ad una contestazione popolare
contro la monarchia, dopo la sconfitta di Novara: viene segnalato come ‘uno dei
più esagitati’, facendo aprire un dossier su se stesso..
Se da questo incontro non ebbe conseguenze, nel 1852
dovette trafserirsi a Genova per sottrarsi ad un mandato di cattura, che fu
applicato nel 1855 quando fu arrestato per sedizione e per aver sobillato dei
militari contro la politica del re, contro la spedizione in Crimea e facendo
propaganda a Mazzini: trascorse quattordici mesi nella prigione di San Pier
d’Arena.
Poi, al processo, fu assolto.
Divenuto rappresentante della Confederazione operaia genovese, aiutò (1857) ad
organizzare sia la spedizione di Carlo Pisacane (alla quale non partecipò per un banale disguido non
precisato); sia una insurrezione
genovese: ambedue fallite per impreparazione del popolo a simili avvenimenti ed
ideologie (1857). Fu condannato –per sedizione- nel febbraio 1858 - in
contumacia - a 12 anni di lavori forzati: così fu costretto a fuggire a Lugano
e poi a Londra essendo ricercato in patria.
Fuori Italia, ebbe diretti contatti con Mazzini, che lo aiutò a trovare un
lavoro presso un cubano come domestico, e nel frattempo a volte lo incaricava
come collaboratore politico per sue attività. Di probabile temperamento
iperattivo, si allontanò dall’amicizia stretta con Mazzini non condividendone
la prudenza e la tolleranza dei Savoia mostrandosi sempre intollerante ad
appoggiare qualsiasi lotta di indipendenza promossa dai reali torinesi. Le sue
idee repubblicane erano esasperatamente ritenute indispensabili per il popolo
dal cui ceto sociale proveniva. Coerentemente, appena rientrato in Italia a
seguito di una amnistia (1860), cercò di partire con Rosolino Pilo, ma ne fu
impedito per malattia; Partì per la Sicilia inquadrato nella brigata Castel
Pucci ma prima di combattere si dimise rifiutando contribuire o collaborare con
la spedizione dei Mille ritenendola troppo favorevole ai monarchici. Mazzini si
arrabbiò molto per questi suoi fatti, concentrando il proprio pensiero nella
frase «pensano più a se stessi che alla cosa da compiersi»
Si
fece inviare a Roma con il Giannelli, per informarsi su possibili prestiti e
valutare la possibilità di creare un Comitato democratico e malgrado vari
pericoli affrontati, riuscì a compiere la missione.
Comunque, stemperata l’intransigenza garibaldina, fu con lui a Sarnico ove fu
arrestato; ma lo ritroviamo a fianco di Garibaldi in Aspromonte, senza
rinunciare agli ideali repubblicani che continuò a propagandare sino alla sua
morte, avvenuta precocemente in Genova all’ospedale di Pamattone il 31
dic.1864.
Qualche
testo lo segnala come Castello: anche il Dizionario Biografico degli Italiani
scrive Castello.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 990
-AA.VV.annuario-guida
archidiocesi- ed./1994-pag.392—ed./02-pag.430
-AA.VV.-Enciclopedia
dei liguri illustri-Erga.1970-III-93
-AA.VV.-Dizionario
biografico italiani-Istit.Encicloped.Italiano
-Gazzettino
S. : 4/72.7 + 5/74.3 + 1/75.5 + 9/79.1 + 8/84.5
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.56
-Pagano/1933-pag.244--/40-pag.241--/50-pag.
215--/61-pag.443-579
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-II-pag.398
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio 1995-tav.34
-Stradario
del Comune di Genova, edito 1953-pag.45
non
citato Enciclopedia Motta e Sonzogno né TuvoCampagnol




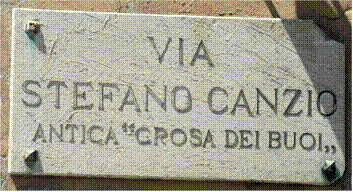
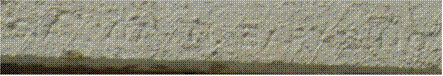 particolare
particolare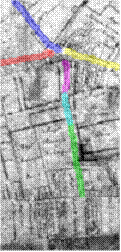 da MVinzoni, 1757. In celeste zona
dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;
rosso via AScaniglia
da MVinzoni, 1757. In celeste zona
dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;
rosso via AScaniglia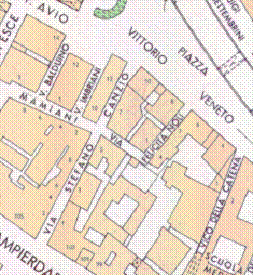 da Pagano/1961
da Pagano/1961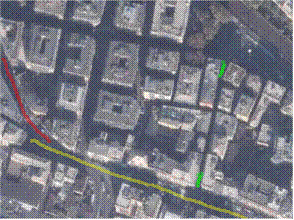 in rosso, via Pacinotti; giallo via
san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007
in rosso, via Pacinotti; giallo via
san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007 fa leggere in corrispondenze della strada, la
definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della
parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi
imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,
sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco
inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,
era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci
e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un
bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a
sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento
dell’impavesata) poi tonda. L’avvento
del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.
fa leggere in corrispondenze della strada, la
definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della
parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi
imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,
sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco
inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,
era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci
e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un
bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a
sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento
dell’impavesata) poi tonda. L’avvento
del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.

 1870 con la moglie Teresita
Garibaldi.
1870 con la moglie Teresita
Garibaldi. 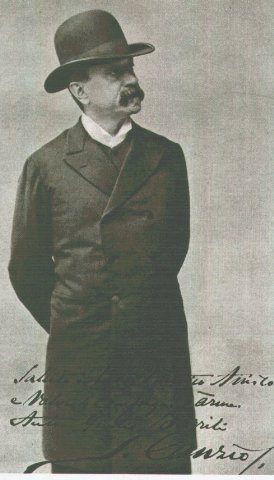

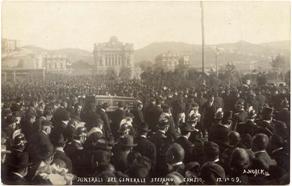
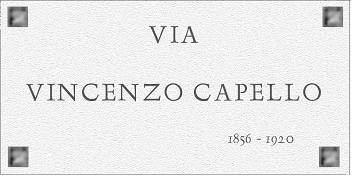
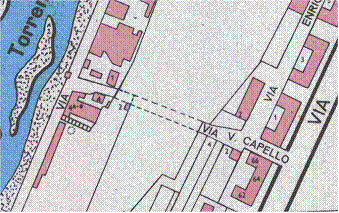



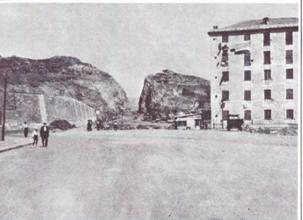



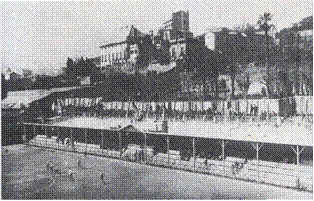
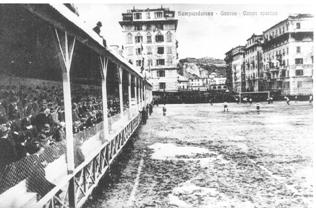






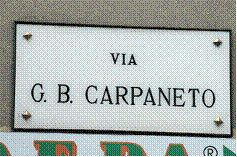

 angolo est via
L.Dottesio
angolo est via
L.Dottesio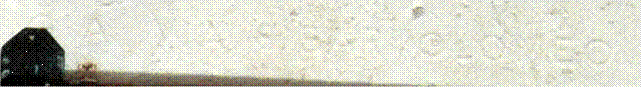
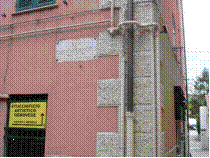
 angolo scala a v.
A.Cantore
angolo scala a v.
A.Cantore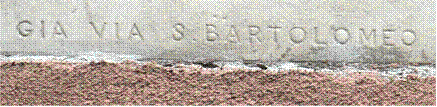
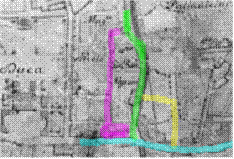
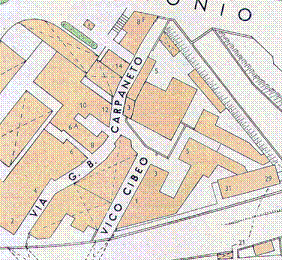
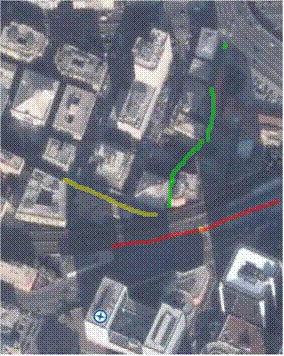






 i
vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori
‘sale’, alla Coscia
i
vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori
‘sale’, alla Coscia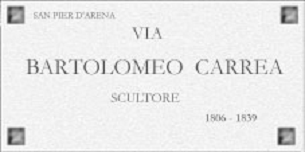
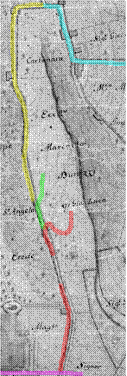
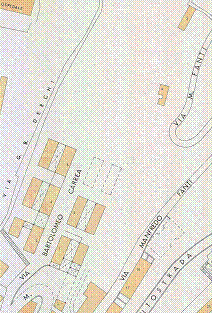
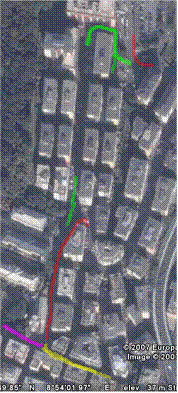
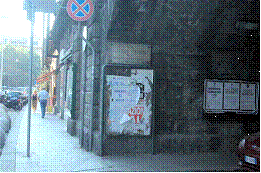


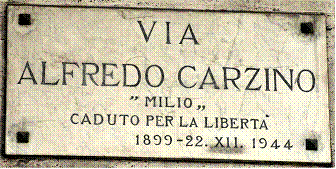

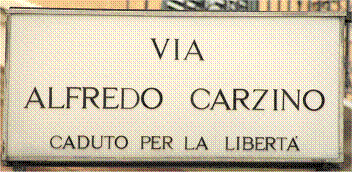

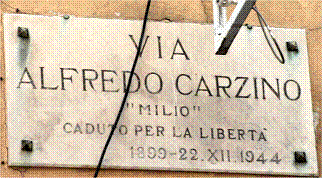
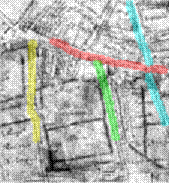
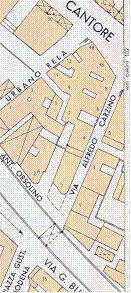

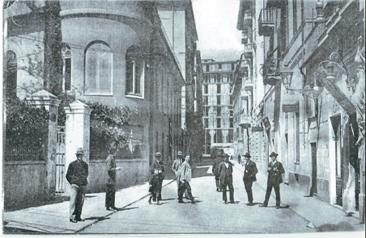



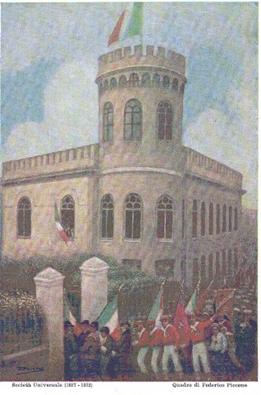

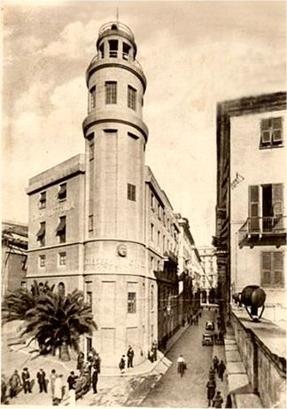

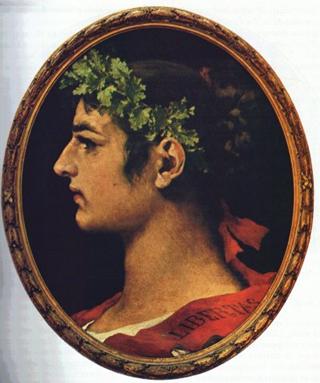






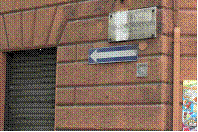
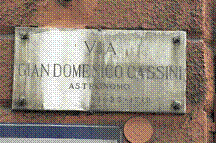 angolo via L.Dottesio
angolo via L.Dottesio