CELLA
via della Cella
TARGHE: via – della Cella
San Pier
d’Arena – via - della - Cella
San Pier
d’Arena – 2751 - via della Cella
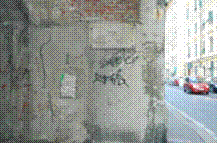
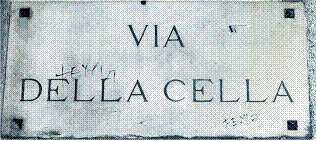
angolo est
con v. G.Buranello

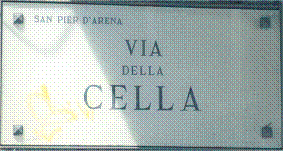
angolo
ovest con via G..Buranello

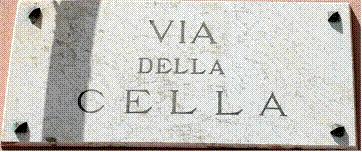
presso il
civ. 2r
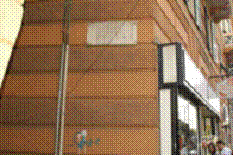
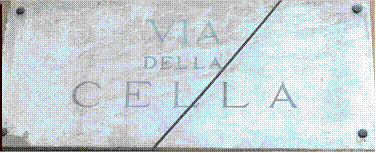
angolo via NDaste
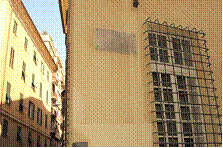
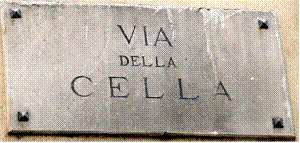
Angolo via
N.Daste
QUARTIERE ANTICO: Comune
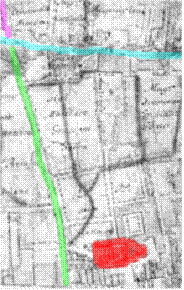 da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;
celeste, via NDaste; fucsia salita
Belvedere.
da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;
celeste, via NDaste; fucsia salita
Belvedere.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2751, CATEGORIA 2
 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO
n: 14980
UNITÀ URBANISTICA:
26 - SAMPIERDARENA
 Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via
G.Buranello.
Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via
G.Buranello.
C.A.P: 16149
PARROCCHIA: N.S. s Maria della Cella.
STORIA: senz’altro, questa viuzza si realizzò in uno dei primi
nuclei costruiti in agglomerato ed abitati del borgo, al suo nascere; contende
quindi questo primato alla zona della Coscia. È collocata nel centro della
città; ed è forse per questo che è popolarmente ricordata come la “crosa del
cuore” (anche se è
riferimento valido per tutte le strade, nell’ottica di chi le ha vissute da
piccolo).
Ci si può chiedere se nacque prima un insediamento
organizzato a san Martino (ove fu costruita
l’abbazia, che per seicento anni fu il perno religioso del borgo), o
alla Coscia (da dove potevano essere più facili
i rapporti con la città di Genova), o alla Cella (ove erano di attracco le poche barche che volevano
usufruire di un riparo e dove ‘arrivava’ sulla spiaggia la strada Aurelia che
scoreva sull’alto del colle); forse i tre ‘sottoborghi’ crebbero assieme
fino a fondersi gradatamente degli anni attorno al mille.
Quando nacque per prima la cappella di san Pietro (su
tutta la spiaggia ci saranno state, sparse, poche decine di anime), e subito
dopo - per volere di Liutprando (siamo nell’anno 726dC) - furono chiamati degli
abati a creare una struttura ecclesiale attorno adeguata alla sua conservazione
e miglioramento, appare ovvio si sia dato il via al costruire attorno nuove
abitazioni, per convivere in una comunità più protetta e associata. Il
territorio era aperto e probabilmente abbastanza libero da vincoli di
proprietà, e presumibilmente con disinvoltura si poteva attraversare tutta la
vallata senza l’obbligo di particolari tracciati stradali. Piace immaginare
che poi nel tempo, la via andò gradatamente a prolungarsi verso l’interno, non
è spiegabile perché inclinata verso ponente se non perché più in linea con
l’abbazia di san Martino, fino all’incrocio con lo spontaneo neonascente asse
longitudinale posto più all’interno (per la logica è perché in linea tra la Coscia ed un guado
sul Polcevera; oppure perché è più protetto dai marosi o perché non sulla
sabbia) e di
collegamento con gli insediamenti vicini.
Con l’avvento delle ville patrizie e rispettive recinzioni
di proprietà, messe in atto negli anni dal 1200-1300, si sancirono di pubblica
utilità questi tracciati fondamentali, che divennero vere e proprie strade di
comunicazione, obbligate. La storia è abbastanza avara di notizie, se siamo
costretti a saltare sei secoli.
Così, ancora il 23 settembre 1801 la Municipalità
constatando che la crosa - in caso di pioggia - si impantana con le acque che
scendono dalla salita di Belvedere, ordina ai cittadini proprietari di liberare
le vie di deflusso (scrive Tuvo: ”per aver voi (proprietari) chiuso quei
recipienti che davano esito alle acque che scendevano dalla salita” (la parola
‘recipienti’ non è di facile spiegazione; ci indirizza subito a delle
fognature, ma a quei depositi di acqua piovana raccolta dai tetti posti nelle
fondamenta dei palazzi, che sopperivano alle necessità quotidiane di acqua; ma
certo questi torrentelli post diluvio, tutto potevano trasportare escluso acqua
potabile).
Il 29 maggio 1817 il nuovo sindaco nominato
dopo la restaurazione, Antonio Mongiardino, firmò il primo elenco di strade
classificate del territorio locale; fra tutte, ovviamente c’è anche questa
crosa. L’anno dopo firma un’ordinanza per la quale proibisce il passaggio
delle bestie da soma (sia cariche che vuote):
pena 10 soldi per i muli, 5 per i somari; esclusi quelli per regio servizio.
1821 L’Amministrazione comunale stanzia 792,07 lire per
far ripulire ‘lo scolatoio della crosa’. Evidente fognatura a cielo aperto
ricuperante acqua , da Belvedere, solo nei giorni di pioggia. Nelle case non
esistevano i servizi igienici; gli escrementi venivano gettati in questi scoli.
Tagliata poi a metà nel 1840 dalla ferrovia e da
via G.Buranello, si formarono - in forma non ufficialmente riconosciuta - un
tratto ‘inferiore’, a mare (praticamente inibito al traffico veicolare e solo da esso incrociato
nel tratto via B.Ghiglione-vico Centro); ed uno ‘superiore’ (che è senso unico viario da mare a monte).
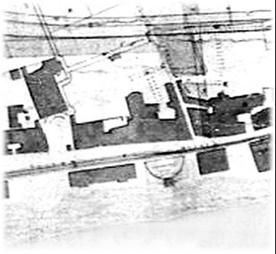
da una mappa ferroviaria del 1845 circa. Si vede la torre
del Comune in basso senza il palazzo del Municipio (e alla sua destra, il
teatro Ristori); il Palazzo del Monastero a sinistra con le vie di collegamento
(v.Ghiglione e Carzino); e via della Cella inferiore, con ingresso da essa alla
chiesa.
Così, nel regio decreto del 1857, quando da Torino fu
concesso dare dei nomi ai tracciati della quanto assai prossima “città”, viene
accettato e sancito il nome di “crosa della Cella”.
L’origine di questo
nome è incerto: riportiamo le varie ipotesi.
---non esistendo delle strade né nomi precisi, gli
agglomerati più densi erano conosciuti e definiti in rapporto a delle caratteristiche
facilmente individuabili nella zona; così una piccola insenatura
naturale (“cellum” in latino: lingua ufficiale ed unica, a quei tempi), che
esisteva in corrispondenza della marina - limitata da uno sperone roccioso (sul
quale poi fu costrita la torre ‘saracena’) - che favoriva l’attracco delle
barche col loro carico e scarico di mercanzie è probabile abbia dato il nome al
posto. Questa piccola cala dettò proprio la scelta di Liutprando: preferì
sbarcare in questa spiaggia le spoglie del santo Agostino, in luogo già in
linea con i sentieri d’internamento verso nord, qualificando la zona in modo
più preciso. In effetti per lunghi secoli e per ragioni non tanto di pescaggio,
in quanto il fondo calava rapidamente allontanandosi di poco da riva - le navi
preferivano im/sbarcare le merci senza attrezzature portuali.
Direi che è l’ipotesi più probabile, trattandosi del nome di
una chiesa: “Santa Maria”; e laddove “della Cella” significa il posto dove
sorse, come Santa Maria in Latinorio per esempio
---Ma “cella” poteva essere il nome della piccola chiesuola,
originaria, quella poi restaurata da Liutprando per ospitare le ceneri; e poi
elemento originario del nucleo abitato. Anche questa ipotesi appare logica,
con lo stesso metro della definizione di un luogo, stabilita per immagine o
abitudine dagli abitanti, pescatori o contadini generalmente analfabeti (come
anche le altre zone della “coscia”, del “canto” e del “mercato”, ecc..).
Infatti le spoglie di sant’Agostino saranno poi riposte in una ‘cella d’oro’,
intesa come locale intimo e personale, anche se inserito in un grosso complesso
architettonico.
---Cella è pure la cameretta dei frati, del primo
convento locale; ma è meno probabile sia stato l’elemento promotore del nome
della località.
---Cella era nell’antica casa latina lo stanzino o
ripostiglio (dal verbo ‘celare’); quindi
non luogo di vita diurna (posta nell’interno, o
sulle alture, o comunque non sulla costa a rischio di incursioni notturne).
Quindi il magazzino ove si disponeva il pesce raccolto per qualità, si
riparavano le reti e le barche, si conservavano gli attrezzi e le barche;
considerato che le abitazioni erano in alto, dove passava la strada.
---Celle, è il nome di un borgo del ponente, prima di
Savona. Anche là, gli insediamenti romani e preromani, sono nell’interno;
essendo il centro sul mare di più recente edificazione.
Nell’anno 1900 fu proposto alla civica
amministrazione il nome più preciso relativo alla chiesa, di ‘via S.M. della Cella’, alla via allora compresa tra via C.Colombo (via Sampierdarena) e via sant’Antonio (via N.Daste); ma evidentemente non fu accettato.
Nel 1910 aveva civv. sino al 24 ed 11. Andava da
via C.Colombo a via s.Antonio tagliando v.V.Emanuele; aveva un vicolo
trasversale davanti alla chiesa che era senza nome (e tale è ancora nel 2006).
Il 19 agosto 1935 le furono regalati sia gli
ultimi quindici metri di strada, in corrispondenza dello sbocco in via
A.Cantore, “rubati” a corso dei Colli-corso Dante Alighieri-corso L.Martinetti il quale appunto, prima
dell’apertura di via A.Cantore, si apriva in via N.Daste in corrispondenza del
rione, chiamato “mercato”; sia il tratto che aveva nome Nicolò Bruno, la cui titolazione fu spostata al
Canto (vedi), e qui rimase senza dedica.
STRUTTURA: Strada comunale racchiusa tra via San Pier d’Arena
e via A. Cantore.
Sotto la strada dovrebbe esserci una conduttura,
originariamente l’alveo di scarico d’acqua torrenziale proveniente dal
Belvedere (e per ciò detto ‘rio Belvedere’): è del 1801 un pubblico
manifesto che invitava i proprietari della crosa della Cella, nei giorni di
pioggia, a tenere aperte le condotte per evitare che si formasse un vero
fossato.
Nella parte inferiore, ha una sola strada laterale anonima
che le appartiene, ed è la prima, che sbuca di fronte alla chiesa; le altre tre
più a nord, sono personalizzate da una targa propria: via Centro, Ciurlo,
Uziel. Nella parte superiore le laterali, tutte a levante, sono tre (oggi
anonime, anticamente no): la prima, subito dopo il voltino e costeggiante la
ferrovia, ha un corridoio nel retro del palazzo e si allaccia alla seconda
formando così un anello attorno al civico. La terza è chiusa in fondo ed ha il
civico 13.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
CIVICI
2007= NERI = da 1 a 15
2
20
ROSSI = da 1r a 123r (manca 117; compresi 41AB, 75°, 77AB, 79AB, 81A)
2r 88r (compresi 28AB, 66B)
NB nell’elenco tratto dalle
vare edizioni del Pagano, la cifra scritta tra parentesi significa che tale
persona era presente anche in quella data successiva
Dal Pagano/1902 si leggono queste attività: al civ. 2 l’orefice
Ricchini Giulio (‘12);--- ed il ramaio Piccardo Aronne
(25);--- 4 negozio
di calzature Carosso Geronima (12);--- al 7 il confettiere Bruzzone Dante (08);--- e l’osteria di Storace
Francesco (12);--- al 7A un negozio tessuti di
Noli e f.gli (25) una fattura datata febbraio 1886 è intestata a “Maria Noli e
Figli – fabbrica di ricami d’ogni genere per esportazione; cravatte folards e
veli – deposito manifatture e mercerie; passamanerie nastri e pizzi - deposito
lane filate estere e nazionali”;---8 il tappezziere,
ebanista e mobiliere Parodi Luigia (12);
--- fabbrica di mobili di Parodi Luigia ved. Vaggi GB (12);--- la fabbrica
di turaccioli di Beccuti
Angelo (12) ---il lattaio (lavorazione latta) Tabacchi Giuseppe (12)--- 8-5 la levatrice Cuneo Maria
(12);---
al 9 una osteria di Pittaluga Bartolomeo (12) telef. 820, ed un’altra di
Pozzo Domenico (12);--- al 10 il negozio di pollame di
Ivaldi Antonio (12) (piemontese di origine, era il padre della moglie di
Roberto Bixio pittore sampierdarenese; poi trasferì il negozio all’inizio di
via A Cantore fino alla chiusura dell’attività);--– al 12 l’osteria di
Pittaluga Giacomo (12);---e Cambiaso Pietro verniciatore;--- 14 il ramaio Remorino Pasquale (12);---civico
non segnato un negozio di tessuti
di Montaldo Giuseppe’ fu Paolo;---
Nel 1908 il Pagano segnala esserci stato in più
al 2 il tintore Alfieri Giuseppe (25) (che nel 1902 era in via sCristoforo).
Nel 1910 la crosa era delimitata dalle stesse vie
di oggi ma che allora
si chiamavano via C.Colombo e via sant’Antonio;
aveva civici sino al 24 ed 11.
Nel Pagano 1911 e 12 (e 1925, 1933) si
aggiungono ai precedenti al
civ.1r commestibili di Canepa Giuseppe;--- al 6
il droghiere Bruzzone
Dante (25)(è anche confettiere al civ.7);--- al civ.
9-11 il prof
Attilio rag. Raffellini
insegna la
lingua inglese (25);---
18 la banca Commerciale (nel ‘25 andrà in via V.Emanuele); al 22r
commestibili di
Vernazza Francesco;---
al 24 il forno per pane di Barabino Agostino (25);--- al 30-32
forno di Casale
Federico,--- al 33r forno di Vernazza Giuseppe 33) (nel ‘25 è anche in via CColombo civ. 77);--- 53r Proietti Martina (25) ha fabbrica di saponi;--- al 55r
forno di
Roncallo Luigia (33);---
e
non specificato dove il negozio di articoli per
calzolai di Aghina
Celestino (33);--- Bottino Maria (33) un negozio di grossista di carbone e legna;--- Montaldo Giuseppe fu Paolo vende tessuti;--- Tortarolo e C. (25) negozio di ferramenta;--- parrucchiere Didone Pietro (25) (nella via
superiore);--- Opessi Antonio (25) (ditta di Torino con officina per riparazioni in
Sampierdarena) di pesi
e misure.
Nel 1927, nell’elenco ufficiale del Comune
genovese approvato dal podestà, appare come ‘via Cella’ senza il ‘della’, di 3a
categoria; omonima di una eguale, a Bavari.
Senza data ma decisamente in epoca fascista, al civ. 16/5
c’era l’ufficio del sig. Lo Faro Salvatore, delegato dal presidente della
federaz.Provinc. (sen.ing.gr.uff. Broccardi Eugenio Salvatore) de «Ufficio propaganda igienica – organizzzazione a favore
delle opere assistenziali / dell’Ente Naz. fascista della Mutualità Scolastica
/ delegazione per la Liguria e Lombardia» di vendere a L.12 un “diffusore di uno speciale autoemanatore
con calendario” raccomandato dalla Presidenza Centrale.
Nel Pagano/33 si segnalano in più oltre i
precedenti: 13 il Pastificio di Monticelli B. & B. (25); 33r macelleria (carne congelata) di Bruzzone I.; al 64r
il marmista Lagorara Luigi (nel ‘25 è intagliatore in legno in via della Cella Superiore); al 67r i Raffetto A.e C.(25) gestivano uno stabilimento con «litografie per illustrazioni casse e latte per
conserve alimentari»; non
specificato dove il
mobilificio Ambrosini
Annibale (la cui fabbrica
nel ‘25 era in via
A.Cairoli); il pizzicagnolo Lanza Angelo (nel ‘25 nella
via c’è Lanza Giovanni mentre Angelo appare in via A.Doria); il
tappezziere Comotto
GB¨ (specificato, nella via superiore).
Sul Pagano/40, la strada va da via del Mercato a via NBarabino; nei
civv. neri da mare a monte comprende al 8 ist.scol Minerva; 9 agenzia Pegni; 10 e 12
Croce d’Oro ‘con sezione radiologica, policl.’ e Commissariato di P.S.; al 17
pastificio Monticelli; al 20 dop.Escursionistico “C.Battisti”. Nei civv. rossi fabbro, 2 tripperia, 2 salumi, 2
parrucchiere, ricami, 3 osteria, biciclette, pompe funebri, otton.,
copisteria, 2 merceria, 2 fruttivendolo, armi, 3 latteria, articol
casalinghi, pollivendolo, 3 macelleria, 2 stiratoria, 2 drogheria,
pescivendolo, panificio, 3 commestibili, farmacia Bisio al 38r, Bagnara
cappelli al 41r,/// officina, autoscuola Aquila al 41Br, fornitura per sarti,
profumeria, tintoria, tappezziere, ottoniere, ardesie, carbone, litografia
Raffetto s.a. al 68r, parrucc.per signora, calzat., polleria= praticamente un
grande magazzino.
Dal Pagano 1950 si trascrive l’osteria di Parodi M. al 10r, senza alcun altro bar né trattoria.
Nel tratto inferiore


è lungo 113, 5 metri e largo 2,95; senza marciapiedi; solo
pedonale; la via è stretta e lineare (anche se – e già così appare nelle carte del 1700 -
lievemente obliqua rispetto la linea del mare. Dovendo
essere il sottopasso ferroviario perpendicolare alla linea ferroviaria, la
linearità della strada ha subito una deformazione ad ansa che snatura l’antico
percorso).
All’inizio è affiancata da piccole casupole di pochi piani
in altezza (due, o tre) dando l’impressione del “molto
antico o primitivo ed architettonicamente
Semplice dei pescatori” (nello slargo all’inizio strada, sino ancora al 1920,
erano

foto1975 del Gazzettino Sampierdarenese
ospitate le barche perché al di là di via C.Colombo iniziava la spiaggia con il Giunsella ed i bagni Italia); si sa che nei fondi di queste
case esistono a sostegno di esse, vecchi pilastri e colonne, fondamenta di
precedenti costruzioni più antiche delle attuali;
T.Tuvo cita una lettera datata 1586 in cui un certoGian
Giacomo Salifero: scrisse “ ai
serenissimi et eccellentissimi Signori di Genova, a proposito
di una mia

casa
in San Pier d’Arena, in fine della crosa della Loggia, a canto della quale
resta un loco circondato da muraglie, il quale desidero ora incorporare con
detta mia casa, non tanto per l’accesso ragionevole e gustoso per me, ma al
pubblico perché si ritira il canto all’altro per pochi palmi ...assicurando che
oltre la bellezza e che ciaschedun abitante ne riceverà, si torrà quel canto
del quale ne puol procedere disgusto ...” - la risposta del 30 gen.1587 ingiunge di “non alzare, né coprire le muraglie della piazzetta
che resta in fondo alla crosa della Cella
”.
Nello slargo iniziale, affissa al muro c’è una prima targa marmorea (un’altra si ritrova uguale vicino al civ. 29r) che avverte che “è vietato il
transito dei carri decreto sindacale 25. 3.19 “. 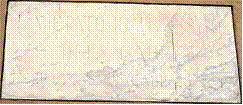
Come già detto il 9 ott.1818, quando il borgo contava 5300
abitanti, era apparso alle estremità della via un manifesto che proibiva il
passaggio delle bestie da soma sia cariche che senza basto, e fissava 5 soldi
per ogni somaro scarico e 10 per ogni carico (venivano esclusi i ‘ Regi
Serviggi’).
All’inizio strada sono stati posti delle ringhiere
trasversali tubulari al fine di impedire da quella parte l’accesso ai veicoli,
anche motocicli.
Rispetto al tratto superiore, conserva una personalità e
l’aspetto della tradizionalità rionale.
CIVICI del tratto inferiore, a
mare
La numerazione civica si sviluppa da mare a monte e,
per i numeri neri, raggiunge oggi i civv.neri 20 e 17.
Nei
primi anni del 1900 erano proprietari : del civ.1 (la numerazione
non corrisponde a quella odierna) Canepa Giuseppe ; del 2 Piccardo
Aronne ; del 3 Canevaro Gb ; 4 e 7 Romairone Natale (quello della
galleria); 5 Samengo Vittorio (quello del vico omonimo); 6 Fossati Luigi e
Tubino Arturo ; 7a la vedova Parodi
===civ. 3r c’era sino al
2002 una antica e l’ultima tripperia
“da Mario” (la trippa è un piatto tipico povero, diffuso in tutte le regioni
(alla napoletana, marchigiana, piacentina, romana, pisana, savoiarda,
bresciana; in frittelle, in insalata, all’aceto, con la verza o le rape,
semplice o ‘accomodä’. Ma qui da noi, c’era una attenzione e un uso con un
culto superiore che altrove; e dato che nulla nasce per caso, forse il
significato non è solo nella povertà della gente – assai spesso immigrati, analfabeti,
destinati a lavori pesanti con poco ed insicuro salario - quanto anche nella
scarsa cultura dell’allevamento di carne alimentare: veniva chiamata la
‘vitella dei poveri’; dal forte odore e sapore caratteristico, era il cibo
quotidiano di chi della bestia non poteva mangiare la carne ma solo ‘le bele’
bollite; il brodo era usato per la minestra, detta ‘la sbira’ (dal suo uso nelle carceri, viene la parola sbirro per
il poliziotto che la somministrava giornalmente). Del digerente, dagli
stomaci all’intestino (tipica erano la chiappa, la riccia, la centopelli, la
castagnetta) una coppetta di trippa da fare poi accomodata in umido con pane,
patate e pinoli, e un cucchiaio di salsa, era il piatto quotidiano.
==civ.7r a testimonianza
di quanto scritto sopra, nel piccolo vano si notano varie colonnine a supporto
del soffitto ad archi a vela; indicativi di ben antiche precedenti
distribuzioni dello spazio costruito.


===civ. 9r = ospitava nei
primi anni del 2000 (ed ancora in ago 02) il «Centro
sociale di volontariato “i Minolli”», centro di giovani volontari (da 15 a 25 anni), con
responsabile la sig.ra Rita Carlo, che vogliono portare un pò di conforto a chi
ne abbisogna (ammalati in ospedale, viaggi, minori. Il Secolo XIX/2001 li cita
quale unico centro sociale (senza guadagno) – oltre le ambulanze - attivo in
agosto in piazza Settembrini opportunamente illuminata da un riflettore
(imprestato dalla Darsena) e munita di una cucina e di 70 sedie per poter
mangiare, pesca di beneficenza, musica e tombola; il tutto per far festeggiare
l’estate da parte di chi era rimasto in città. Nel 2002 tale cerimonia fu
iniziata in ritardo per maltempo e disguidi, ma con eguale buon esito tanto da
proporre di prolungare alcuni giorni, ma da Tursi venne inspiegabilmente
imposto l’alt con malcelata rabbia del gruppo.
Nel 2004, il locale di 16mq occupato dal centro, è vuoto ed
in affitto.
===civ.15r nel 1950 c’erano
Ferraris & Traverso, per il Pagano/50 unica impresa di pompe funebri
cittadina in quell’anno. Nel 2004 “affittasi, con cortiletto interno”.
===civ. 30r, l’ex antico negozio di ferramenta ‘Mondo’. A lui è succeduto Lucà Antonino (figlio del Lucà che fabbricava reti da letto in via
Pacinotti) il quale nel 2002 si spostato
in via Giovanetti essendo più frequentata; ovvio che il suo trasferimento ha
aumentato il senso di vuoto ed abbandono di questa antica via.
===civ. 40r, La casa, detta
‘palazzo Raffetto’ nel cui corpo si aprì la farmacia, risulta al margine di
levante dei giardini di villa Centurione (o del Monastero), e fu eretta dove
erano delle stalle. Poco prima dello sbocco in via Buranello, c’è l’entrata dell’antica - la prima nata in San Pier d’Arena - farmacia Raffetto, in via della Cella angolo via
Mazzini=via Ghiglione: il dott. Angelo
Raffetto fu il primo farmacista che
nel dic.1873 (quindi già attivo in quell’anno; ma risulta che un
servizio notturno e concessione di farmaci gratuiti per i poveri riconosciuti
dal Comune, sia dell’anno prima. A ruota nacquero poi la Levrero in v.C.Colombo
47 (via Sampierdarena), la Milanesio in via sant’Antonio 18 (via Daste angolo Giovannetti) e la Sommariva in via Buoi (via S.Canzio) stipulò un
contratto –con entrata in vigore nel 1874 all’apertura del nosocomio cittadino-
con l’amministrazione dell’ospedale Masnata, al fine di fornire tutti i
medicinali -comprese le poche specialità allora esistenti - per il valore di
una cifra forfettizzata di 40 cent. al giorno per ogni ricoverato. Quando nel
1881 la gara d’appalto fu vinta dal dott. Milanesio (in via Giovannetti), il Raffetto per nulla offeso offrì gratis i
farmaci necessari di notte. Rimase Consigliere della farmacia dell’ Ospedale
fin oltre il 1938.


uno dei tre ingressio della
farmacia sulla strada
A
lui, ma più probabile all’omonimo industriale della latta, fu dedicata una
strada cittadina, tutt’ora esistente.
Gli
successe il dott. Raffetto Carlo. Non sappiamo bene quando, venne acquistata da
Aristide Bisio, acceso repubblicano;
caratteristico personaggio anche fuori della professione. L’attuale
proprietario, dott. Fioretti nel 1995 preferì trasferire l’esercizio nella più
frequentata via
G.Buranello, abbandonando così
all’incuria anche i marmi che la arredavano, e con essi una caratteristica
fetta di storia professionale.
===civ. 6: nel 1967 fu spostato a nuova apertura
conseguente a modificazione edilizia
===di fianco al 29r, c’è il
secondo marmo con inciso “ É vietato il
transito - dei veicoli e quadrupedi in direzione di Genova”.
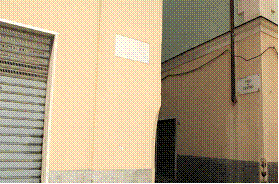

angolo con vico el Centro anni
1980 – prima del restauro
===33r era l’ingresso di un
negozio, i cui lati e la sommità hanno una semplice ma vistosa decorazione
marmorea il stile tardo liberty
===il 41r ed il 48r sono gli ultimi negozi del tratto inferiore
_____________________________________________________________
Nel tratto superiore,
lungo 150 metri e largo 5, con due marciapiedi larghi 1,4 metri; al limite
interno del voltino, a destra c’era uno dei pochi vespasiani
sopravvissuti in città: chiuso perché anche se abbastanza frequentato,
era poco curato ed in condizioni non è certo di idoneità per una città che
cerca spazi nel turismo: meglio farsela addosso o dover pagare dei caffé. 
Negli
anni di poco precedenti il 1900 (i civici di allora possono non corrispondere
agli attuali) erano proprietari: dell’ 8 gli eredi Nazzi ; 8a
Canepa, Noli e C ; 8b Barabino Andrea (aveva acquistato nell’apr.1872
per 2000 lire un gruppo di appartamenti, magazzini e negozi posti nell’angolo
sinistro del caseggiato vicino al vicolo; un negozio di questi ospitò per ben
117 anni una latteria, della Lisin, gestita
dalla sorella per 84 anni e poi dalla nipote Angiolina
e dalla pronipote Bianca, quando il latte
portato dalle alture o dall’entroterra, si vendeva non pastorizzato in
tetrapack ma ancora grasso-saporoso, misurandolo con quartini e mezzolitri di
alluminio dal lungo manico) ; 9 Pittaluga Bartolomeo ; 9a
Pittaluga Gandolfi e C ; 10a eredi Monticelli (vedi in via N.Daste) ; 10,10b,11,12,13,14 eredi Samengo (vedi).
===civ. 8: Una carta del 1853, mostra questo sito su cui il sig. Morasso
Angelo chiese poter costruire una casa, alta solo 7,15m e distante 5 m dal
muraglione delle ferrovia che è alto 6,10 m (quando essa era a doppio binario; oggi è raddoppiato e la distanza
dalla casa quasi azzerata).
Nel 1904, vi fu costituita la soc. di Mutuo Soccorso Muzio
Scevola, che svolgeva assistenza generale, ed aveva come presidente
onorario il sen. Nino Ronco.
Nei suoi giardini, venne successivamente eretto il palazzotto della Croce d’Oro
( la cui vicinanza ha portato all’errore
alcuni storici che danno la SMS residente al civico 10 dove invece è la Croce). La sezione sportiva, organizzò delle gare
ciclistiche nel 1919 per “corridori
indipendenti e che non avessero mai vinto primi premi”.
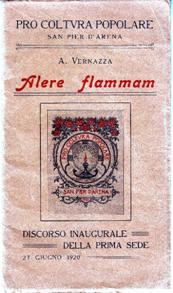
Ospitò, dal 27 giugno 1920, anno della
sua costituzione, l’Associazione Pro Cultura Popolare
avente “per iscopo l’elevamento morale ed intellettuale di tutto il popolo,
senza distinzioni politiche o sociali”. Il motto, come era costume allora, di
tipo classicheggiante, era “Alere flammam”. Ammesse le donne.
Presidente
era il prof. Angelo Vernazza; viceP. il prof Mario Biagi; segret. Oliverio
Olivari; contab. rag. Genesio Perazzo; econ. Carlo Moreno; tesor. Luigi Bonino;
consiglieri il maestro Antonio Rossi, GB Ferrando, Natale Barabino, Trieste
Belleno, Lorenzo Bianchetti
Un
primo impegno fu stampare il discorso inaugurale del Vernazza, seguito –firmato
dallo stesso- un libretto con la celebrazione del 1° Centenerio della nascita
di N.Daste; ed un opuscolo (1921) in occasione della “Prima mostra d’arte e di
tecnica”
Favorì (dal 1921) mostra d’arte di
autori operai; numerose serate danzanti; una grande fiera di beneficenza, con
balli e teatro a favore dell’ospedale civile; ed esibizioni filodrammatiche nel
teatrino sociale (in esso l’Accademia
filodrammatica Muzio Scevola programmava commedie anche in dialetto, come ‘o testamento
dö sciö Lumetti’ , ’O löu perde o vizio’, ‘Vi amo e sarete mia’ , ‘A paggia
vixin a-ö feugu’ , ’O miracolo’; dalle quali prese l’avvio professionale l’attrice
concittadina Bianca Zanardi, divenuta ‘ la
Duse di San Pier d’Arena’) .
Sopravvisse sino al nov.1933 quando si
fuse con la A.M.S. Fratellanza ed Amicizia di salita Millelire. Infatti nel
Pagano/33 è ancora citata.
Nel 1933 divenne la sede dell’ Istituto scolastico parificato Minerva, autorizzato dal ministero della
P.I., nato con lo scopo di preparare gli studenti con corsi di riparazione o
agli esami per qualifiche professionali quali disegnatori, meccanici,
elettrotecnici, corrispondenti commerciali ed interpreti, stenografi,
dattilografi comptometria e contabilità. Infatti offriva – con corsi diurni e
serali - seguendo un programma governativo ed esami interni - la possibilità di
ottenere, in un anno, licenza di avviamento commerciale, avviamento
industriale, scuola media e scuola tecnica commerciale + idoneità alla
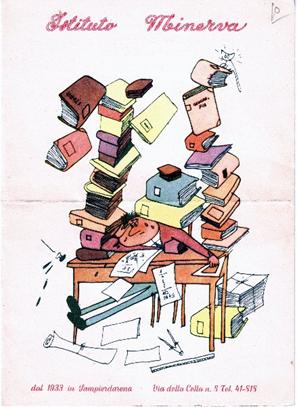
II,III,IV,V
classe superiore ragion.-geom.-macch.-capit. + corsi celeri per abilitazioni
per ragioniere, macchinsta navale e capitano di lungo corso. + qualifiche
professionali di specializzazione per disegnatori meccanici-esperti elettrotecnici
e corrispondenti commerciali ed interpreti nelle lingie estere. L’istituto
chiuse l’attività negli anni ’90.
Come direttore aveva il prof. V.Gabbarini, grande collezionista
di opere d’arte (soprattutto quale esperto
internazionale di ceramiche e quadri) da avere in casa (in corso L.Martinetti, 4/15) un museo
personale. E – si racconta – come insegnante il figlio della famosa
saponificatrice, che abitava in via Carzino
I locali furono affittati ad
altri, solo a piano terra: il vetraio per lunghi anni ospite si è poi
trasferito in via Gioberti. Ora, 2004, vi è un riparatore di elettrodomestici
gestito da un sudamericano.
L’edificio
sarebbe appetibile dalla vicina Croce d’Oro, che però trova insormontabili
ostacoli nei meccanismi di una eredità confusa.
Nelle
vicinanze, il sig. Marchisotti (grande e
polivalente atleta cittadino; Maestro dello sport; genitore del dirigente del
DonBosco calcio a cui è intitolato il più prestigioso ed antico torneo di
calcio locale con la DonBosco calcio; scomparso da oltre dieci anni) ricordò che in una “stalla” locale, si riunivano i
primi atleti della Società di Ginnastica Sampierdarenese.
===civ. 54r: dove era il vetraio; viene descritto dalle
Belle Arti che ci fosse una decorazione ad arco attorno allo stipite, di stile
liberty; che ora non c’è più (era ricerca
individuale negli anni a cavallo tra il 1800 e 1900, tentare di diversificarsi
decorando portoni e negozi con fregi; qui, un allargamento dell’accesso,
successivo all’epoca, troncò la cornice originale che ancora si intravedeva
nella porzione terminale prima che altri restauri ne cancellassero ogni traccia). Probabilmente è un errore nellarchivio delle Belle
Arti.
===civ. 43r La scuola guida Aquila, di anziana memoria. Nel 1933 a Sampierdarena, è
descritta solo l’auto scuola ‘Moderna’, in via
G.Carducci (via A.Cantore) 167r
===civ. 47r nel 2004-6
ospita la «Chiesa Evangelica Apostolica nel nome di
Gesù»
===civ. 49r-51r negli anni
70 erano occupati dalla ditta ALBA di Pirozzi Luigi, poi Pirozzi B. che
lavorava in lavoazioni di saldatura e riceveva elettrodi, punte int.,
bacchette, ecc.
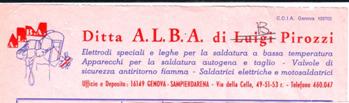
===civ. 10: si aprono i cancelli della soc. Croce d’Oro, servizio di ambulanze di
soccorso, attiva dal 1898.
Cinquanta anni prima della nasciata, con l’avvento
dell’industria e delle numerose attività artigianali, concomitarono sia una
enorme immigrazione di gente povera e senza assistenza, sia un aumento
vertiginoso di incidenti e malattie, sia la constatazione dell’eccessiva
lontananza dell’ospedale
Pammatone (considerati
i mezzi a disposizione e che il nosocomio era ubicato al di là del colle di san
Benigno che era quindi da scavalcare).

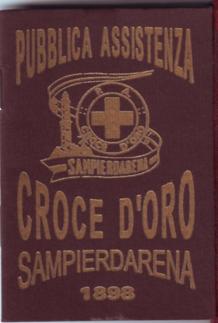
lapide in via San Pier d’Arena
Fu fondata per iniziativa di sette operai (sottoscrivendo un manoscritto, le
firme sono di Vittorio Landini (primo presidente), Nicola Crespi proprietario
del bar, Giovanni Corsani, Giovanni Savani, Renato Ramaciotti, Vittorio Gallo e
Carlo Parodi; l’ottavo, un toscano di nome Marconcini, sull’esperienza delle
misericordie toscane, diede l’idea, ma non partecipò; Fravega aggiunge un
Giovanni Santi) che per
primi -favoriti dalla sempre più forte necessità sociale di mutuo soccorso e
dalla contemporanea apertura dell’ospedale Masnata- provarono ad organizzare
questo servizio volontario, destinando il resto della loro consumazione a
formare il primo capitale dell’Associazione: infatti nell’osteria che
solitamente frequentavano, la caffetteria Crespi
in via Colombo (via San Pier d’Arena, ove ora c’è una lapide appesa al muro «nel luglio del 1898 / in
questo locale / a rudi lavoratri d’animo generoso / sorse l’idea di costituire
/ la P.A. CROCE D’ORO / nel XXI anniversario sociale / in segno di
riconoscenza»), la sera
del 30 luglio (si
precisa anche alle ore 21,30) decisero di organizzare e realizzare un primo servizio di
volontariato continuo; e versarono quale quota sociale 15 centesimi.
Il compenso era,
ed è, nella coscienza di aver compiuto un serio, faticoso e simil professionale
dovere sociale. La
Società, è divenuta nel tempo organizzatissima, efficientemente indispensabile
nel contesto cittadino; sempre presente nelle più svariate necessità, sia nei
quotidiani interventi di routine locali, sia quelli straordinari – abnormi o
pericolos - che sono stati attestati dalle innumerevoli citazioni e documenti
di ringraziamento e riconoscenza quando le vie di comunicazione erano difficili e lente, e le
località raggiungibili solo a piedi.
Nel disastro ferroviario a Mignanego dell’apr. 1905 (durante
un trasporto di truppe del 54° Reggimento fanteria: si ebbero quattro morti ed
i 25 soldati feriti furono da loro portati per cure a San Pier d’Arena, e per
l’abnegazione dimostrata, il Ministro della Guerra premiò la bandiera di una
medaglia d’oro); al terremoto in Sicilia nel 1908; per il colera in Puglia nel
1910; il crollo della diga di Molare nel 1935; una tromba d’aria al Fossato
portò inondazione e devastazione; esplosioni (della polveriera sia a
Borgoratti che nel forte Guano sopra Cornigliano e nei Docks Liguri); gli
eventi bellici mondiali (specie nell’ultima con i bombardamenti, i crolli ed il
rischio e pericolo diretto della propria vita); la grande alluvione del 1970;
il naufragio della London Valour, via Digione).
Una vera e propria ‘mania’ di altruismo e protagonismo
La prima sede fu in
affitto verso la fine di via don Bosco (allora non ancora santo) in
località Fornaci, ed il primo firmatario dell’atto di nascita ne fu anche il
primo presidente. In quella località, una foto testimonia le esercitazioni ed
il materiale in dotazione: carri barella trainati da animali su strade spesso
sterrate e barelle a mano.


zona Fornaci - a destra, la villa dei Salesiani
Trasferiti poi nella seconda
sede, in via generale Marabotto (via
D.Storace) poterono
comperare il primo carro-barella, visibile nella sede.
Nel 1901 la CRI
concesse l’uso di un sottopasso ferroviario
di piazza Ferrer (p.zaV.Veneto), a cui si aggiunsero per concessione Comunale e nel breve
tempo a seguire, altri due fornici (dietro gli scaffali per libri nella libreria ‘La bottega
del lettore’, ci sono ancora le bianche mattonelle poste sui muri, allora
necessarie in tutti i locali soggetti a pulizia più rigorosa come nei sanitari;
uno serviva da ‘pronto soccorso’ e gli altri da ‘dormitorio’. Presidente era
divenuto GB Ferrando).


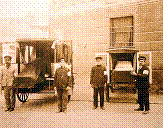
1908 la direzione sala del
Consiglio barelle coperte; traino a mano
Una foto del 1910, ricorda i soci
attivi nella ‘campagna colerica’ di quell’anno.

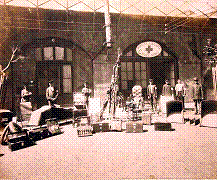

1911 - vano dormitorio davanti ai voltini
ferroviari carri-lettighe
Il 12 luglio 1911 il presidente
G.Elia Currò fece un discorso riassuntivo delle benemerenze. Ricordò la Medaglia d’oro avuta dal
Ministero della Guerra, da quello dei Lavori Pubblici, dai Municipi di
Sampierdarena, Rivarolo e Cornigliano, ed all’Esposizione di Milano del 1906;
medaglia di bronzo ai benemeriti del terremoto. Esaltò la raggiunta capacità di
poter eseguire contemporanteamente ben cinquanta trasporti.
Nell’apr. 1914 per concessione del
terreno demaniale da parte del CAP, fu costruita una apposita terza sede, una palazzina in via C.Colombo di soli 150 mq perché
con un piano in meno rispetto l’attuale (vedi
in via SanPierd’Arena, civ. 16).
Nel marzo 1921 la giunta diretta dal
sindaco Gandolfo, approvò la spesa di £. mille per la fornitura di “una
motocicletta per celere servizio di trasporto defunti per fatto violento”. Erano ancora tempi in cui ci si
doveva rivolgere a Pammatone perché nell’ospedale Masnata la camera mortuaria
era da restaurare e non aveva personale fisso di custodia. Nella moto era
applicabile una barella per le salme o un’altra per i feriti (spese di benzina,
chaffeur e manutenzione a carico della PA).
Nel gennaio 1922,
presidente L Schiappapietra, vennero inaugurati sia il ‘servizio medico
notturno’, che ‘servizio medico domiciliare’ in epoca in cui la mutualità non
copriva tutta la popolazione e lasciava fuori proprio le fasce più deboli: 23
medici (50 scrive, Anfas: praticamente tutti) della città, a servizio della
Croce. (nella foto
sotto è visibile lo stabile, ove allora aveva sede la Pubblica assistenza).
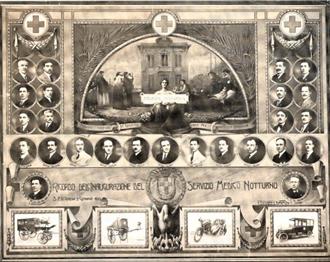

staff medici servizio notturno con la seconda sede
motocicli, per servizio medico notturno
Forse sono di questi tempi, le prime ambulanze a motore; ed
un labaro che ricorda l’esistenza di un “corpo
musicale Croce d’Oro”.
Nel 1923 con
una lapide posta nel salone principale, vennero ricordati i nove iscritti
caduti nell’evento bellico precedente:
ANNO 1923
LAPIDE INAUGURATA NEL 1923
CADUTI IN GUERRA
1° APPENDINO LUIGI – CAPORALE del
1891
2° BONFATTI MICHELE – CARABINIERE 1892
3° ELIA CURRO’ ENRICO - CAPITANO
1893
4° FACCO GIUSEPPE -
TENENTE 1896
5° FERRERO NATALE - SOLDATO 1887
6° STORACE GAETANO - SERGENTE
1885
7° PAOLUCCI CINZIO - CAPORALE
1893
8° LANFRANCHI RAIMONDO - CAPORALE MAGG. 1897
9° ROSSI EMILIO - SOLDATO 1898
PER LIBERALE
CONCESSIONE
DEL
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA
AUSPICE
NINO
RONCO
(tra
essi DG Storace). Sul marmo furono aggiunti i nomi dei militi che persero la
vita nella seconda guerra.
 esercitazione anni ‘20
esercitazione anni ‘20
Una delle prime autolettighe acquistata negli anni
venti, fu ricavata rielaborando una Fiat 512 usata dal principe Umberto di Savoia per sposarsi con
Maria Josè del Belgio; l’auto storica, rimase funzionante anche nel dopoguerra.


Anche questa sede-casetta però ben presto si rivelò
insufficiente; così nel 1926 col
beneplacito del Consorzio essa fu venduta ad un privato.
Con la somma ricavata dalla vendita del fabbricato, la
società poté acquistare il terreno ed erigere l’attuale
quarta sede in via della Cella,

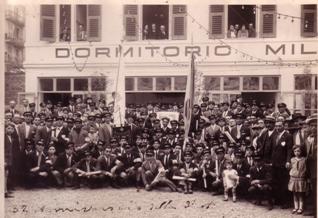
ingresso
1926 32° anniversario
rimanendo in debito di 230mila lire di allora (325mila lire per acquisto, 132,128
per adattamento, 15mila per mobilio, 65mila per lavori d’impianto); l’avvenimento è ricordato da una lapide posta nel salone delle adunanze, che dice : “ Per liberale concessione del CAP -
auspice Nino Ronco - la P.A.Croce d’Oro - presidente Ernesto Skultecki -
poteva - qui - erigere le sue sedi -- a testimonianza del beneficio - a -
consacrazione dell’avvenimento - gli amministratori - questo ricordo vollero -
MCMXXVI - con animo memore a maggiore gloria - in questa sede traslata - 1926
“.
In concomitanza, correva voce e fu oggetto di denuncia da
parte della CRI e del Prefetto, che il locale Fascio (che alloggiava in via
Mameli al civ. 1, e desioso di aprire una cooperativa di consumo) premeva per
occupare le arcate ferroviarie di p.zza VVeneto –occupate dalla CdO e ad essa
concessa dalla CRI che l’aveva primitivamente ottenuta dal Ministro dei LLPP
col consenso dell’Ispettorato gener. delle Ferrovie; e, dal 27 giu.1903
destinate all’esercizio di ‘stazione di Pronto Soccorso’.
In quegli anni, la bassa costruzione a destra subito dopo
il cancello d’ingresso, fu adibita a ‘dormitorio
militi’ -con grossa scritta della funzione, subito sopra le porte-finestre del
piano terra-, istituendo così questo servizio (necessario sia perché così già presenti all’atto di
una chiamata, sia perché potessero riposare essendo tutti volontari con un
altro lavoro da dover espletare).
Nel 1929, in
assenza di assistenza mutualistica, fu aperto un Policlinico con visite
specialistiche ed un laboratorio compreso radiologia, ed in cui prestarono gratuito servizio famosi medici locali
come E. Olivelli pediatra, T. Tosonotti
chirurgo, L. Masio medicina generale, P. Rettagliata ostetrico ginecol.
La società fu eretta in Ente Morale il 18
luglio 1930, acquisendo così anche
vita giuridica.


anni 1930
Sei sono i soci ricordati con un riquadro posto nella sala
maggiore, caduti nella guerra, nel periodo 1944-45.
Il labaro della società, è ricco di oltre 75 medaglie
d’oro di merito e riconoscimento, ottenute nell’arco di tutti questi anni.
Nel luglio1958
fu bandito un concorso di biliardo, a squadre, tra società.
Economicamente drammatico il febb/61 a seguito dell’ingiunzione di spesa di
15milioni di lire causa risarcimento danni per un incidente stradale accaduto
nel 1948. L’aiuto provvidenziale di altre società consorelle permise superare
questa difficile fase economica.
Nell’88°anniversario, 1986,
presidente Baldini (onorario don Berto Ferrari; sindaco di Ge. Campart), manifestazione per 5 gg. -ideata da DiGiuseppe Mino -
suddivisa in 4 sezioni, con premi per : ---poesia dialettale ligure ed in
italiano; ---gastronomia ligure (con menù fisso: “succu, trofiette, corzetti, buridda de
stocca, coboletti”);
---pittura – scultura – grafica; --- culturali (poesia, musica)
Ogni giorno cabaret, canzoni, concerto bandistico, ballo,
ecc..
Prima di entrare nella grande sala del consiglio, alla parete è appeso dal 1997 un quadro
donato dal pittore sampierdarenese Angelo Baghino,
volutamente inquietante e drammatico per il sovraccarico di colore nero, per
esprimere il dolore e la sofferenza di coloro -ed in particolare dei soci che
nell’ultima guerra furono soggetti a deportazione nei campi di concentramento
nazisti - alcuni
presenti anche nel periodo bellico, pagarono con la deportazione: di essi
vengono ricordati Andreani Amedeo, Baiardo Domenico, Dellepiane Irmo, Dondero
Stefano, Fraguglia Pietro, Giusti Bruno, Venanzini Aristide.
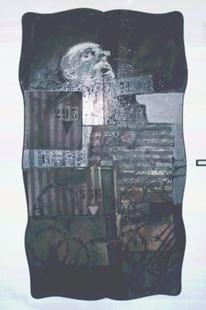


il labaro l’ingreso nel 2007;
l’albero di canfora nell’angolo
Con quattromila soci, solo pochi dipendenti, e l’opera di
trecento volontari è considerata all’apice degli interessi della cittadinanza
locale e della gente che la alimenta con donazioni e lasciti testamentari; la Croce si autoalimenta economicamente solo con
donazioni volontarie o attraverso le più varie e frequenti iniziative, a cui
la popolazione partecipa con interesse ed entusiasmo; attraverso una oculata e
sensibile amministrazione, negli anni è divenuta una delle più qualificate
dell’intera grande città: con 13 auto riescono a svolgete oltre settanta
interventi giornalieri i più dei quali urgenti; negli ambulatori si svolgono
visite specialistiche gratuite (in rapporto alla disponibilità dei medici) di
chirurgia, senologia, podologia, pediatria, ortopedia, terapia iniettiva,
prelievi ematici e controllo della pressione arteriosa.
In un garage, dall’aprile 1997
è in dotazione - in attesa di legislazione legata al ‘servizio 118’ - una
automedica attrezzata con tutti i necessari per l’intervento urgente di
rianimazione.
Nel 1998 i
cento anni di solidarietà vennero ricordati con una mostra fotografica al
centro Civico. Presidente era Massimo Bisca.
Negli anni 2010 è completamente rinnovato il parco auto,
con donazione di una ambulanza pediatrica da parte della famiglia Romano (prof. Romano Cesarino, valente primario studioso al
Gaslini di malattie metaboliche infantili, abitante a SPdArena, la cui
consorte è proprietaria della farmacia Croce d’Oro).
La saletta del bar è
ospitata alla base della palazzina centrale; ha dei soffitti e sopraporte
decorati con pregevoli stucchi



Nel salone, un grosso
tavolo al centro per riunioni dirigenziali ma offerto anche per riunioni di
associazioni; alle pareti numerosi ricordi e lapidi.
Alcune salette ai lati
del salone offrono spazio alla segreteria ed a quelle gloriose dei Donatori volontari del sangue e dell’associazione Carabinieri in pensione (in
quest’ultima si conservano foto del carabiniere Tirelli, qui fondatore della
S.M.S. e nonno della armacvista della s.Gaetano in via C.Rolando; e di Tosa,
del quale abbiamo titolata una strada).



soffitto del salone
la sede in via C.Colombo ricordo dei Caduti


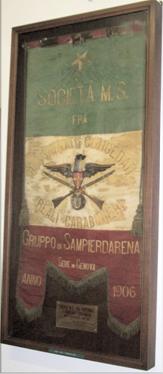
altorilievo
simbolico 1° premio al Carosezzo 1949
SocM.Socc Carabinieri
===civ. 66r (il Pagano/61 segnala al 64r la ditta
Dapelo&Macciò di cromolitografia), dove ora si accede tramite voltino ad un
atrio interno che oggi –a sua volta- da accesso a dei box (costruiti di recente
nell’area di una ex fabbrica) e ad un meccanico riparatore di roulottes (negli
anni
1960/80 si chiamava RARA=riparazione autoveicoli, roulottes ed affini):
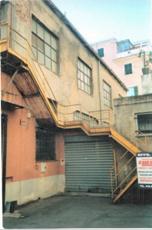
===civv. 16-20 Mi si dice che quando l’edificio fu
iniziato, l’impresa fallì e nacquero così dei contenziosi della proprietà
finché non divenne tutto di una Marchesa
NegrottoCambiaso che viveva all’estero.
Il portone è sormontato da due bassorilievi con cartigli
stemmati a richiamo religioso: uno reca la cifra IHS (con la croce sopra la h; significa
Iesus), l’altro la
stessa sigla incrociata con MV in basso (il nome di Maria Vergine). Evidentemente han dato sede ad istituti religiosi,
posti come sono sul retro dell’antica sede di don Daste. 
===il 18r
è un errore, perché assegnato ad un negozio di vernici e colori, che dovrebbe
avere il numero rosso; però inizialmente poteva essere un ingresso, poi
trasformato in negozio.
===Al civ 20 aveva sede il gruppo
Escursionisti C.Battisti.
A a più voci relative
ad una fabbrica di latta. ci segnalano che era localizzata a ponente, ovvero
al
===civ. da 67r- a 75r sono nel retro del palazzo, con progressione da
monte a mare e penso che, anche se ora sono in via della Cella, tale
numerazione faccia parte dell’antico nome che aveva: vico N.Bruno - Sino al 2010, emergevano dall’asfalto scorticato dal
tempo(foto↓), gli antichi ciottoli con i quali era pavimentata. In
quest’anno è stata riasfaltata ed essi sono nuovamente finiti sotto il bitume.
 Nel primo vicolo laterale, che
poi continua e contorna verso mare il palazzo che nella foto sotto è a destra,
sulla facciata a mare si apre un vano ‘tipo box’ col civ, 63r; di fronte ha una
serie di 79r legati a dei box di recente costruzione; nella foto si nota a
sinistra la antica lavanderia (vedi sotto).
Nel primo vicolo laterale, che
poi continua e contorna verso mare il palazzo che nella foto sotto è a destra,
sulla facciata a mare si apre un vano ‘tipo box’ col civ, 63r; di fronte ha una
serie di 79r legati a dei box di recente costruzione; nella foto si nota a
sinistra la antica lavanderia (vedi sotto).
Nel secondo vicolo laterale poco
più a monte del primo, ove ora un falegname (vedi
civ. 105r)↓, esisteva sino al 2010 un vecchio ingresso
(caratteristico) con porte di legno che molto probabilmente era quello
carrozzabile della villa Centurione che ora si apre in via Daste al civ. 28;
infatti finisce nel giardino del retro della villa. Negli anni 2010 detto
portale è stato demolito e sostituito dall’entrata di due box.
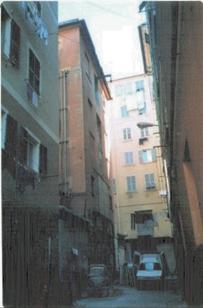

il vicolo chiuso
l’antico ingresso al giardino (ora box)
Non
facile individuare dove potesse essere negli anni 1920-30 la fabbrica dei succ. Raffetto
Angelo, anche loro impegnati nella lavorazione della latta per
conserva e metalli. Il Pagano/25 (vedi sopra) dice che erano al ===civ.67r (dispari, quindi a levante); ed a levante della strada, dietro alla casetta, nel
dic.2004 si sta demolendo un edificio con le caratteristiche dell’industria
(alto cinque piani, ampie e multiple vetrate con riquadri rettangolari). Questo
edificio, più recente è stato occupato dalla lavanderia
industriale Ciglia Maltis di Antola Franco che è andata dimessa negli
anni 1990 circa (negli anni 1977 una fattura è intestata a “Lavanderia Maria
Cilia srl – lavanderia a vapore e lavaggio a secco – steam laundry & dry
cleaning” – capitale soc. £.900mila interamente versato - – via della Cella 79r
– e firmata dal direttore dei servizi: Mario Calabria ). Nel 2004-5 è stata
abbattuta dalla soc. EcoGe per farne dei box ad un solo piano+tetto con ovvia
ampiezza di luce per chi abita nella zona; nella demolizione un tratto è
crollato improvviso, creando rumore e qualche danno all’edificio di fronte) che
potrebbe vantare la stessa appartenenza, anche se avrebbe i civ.rosso inferiore
al 67r (perché tale numero, è il primo del palazzo dopo).
 ................
................  ...
... 
la
lavanderia –nell’angolo a destra- vista da palazzo Serra
===civ.
13 si apre nel terzo vicoletto anonimo laterale; una volta la facciata
retro di questo palazzo era collegata con la villa (che viene descritta in via Daste) con un muro (oggi abbattuto e l’apertura porta a dei box
sotterranei alla villa stessa) e quindi
qui si apriva - negli anni 1930 - il ‘premiato pastificio
Monticelli B&B’ (per Pagano/61
era al civ. 17n; ora l’apertura è il civ. è 115r).
Su
quel muro su descritto, sulla facciata della strada quindi, prima dell’ultimo
restauro c’era un pregevole riquadro in rilievo (foto sotto↓) di forma poligonale,
raffigurante la Madonna con Bambino (all’arch. Storico di Pal. Ducale è scritto che era
stata restaurata nel 1957 e che era un quadro “dipinto su tela”) e che ora è scomparso. Era buona speranza pensare vi
sarebbe stato ricollocato alla fine dei lavori, ma essa appare vanificata:
l’immagine è scomparsa, l’ingegnere restauratore ‘non sapeva che ci fosse’;
alla fine, ‘nessuno’ ne sa più alcunché.
===civ.
105rosso – nell’interno del vicolo chiuso, antica
falegnameria che nel 1012 viene gestita da due
generazioni di artigiani; ora proprietari, dapprima avevano in affitto il
grosso locale, bivolume: nella parte più profonda, verso nord, di circa 30m² il
soffitto è in cemento, e sopra ha abitazione della antica villa; nella parte
più a mare il soffitto è ancora con vecchissime travi a capriata (foto↓) –
probabilmente ex alberi di navi perché di spessore diverso alle due estremità.


tetto
della falegnameria: interno ed esterno (dietro, la torre di villa Serra
Monticelli)
===civ.6 è
chiamato il caseggiato dei Lo Faro: a
cavallo tra 1800-1900, occuparono l’ultimo tratto libero del parco della vicina
villa Serra, quando era già sede del pastificio Monticelli e ad essa tolse
definitivamente la vista della loggia, caratteristica che per tanti secoli- di
essa o di quella a fianco dei Samengo- furono da sole a dare il nome alla zona
del borgo: i nobili ed antichi proprietari, affacciati dal colonnato arrivavano
a vedere il mare e godevano della quiete degli orti sottostanti; in molte carte
anche comunali, dire solo ‘la Loggia’ , era -come ‘la Cella’- indicativa del
posto, anche se in altri documenti, col termine ‘Loggia’ viene intesa la villa
seguente dei Samengo (probabilmente rimasta più a lungo a lasciar vedere spazi
profondi).
===civ. 8 ha sede la palestra
G.A.J. (Gruppi Autonomi Ju-jitsu) già gestita da Nicolino
Rosa famoso ed apprezzato maestro dell’arte orientale del jiu-jitsu,
seguendo il metodo del maestro Bianchi. Apprezzatissimo è il suo interessamento
e coinvolgimento anche di bambini subnormali, che possono trovare nella
palestra le attrezzature loro idonee e in questo sport uno sbocco emotivo, di
fiducia e quindi di inserimento. La palestra fu ristrutturata nel 1987.
Al termine, di fronte il loggiato, mentre invece restringe
la strada il fianco di ponente del palazzo Serra-Monticelli, descritto in via
Daste.



prima del restauro, logge tamponate; poi, saggiamente
riaperte.
Nella prima foto, nella costruzione a un piano, sopra le tre
finestre si vede chiaramente una Madonna con
cornice ottagonale: nell’abbattimento di questo edificio, essa è scomparsa.

verso il mare, dalle finestre di villa Serra
Come già detto, l’ultimo tratto che poi termina in via
A.Cantore, attualmente è sempre via della Cella, anche se sino all’apertura
dell’ultima grossa arteria (1935-6), era il tratto iniziale del corso dei Colli (corso L.Martinetti: i civv rossi 2-4-6 di quest’ultima
strada, divennero 84,86,88 della Cella nel 1955; e l’88r è l’ultimo della via,
con il 123r*** di fronte) .
DEDICATA alla chiesa che anticamente si apriva sulla strada
con ampio piazzale e che ora è descritta in via Giovanetti (ma, non essendoci
il nome della Madonna o della chiesa stessa, potrebbe anche essere dedicata alla
zona, sempre in base alla radice dal latino).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
S.Comunale Toponomastica - scheda 1060
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi- ed./94-pag.393---ed./02-pag.431
-AA.VV.-ANPAS
100 anni di volontariato-2004- foto 1910
-Castruccio
A&C.-Genova e paesi circostanti come ...-Mondani.1983-fasc.6.
-Costa E.-i
100 anni della s. Fratellanza Amicizia-DonBosco.1993-p.28.31
-DeLandolina
GC – Sampierdarena - Rinascenza.1922-pag.36
-Gazzettino
SPD’Arenese : 2/72.2 + 5/73.14 + 7/73.3 + 3/74.5 + 9/80.7 +
9/85.14 + 9/86.18 + 4/87.14 + 9/89.17 + 6/90.7 + 2/91.3 + 6/92.14
+ 7/93.4 + 4/94.7 + 3/95.7 + 9/95.7 + 4/97.22 +
-Grillo
F.Origine storica delle località e antichi...-Calasanzio.1964-pag.107
-Il Secolo
XIX del .1986 + 30.1.99 + 16.2.00 + 15.8.01 + 1.12.04 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.57
-Millefiore&Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag. 104foto
-Morabito&Costa-Universo
della solidarietà-Priamar.1995-pag.476
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.17
-Pagano/08–pag.873-9;
/33-pg.1539.1690; /40-pg.245; /61-pg.143.573.593
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.418
-Poleggi E.
&C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav. 34-50
-Remondini
A.-Parrocchie dell’archidiocesi-vol.XI-pag.77
-Tuvo
T.-Memorie storiche di SanPier d’Arena-dattiloscr.inedito-pag.48
-Tuvo&Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag. 19-20.284
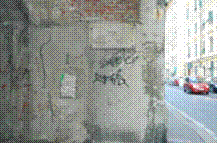
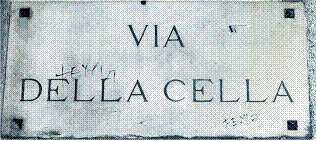

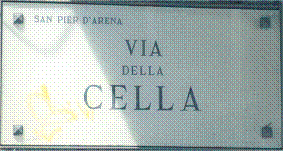

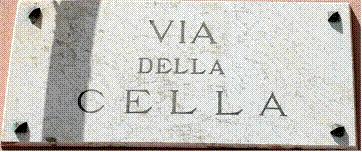
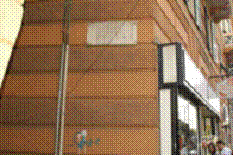
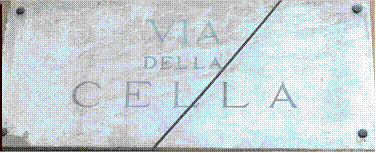
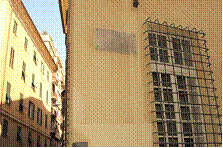
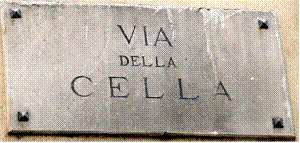
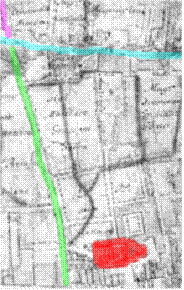 da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;
celeste, via NDaste; fucsia salita
Belvedere.
da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;
celeste, via NDaste; fucsia salita
Belvedere. da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8 Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via
G.Buranello.
Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via
G.Buranello. 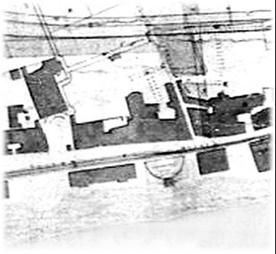




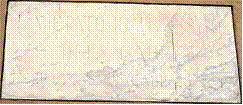




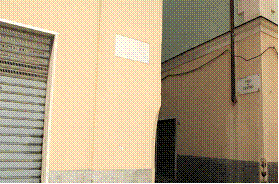


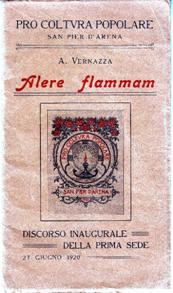
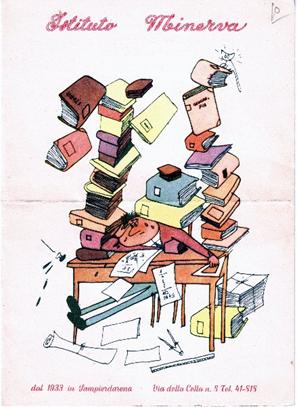
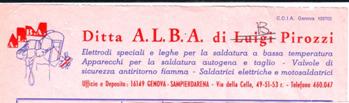

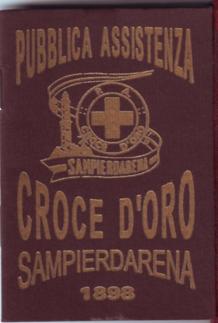




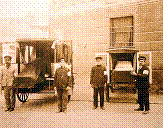

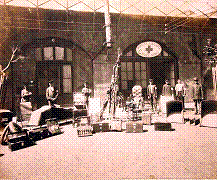

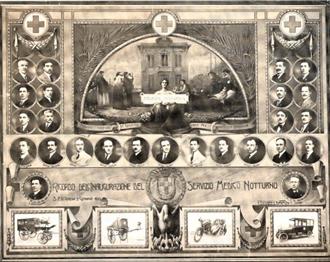





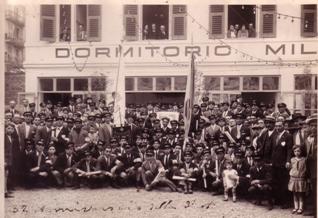


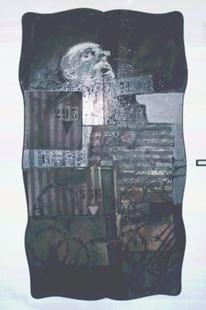










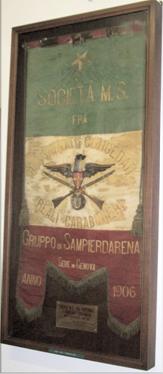
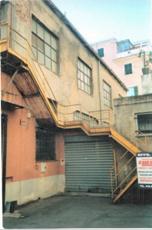


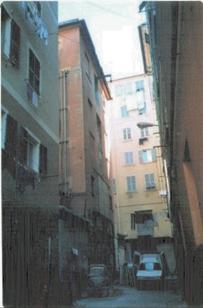

 ................
................  ...
... 





