fabbriciere
o segretario nella chiesa cittadina della Cella ove frequentava le
congregazioni del S.Rosario, del SS Nome di Gesù, o alla Dottrina; nonché in
Confraternita nell’oratorio di san Martino ed in quella ‘delle Anime’.

Fu
allora, probabilmente, che maturò l’idea della prevalente devozione alla
“Divina Provvidenza” quale appiglio a cui aggrapparsi e da insegnare, invocare,
pregare, quale collante nella catena Dio-offerta-uomini: “Dio per dare agli
uomini i serve degli uomini, tramite la DP; così alla fine gli uomini danno;
ma è la DP che ha fatto sì che loro diano”
Così, seppur tardivamente, solo a 40 anni fece esplodere una travagliata
vocazione, desiderata ma sempre oppressa per altre scelte di più immediata
apparente importanza. Decise quindi nell’agosto del 1860 la via del sacerdozio,
abbandonando il lavoro presso lo zio ed il fratello che continuavano l’opera
paterna.
Risultando tardi per entrare in seminario, per la formazione teologica provò a
rivolgersi all’insegnamento del sac. Vincenzo Carlini allora parroco di Masone
e custode della cappella gentilizia nella villa Rostan a Multedo: come suo
discepolo trascorse solo 4 mesi, quando sentì il bisogno di avere basi più
solide: preferì trasferirsi alla Certosa di Rivarolo ospitato in due stanze dal
medico Garello sperando apprendere dal parroco –un suo omonimo- di più, della
lingua latina e filosofia; ma anche qui, fu subito ‘sfruttato‘ quale
fabbriciere e soprintendente ai lavori per cui preferì cercare –accettando un
periodo di prova- presso la chiesa di san Pancrazio assumendo l’incarico di
inserviente. Ma alla fine ritornò da don Carlini per affrontare i temi della
teologia, ospite nella villa Rostan: qui, rientrato in sintonia, riuscì a
concentrarsi nello studio e rafforzare la chiamata, fino a che tutto si
completò a 46 anni, nel 1866: dopo un ritiro a Campi dai frati Cappuccini, subì
la cerimonia dell’abito talare, la tonsura e gli Ordini Minori (da mons.Filippo Gentili, vescovo di
Novara in quel tempo alloggiato a Genova nel suo palazzo patrizio). A questo, seguì la promozione a suddiacono (da mons. A.Charvaz), e poi a diacono (a san Michele di Pagana da mons Pallavicino).
Infine fu ordinato sacerdote a 47 anni, il 24 giu.1867, (festa di san Giovanni Battista); e la prima messa fu da lui celebrata il 29
giugno (festa di san
Pietro) alla Cella, dove rimase ad
esercitare il suo ministero, irradiando quel fascino e carisma che lo
accompagnerà per tutta la vita sacerdotale: un potere irresistibile che
accomunò nel giudizio ed ammirazione poveri e ricchi, credenti e non (SPdA era ‘roccaforte del
socialismo, con forti matrici anarchiche e quindi anticlericali; ma non era il
credo politico che faceva fare differenze nell’essere disponibile sempre ed a
tutti. La gente ‘sentiva’ che lui era al di sopra della politica).
L’anno dopo, madre Angela Massa delle
Franzoniane (era Madre superiora del convento, ove
già da più di cent’anni (dal 1751) era prioritario
l’interesse del problema specificatamente coinvolgente la classe sociale degli
operai; e della loro famiglia, sopratutto le orfanelle, divenute prive di
qualsiasi sostentamento sociale, affettivo ed educativo): non avendo consorelle a numero sufficiente per
gestire l’istituto, si affidava a pie coadiutrici esterne come la concittadina Apollonia Dellepiane animata di carità ed
ispiratrice dell’iniziativa di occuparsi in casa sua di nove fanciulle rimaste
orfane di operai concittadini deceduti).
Dovendosi trasferire a La Spezia, cercò come affidare l’organizzazione delle 12
orfanelle che teneva riunite. Si rivolse dapprima al direttore don PietroPaolo
Gallo –e questi rigirò il problema a don Daste.
Possiamo immaginare la personale sensazione di incapacità ed impreparazione:
un incarico impari alle sue modeste capacità. Ma impossibile dire no. La Divina
Provvidenza lo avrebbe aiutato.
Così, don Daste, caricato dell’onere totale del mantenimento di questo impegno,
coadiuvato dalla stessa Dellepiane -divenuta suora- e da altre animatrici come
suor Caterina Cipollina e suor Ghio Giulia, dapprima le portò in angusti
locali di via san Bartolomeo, poi in via Bombrini, via Goito, piazza Capitan
Bove (in palazzo
Boccardo) ed ultimo, quando le ragazzine
erano diventate 30 o 40, in via Mameli (cioè via Carzino, nella casa di proprietà del principe
Centurione; questi volle venderla al sacerdote per una minima cifra (25mila
lire), che fu raggranellata con la vendita dei palchetti del teatro Modena e
l’aiuto di benefattori).
Al sacerdote -in base alla regola dettata per prima “al bambino è dovuto il
massimo rispetto”- toccò questuare, educare, alimentare, vestire.
Ma
per lui non era problema il proporsi quotidianamente agli altri nella maniera
più umile, facendosi riconoscere ovunque come il “poverello di San Pier
d’Arena” ed accumulando aneddoti della sua bonaria, disarmante semplicità e
visione ottimistica della vita (oltre il colera nel 1886 ed il terremoto del 1887 -nel
ponente ligure, con Bussana distrutta-, si dovette affrontare la miseria
quotidiana di tanta gente in una città in piena trasformazione sociale: sono
anche gli anni di San Pier d’Arena appena riconosciuta città, di don Bosco
attivo a san Gaetano; ma anche gli anni in cui i ricchi borghesi che gestiscono
il potere al posto degli aristocratici, decidono per l’industrializzazione, e
si scontrano con le masse degli operai sfruttate e anelanti a nuovi migliori
diritti, primo tra tutti la protezione dei più deboli). Schierandosi apertamente dalla parte dei
disperati, ne assunse tutti gli oneri, anche se apparentemente preziosi solo allo
spirito; ma -riuscendo a creare nei facoltosi il bisogno alla carità- ottenne
così il contemporaneo plauso di ambedue le classi sociali. I suoi fagotti
raccoglievano tutto il possibile, ed in tutto il circondario genovese (arrivava a Ronco, a Gavi, in riviera;
quando tornava, per concessione amministrativa locale passava liberamente senza
pagare il dazio; anzi a volta gli veniva aggiunta altra merce sequestrata) per migliorare la sua casa ove mancava tutto, dalle
seggiole ai letti, dal fuoco per l’inverno al cibo quotidiano. Gli aiuti più
vicini, nel limite, arrivavano dal parroco della Cella don Francesco Olcese,
dal vescovo (prima
mons.Andrea Charvaz, poi Salvatore Magnasco ed infine Tommaso Reggio), dal Comune (il sindaco Federico
Malfettani e l’assessore -il pittore Orgero- promossero ed ottennero dal Consiglio una retta fissa tratta dal
bilancio comunale, idonea ad aiutare l’istituto), dalle varie Società Cooperative (che seppur di idee differenti, non facevano mancare
generi alimentari), dalla stessa UITE
che lo faceva viaggiare gratis. Era divenuto un prete speciale, un prete che
applicava il concetto di povertà andandola a cercare nella strada e
portandosela a casa; non faceva questua ma offriva umilmente se stesso per
ottenere la carità: questo suscitava rispetto non solo nei benestanti quanto
soprattutto in tutti coloro che come lui dovevano lottare per sopravvivere e
che -malgrado ciò- lo eleggevano non concorrente ma nobile alleato da
rispettare.
Gradatamente realizzò nuove regole di vita per sé e per i propri collaboratori,
dando inizio ad una nuova Opera ed alle Figlie della Divina Provvidenza, con
regole nel 1873 (e
poi riscritte aggiornate nel 1916, 1950, 1982); devozione particolare alla Madonna onorata sotto il titolo di N.S.
della Divina Provvidenza la cui festa solenne cade la seconda domenica dopo
l’Epifania. Patroni dell’opera sono san Gaetano da Thiene (1480-1547, il santo della
Provvidenza), san Girolamo Emiliani (1486-1537, detto padre degli orfani); sant’Angela Merici (1470 ca-1540 una delle prime a raccogliere le
orfanelle) e sant’Orsola martire; gli
abiti debbono essere i più semplici e modesti; requisiti fondamentali l’umiltà,
l’affetto da donare ed un’instancabile operosità.
Dal
1887 compaiono delibere della Giunta comunale mirate ad esentare del
pagamento del dazio per l’Istituto, da pagarsi all’’inroduzione di generi
alimentari diversi’.
Nel 1891 il sacerdote presentò domanda poter murare, sotto la nicchia
esistente nell’angolo nord del palazzo, “una tavola sostenuta da mensolette di
ferro e ornata all’intorno con una mantovana metallica”: sulla quale poter
apporre fiori, candelieri o paramenti. Il tutto corredato di progetto
dell’ing. Salvatore Bruno. Il parere della Giunta fu positivo. Ma nulla si
rivela circa la statua contenuta nella nicchia.
Il 6 dic.1892 aprì una casa anche in Sestri Ponente, cittadina dallo
sviluppo tumultuoso dei cantieri e dell’industria, e per i giovani precaria
come San Pier d’Arena, affidata alla direzione di suor Agnese
Morasso. Pochi mesi prima, il re UmbertoI, in visita a S.P.d’Arena, o
aveva lodato e gli aveva fatto pervenire una offerta in denaro.
Dopo un intervento agli occhi per cataratta, nell’inverno si pose a letto e
morì settantanovenne poco prima della mezzanotte del 7 febb.1899.
La
giunta comunale nelle figure del sindaco F. Malfettani e dell’assessore Orgero (che tante volte l’avevano aiutato
anche con donazioni personali), riunita
d’urgenza deliberò all’unanimità lutto cittadino con la bandiera a mezz’asta,
le spese per il rito funebre e un posto distinto al cimitero della Castagna. Infatti, la mattina seguente, in Comune
avvenne una seduta straordinaria, per commemorare la contemporanea dipartita
del prete e dell’ing. Nicolò Bruno. Per il prete, la relazione scrive che il
sindaco Federico Malfettani “alzatosi in piedi, pronuncia le seguenti parole:
signori Consiglieri, la vostra Giunta...commossa da tanta sventura, che rapiva
persona sì eletta, da tutta San Pier d’Arena rimpianta, che sol visse di
carità, per il bene dei sofferenti; il sacerdozio esercitando evbangelicamente,
affatto mondo da terrene intenzioni; tutte le sue sostanze, tutte le sue cure e
fatiche erogando per il sostentamento dell’Opera pietosa da Lui fondata; dalla
quale da anni traggon pane e vita morale tante povere fanciulle derelitte; la
vostra Giunta, onde render solenne tributo di stima e di amore a cotal angelo
di bontà; a chi serenamente moriva in aureo vivido cerchio da tutti benedetto,
interpretando i vodstri sentimenti, qui decise radunarvi per sottoporre alla
vostra approvazione le proposte alle disposizioni pei funerali cui è caso: Vi
propone quindi oltre all’aver già provveduto che la bandiera di tutti gli
stabilimenti comunali sventoli per quattro giorni abbrunata, di assegnare una
tomba d’onore nella cappella del cimitero civico alle spoglie venerate”.
Presero parola vari consiglieri tra i quali il geom. Pietro Giacomardo che
espresse il parere dare titolazione al prete per tratto di strada sino ad
allora detta ‘via Mercato’; altri che promossero non lasciar morire l’opera del
prete, sussidiandola; lo stesso Pietro Chiesa socialista, propose “ascrive a
mio dovere l’affermare che le proposte della Giunta onorano ogni partito che
simboleggi la carità, il sacrificio, il lavoro. Quando un uomo come don Daste
muore povero, mentre povero non era quando intraprese il suo apostolato, è
debito civile onorarne la memoria”.
Non fa stupore quindi che ai solenni funerali,
partecipò tutta la cittadinanza, con tutta la municipalità ed autorità genovesi
e delle delegazioni limitrofe. La messa fu
celebrata dal parroco delle Grazie, don Costantino Zenega; il carro – di prima
classe - fu offerto dalla ditta Robba. Continuò così la gara ad ancora ‘dargli
qualcosa’ che potesse soddisfare l’esigenza interna di tutti di essere stati
vicini all’ “Uomo più grande di SanPierd’Arena”.
Tutta l’opera del piccolo prete, con la sua morte ebbe un
‘rialzo di quotazione’: lo stesso Consiglio comunale nel marzo successivo
convenne sulla “utilità che ne deriva alla città dell’esistenza dell’Istituto
della Piccola Provvidenza (sic)”, e prospetta “convenienza del Comune al
concorrere al miglioramento di detto istituto nell’interesse generale della
Cittadinanza...”. Cosicché altre case furono aperte in Prà (1932), in alcuni
asili parrocchiali (1946) ed in India (1979). Assunse le redini della casa quale direttrice suor Clotilde Pavan (probabile già colaboratrice e facnte arte del comitato
pro-lapide), mentre fu sostituito come
direttore dell’opera da don Anacleto Cotta.
Datato 20 genn. 1901, un comitato
composto da una ventina di cittadini si propose - davanti a notaio -
sobbarcarsi l’onere di porre una lapide nella
facciata del palazzo dell’Istituto in via Mameli (vedi anche via
Carzino).
La cosa si realizzò nel 1905. In
occasione dell’inaugurazione della lapide (il marmo era stato disegnato dall’ing. Sirtori e donato dal
cav. Mazzino - vedi
descrizione a ‘via G.Mameli’ e ‘S.Carzino’), fu a lui intestata anche la strada adiacente.
L’ing.
Pietro Sirtori, faceva parte del comitato per l’applicazione
della lapide del prete don Daste in via Mameli (Carzino); era esponente politico
nella Giunta, rappresentante il Partito Popolare fondato da don Sturzo; in
quanto assessore ai Lavori pubblici, era stato progettatore del Piano Regolatore
che prevedeva – tra l’altro - una grossa strada centrale (v.Cantore) ed una a
mare (Lungomare Canepa) le quali, allora, non furono realizzate per
l’assorbimento nella Grande Genova; dopo la devastazione fascista -1924- sia
del Circolo della Gioventù Cattolica intitolato a Giosuè Borsi (vedi via
Carzino) che della Cooperativa di Consumo intitolata a Giuseppe Toniolo, diede
– assieme a suoi quattro colleghi di partito (Bono, Ferrea, Penna, Platone) - le
dimissioni (ottobre) dalla civica amministrazione, malgrado le formali scuse de
Direttorio fascista locale.
Il
13 genn.1905 il sindaco N.Ronco fece assegnare definitivamente la tomba del sacerdote; il feretro, dopo le dovute
riparazioni (effettuandosi la cerimonia in forma solenne) il 7 aprile fu traslato
dal Pronao (ove era nel
posto n° 22) al ‘suolo della Chiesa’...
‘più vicino all’altare della Cappella’, sulla quale fu collocato un cippo
molto semplice, dello scultore Giuseppe Frondoni, recante la scritta “sac. Nicolò Daste - benemerito fondatore del Pio Istituto
della Provvidenza - 1820 - 1899 “ e
soprastante, un tondo con olio raffigurante il sacerdote, curato dal pittore
Angelo Vernazza.
Il 6 luglio 1924, dopo 25 anni dalla
morte, a cura di don Davide Lupi e con autorizzazione e origanizzazione del
sindaco Manlio Diana, la salma fu novamente traslata
con grande cerimonia (comprendente
corteo, sosta e messa alle Cella, commemorazione al Politeama Sampierdarenese,
trattenimento delle 150 orfanelle ospitate. Pubblicazione di una biografia) in una cappella della casa madre, ovvero nell’istituto
ora a lui dedicato nella villa di salita Belvedere 2. La tomba in marmo, fu
disegnata e scolpita dal prof. Daniele Danusso, torinese.
Il 20 magg.1965 le spoglie mortali del
prete vennero nuovamente e definitivamente traslate
in una nuova cappella (sempre interna nell’istituto ed aperta col generoso contributo di un
imprevisto donatore, il prof. Marino Cortese zoologo: aveva suggerito ad una
cliente di fare una donazione ad un istituto, questa scelse il don Daste ed dal
successivo ringraziamento nacque la conoscenza e la donazione; nel 1962,
durante i lavori di fondamenta, fu fortunosamente ritrovata una grossa bomba
inesplosa. La cappella fu consacrata dal card. mons.G. Siri) ponendo la grossa lapide sul lato sinistro del
presbiterio (con la scritta : “ SACERDOTE - NICOLAUS DASTE -
1820-…1899…..?”***) , di lato all’immagine della Madonna venerata dalle suore,
dipinta dal francese Pierre Mignard e da lui chiamata “Vierge au grappe” (o
drappe?)
Interessanti voci, dicono -già dal 1992- di una proposta di beatificazione: si
stanno ricercando testimonianze, informazioni narrazioni di eventi che possano
portare alla valutazione dell’apposita Commissione vaticana; è comunque un iter lungo e minuzioso
alla cui base occorre che la pratica sia corredata da precise testimonianze di
un evento miracoloso accaduto a qualcuno dopo una sua invocazione; sarebbe un grande onore per San Pier d’Arena.
BIBLIOGRAFIA
Gli autori in verde=già
trasferita la bibliogr. a Largo Gozzano (x villa imperiale).
In rosso restano qui a Daste.I
bianchi, da controllare.
-A Compagna-Gente di Liguria, Almanacco-1971-pag.297
-A.sconosciuto-storia del trasporto pubblico a Ge.-Sagep.1980-pag.157
-Alizeri F.-guida
illustrativa per la città di Ge.-Sambolino.1875-p.650-653
–Archivio
Storico Comunale - Toponomastica.
-Assereto G.-La città fedelissima-Ferraris2007-pag.224.227
-AA.VV-Agenda de “il Cittadino” 2009- pag. dei giorni 20
gen.+ 10 luglio
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.400—ed./02-pag.438
-AA.VV.-Catalogo
delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag.42-3.172-185
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.51-63.71-76 foto
-AA.VV.-Pierre
Puget-Electa.1995-pag.240
-AA.VV.-Rubens a
Genova-mostra 1978-pag.148(grotta
Pavese)
-AA.VV.-Scultura
a Ge. e in Liguria-Carige-vol.I-pag.393
-Baldassarre&Bruno-Schedario
degli uomini illustri in Savona-1981
-Battilana
N.-Genealogia delle famiglie nobili..-Forni.1971-vol.II-pag.134
-Bitossi
C.-Personale e strutture dell’ammin....-SocLiStPatr.1987.pg.216
-Boccardo
P.-L’Età di Rubens-Skira.2004-pag.218
-Boggero F.-Andrea
Ansaldo un pittore genovese...-Sagep.1985-
-BuonoRaffoE.-personaggi
genovesi nella storia-LionClub2006-pag.48
-Cadelli don G-il
poverello di S.Pier d’Arena-Tipog.Daste.1992-
-Cappi
G.-Ge. e le due riviere-Rechiedei.1892-pag.108
-Castagna.Masini-Genova
guida storico artistica-Masini.1929-pag.447-8
-Cavallaro G.-Ospedale
civile di SPd’Arena-Pagano.196_-pag.86.115.117
-CilientoB.BoggeroF-un ciclo inedito di Giovanni-Storia Arte n.49-1983
-Costa/1922- guida
genovese
-DeLandolina GC-
Sampierdarena-Rinascenza.1922- pag.17.18.39
-DeNegri
F.-l’abate Paolo Gerolamo Franzoni...-BuonaStampa.1954
-DiRaimondo&Muller-B.Bianco
e Genova-ERGA.1982.pag.65
-Dolcino
M.-Enciclopedia dei liguri illustri-vol.2-Michele Canzio
-Doria
G.-Investim.e svil.econ. a Ge.-Giuffrè.1973-vol.II-pag.235.425.772
-Doria G.-Nobiltà e investimenti in età moderna-Brigati
95-pag273
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.17-8.47
-Durante A.-don
Nicolò Daste-donDaste.1984-pag.84
-Fajella
T.-La casa delle madri Pie-Mensile “Liguria” n. 2/61.pag.31
-Favretto
G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.175
-Ferrando.Mannoni-Liguria-Sagep.1993-pag.92foto71 villa Doria non Grimaldi
-Felloni G.-Gli investimenti finanziari
genovesi-Giuffré.1971-
-Fravega
R.-su il Secolo XIX del 1/1987
-Gazzettino
S-: 2/72.7 + 2/73.3 +
3/73.7 + 4/73.5foto + 8/73.8 + 7/74.8 + 10/76.3 + 1/77.10 +
5/78.3.6 + 7/78.18 + 9/78.13 + 10/78.3 + 4/79.9 + 8/79.1 + 7/80.3
+ 1/81.3 + 1/83.4 + 8/83.2 + 2/84.13 + 3/84.7 + 5/84.12 +
8/84.11 + 9/84.11 + 6/85.8 + 9/85.5 + 1/87.9 + 9/87.3 + 9/88.2 +
6/89.3 + 8/89.12 + 2/91.3 + 4/91.3.5 + 9/91.5 + 9/92.5 + 10/92.5
+ 5/93.5 + 9/93.7 + 2/94.7 + 8/94.9 + 8/95.1 + 1/96.5 + 4/96.9 + 4/97.6 +
5/98.7 + 8/98.4 + 03.02.4 + 10/02.9 + 03/03.7 + 04.03.3 + 08/04.7
-Genova
Rivista municipale : 6/34.474 + 12/37.XXVI + 2/38.50 + 1/39.6 +
2/41.79 + 7/67.20 + 12/67.50pag.verdi +
-Gregori
M.-Pittura murale in Liguria -SanPaolo IMI.1998- vol.IV-pag.79
-Guida
di architettura-Allemande-pag.221
-Il Cittadino del 21.12.08 + 23.11.08-pag.13
-Il
Giornale-quotidiano- PraeGiordan 31.01.2010 p.52
-Il
Secolo XIX del 15.1.99 + 24.03.02 + 2e14/3/04 +
-Lamponi M.-
Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.59.63
-Leonardi A.-L’Età di
Rubens-Skira.2004-pag. 445
-Leonardi A.-Dipinti per i
Gavotti-Edit.Tipogr.2006-pag.429.437
-Levati PL-Regnanti a Ge.
nel sec.XVIII-Gioventù.1910-pag.7.13.19.56.
-Levati PL-Dogi
biennali-Marchese & Campora.1930-vol.I-pag. 261
-Lupi D.-conferenza nel XX
annivers.della sua morte-DonBosco.1919-
-Magnani L.-tra magia,
scienza e “meraviglia”...-Sagep.1984-pag.20foto grotta
-Magnani L.-Il tempio di
Venere-Sagep.1987-pag.90.125foto
-Marcenaro
E. su Il Secolo XIX-: 2/3/01 La grotta Pavese
-Marchini
L.-Biblioteche pubbliche a Ge-SocLiStPatr.XX.f2.1980-pag.57
-Medulla M.-Sampierdarena, vita e immagini...-DeFerrari 2007
–pag. 20
-Millefiore.Sborgi- Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.’86-pag.118.120
-Miscio
A-La seconda Valdocco-Elledici.2002-vol.I-pag.106.221.345
-Moretti
AM-MMusica e costume a Ge.-Pirella.1990-pag.58.205
-Novella
P.-Strade di Ge-manoscritto bibl.Berio-1900-30-p.11.18.19.26.32
-Oliveri mons.G.-Abate Gerolamo Franzoni- Il
Cittadino-18.03.08-pag. 18
-Oliveri mons.G.-don Daste-Il
Cittadino.10.06.2007-pag. 16
-Pagano/33-pag.246.483.872.1982;
/40-pg.270337--/1961-pag.179.593
-Pallavicino
G.-Inventione di scriver tutte le cose...-Sagep.1975-pag.83-86
-Parma E.-Il cinquecento-Microart’s per
Carige.1999-pag.340.
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di
Ge.-Tolozzi.1985-p.310.552
-Pescio
A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.145
-Pesenti
FR.-La pittura in Liguria Primo 600-Carige.1986-pag.13.125.155
-Piastra
W.-Dizionario Biografico dei Liguri-Brigati 1992-vol.IV-pag.99
-Piersantelli
G-Storia delle biblioteche civiche genov-Olschki.1964-pag.41
-Pizzagalli
D.-la Signora della pittura-Rizzoli.2003-pag 214
-Podestà.Musella.Augurio-i Serra-Testo&Immag.1999.pag.161.188.494
-Podestà E.-uomini monferrini signori
genovesi-Pesce1986-pag.249
-Poleggi
E.-Genova una civiltà di palazzi-Silvana.2002-pag.90
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav. 34.35.51foto
-Puncuh
& AAVV-il cammino della Chiesa genov.-Q.Franzon-1999-p.382
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.218
-Ratti CG -Instruzione di
quanto può...-Forni1780-vol.I-p.385-vol.II-p.112
-Remedi A.-Documentazione
inedita o molto rara...-dattiloscr. 2011
-Remondini A.-Parrocchie dell’archidiocesi-vol.XI-pag.
70.131.282
-Roberto F.-L’edilizia
residenziale pubb.-C.dei Librai-1999-.143, sch.131
-Rocchiero
V.-GBDerchi-Fassicomo.1987 per Fenespart-
-Roscelli D.-Nicolò
Barabino-soc.Universale.1982-pag.153-4
-Santamaria R-Luca Cambiaso-ricerche
e restauri-Brigati2009-pag.103
-Scorza A.MG-Le famiglie nobili genoveso-Olivieri 1924-
-Semeria
GB-Secoli cristiani della Liguria-1843-vol.I-pag.357.386
-Tuvo T.-SPd’Arena come eravamo- Mondani.1983-pag.156.159.165-8.171
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.’75-p.83-4.106fot152
-Verzellino GV-Delle memorie particolari...-
Bertolotto.1891-vol.2-pag.105.151
DASTE vicolo Daste
viene
citato dal regio Commissario straordinario, nel proporre alla giunta comunale
il 31 dic.1900 un elenco di vecchie strade, da rinominare o modificare, ed a
cui aggiungere quelle nuove. Nel descrivere questo vicolo, lo si pone “ a
notte di via Polcevera” (quindi “a nord di via G.Tavani”).
Fu poi scelto diversamente; titolato, ufficialmente divenne ‘via Calatafimi’ (via C.Orgiero); così la proposta iniziale cadde definitivamente.
Si presume che il nome Daste non sia attinente alla casa di nascita del famoso
prete, anche se il vicolo al suo finire verso la marina poteva affiancarla
quando, allora tutto i mezzo a prati, finiva incrociando via san Cristoforo.
Piuttosto sia legata all’abitazione di altri Daste, omonimi sufficientemente
ricchi da avere nel vicolo ben tre case: i civici 4b, 4d e 4e di via Polcevera , case poi vendute
separatamente ad un Somano ed un Bianchi).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
DATTILO via
Cesare Dattilo
TARGA:
San Pier d’Arena – via – Cesare Dattilo – caduto per la
libertà –1921 – 23·3·1945
Via – Cesare Dattilo – Oscar – caduto per la Libertà –
1921-23.3.1945


angolo con
via C.Rolando


angolo con
via M.Malfettani


angolo con
via P.Cristofoli
QUARTIERE ANTICO: San
Martino
 dalla carta del Vinzoni 1757. In
giallo via C.Rolando; celeste, via A.Scaniglia; rosso, ex-via N.Daste; fucsia
ex crosa dei Buoi; in verde vico dei Disperati e blu la ex-villa Lomellini di via
GBMonti 20.
dalla carta del Vinzoni 1757. In
giallo via C.Rolando; celeste, via A.Scaniglia; rosso, ex-via N.Daste; fucsia
ex crosa dei Buoi; in verde vico dei Disperati e blu la ex-villa Lomellini di via
GBMonti 20.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2765
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 21440
UNITÀ URBANISTICA: 25
- SAN GAETANO
 da Google Earth 2007. Fucsia, via
GBMonti; giallo, via LFarini; celeste, via PCristofoli; verde inizio e fine
dalla nostra via.
da Google Earth 2007. Fucsia, via
GBMonti; giallo, via LFarini; celeste, via PCristofoli; verde inizio e fine
dalla nostra via.
CAP: 16151
PARROCCHIA: san
Gaetano e san Giovanni Bosco
STORIA della strada:
è una strada nata agli inizi del secolo quando iniziò la lottizzazione dei
giardini ed orti delle varie ville locali (vedi via C.Rolando), vicino alla
zona detta delle ‘fornaci’.
La
cronologia dei nomi della strada, è un po' difficoltosa: nacque agli inizi
secolo 1900 ufficialmente intestata dalla giunta municipale come via Pastrengo,
ovviamente nell’onda enfatica del Risorgimento, da via A. Saffi (via C.Rolando) a via GB.Monti.
Il
19 ago.1935 fu trasformata in via E.Rayper.
Negli
anni dell’ultimo conflitto, per decreto del podestà del 20 dic.1943 fu
cambiata in via Manlio Oddone.
Dopo
il 1945, per delibera della giunta comunale del 19 lug.1945, fu dedicata al
partigiano C.Dattilo.
Con
delibera del consiglio comunale del 26 mag.1947 venne ‘distratto’ il tratto da
via P.Cristofoli a via GB Monti, che fu restituito al pittore E.Rayper.
Per anni, all’angolo di via C.Rolando (come per via GB Monti) le targhe sono
state due, contemporaneamente poste una vicino all’altra: una era in stile marmoreo antico (probabilmente raffazzonata lì per
lì subito dopo la dedica al partigiano, parzialmente coperta da vernice e
si leggeva solo “via...Cesare”); nella seconda, tutto chiaro eccetto - perché non si leggeva - il
nome della titolazione precedente; si intravvedeva un ‘già...’ (‘già via Pastrengo’).
Una terza, al posto delle due, apposta nel 2001, plastificata, ha risolto ogni
problema di lettura.
STRUTTURA: senso
unico viario da via C.Rolando a via P.Cristofoli;
è
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
CIVICI
2007*=
NERI = da 3 a 5 (manca 1)
da 2 a 10
ROSSI= “ 1r
23r (compresi 1C, 13A, 15A) 2r 6r (compreso 6B)
La strada finisce col civ. 21r; iI civ. 23r è in via Rayper.
Vi è un box-auto presso il 15r, che non ha civico rosso.
===civ.
2, 4, 6 neri, sono stati costruiti in un corpo unico
basale (fino al primo piano), sovrastato con tre torri separate corrispondenti a
ciascuna scala; così fatto, risultano speculari ai civv. 1,3,5 di via Anzani.
===civ.
2r-4r-6r rossi nel 1950 ospitavano il bar di Ceccarelli
Giuseppe
===civ.3
e 5 corrispondono ad un palazzo della Telecom
===civ
7 palazzina (un piano, più un ammezzato) del patronato sindacale della CGIL.
Da un
opuscolo del 1894 si intitola: «Cosa sono ed a che servono le Camere del Lavoro? / Edito per cura delle società
promotrici della Camera del Lavoro in Sampierdarena / prezzo c.10 / tip. e
cart. G.Palmieri e Figli - Sampierdarena via Vittorio Emanuele, n.15 / 1894. si
comprende che
A)—nacquero con lo scopo di organizzazione
sindacale, che raggruppasse i lavoratori aderenti alle diverse categorie.
Erano state costituite per prime -1891- a Milano, Torino, Piacenza, e
divennero il motore propulsore del sindacalismo di classe schierandosi con le
posizioni massimaliste del movimento.
Dopo la formazione della CGIL -1906- alla quale fu
attribuita la rappresentanza nazionale dei lavoratori, le CdL mantennero la
funzione organizzativa, assistenziale e mutualistica locale. Nel 1926,
dichiarate centri di resistenza al fascismo, vennero chiuse. Furono
ricostituite nel 1944 col Patto di Roma che prevedeva una autonomia e
singolarità provinciale. Nel 1948 le CdL si identificarono con la CGIL.
B)— a San Pier d’Arena la Camera
del Lavoro si costituì ufficialmente il 24 marzo 1895, su iniziativa
della soc. Istruzione e MS, della soc. Universale di MS, della Cooperativa di
Consumo e Produzione. Nel 1904, i dati statistici sui metallurgici
organizzati sono molto incerti, anche perché solo una parte di essi era
iscritta contemporaneamente alla Camera del Lavoro e alla Federazione
metallurgica, mentre gli altri aderivano o all’una o all’altra. Dal “Bollettino
del Lavoro”, vol. 3° (1° sem. 1905) risulta che alla fine del 1904 erano
iscritti alla C.d.L. di SPdA 208 operai metallurgici mentre gli iscritti alla
Federazione metallurgica erano 250. C)—una
carta intestata riporta il telefono=14-44 e la la sede in via Vittorio Emanuele,
34 questo civico nel 1902 era vicino all’ opificio dei f.lli Sasso fabbrica di
pallini, che a loro volta erano al civ.34L. D)--
Già dall’anno 1900 esisteva -voluta da soci appassionati di musica- una società corale filolirica con rappresentazioni pubbliche
di brani ed operette. Il gruppo era organizzato dal partito socialista
sampierdarenese. Nel 1904 il gruppo trasferì la sede qui, ove trovarono spazio
assieme a gruppi appassionati di filodrammatica, commedie e musica moderna,
tutti volenterosi dilettanti non certo competitivi con i più grossi teatri
aperti allora in città, ma seguiti entusiasticamente dal pubblico meno
abbiente. E)-- Fu creato nell’interno un vasto
salone adibito a teatro con palco e superiormente un loggione
semicircolare, capace di alcune centinaia di posti, aperta anche ad iniziative
popolari come veglioni, feste da ballo e cenoni. F)--
Fu titolato “teatro sociale G.Donizetti”. L’inaugurazione fatta nel maggio 1904
vide P.Chiesa quale propugnatore del teatro stesso e relatore della figura del
musicista. Inizialmente le rappresentazioni erano solamente musicali e canore
essendo la Società – nata in seno ai socialisti – prettamente corale; con
l’erezione della più ampia struttura, si allargò il programma ad altre
rappresentazioni. G)--Negli anni del
fascismo la sede fu sequestrata per uso del partito, H)--finché
nel dopoguerra divenne proprietà del Ministero del Lavoro; I)-- da questi, per legge varata riguardante i
possedimenti fascisti e destinati a divenire proprietà di una confederazione
sindacale, dal 1979 fu destinata alla
CGIL. L)-- Nel 1989,
con i fondi della GCIL nazionale, dello Spi e con le sottoscrizioni di molti
lavoratori, l’edificio trovandosi in condizioni assai deprecabili, fu
ristrutturato e trasformato in centro servizi polivalente al servizio dei
cittadini (disoccupati, sfrattati, pensionati, terzomondo, comprese consulenze
fiscali e problemi della famiglia) del ponente e della Valpolcevera.
===civ. 7r nel 2011
ha sede il “Centro Sociale interaziendale Ansaldo”
che – quando nacque nel
1927 aveva titolo di ‘dopolavoro Ansaldo’-. Per tanti anni ha avuto sede in via
U.Rela al civ. 1 ed a piano terra (vedi). Nato in epoca fascista, fin dagli
inizi ha come scopo cercare di organizzare per i numerosi dipendenti il tempo
libero sia con servizi ludici (turismo di gruppo, attività sportive, mostre,
ecc.) che sociali. Un lungo persorso, durato ottant’anni, da loro definito
‘travagliato, con testimonianze di vita vissuta da parte dei lavoratori...con
un egame profondo e costante con l’associazione e il territorio di
Sampierdarena’. Nel 1977 il Comune localizza il Centro in via Cantore civico
senza numero e via N.Daste, 3 (campo da tennis?) ed aumenta loro il canone di
affitto dei locali, da 12mila/annue del 1976 a 240mila nel ’77.
===Il
civ. 10, evidentemente legato ad un unico costruttore con unico
progetto; perché costruito in grosso corpo unico, è totalmente speculare al civ
7 di via C.Rota con 4 scale (identica prima rampa di scala dopo il portone,
sino al primo piano, ove si continua con una scala A del caseggiato, e
contemporaneamente si apre pure a un cortile interno, che a sua volta da adito
a tre scale B, C, D).
===al 13r Calderoni Primo
aveva nel 1950 i macchinari per riprodurre disegni (vedi via A.Cantore).
===sul
fianco offerto alla via, del civ. 1 di via Malfettani, c’è una edicola
all’altezza del primo piano, con raffigurata l’immagine del Cristo con la Croce
(del SS.Salvatore) .
===civ.30r da oltre 50 anni, una Chiesa
cristiana Evangelica Battista
===al civ. 62 nel 1950 c’era la ‘soc. Elettromeccanica
Ligure’ di costruzioni elettromeccaniche.
Nella strada si aprono nel 2003 numerosi negozi che
naturalmente nel tempo hanno cambiato proprietari e destinazione d’uso.
DEDICATA: al
partigiano, col nome di battaglia “Oscar”, nato a Cogoleto l’ 11 set.1921,
meccanico dello stabilimento san Giorgio di Sestri Ponente, militante del
P.C.I.
Sfuggì ad un rastrellamento compiuto dai nazifascisti tra le maestranze
dell’officina il 16 lug.1944, e rifugiò in montagna dove dimostrò subito la sua
capacità di essere deciso e volenteroso, vigilando attentamente e compiendo
azioni in grande stile (sul
monte Zucchero, smantellò una postazione nemica, riuscendo a convincere molti
nemici ad arruolarsi nei partigiani e lasciando gli altri di tornarsene a casa).
Gli
venne affidato il comando di un distaccamento (chiamato divisione Doria, dal nome del comandante), di stanza ad Acquabianca, nei pressi di Sassello.
Nel sett. dello stesso anno, divenne comandante della brigata d’assalto
“G.Buranello” della divisione ligure-alessandrina Mingo, con la quale partecipò
a numerose azioni belliche, nell’appennino ed in riviera, compreso la cattura
di due compagnie di alpini delle divisione Monterosa; comunque sempre con
notevoli bottini di armi ed equipaggiamenti; ma soprattutto generando sorpresa
e scompiglio nel nemico.
Con
questo grado ed incarico, ai primi di dicembre del 1944, fu catturato a
Tiglieto (Pastine scrive a s.Pietro d’Olba) in un rastrellamento compiuto nella
zona dagli alpini delle brigate nere della divisione San Marco, e tradotto in
vari carceri: Forte del Giovo di Sassello, sant’Agostino di Savona, poi alla
Casa dello Studente di Genova, luogo sinistro di torture, ed infine a Marassi
nella IV sezione.
I
partigiani della stessa brigata riuscirono a catturare tre militari fascisti del
presidio locale, e la moglie del colonnello italiano Cesare Romanelli che aveva
condotto il rastrellamento da cui era derivata la cattura del Dattilo:
L’immediata
reazione fascista fu un nuovo rastrellamento a Rossiglione (arresto di 2
disertori, 9 renitenti, alcune famiglie in ostaggio). Con ostaggi da ambedue le
parti, furono aperte trattative anche con le autorità germaniche per sospendere
la condanna di Dattilo in cambio della liberazione degli ostaggi, cosa che
avvenne reciprocamente, escluso il partigiano.
Per
lui, il destino decideva diversamente: Il
22 mar.1945 un gruppo di partigiani della brigata volante Balilla comandati da
Angelo Scala detto Battista (anziano militante comunista di Bolzaneto), tende
imboscata, attacca e dopo conflitto a fuoco, distrugge a Cravasco una
pattuglia di nove soldati delle SS tedesche, compresi due graduati, finendo sul
posto i feriti e ripiegando verso Molini di Voltaggio. Il Comando tedesco
decide una rappresaglia, voluta da alcuni di loro proprio per il colpo di
grazia inferto ai feriti (la titubanza derivava dalla ormai prossima fine della
guerra, perduta, e la minaccia di accuse di essere stati criminali di guerra:
occupando il paese con reparti delle SS e brigate nere, fece ostaggi tra la
popolazione, compreso il parroco; saccheggiarono ed incendiarono molte
abitazioni; e decisero la fucilazione sul posto di venti prigionieri da
prelevarsi dal carcere di Marassi scelti tra i membri dei quadri militari
partigiani). (vedi a G.Malinverni)
Assieme
a Giuseppe Malinverni, Renato Quartini ed altri 17 partigiani, il 23 mar.1945
Dattilo fu prelevato da Marassi e, portato a Cravasco, fu fucilato.
Altrettanto dura fu la reazione del comando partigiano della
VI zona, convinti di doversi opporre con immediate ritorsioni, definite
“ammonimento”. Battista decise la fucilazione di 39 militi ed ufficiali, delle
SS, brigate nere e “mongoli” della Turkestan tenuti nei campi di prigionia di
Rovegno e Cabella Ligure: da Rovegno, a marce forzate li condusse attraverso la
sella di Monte Carlo dominante Cravasco, di fronte al paesino di
Pietralavezzara sulla strada per il passo della Bocchetta, e lì li fece
fucilare il 4 aprile abbandonando i corpi sul posto ladsciato avvertire il
parroco. Per fortuna, la spirale si fermò non avvenendo nessuna reazione dei
tedeschi che si limitarono a ricuperare i corpi dei loro caduti solo
costringendo alcune donne del paese ad aiutarli nell’opera.
Molto bella una poesia di Edoardo Firpo : « Quello
strazetto da crave – tra stecchi nû e spinoin – che verso a çimma o s’asbria, -
a stradda a l’é ch’an battûo – in quella tetra mattin.---Cianzèivan finn-a i
rissêu; - cianzeiva l’ægua in to scûo –a-o fondo di canaloìn --- Me pâ sentì i
so passi – luveghi comme un tambuo – lenti, che scûggian indietro - cö mutilòu
insce-e spalle; - i veddo cazze, stâ sciù: - perché stan sciù se fra poco –
cazzian poi tutti lasciù? --- Han ciammòu Dio in aggiûtto – con ogni colpo do
chêu – pe lô, pe-a so moæ, - pe-i figgêu, - ma o fî o se faeto ciù cûrto – e a
raffega a-a fin a l’à streppòu. – Perché in te grandi ingiustizie Dio o l’è
sempre lontan? --- E çerco in gio ai mæ passi – se un segno o fosse restòu; -
no gh’è che pochi fioretti – che in sce-o senté n’han lasciòu, - poi un
strassetto de feuggia – secca ch’a sbatte a unna ramma. --- Ma in ta gran paxe
di monti – se sento l’eco da l’ægua – lontan ch’ai ciamma, ch’ai ciamma.»
Anche a Sciarborasca gli è stata intitolata una strada
principale; però sulla targa il nome e la motivazione sono più complete.
 29 ottobre 1944. Manlio Oddone.
Ricordo dei familiari
29 ottobre 1944. Manlio Oddone.
Ricordo dei familiari
BIBLIOGRAFIA
-Antonini
S.-La «banda Spiotta» e la BrigataNera...-DeFerrari2007-pg.83
-Antonini
S.-La Liguria di Salò-DeFerrari.2001-pag. 369
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.400—ed./02-pag.438
-AA.VV.-40°
anniversario della Repubblica-ATA.1986-pag.21
-AA.VV.- -SPd’Arena 35°
-Cosso.Lamponi-Il
comune di Campomorone-GenoaService.00-p.10(append.)
-Gazzettino
S. : + 5/83.10 + 7/83.10 + 8/89.8foto teatro
-Gimelli
G.-Cronache militari della Resistenza...-Carige.1985-vol.III-p.505
-Pagano/1933-pag.248---/1950-pag.142---Pagano/1961-pag.446
-Pastine
G.-Fuoco sulle montagne verdi-DeFerrari 2007-pa.116
-Pastorino.Vigliero.Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.554
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.34
-Ragazzi
F.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-pg.143
-Stradario del Comune di
Genova, edito 1953-pag.65
D’ AZEGLIO via
Massimo D’Azeglio
Ci adeguiamo all’inserimento del nome alla lettera D, come
appare in tutti gli stradari compresi quelli comunali, quando però dovrebbe far
parte della lettera A di Azeglio.
TARGHE: via Massimo d’Azeglio


da via D.Chiesa


da via G.Malinverni
QUARTIERE
ANTICO: Coscia
 Da Vinzoni 1757. ipotetico tracciato della via, nei terreni del
principe di Francavici. In blu villa Spinola; rosso villa Grimaldi della Fortezza;
giallo villa Scassi e vico Imperiale; celeste ipotetico tracciati di via
Malinverni e fucsia, via Pirlone.
Da Vinzoni 1757. ipotetico tracciato della via, nei terreni del
principe di Francavici. In blu villa Spinola; rosso villa Grimaldi della Fortezza;
giallo villa Scassi e vico Imperiale; celeste ipotetico tracciati di via
Malinverni e fucsia, via Pirlone.
N°IMMATRICOLAZIONE:
2766, CATEGORIA 2
 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 21460
UNITÀ URBANISTICA: 28
– s.BARTOLOMEO
 da Google Earth, 2007. In fucsia via
palazzo della Fortezza; celeste, via DChiesa; giallo, via Malinverni.
da Google Earth, 2007. In fucsia via
palazzo della Fortezza; celeste, via DChiesa; giallo, via Malinverni.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria
delle Grazie
STRUTTURA: strada
comunale carrabile, senso unico veicolare da via D.Chiesa a via G.Malinverni.
Lunga metri 62,57, è larga m. 5,52 .
STORIA: nel primi
anni del 1900 fu proposta questa intestazione, per il “vico trasversale
che da via E.DeAmicis (via
G.Malinverni + via G.Balbi Piovera)
tende a quello Imperiale” (via
D.Chiesa).
Con le stesse delimitazioni stradali, e sempre ‘vico’, era ancora nel 1910 (da “via E De Amicis al vico
Imperiale”), con civici sino al 5.
Per il Novella (descrizione
del 1900-1930 circa), si dipartiva come
“vico, da via N.D’Aste”: questa
descrizione, o è un errore, o al suo tempo comprendeva il tratto, attualmente
intestato a via Palazzo della Fortezza, che da via Daste si innesta nella
strada trasversale.
Nel 1927 è inclusa nelle vie cittadine dello stradario firmato dal
podestà, e classificata di 3a categoria.
Nel 1933 ancora congiungeva le strade con gli stessi nomi: “da via
Imperiale a via E.De Amicis”; ed era sempre di 3.a categoria.
Dopo l’ultima guerra il tratto perpendicolare centrale proveniente da via Daste
–il che confermerebbe che si considerava facente parte di questa strada-
cambiò nome, venendo considerato prolungamento dell’antica strada Larga, verso
il mare, e quindi la titolazione a D’Azeglio divenne definitiva limitatamente
alla trasversale che unisce le due strade principali parallele.
Nel Pagano/40 appare limitata da via G.Balbi Piovera e da via D.Chiesa;
e nei 4 civv.rossi sono descritti una latteria (14r), una osteria (9r), un
carbonaio (1r) ed un fruttivendolo (16r)
Nel Pagano 1950 è descritto un solo esercizio commerciale: l’osteria al
9r di Obelisco G.
CIVICI
2007=NERI
= da 1 a 5
ROSSI = da 1r a 23r e
da 2r a 20r
Il Costa/1928 cita questi esercizi: 13r=Vernier Francesco, modellista-- 21r=Perfetti
Giuseppina, fruttivendola-- 23r=Sanguatti Antonio,
conserve alimentari--
DEDICATA al pittore,
letterato, politico torinese (nato il 24 ottobre 1798 -1866) terzogenito
(dopo Roberto e
Prospero; prima di Luigi ed Enrico) di
Cesare (uno dei
migliori ufficiali piemontesi) e
Cristina Morozzo di Bianzé. Il loro cognome reale era Taparelli, marchese
d’Azeglio (comune in
provincia di Torino).
 Durante
l’occupazione francese del Piemonte visse l’infanzia esule a Firenze, poi a
Napoli; venendo severamente educato dal padre sia fisicamente che nel
controllare le emozioni e ad erudirsi.
Durante
l’occupazione francese del Piemonte visse l’infanzia esule a Firenze, poi a
Napoli; venendo severamente educato dal padre sia fisicamente che nel
controllare le emozioni e ad erudirsi.
Caduto
Napoleone, poté tornare a Torino ove poi frequentò l’ università.
Seguendo l’indole paterna nella carriera militare
si arruolò come ufficiale sottotenente di cavalleria nel reggimento “Piemonte
Reale”, dimettendosi nella prima maturità. Riprese poi la divisa, all’età di
50enne.
1820- andò a studiare a Roma, sopratutto –inizialmente-
come pittore ma dove frequentò, e ne divenne seguace l’Alfieri, dal quale
apprese l’amor patrio infuocato.
Dalla Città eterna tornò per esporre (a Torino-1831; Brera di Milaneo-1833; Parigi-1836), producendo fino all’età di 50 anni tele di
paesaggi, e scene di avvenimenti storici, molti ora conservati a Torino e
Milano.
A Milano, inseritosi nel gruppo romantico che faceva capo al Manzoni conobbe e
sposò nel 1831, Giulia, sua primogenita, che però morì
giovanissima: iniziò allora a scrivere temi ad indirizzo legale, lontani
dai moti rivoluzionari ma permeati dell’amor patrio acquisito; dal suocero
ottenne incoraggiamenti a pubblicare nel 1833 il romanzo ambientato nel
1503, intitolato “Ettore Fieramosca, la disfida di Barletta”, a cui seguì dieci
anni dopo “Niccolò de’ Lapi” ambientato nell’assedio di Firenze del 1530, e “La
lega Lombarda”; tutti e tre con chiari propositi di libertà e di sentimenti
patriottici.
Maturò contemporaneamente una attività politica, anch’essa tesa alla
causa del Risorgimento e favorevole all’ideale di unità a cui collaborò, sia
scrivendo e pubblicando opere atte ad incendiare i cuori di amor patrio, seppur
sempre contrario a raggiungere lo scopo con congiure segrete o sovversive,
cospirazioni e rivoluzioni. Iniziò girando l’Italia per conoscere le società
carbonare e mazziniane.
Nel 1846 scrisse una forte critica al malgoverno pontificio con il libro
“Degli ultimi casi di Romagna”: denunciato per questo, fu obbligato ad
abbandonare la Toscana e rifugiarsi a Genova.
A Genova propose le parole per la lapide da porre in Portoria al monumento del
Balilla (sempre con la
mira di stuzzicare gli animi contro l’austriaco); e si adoperò affinché la città - in segno di amicizia tra italiani -
restituisse a Pisa le catene che difendevano il porto e che nel lontano 1290
furono prelevate quale trofeo di vittoria, da Corrado Doria.
Nel 1848 a Roma stampò “I lutti di Lombardia” riferiti alla repressione
in Milano e ricercando la giustificazione storica dell’imminente guerra contro
l’Austria.
Cinquantenne, seppur mirato alla pace, coerente con gli ideali politici e di
azione, rivestì la divisa militare e partì per la guerra (1848-9)
come aiutante di campo di Durando; rimase ferito il 10 giugno a Vicenza prima
dei fatti di Custoza. In convalescenza frequentò così amici che diverranno
grandi economisti o politici o narratori, come Marco Minghetti, il sac. Raffaello
Lambruschini, Cesare Cantù.
Nel 1849, subito dopo Novara, Vittorio Emanuele II lo incaricò di
formare un governo: fu così dal 7 maggio, il primo Presidente del Consiglio dei
Ministri; resse l’incarico sino al 1852, quando si dimise per divergenze
di idee col Cavour, che però lo suggerì come suo successore avendo ben agito
nella pace con l’Austria, Francia ed Inghilterra e con la Chiesa (con la quale stilò un trattato
giudicato di “ridimensionamento rivoluzionario”: abolizione dei privilegi,
dell’immunità, dei tribunali; ed apertura di asili).
Nominato senatore l’anno dopo, scrisse il libro”il Governo di Piemonte e la
Corte di Roma” per evidenziare il comportamento equivoco e di doppiezza di
molti prelati vicini al Papa.
Inviato come diplomatico, ministro plenipotenziario all’estero (Parigi e poi
Londra), svolse il ruolo di regio commissario in Romagna e governatore di
Milano.
Tendenzialmente chiuso, divenne sempre più isolato, incompreso nonché
trascurato; preferì ritirarsi a vita privata sul lago Maggiore, dandosi a
scrivere“ I miei ricordi”, rimasti però incompiuti per la morte sopravvenuta a
Torino il 15 gennaio 1866 (pubblicati postumi nel 1867 dalla figlia Alessandrina
marchesa Ricci, rappresentano una delle opere autobiografiche migliori dell’
800, sia letteraria che storica).

vista verso ponente (da satellite, 2010)

veduta verso levante (da satellite, 2010)

BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
St. Comunale Toponomastica - scheda1534
-AA.VV.Annuario-guida
archidiocesi –ed./94-pag.400---ed./02-pag.438
-Costa,
guida di Genova 1928-pagg. da 967
-DeLandolina
CG- Sampierdarena -Rinascenza.1922-pag.39
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Enciclopedia
Treccani ed.1933
-Lamponi
M.- Sampierdarena- LibroPiù.2002. pag. 63
-Novella
P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.17.18
-Pagano
1940- pagg. 270
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35
DE
AMICIS
via Edmondo De Amicis
Non più a Sampierdarena,
attualmente in Portoria (era in san Vincenzo; sull’elenco delle
strade-toponomastica del Comune- gli hanno cambiato il nome in Edoardo).
Corrispondeva a tutto il
percorso che da via De Marini (poi ‘generale
Cantore’, ora ‘via N.Daste’ ), saliva alla “proprietà Piccardo” (vedi via GB.Botteri) e –più su- sino al
progettando ospedale; quindi le attuali via Malinverni e via Balbi Piovera,
allora unite in unico nome, prima del “taglio” di via A.Cantore.
Nel 1757 il territorio
posto a ponente della casa Spinola, apparteneva al marchese di Francavici
(meglio Francavilla).
Nel 1910, in uno dei
primi elenchi stampati dal Comune con censite le strade cittadine, era ancora
“da via DeMarini verso la collina”; itinerario precisato negli anni subito dopo,
con la soprascritta a penna: “fino all’incontro della via Promontorio e della
salita Galileo Galilei”. Quindi coinvolgeva anche l’attuale via M.Fanti e via
G.B.Derchi. Essendo una via lunga in questa data, ovviamente già aveva i
numeri civici che arrivavano al n° 78 e 73.
Nel Pagano 1912 hanno
recapito nella via gli appaltatori di
costruzioni Zaccheo Giacomo¨¤ e Puppo-Lavagetti; ed i f.lli Tubino demolitori
di bastimenti.
Nel Pagano 1925 compaiono al 2-3 lo scultore Onorato Toso; al 4-4
la levatrice Musso Maria ed al 5-8 Rossi Amelia;--- al 12-12 il negozio
del grossista di vetri Canepa Angelo;---
Nel 1927, l’elenco
delle strade genovesi pubblicato dal Comune, registra due vie omonime; una
anche a Sestri. La nostra, di 3a categoria,
Negli anni 1930, al civ.73
c’era l’osteria Texetto ove in quell’anno fu
tenuto una prima gara-convegno di canti popolari, quando il dialetto era ‘cosa
del popolo’..
E così era ancora nel 1933¤,
di 4a. categoria. Pagano/33 segnala il recapito
dell’appaltatore edile Zaccheo Giacomo; al civ.4 del floricoltore Bonzi Domenico; al 12.11
il negozio di vetri di Canepa Angelo & C.;
ed al 37r l’unica gelateria cittadina di
Almone Domenico (già presente nel 1925).
Solo il 19 ago.1935 il
podestà decise dedicare un tratto di strada a GB.Derchi ed il resto a G.Balbi
Piovera; solo in un terzo tempo, nel mezzo, subentrò via M.Fanti.
DEDICATA al poeta ligure (solo per nascita,
avvenuta ad Oneglia il 21 agosto (il Diz.Biog. e
Zanichelli scrivono ottobre)) 1846, da Francesco (regio banchiere dei sali) e Busseti Teresa.
Infatti visse quasi totalmente fuori regione.
E vi tornò solo per morire di ictus, a Bordighera l’ 11
mar.1908).
Quattordicenne, scappò di casa per arruolarsi nei
Mille: fu ripreso prima di imbarcarsi e riportato in famiglia.
Inizialmente si orientò verso una
carriera militare; in tale veste, partecipò col grado di sottotenente
alla terza guerra di indipendenza, da Custoza (1866)
fino alla presa di Roma (1870). Di quel
periodo rimangono un libro, intitolato ‘Vita Militare’(1868, poi più volte rimaneggiata fno al 1880), e vari altri
scritti sul tema, di cui i più famosi sono i ‘bozzetti’, ipotesi di un libro
che avrebbe potuto chiamarsi ‘Patria’ e per il quale aveva steso le pagine di
giovani eroi come ‘la piccola vedetta lombarda’ ed il ‘tamburino sardo’.
Congedato e maturato, preferì
dedicarsi al giornalismo, iniziando come corrispondente dall’estero
(Spagna, Marocco, Olanda, Turchia) del Corriere della Sera; confermò così le
sue doti di scrittore brillante di esperienze di viaggi, e di facile
comunicabilità (famoso il libro “Costantinopoli”
del 1887 del quale il premio Nobel turco Pamuk Orhan ha scritto “il miglior
libro per ragazzi su Istambul”; ma altrettanto “Spagna”, “Olanda”, “Ricordi di
Londra”, “Marocco”, “Ricordi di Parigi”).
Così si scoprì essere, più che
giornalista, uno scrittore di libri con alto impegno civile. La
scuola in primis.
Erano i tempi in cui don Bosco,
don Daste ed altri filantropi cercavano modelli da dare ai giovani che
lottavano, nell’analfabetismo, contro la povertà esasperata, la fame,
l’emarginazione sociale. Produsse opere che sottilineavano, marcando a fuoco,
le caratteristiche cercate nella gioventù: comportamenti e scelte di vita
improntate di semplicità ed alti ideali (della Mamma
e della Patria, con la grande avventura del giovane genovese Marco descritta
con il suo capolavoro per gli adulti “sull’Oceano” (1889); in esso espone
questi due ideale come meta fissa, e che raggiunge al di là dell’oceano dopo
mille peripezie), ispirate alla amicizia, lealtà e bontà, facendo
primeggiare sentimenti di altruismo e fratellanza (indimenticabile
è il capolavoro per ragazzi intitolato “Cuore” (1866), diario di uno scolaro, con
cui commosse intere generazioni, per l’educazione dei sentimenti da trasmettersi
in tutti i vari episodi; tanti valori che ai tempi d’oggi sono stati stravolti
assumendo all’opposto un indirizzo più individualista, meccanicista ma almeno
non così ipocrita. Ad ognuno i suoi tempi.
Aveva
creato il buonismo deamicissiano, alquanto irrazionale alla luce di oggi che al
predominio del cuore-sentimento preferisce credersi raziocinante-cerebraloide.
Ma, allora, divenne uno degli strumenti più potenti nel creaure una
unificazione culturale nazionale sul metro della media borghesia umbertina del
nord. Al punto che qualche studioso definì questa commozione dell’io italico -
divenuto un noi con molte ipocrisie - una solenne truffa psicologica;
scivolando però nell’io isolato ed elefantiasico: io, solo io che soffro per
colpa degli altri, io che indiscutibilmente amo-odio, rido-piango, ho solo
ragione io, io che anelo mettermi in mostra nella vetrina di Facebook o dei
reality). Con questa qualità dei testi, a lungo il narratore è rimasto
della memoria collettiva quale “il Padre letterario della Patria”.
Ma l’impegno civile si legge
anche nel “Romanzo di un maestro” (1890 - nel
quale l’insegnante non è il solito espositore delle glorie nazionali, ma è un
uomo con famiglia, impegnato da solo in quanto non aiutato dallo Stato nella
sua battaglia contro l’analfabetismo, contro le famiglie contrarie alla scuola
e bisognose di braccia nei campi. Questo romanzo fu censurato dal fascismo e,
dal 1927, proibito alla lettura), negli scritti relativi ai drammi della
miseria, dell’emigrazione, dei disperati, dei malati mentali (“Il giardino
della follia” -1902), del bisogno di maggiore giustizia sociale e di maggiore
interesse verso il popolo delle periferie.
Nel 1884 da Genova si imbarcò per
Buonos Ayres invitato per delle conferenze dal giornale locale “Nacional”.
Così lentamente emerse anche l’impegno
politico, in modo altrettanto vivo, intelligente e coinvolgente. Quest’ultimo
ideale, maturato con una sempre maggiore convinzione, politicamente fu
orientata a sinistra verso il nascente socialismo quando il movimento era
ancora visto sia dallo Stato che dalla Chiesa come un nemico o il diavolo (divenne amico e seguace di F.Turati anche nei momenti
in cui il socialismo fu bandito come pericoloso e l’amico incarcerato). Non
solo lo propone quale voce delle idee socialiste, più esplicita ne “Lotte
civili” del 1899 e “Primo maggio” pubblicato postumo (1980 - di ispirazione marxista);
ma perfino lo farà separare dalla moglie (che
detestava queste idee).
L’improvvisa morte di un
figlio (suicida), determinerà un finale
di vita più riflessivo, meno pubblico ma sempre impegnato politicamente. Suoi,
articoli sulla società in fase di sconvolgente sviluppo industriale: sul
calcio, sull’alcoolismo, sulla pace e contro il militarismo; e tanti appunti
per altrettante conferenze nelle sezioni del partito e poi pubblicati sulla
stampa socialista a diffusione nazionale.
Alla sua morte, avvenuta a
Bordighera il 11.3. 1908, per suo volere, la salma fu traslata a Torino. Il
treno che trasportò il feretro, fu segno di popolare riconoscimento e di
affetto e commozione lungo tutto il tragitto: numerose presenze di estremo
saluto e fiori.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio St.Comunale
Toponomastica
-AA.VV.-Dizionario biografico
degli Italiani
-AA.VV.-Enciclopedia Zanichelli
-Balma M-Nel cerchio del canto-DeFerrari.2001-pag.252
-DeLandolina GC- Sampierdarena
-Rinascenza .1922-pag.39
-Il Secolo XIX quotidiano,
10.03.08-pag.8; 31.03.11pasg.55
-Novella P:-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.17
-Pagano/1933-pag.246
-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.123
-Piastra W &C-Dizionario biografico dei
Liguri-Brigati.1992-pag.272
-Tuvo T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani.1983-pag.63
DEGOLA via
Eustachio Degola
TARGHE:
San Pier d’Arena – via - Eustachio Degola – teologo scrittore
politico - 1761-1826


presso il sottopasso ferroviario


sulla facciata del Palazzo dei Tabacchi
QUARTIERE ANTICO:
Mercato Ponte
 Da Vinzoni, 1757. In blu via NDaste;
rosso, via CRolando.In celeste ipotetica lunghezza di via RPieragostini; ed in
giallo di via AScaniglia
Da Vinzoni, 1757. In blu via NDaste;
rosso, via CRolando.In celeste ipotetica lunghezza di via RPieragostini; ed in
giallo di via AScaniglia
N° IMMATRICOLAZIONE:
2767

 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 21680
UNITÀ URBANISTICA: 25
– SAN GAETANO
26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA:
s.G.Bosco
STORIA: Nella carta
vinzoniana del 1757 la strada appare tracciata, ma ovviamente senza
nome, circondata da proprietà private: a nord di proprietà Domenico Spinola (i quali estesi est-ovest lievemente arcuati,
arrivavano sino all’attuale via C.Rolando ove era la villa –attuale civ.8);
ed a sud degli eredi Nicolò Pittaluga e del rev.do Stefano Ferrari.
Anche nella carta –presumo del Porro- di poco
antecedente il 1781, la nostra strada corrisponde al tratto che era
delimitato verso nord dai terreni delle stesse persone sopra.
Nel 1846 è chiamata “Strada Provinciale di Ponente”;
Nel 1857, un regio decreto deliberando i nomi delle strade della città,
la definisce via san Cristoforo: con questo nome, era però iniziante da via san Martino (via
C.Rolando) e comprendeva tutta l’attuale via AScaniglia, via E.Degola e
-proseguendo verso ponente- anche l’attuale via Pieragostini, sino al ponte.
Nel dic.1869
l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della Provincia, scrisse al Sindaco
segnalando che nei giorni piovosi, ”trovasi talmente ingombra di fanghiglia da rendersi
alquanto disagevole il transito che senza interruzione vi si esercita per la
riviera occidentale …le speciali condizioni di giacitura ed altimetria di quel
tratto di strada, esigono cure speciali…
”; nel gen.1870, ancora in attesa di una risposta, si andò a precisare che la
strada non è di competenza del governo né della provincia (ma del Comune di SPd’Arena, perché
veniva considerata “strada provinciale di ponente” solo da oltre la sponda
destra del torrente).

foto risalente alla prima decade del 1900. Riproduce l’”orto
floro botanico”
di Carlo Camerano, con negozio anche in via A.Saffi (via
C.Rolando)
Dopo la guerra del 1915-18, divenne via Cesare Battisti, di 4.a
categoria, sempre uguali i due limiti: da via A.Saffi (via C.Rolando) al
ponte; e tale era ancora nel 1933.
Con delibera del podestà del 19 agosto 1935, via Cesare Battisti fu
‘spezzettata’ e quindi non più con un nome globale ma via A. Scaniglia il primo tratto, via E. Degola per il tratto che ora trattiamo; dalla Crociera al ponte, divenne via
Monte Corno (poi dopo
ancora, via Pieragostini, dal 1953).
Di questa frammentazione per lungo tempo rimane unita
la progressione numerica dei civici: e lo stesso vale dopo le varie
demolizioni, infatti gli unici civici di via E.Degola, posti a mare della
strada in una rientranza, sono ancora il 10 e 12 dirimpettai. Curiosa nella
rientranza per accedere a questi civici, l’esistenza all’inizio di essa di
grosse pietre di pavimentazione stradale, orientate in curva per far entrare i
carri nel capannone posto a ponente - ora occupato da un artigiano che si
interessa di sospensioni di auto e camion - e che evidentemente aveva
l’ingresso –ora murato - in questa rientranza e non sulla via principale che, a
quei tempi, essendo la strada più stretta, era di conseguenza più lontana.
Subito prima della seconda grande
guerra, dal Pagano 1940 si rileva “da via M.Fascisti a via Pacinotti”;
con civici neri= al civ. 2 i Carabinieri reali; al 3, Deposito generi di
Monopolio e la r. Guardia di Finanza; al 14 Perinotto sorelle, fiori artificiali;
al 16 s.a. f.lli Feltrinelli legna; 20, dopolavoro ferroviario. E civici
rossi= 4r Dopolavoro Ferrov. bar ristorante; con commercianti uno per tipo:
mercerie, foraggi, formaggi, metalli, elettricista, calzolaio, bottiglier.,
friggitoria, parrucchiere e osteria.
Nel
piano regolatore generale approvato nel marzo 1956, fu previsto e poi
attuato l’allargamento a 20 m del sottopassaggio ferroviario di via Degola, in
due fornici paralleli ed ambedue a senso unico ovviamente verso il ponente. Il traffico, proveniente da via
Cantore, all’incrocio prima del sottopasso (appartiene a via P.Reti) è fonte di
accentuato intralcio alla snellezza della circolazione stradale.
Sino al 1960 circa, era decisamente più
stretta rispetto oggi, fiancheggiata sul lato mare da case operaie
(rettangolari, che offrivano sulla strada il lato più stretto) e da baracche di
officine e forse orti di proprietà private. Di esse, alcune case andarono
parzialmente distrutte dai bombardamenti che miravano alla ferrovia, favorendo
il posteriore allargamento dell’asse viario.
Nel 1963-4 avvenne il raddoppio della carreggiata sotto il tunnel
iniziale, corrispondendo il Comune anche una certa somma alle Ferrovie. Seguì
da parte del Comune l’acquisto di un magazzino con cortile e di alcuni immobili
(tutti della sig.ra Clorinda Mascardi) col fine dell’allargamento della via
E.Degola alla dimensione odierna.
Nel 1969 viene segnalato un transito di 2250 veicoli (nelle ore tra le 7 e le 21)
Nel gennaio 1989 si parlò dell’insediamento del progetto di un centro
commerciale (non
supermercato) di 9mila mq con ristrutturazione del dopolavoro, dei servizi,
della ferrovia e suoi passaggi pedonali (solo questi ultimi realizzati). Invece
è subentrato un supermercato Basko privato.
Nel gen.1991 si dava ‘quasi certo’ la costruzione di un grosso
parcheggio anche interrato da 950 posti auto nella strada così vicina alla
stazione; con l’o.k. anche da Roma. Ma dopo oltre dieci anni tutto tace.
STRUTTURA: senso
unico verso ponente, da via P.Reti a via Pieragostini-largo Jursè, iniziante
col sottopasso ferroviario.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
Inizia con il sottopassaggio rispetto la
ferrovia che sino al 1960 aveva un solo fornice
ad angolazione che, si disse, fosse stata progettata nel pensiero di creare una
strada diritta con via A.Cantore (1935) demolendo le costruzioni che
prospettano nella linea; appare più probabile sia legata alle più
antiche strutture che fanno da fondamenta alla stazione ferroviaria (qualcuno ha accennato alla possibilità che la
massicciata ferroviaria abbia coperto una antica abbazia, considerati i vuoti
esistenti alla base di essa; il che è assai improbabile, anzi decisamente
improponibile).
L’inizio del sottopasso è zona che quando alluviona, essendo
a conchetta, è la prima a riempirsi d’acqua bloccando tutto il traffico
stradale. Anche a settembre/05, intense piogge hanno creato allagamenti della
sede stradale. Non infrequente (una nel 2003; tre nel 2004) l’incastro di tir
sotto la volta (che non supera i m.3,80), con non poche difficoltà a
disincastrare il mezzo
CIVICI
2007= UU25=NERI = da 1 a 5
ROSSI = da 1r a 3r (compresi 3DE)
UU26= NERI = da 2 a 20 (mancano
6, 8, 14→18)
ROSSI = da 2r a 58r (mancano 6, 8,
12→24, 48→52)
Nel Pagano 1950 sono segnalate una osteria al 72r (di Giacobbe G.), il bar del
Circolo Ricr.Ferrov al 20r; nessuna trattoria
In particolare, prima ancora del 1960 da dopo il voltino
i civv. pari andavano dal 2 al 22:
===civv. 1, 3, 5 sono nel lungo e massiccio
edificio dei tabacchi: in custodia della Guardia di Finanza come deposito dei
generi del Monopolio. In particolare, i civv.3D e 3E furono assegnati nel 1998.
Al civ.5 il magazzino tabacchi greggi. Nel complesso
la strada a destra andando verso ponente è tutta fiancheggiata dall’ unico e
lungo manufatto detto “Palazzo dei Tabacchi”
oppure ‘deposito tabacchi del Monopolio di stato’, ristrutturato negli anni
1990. Di struttura massiccia, con pietre a muraglione e base allargata -come
un fortilizio-, vi vengono depositati tutti i valori del monopolio, soprattutto
i tabacchi che arrivano direttamente per ferrovia con binari sino
all’interno; sorvegliato da agenti della Guardia di Finanza e televisioni a
circuito interno.
Appare antichissimo, ma fu invece finito di essere
costruito nel 1854 (infatti in una carta del 1846 non c’è ancora.
Favretto scrive che “nel 1860
(nb=contrasta la data con quella sopra) Luigi Balleydier sottolineò in Consiglio
Comunale quale grande occasione per lo sviluppo della città potrebbe divenire
la fabbrica, sia per l’opportunità di lavoro per almeno mille addetti, sia per
la presenza dei funzionari statali che l’avrebbero diretta. Davanti a tali
prospettive, l’amministrazione decise di provvedere ad un proprio progetto
edilizio, individuando l’area sottostante la stazione ferroviaria, che in
seguito sarà sostituita dall’area situata più a nord”.
In occasione, il regio
erario provvide anche ad allargare la strada definita ‘un vico tortuoso tra alti muri di cinta agli orti
laterali, facendola arrivare a 8,5 metri; a fornirla sul lato a tramontana di
apposito ‘capievole acquidotto coperto da vôlto in mattoni …e in rilievo un
marciapiede della larghezza di metri 1,1 formato in ciotoli contenuti
esternamente da una continua fascia in petra da taglio della Spezia ..come da
offrire due difesi sentieri selciati ai pedoni …per il lato di riscontro è
praticata una cunetta selciata…e apposti n° 16 robusti paracarri di forma cilindrica
obliqua in pietra della Spezia tanto da impedire ai carri il passo sul vôlto
dell’acquedotto…’ . Altrove viene citato
che nel 1864 i velieri liguri avevano
scaricato sulla spiaggia cittadina-ancora allora totalmente indipendente dal
movimento dentro il porto di Genova- oltre 7500 tonnellate di tabacco greggio,
da essere lavorato nella regia fabbrica).
Nel
1933 (quando la strada era ancora via C.Battisti), al civ. 9 di allora c’era una brigata stanziale
della tenenza sampierdarenese della GdFinanza; all’ 11 il deposito generi del
Monopolio (tabacchi); ed al 13 il deposito tabacchi greggi e tè.
Nel
Pagano 1950 al civ. 5 è la sede del
‘Magazzino Tabacchi Greggi’
Nel
1998 la struttura divenne degradata e
precaria: caduta di calcinacci, deposito ‘vuoto’ o pressoché inutilizzato(lasciando
abbandonati 800 mq di superficie coperta e circa 9mila in totale).
Da
anni coloro che ivi lavoravano erano stati trasferiti a quello di Sestri; era
rimasto in funzione un po’ di spazio per la distribuzione in loco, poi anche
quella cessò. Praticamente è da anni lasciato al suo destino, come un barattolo
vuoto da buttare’. Infatti erano già trent’anni che le lavoratrici erano state
trasferite (le famose
sigaraie, la cui professionalità si trasmetteva di generazione in generazione
ma ora ormai sostituite da macchinari; a quei tempi erano capaci di lavorare a
mano le foglie, producendo fino a 800 sigari al giorno), e da dieci inutilizzato (ovvio il confronto con il palazzo
del sale, pure lui demaniale). Questo
venne ristrutturato e rimesso a nuovo, con una spesa preventivata di 10
miliardi, dalla impresa toscana Pontello; furono iniziati i lavori di
ripristino dopo il 1990. Entrato nelle
mire della Regione negli anni 2000, per farne la sede della ASL3 Genovese o
addirittura dell’ospedale ‘di vallata’ valido per tutte le delegazioni della
val Polcevera, compreso quelle di ponente (Sestri e Voltri); i tempi politici
sono enormi (e le spese previste si alzano esponenzialmente). Nel lug.2011, con un investimento previsto di 17,2
milioni di euro (più 2 di notaio) si riprospetta farlo diventare il ‘quartiere
generale’ della Asl: si apprende che l’attuale proprietaria dell’immobile è la
“Quadrifoglio Genova” società del gruppo Fintecna (assieme al cotonificio De
Ferrari). Si prevedono posteggi per cento auto a piano terra, più ambulatori di
medicina legale, uffici vari per 320 dipendenti, un asilo nido aziendale per
trenta bimbi; oltre l’utilizzo dell’area esterna ora occupata da binari.
===civ.2: Vedi la foto sopra, degli anni 1910, relativa ad un
“orto floro botanico” di Carlo Camerano, non
descritto sui Pagano.
Nel
1940 c’erano i Carabinieri reali; nel 1957 fu
assegnato a costruzione più interna, di proprietà delle FFSS. Provvisoriamente
sulla porta di un residuato del vecchio edificio fu applicato 2A nel 1957, ma
il tutto fu soppresso nel 1961.
===civ.4: assieme al 4A fu demolito nel 1962.
Il
numero civico fu riassegnato nel 1963 a porta che era senza numero (anche se il Pagano/50 scrive che era
il 20r: poco probabile essendo all’inizio della via e non alla fine), e che corrisponde al Circolo ricreativo ferroviario o altrimenti detto
‘dopolavoro ferroviario’ (nato
nel 1938, in cemento armato, ovviamente di
proprietà delle FF.SS. collegato tramite un sottopasso ferroviario, con via
S.Dondero. Aveva annesso un bar-ristorante).
Negli anni postbellici fu trasformato in sala
cinematografica, chiamato
brevemente ‘Ferroviario’, di oltre 300 posti a
sedere e proiezione di film “normali”.
Rimodernato, negli anni ‘87
divenne ‘ABC’ per cine-forum gestito dall’impresa Razzetta
Palmieri. Classificato di IV categoria, aveva un palcoscenico (senza pedana ma
con boccascena, buca per suggeritore, quinte, attrezzatura per impianto di
scene e locali annessi per attori). Aveva 309 posti dei quali 269 in platea e
gli altri in galleria. Piastrellato per terra; munito di un impianto acustico
monofonico, illuminazione al neon, aspiratori d’aria essendo ancora consentito
fumare in sala, e poltroncine in legno con imbottitura.
(anche la palestra di via Porro, fa parte del circolo delle
FF.SS.)
Dagli anni ’90 iniziarono le
proiezioni di film “a luci rosse”; con l’espansione della TV nelle
singole abitazioni, questi film furono gli unici ad attirare quel poco
pubblico nei locali cinematografici.
Finché
dal 1998 ridivenne ‘DLF’
(DopoLavoroFerroviario), sempe rimanendo di proprietà delle FF.SS., anche se, con la spesa
-circa 1 miliardo di vecchie lire- sostenuta da privati capitanati dalla
società genovese Admiral, e su disegni di Beppe Riboli, è stato trasformato in
sala polifunzionale di intrattenimento, in particolare sala da ballo o
discoteca, con un bar anche nell’ex galleria; pur conservando lo schermo,
palcoscenico e proiettore. Negli anni vicino al 2000
gli impresari del DLF diedero avvio a concerti rock (63, in 18 mesi) cercando
di portare la città nel circuito di questo tipo di musica con complessi che
attirano soprattutto i giovani, anche dalle regioni limitrofe: furono bloccati
dal Comune per inquinamento acustico (avvenivano di notte, dalle ore 22 alle
06).
Non
conosciamo i passaggi ma è dagli anni 2000 è occupato dal Crazy Bull, locale per concerti dal vivo
==civ.6:
era un lungo unico edificio rettangolare. Fu demolito nel 1961-2
==civ.
7 : nel 1959 fu trasferito al neonato largo E.Jursè
===civ.8-10 : un unico palazzo, rettangolare come il 6, diviso
in due scale. La metà palazzo verso la strada, corrispondente al civ.8 fu
distrutta da una bomba: rimase per 15 anni il fianco sventrato finché fu
restaurato salvando il civ. 10 che esiste tutt’ora.
==civ. 12r vi era un
negozio di commestibili della coop.ferrovieri
Ancora nel 2005, da
questo civico a ponente, si riscontrava solo civv. rossi: in due grossi
capannoni affiancati col tetto spiovente ad un unico piano: ex civ.50r=officina balestre; ex-52r=officina
per auto e camion; poi ex-54r-56r=Coop.Basko; e dal 58r
al 62r vuoti
==civ.
14 era a forma di palazzina. Fu demolita totalmente nel ’61-2
Si
descrive in punto non precisato della strada esserci stato un edificio
abitativo, e presumo sia stato questo, di proprietà Remorino, eretto nel 1907
dall’arch. A.Petrozzani, con sulla facciata un grazioso arredamento liberty. Vi
lavoravano le sorelle Perinotto nella produzione di fiori artificiali; il cui
nome compare ancora nel 1950.
===civv. 16: ancora nel 1950 vi aveva una sede la filiale della
spa f.lli Feltrinelli, industria e commercio dei legnami, che fu soppressa nel
1996. Allora il civico fu trasformato in civ.rosso
==civ 18,
penultimo edificio della strada, messo prima di vico A di Bozzolo, fu demolito
negli stessi anni degli altri.
== Viene descritto, di
fronte ai tabacchi, esserci stati i magazzini della ‘soc. Solej Hebert & C’. Dal febbraio 1888 questa ‘vecchia ditta genovese’
produceva specchi non solo su scala regionale ma con sedi succursali sparse
nella nazione (Mi, To, Fi, Ba, Pa, Na, Lecce) ed una a B.Ayres. Nel 1890 con un
intervento multiplo finanziario (raggiunse 200mila lire di capitale) divenne
‘Società vetraria di Sarzana’ con l’intento di trasferire lo stabilimento in
quella sede. Nel 1912 fallì, nel marasma imprenditoriale del quinquennio
anteguerra che coinvolse soprattutto le piccole industrie locali a vantaggio
dei grandi trust e dei ‘fornitori’ dello stato. Nel 1940 subentrò Massone
Giuseppe, rivenditiore di foraggi
===civv. 20r, 22r erano nell’ultimo palazzo della via, dopo l’incrocio
con vico A.di Bozzolo e collocato dove ora sono dei giardinetti.
Ai primi del 2007 è stata
fatta domanda al Consiglio di Circoscrizione di occupazione del civ.20 quale
sala di culto.

visti
dalla ferrovia, il retro a mare,
delle
due ultime costruzioni di v.Degola
Un grosso riquadro di
lato all’ingresso segnala «Chiesa cristiana
evangelica “delle Assemblee di Dio” in Italia»; un altro appeso, porta uno stemma
con punta in alto e, nella parte superiore la scritta ADI, nel centro un libro
aperto con la scritta 2tutto l’evangelo”.
Questa
aggregazione religiosa si chiama ‘Pentecostale’ perché, pur appartenendo alla
riforma protestante anglosassone, ha come varietà una maggiore osservanza -ispirata
dal Vangelo laddove è citato –ed a cui vuole rifarsi- il battesimo degli
Apostoli per immersione praticato nei giorni di pentecoste. Proviene dal sud
Italia dal 1946, ed iniziò a meglio organizzarsi nel ’49 aprendo una sede in
san Benigno gestiti da Francesco Testa (1899-1988). Nel 1951 succedette
Eugenio Palma, originario degli USA, al quale seguì nel 1955 il romano Paolo
Arcangeli che trasferì la sede nel palazzo del Sailor’s Rest di proprietà della
chiesa scozzese. Nel 1975 ca la chiesa si trasferì in via Cassini 5r, occupando
una ex-officina; e là restorono per trent’anni finché dal 2005 sono inseriti in
via Degola.
Numerosi erano i
negozi e le officine aperti sul lato mare, oggi -i primi- tutti scomparsi. Si
ricordano una solita osteria, parrucchiere, friggitoria, latteria, cartoleria,
fruttivendolo, falegname, calzolaio e parrucchiere; al 60r c’era un ‘Consorzio
Industrie Fiammiferi’ (gestito dalla regia GdFinanza; l’ufficio vendite era
in esercizio ancora nel 1950); al 30 l’OEMA riparazioni ascensori.
DEDICATA al sacerdote
sampierdarenese nato il 29 (il Massobrio dice il 20) sett.1761
da Giovanni Pietro qualificato ‘borghese mercantile’. Con i nomi di Eustachio,
Antonio, Emanuele, Giuseppe, Maria (Massobrio dice nobile, di origine spagnola; che comunque si estinse nei primi
del 1900, essendo gli eredi senza prole).
Ebbe due fratelli che si dedicarono al commercio.
Compì
gli studi con facilità, essendo di spiccata intelligenza e critica
1784
Divenne diacono a 23 anni; ed ottenne
dalla s.Sede la licenza a leggere libri proibiti, o comunque contrari ai dogmi
della fede.
1785; a 24 anni, divenne sacerdote. (si laurerà anche in
teologia a Pisa a 35 anni).
1787
-26enne- Accettò l’ideologia
giansenista seguendo le lezioni dello scolopo GB Molinelli, maestro di tale
dottrina religiosa anticurialista ed antigesuitica (dottrina nata da studi di Giansenio
Cornelio (Jansen Cornelis, 1585-1638, teologo olandese, vescovo di Ypres nel
1635 nella abbazia di Port Royal; per primo teorizzò una dottrina radicale, antigesuitica
e di estremo rigore dell’insegnamento di s.Agostino sulla Grazia e sulla vita
morale.
Fugacemente iniziata nel seicento con la pubblicazione
postuma dei suoi scritti (Augustinus,1640), questa teoria fece molto scalpore
del XVII secolo, ma prontamente condannata dalla Chiesa. Secondo Giansenio, la
Grazia doveva portare la Chiesa alla purezza evangelica, slegandola sia dai
beni terreni –ricchezze, possedimenti terrieri, armigeri- e sia dalla ferrea
gerarchia in atto. Tutta la tradizione plurisecolare che aveva creato attorno
ai vangeli una venerabile e complessa struttura (infallibilità del papa e suo
primato sui vescovi), doveva tornare azzerata alla povertà e semplicità
iniziale.
Con la rivoluzione francese, la teoria giansenista riaffiorò
pubblicamente, e dai suoi principi fu che poi il Governo Democratico francese
passasse al sequestro e spoliazione di tutte le chiese di tutti i loro beni,
non fu che l’applicazione distorta ed interessata del pensiero; gli ori e gli
argenti divennero patrimonio della nazione (furono restituiti da Napoleone nel 1804 all’ arcivescovo
mons Giuseppe Spina, lo stesso che l’anno dopo a Milano offrì l’annessione
della Liguria all’Impero; il catino del santo Graal conservato in san Lorenzo
fu reso dai soldati russi subentrati ai francesi, molto dopo e rotto). L’idea influenzò e catturò grandi
pensatori come Pascal e lo stesso Manzoni: quest’ultimo scelse il Nostro come
confessore, però poi decise riconvertirsi totalmente e ferventemente al
cattolicesimo tradizionale.
A Pistoia il
vescovo Scipione DeRicci (iniziò a porre in atto nel 1786 tali riforme
con l’aiuto del suo Stato, che in un sinodo cercò di dar vita ad una chiesa
giansenista nazionale); e parimenti a Noli il vescovo Benedetto Solari
(divenne il migliore amico del Degola e lo instrado alla cultura della chiesa
francese); ed a Pisa Marcello del Mare (lo introdusse all’Università ed
alla laurea); non ultimo all’estero la chiesa di Utrecht e l’abbé Henry
Grégoire (con lui nel 1801 partecipò al 2° concilio della Chiesa di Francia,
divenendo personaggio di spicco colmato di onori; e con lui viaggiò percorrendo
la Germania, Belgio, Olanda) tutti si trovarono in perfetto accordo su questa
corrente teologico-spirituale, favoriti dalla rivoluzione francese e dalla
ventata di ‘liberi tutti’ che -abbattuta la antica repubblica aristocratica-,
aprì lentamente la strada alla nuova repubblica borghese.
Quindi, la
tesi giansenista
francese, alla quale aderirono fior fiore dei filosofi di allora, perdurava sottotono -come la brace
del fuoco- e richiese alla fine la drastica posizione della Chiesa che portò il
Degola alla sconfitta; infatti fu troncata dalla bolla papale di Clemente XI (‘Unigenitus’; – è il nome di un’altra bolla papale,
già emanata da Clemente VI nel 1343, però per indire un giubileo di sette anni
dopo,) datata 8 settembre 1713 e di poco seguente la distruzione -1709- della abbazia francese ad
opera di Luigi XIV.
Il
Nostro acquisì -per le sue capacità- il riconoscimento di capo guida religioso
in Liguria.
Il
suo apostolato riuscì a influenzare l’arte sacra con tendenze che se prma erano
sopite, ora diventano palesi nell’interpretazione della Via Crucis e del culto
del Sacro Cuore.
Il 1792, dopo aver tanto ed a lungo lavorato dietro le quinte fu l’anno
in cui si giunse ad un primo scontro aperto con il clero tradizionale legato
all’arcivescovo Giovanni Lercari, ai
gesuiti, a Roma in genere. Avversario diretto, oltre l’arcivescovo era GB Lambruschini, acceso
antigiansenista, filogesuita, professore di teologia nel seminario: sotto
pressione del Degola, fu allontanato e sostituito con Stefano deGregori; ma
l’arciv. Lercari, capita la manovra, allontanò anche questi e riportò la
bilancia a suo favore nominando Bartolomeo Rivara
Nel 1793, in un tentativo di riportare il Degola sulla strada
tradizionale, gli fu offerta la guida della parrocchia di Voltri, ma lui
rifiutò l’incarico. Pur rimanendo genericamente inglobato nel sistema, si trovò
pericolosamente ai margini dell’eresia; infatti in numerosi
scritti, dimostrandosi interessato alla cultura e riformismo francese, propose
modifiche nell’organizzazione della Chiesa: ostilità al potere temporale, una
maggiore indipendenza da Roma specie sulle dispense matrimoniali e sui conferimenti di benefici od
ordini sacri, quali elezione popolare dei parroci e dei vescovi locali; il pensiero di reintrodurre nelle cerimonie
l’antica liturgia dell’ordine dei penitenti; nonché una costituzione ‘più
civile’ per il clero, dimostrandosi ostile al potere temporale del papa
tacciato di antidemocratico: idee -pressoché tutte- che furono poste subito
all’indice dall’autorità ecclesiastica.
Il 28 ago.1794 papa Pio VI pubblicò –contro il sinodo di Pistoia
e contro le sue teorie- la bolla ‘Auctorem Fidei’. Essa riunì nello sdegno
tutti i fedeli giansenisti sparsi nello ‘stivale’ ed inizialmente slegati l’uno
con l’altro, contro quello che veniva definito un atto dispotico ed odiosissimo
del papa ed a difesa della loro ‘verità crocifissa’; il Solari rifiutò la pubblicazione
della bolla nel suo territorio. Comportò per il Nostro intensi contatti con ‘l’estero’
(come la chiesa
giansenista di Utrecht ed olandese in genere, divenendone estremo difensore e
propagandista al punto da essere scelto quale amministratore dei beni), che gli permisero poi di conseguire anche il
dottorato in teologia all’università di Pisa (1796).
Determinante, in tutto queasto avvicendarsi, fu l’insediamento
di un governo filo francese aveva portato distruzione delle antiche istituzioni
(da oligarchici a democratici); possibilità di scrivere e pubblicare con
discreta libertà anche su temi religiosi; nelle case delle persone più colte –assieme
alla Repubblica Ligure- un nuovo fermento ed una novella fede politica più o
meno totalmente svincolata dalla soggezione religiosa: rimanendo
fondamentalmente repubblicani (e questo ancora dopo il 1815 alla restaurazione
ed asservimento al regno sabaudo) proliferarono le varie deviazioni o sette:
dei giansenisti, dei massoni, dei carbonari, della Giovine Italia; numerosi
erano quelli che dall’ “albero della libertà” speravano potesse sorgere innanzi
tutto un’Italia libera, e poi possibilmente unita. Il giansenismo del Degola si
inserisce in questa ventata di rimodernamento, mostrando la possibile
assimilazione e convivenza delle nuove istituzioni democratiche nel contesto
della religione cristiana ponendosi al centro delle idee giacobino-illuministe
da un lato e gesuitiche dall’altro, coniugando il vangelo con i principi
repubblicani ed alleandolo con i concetti della ‘libertà’ e dell’’eguaglianza’.
Iniziando
a scrivere con lo scopo di istruire sui diritti e sui doveri in un rapporto
basato su eguaglianza e democrazia (a quei tempi concetti assolutamente inconcepibili), scrisse praticamente da solo -dal 17 giu 1797-
degli “Annali politico-ecclesiastici”, limitandoli dal 5 genn.1798 al 7 dic.
1799 ad “Annali ecclesiastici”; genericamente rivolti alla popolazione -che
però a quei tempi era generalmente analfabeta-, e partecipò alla ricca
produzione giornalistica del tempo (in Genova, c’erano fin trenta testate; molte di esse
gettarono le basi della attuale “libertà di stampa”).
Il 21 maggio Felice Morando ed il nobile Filippo Doria,
accesi da idee giacobine e con coccarda tricolore, aprirono le ostilità ed il
carcere imponendo cinque componenti nella Commissione straordinaria deputata a
tutelare l’ordine; pronta una controrivoluzione che al posto della coccarda si
pose un santino, si impadronì dell’Arsenale e in nome della pace commise stragi
e violenze uccidendo anche il Doria; il 27 maggio Napoleone inviò un ultimatum
al Senato, il quale cedette su tutti i punti: il 6 giugno successivo, la
vecchia repubblica aristocratica ebbe così fine, aprendo l’era della
‘repubblica democratica’ (erezione degli alberi della libertà, abbattimento
delle statue di Andrea e GioAndrea Doria; successivo tardivo aspro rimprovero di Napoleone), alle fiamme il ‘libro d’oro’
della nobiltà e la portantina dogale, liberazione degli schiavi barbareschi,
festa sacra con grande processione. Il 4 settembre 1797, contro questi
rivoluzionari le cui riforme apparvero sostanzialmente contrarie alle idee
religiose, scoppiò in valpolcevera una più corposa controrivolta del clero
delle parrocchie di campagna e dei contadini, che al grido di “viva Maria” si schierarono contro i filo-francesi (il grido, era stato già usato contro
gli austriaci, cacciati dal Balilla); dapprima i popolani furono affrontati pacificamente
dall’arcivescovo, ma insistendo, il 6 sett
ebbero di fronte i
soldati del gen.Duphot chiamato dal governo locale (che partendo dal colle di san
Benigno fece una carneficina: vinse, sbaragliò e braccò gli insorti
controrivoluzionari causando cento vittime tra morti e feriti).
Il Degola, favorito da questi eventi, insistette adoperandosi attivamente
anche in politica esprimendo -negli annali su descritti- pareri, critiche e
progetti sulla neonata Repubblica Ligure (1797-8), sperando essere favorito dai
novelli giacobini con l’etichetta di democratico, nell’idea di una riforma
ecclesiastica -a scapito soprattutto dei gesuiti-, nella fioritura di una
chiesa giansenista nazionale, e nella presenza -nell’elenco dei commissari
destinati a redigere la nuova Costituzione- di persone favorevoli alle sue
idee.
Nel
contempo, tramite le prediche, acculturava alla sua idea ed ai suoi principi
democratici il popolo.
Ottenne infatti all’inizio del 1798 che il Consiglio dei Sessanta
concedesse al Direttorio la autorizzazione ad allontanare dall’esercizio delle
loro funzioni, o dalla residenza finanche con detenzione, tutti gli
ecclesiastici che si rendessero sospetti, anche di sola indolenza; ed alla fine
dello stesso anno che l’arcivescovo Lercari fosse trasferito a Novi, trovando
così la strada spianata e lui pronto e libero di mettere in pratica la sua
dottrina col favore del governo. Genova sarebbe divenuta la prima diocesi
scismatica giansenista d’ Italia. Ma l’avvenimento non maturò, proprio nella
fase culminante, nel momento in cui si doveva eleggere un giansenista al soglio
arcivescovile cittadino; il clero genovese, malgrado la numerosa presenza
giansenista, non si era fatto assorbire globalmente. Il candidato ad occupare
l’incarico di futuro arcivescovo, il vicario Moscino, entrò in crisi e rinunciò
proprio all’atto dell’insediamento.
Questo fallimento gettò in
dissesto il programma del Degola (la prima bolla pontificia con la quale il papa Clemente XI
promulgò l'avversità al giansenismo francese, è molto anteriore ai tempi del
Degola essendo datata 8 settembre 1713 ed ha il nome 'Unigenitus' (eguale nome,
di altra bolla che fu già emanata nel 1343 da Clemente VI per indire un
giubileo per sette anni dopo). Essa diede adito a due contrapposti concetti
religiosi, che perdurarono sopiti -come la brace del fuoco- per tutto un
secolo; richiedendo alla fine la drastica posizione della Chiesa che portò il
Degola alla sconfitta)
Il
definitivo scrollone lo diede Napoleone che, insediatosi al potere ed esautorando
il Direttorio, non trovò politicamente utile inimicarsi il Vaticano, anzi trovò
necessario disfarsi degli ingombranti alleati: fece sospendere un Concilio dei
giansenisti in cui avrebbero potuto ricuperare le forze internazionali e dettò
una convenzione per cui nulla doveva essere fatto ”che fosse contrario alla
cattolica religione”.
Così, dopo la caduta di Genova del 4 giu.1800, l’arcivescovo Giovanni
Lercari riuscì a riottenere il sopravvento ed a cacciare il Degola deluso
anche dai francesi che non avevano accolto le sue idee: malgrado il rientro
delle truppe francesi in Genova, il giansenismo fu frustrato dall’accordo diplomatico
tra Napoeone ed il Pontefice.
Nel 1801 andò (assieme
a GiovanniA Bergancini, unici italiani a Parigi per un secondo congresso
internazionale del clero costituzionale non francese), dove però venne di nuovo sopraffatto sia da un
concomitante concordato tra Roma e Parigi (che decapità la mahggior parte delle autorità chiamate a
dirigere il consesso), e sia dal rientro
nel gregge papale dell’amico Scipione de’ Ricci che interruppe il ricco epistolario con il Nostro. Rimase nella capitale francese per 5 lunghi anni,
alternando viaggi (in
Inghilterra, Belgio, Olanda e Germania ove ebbe contatti con Goethe) per cercare di arginare la scissione e dispersione
dei seguaci: collaborando a giornali, scrivendo intensamente, coltivando
amicizie e stimolando alla conversione.
Un fugace ritorno a Genova avvenne in ottobre 1805, ma il card. G.Spina
gli interdì la facoltà di celebrare e confessare (tale interdizione fu poi
revocata); mentre il Governo si mostrò seccato dalla sua posizione contraria
alla annessione della Liguria alla Francia.
Pertanto -1809- rientrò a Parigi con la scusa della partecipazione al
centenario della distruzione della abbazia di Port Royal des Champs. Qui rimase
otto mesi riprendendo contatti allentati e continuando l’opera missionaria
‘conquistando’ nuovi proseliti (tra essi, più
famosi risultano la dama Adele de Sellon, futura madre del Cavour; la famiglia Mazzini, soprattutto la madre Maria, dibattuta tra la convinzione
giansenista, la fede cattolica tradizionale, le nuove idee del figlio
perseguitato ed esule e la figlia andata suora dalle Franzoniane. Ed anche Enrichetta Blondel (già calvinista: nel magg.1810 ella
abiurò nella chiesa di St Séverin ricevendo dal Degola un memoriale di vita
spirituale mirato a guidarne la vita), sua madre Giulia Beccaria (recuperandola da una avviata vita dissipata; fu poi
seguita dal parroco canonico Luigi Tosi), ed infine il Manzoni stesso (sposo nel 1808 della Blondel. Conobbe il prete nel 1810
scegliendolo quale direttore spirituale attraverso visite ed anche fitta
corrispondenza nella quale il Degola approvò la pubblicazione di «Osservazioni
sulla morale cattolica». Ambedue i coniugi poi si riconvertirono al
cattolicesimo, come descritto nel libro di Francesco Ruffini intitolato “La
vita religiosa di A.Manzoni”).
Tornato a Genova, andò a risiedere nella sua casa a Sestri Ponente; seguì attivamente
Ottavio Assarotti scolopo dedito a favorire del famoso Istituto dei
Sordomuti (primo in
Italia a protezione ed occupazione dei minorati. In questo Istituto collaborò,
interessandosi ai nuovi metodi dell’educazione dei giovani e pbblicando un
testo nel 1820), e nello scrivere
il suo libro più importante: il “Catechismo dei Gesuiti” col quale si illudeva
di stimolare il mondo cattolico e che invece passò pressoché inosservato. Il
colpo finale avvenne nel 1814 quando l’ordine dei gesuiti, i suoi più
acerrimi nemici, venne ripristinato.
Morì
a Genova il 17 gennaio 1826, a 65 anni, nella piena e continua
convinzione delle sue idee, senza riconciliazione con la Chiesa romana.
Numerose
furono le sue traduzioni (pubblicate con lo pseudonimo Ireneo Filarete).
Di lui possiamo dire che anche se sconfitto nella sua missione fondamentale
antipapale ed antigesuitica, fu promotore di un pensiero vincitore se si
considera l’importanza non indifferente e decisiva del seme cattolico
laico-liberale, per la nascita della Nazione riversato negli scritti del
Manzoni, nell’educazione del Cavour e del Mazzini, nell’ideologia di tutti i
personaggi che furono primi attori degli eventi dell’epoca.
Che
il comune locale non abbia mai avuto affinità affettive con la Chiesa è
riscontrabile nel costante comportamento strettamente e prettamente laico della
sua amministrazione, cointeressandosi del sociale religioso solo in convivenza,
ma rispettosamente a distanza. La scelta del cambio di titolazione alle strade
deicate a dei santi, e della titolazione di altre ad un prete cattolico come
don Daste e don Bosco potrebbe far pensare il contrario; invece aggrava il
distacco e freddezza, anzi sembra una sfida, se si considera la qualità della
fede professata dal Degola in netto contrasto con la chiesa di Roma.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Com. Toponomastica - scheda 155_
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.401—ed./02-pag.438
-AA.VV.-Dizionario
biografico dei liguri-Brigati 1998-vol.IV-pag. 459.
-AA.VV.-Strutture
dello spettacolo-Reg.Liguria-pag.92
-Cappellini
A.-Dizionario biografico dei genovesi ill.-Stianti 1932-pag.46
-Costa
E.-Dizionario biografico dei Liguri-Brigati
-Doria
G.-Investim. e sviluppo econ.a Ge.-vol.II-Giuffré.1973-pag. 7.443
-Favretto
G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.165
-Ferrari
GB-Capitani di mare e bastimenti-Tigullio.1939-pag.136
-Fontana
P-Tra illuminismo e giansenismo-QuaderniFranzon.-XII-2-p.384
-Gavazza&Magnani-Pittura
e decor…nel 700-Carige-Sagep 2000-pag304
-Gazzettino
S.: 1/73.9 + 4/88.8 + 1/89.8 + 6/90.3 + 1/91.2 + 8/98.4
-Genova,
rivista municipale: 9/37.23+11/37.31+4/56.38+1/64.42+3/64.52
-Il Secolo XIX : 20/2/2000 pag. 35 + 12/09/05 + 27.7.011 pag.20 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena. –LibroPiù.2001-pag.102
-Massobrio
A.-storia della Chiesa a Genova-DeFerrari.1999-pag.22.38
-Millefire.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA-1986-pag.141
-Pagano/1940-pag.271---1950
pag.582---/1961-pag. 564-5carta
quadro79
-Piastra
W. &C-Dizionario biografico dei Liguri-Brigati.1992-IV-p.459
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.33
-Puncuh
& AAVV-Il cammino della Chiesa genov-Q.Franz.1999-pag383
-Ronco
A.-Storia della Repubblica Ligure-Sagep.1986-pag. 180.365
-Tuvo
T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani.1983-pag.46
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag. 192carta
-Vitale V.-Onofrio
Scassi-SocLigStPatria.MCMXXXII-pag.40
-Volpe&Padovano-La grade
storia di Ge.-ArtLibri 2008-vol.VI-pag.146
DELEGAZIONE piazzetta della Delegazione di
Porto
Evidente
che questa terminologia appartiene a quella non ufficiale del Comune, ma a
quella in uso popolare pratico mirante ad indicare una zona o strada in
rapporto alla principale fonte di interesse che vi fosse posta.
Negli
ultimi anni del 1800, ci si propose una più precisa definizione delle strade;
cosicché individuata nell’anno 1900 a lato mare della via C.Colombo una
piazzetta ove lavorava questa autorità portuale, nell’anno 1901 fu proposto
cambiare questa generica titolazione, con una nuova precisazione funzionale:
“piazza della Sanità” .
Il
nome lascia pensare che - nell’epoca in cui ancora il porto non c’era a San
Pier d’arena, esisteva un punto di riferimento per il controllo di tutte le
operazioni di imbarco e sbarco dai velieri, per il guardianaggio, per il
coordinamento delle varie categorie di lavoratori e, non ultima anzi la più
importante, per i controlli sanitari.
BIBLIOGRAFIA
Archivio Storico Comunale
DE MARINI via De
Marini
TARGHE
San
Pier d’Arena – via – De Marini


sul WTC,
angolo via Scarsellini


angolo via
Scappini


angolo via
P.Chiesa
QUARTIERE ANTICO: Coscia
 Da Vinzoni, 1757. In celeste, la
strada alla Lanterna; giallo via sAntonio (via NDaste); rosso, via Larga
(Palazzo della Fortezza).
Da Vinzoni, 1757. In celeste, la
strada alla Lanterna; giallo via sAntonio (via NDaste); rosso, via Larga
(Palazzo della Fortezza).
N° IMMATRICOLAZIONE:
2768 CATEGORIA 2
 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 22020
UNITÀ URBANISTICA: 26-
SAMPIERDARENA
 da google Earth 2007.
da google Earth 2007.
CAP: 16149
PARROCCHIA: NS sM
delle Grazie
STORIA:
PRIMO
TRAGITTO: ANTICO 1. normalmente si descrive questa strada, partendo dalla
Lanterna e proseguendo verso il borgo. E così era in antico: il primo tratto
della prima -e più importante- strada costruita nel centro del borgo, dalla sua
nascita fino a metà secolo del 1600. Per mille e più anni, essa costituì
l’unico transito d’obbligo, nell’interno del borgo
Ultramillenario quindi il tracciato che dall’angolo del primo agglomerato di
case, detto Coscia (o anche “primo quartiere” o “quartieretto” (termine di origine della seconda
metà del settecento, quando Genova era divisa in 5 quartieri, ed il nostro, per
i genovesi, primo ‘fuori porta’)),
andando un po' a rientrare - per evitare la spiaggia e le mareggiate e
procedere sulla terra dura - portava in senso longitudinale parallelo al mare,
sino “alla Polcevera”.
È
una strada con un grande passato, di grande importanza, con una grande storia;
grande signora … purtroppo poi spezzettata, dal dopoguerra decaduta, ignorata,
isolata e dimenticata anche nelle strutture andate in disuso, di cui poco se
ne è parlato se non in negativo a causa dei poveri immigrati tra i quali sono
si mescolati i peggiori delinquenti della società di oggi.
SECONDO
TRAGITTO: ANTICO 2 Tornando lontano, la sua seconda storia inizia quando fu
aperta la strada dalla Lanterna, con le mura del 1630. Da allora, sino alla
fine del 1800 non aveva nome: era genericamente la strada principale, quella
interna (o superiore, o comunale) di collegamento con Genova per mercanti,
viaggiatori, militari e per i proprietari delle ville di tutto il ponente.
É del 5 ottobre 1758 la legge che prevedeva il lastricamento di questa
strada, dalla Coscia a Mercato (e poi oltre, prolungata sino a san Martino ed
al ponte): il tratto
fu misurato in 935 cannelle (misura che serviva per i terreni; il Casaccia dice
che una cannella “contiene 12 palmi in quadrato ossia 144 palmi genovesi” che
calcolando corrisponderebbero a 297,7 cm: quindi un totale di 2,783 km = anche
sino a san Martino, mi appare troppo ed impossibile!), contemplava una spesa di
4116,10 lire a cui dovranno concorrere 35 persone .
Nel giugno 1805 fu percorsa da Napoleone,
entrando in Genova; l’attendeva alla porta della Lanterna il ‘maire’ di Genova
Michelangelo Cambiaso che gli offrì le chiavi della città (a simbolo di sudditanza alla
Francia; ma Napoleone le rifiutò, ad altrettanto simbolo di lasciar conservata
e libera la Repubblica).
Prima del 1850 ancora non aveva un nome
definito, e veniva genericamente chiamata “strada comunale interna”.
Dopo quella data subì il primo taglio, dalla ferrovia che la incrociò a x , e
la spezzò in due parti. Ciononostante conservò ancora una certa unità, infatti
quando col regio decreto del 1857, si vennero a stabilire per la prima
volta i nomi delle vie cittadine, al pezzo di strada dalla Lanterna sino alla
crosa Larga (al palazzo
Grimaldi della Fortezza), fu dato il
nome di “primo tratto della lunga ‘strada superiore’ (i successivi pezzi erano -in
continuità verso ponente-: via sant’Antonio, via (del) Mercato, via san Martino
). Quindi ancora anonima.
Non esiste alcun documento che in forma ufficiale
decreti la titolazione ai DeMarini; si è liberi quindi di supporre possibile
che il cardinale (che abitava nel nostro borgo e
per le alte benemerenze che aveva acquisito nel nostro territorio),
alla sua morte, nel 1747, abbia lasciato così profonda emozione (e donazioni) da
far sì che la gente o gli incaricati comunali la dedicassero a lui che per i
suoi alti uffizi doveva giornalmente percorrerla per andare all’Arcivescovado o
a Palazzo. Perché quando agli inizi del 1900 arrivò dallo stato regio di Torino
l’obbligo di dare i primi nomi stradali, questo fu uno dei primi –se non il
primo assoluto- ad essere imposto ad una strada, più o meno assieme a via
Vittorio Emanuele II; prima di eventuali tanti altri personaggi possibili.
In contemporanea, arrivò
il ‘progresso’: alle ferrovie seguirono il porto, il taglio di san Benigno, le
nuove strade laterali e parallele, la camionale, i nomi nuovi inglesizzati (già
d’antico ci facevano vantare di essere la ‘Manchester italiana’: poveri noi,
che bubboli! Nessuno – e forse neanche noi, oggi - conosceva le immagini
obbrobriose della città inglese avvolta nello smog prodotto da centinaia di
ciminiere, fitte come le croci nei cimiteri; ed così altrettanto, ci riempivano
di fumi, rumori, sovrapopolamento. Non vita ma sopravvivenza, e lasciarono
rompere e distruggere tutto quello che nelle altre parti del mondo è usato per
menarsene vero vanto: l’antico, la bellezza e la natura. Ci sono stati anche i
lati positivi, del lavoro, della socialità maturata nelle strutture che oggi
godiamo – pensione, sanità, libertà. Ma con una conduzione più oculata, si
potevano avere tutte e due assieme).

Foto del 1910 circa - A
destra negozio di parrucchiere (l’insegna dice “sala toeletta”),
poi la chiesetta, poi la
villa De Franchi
Nel 1940 andava da via di Francia, e finiva chiusa.
Oggi, superato il sottopasso, via DeMarini non prosegue
più diritta (dopo un lieve Z) verso mare
fino allo spiazzo chiamato Largo Lanterna (ora, questo tratto è anonimo e, a
ponente, dove c’erano delle case -che sono state abbattute- ora è bosco
incolto chiuso dai muri esterni dei palazzi stessi, troncati a due metri di
altezza; sino al Largo, che ormai ha perso tale dignità, conservando però
ancora –nell’era incolta- l’inizio di via Vittorio Emanuele II con la
ringhiera. A levante, all’inizio c’è ancora (nel 2007) il palazzo
d’angolo, ovviamente vuoto ed in stato predemolitivo (se non precipiterà da
solo), seguito sino al Largo da un muro fatto di antiche pietre sovrapposte,
sopra il quale troneggia la Nuova Darsena, seguita dalla strada che va a finire
in un vasto piazzale di posteggio tir e camions).
La Targa apposta sulla strada prima dell’ultima
rivoluzione era «S. Pier d’Arena – 2768 - via – De Marini»
TERZO TRAGITTO; MODERNO 3 Per descriverlo mi occorre
invertire il senso, procedendo all’inverso: la strada oggi è come una T: inizia
l’asta orizzontale inizia davanti al WTC e prosegue verso il mare diritta come
in antico: dopo l’elicoidale infatti continua verso la Lanterna anche se
momentaneamente anonima. Prima di sottopassare l’elicoidale si innesta l’asta
verticale della T e nuovo percorso: infatti, proveniente dal WTC gira a destra scorrendo
a ponente del muro dell’elicoidale, e sbuca in via Pietro Chiesa.
CIVICI
2007 = da 1 a 61
(compresi 17AC; mancano 23→ 33,43→49, 57, 59)
da 2
a 62 (mancano 24→48, 58)
Un documento del 29 maggio 1878,
segnala che “al civ. 25 di via De Marini, il sig. Carlo DeFranchi dove abita,
ha impiantato una attività privata industriale”: sicuramente non il primo ad
incominciare!
Un elenco della fine ottocento, dei proprietari
delle case della strada, vede:
civ.1,1b,1c,4 Bianchetti
Sebastiano;--- 1a Tramway elettrico;--- 2 e 5 Rebora Andrea;--- 6 e 7
Scarsi e C.;--- 8 Carpaneto GB;--- 10,13,14, 15,17,18 Canepa
Francesco;--- 11,12,13a eredi Balleydier («costruttori meccanici e
fonderia in ghisa);--- 15b Gattorno;--- 16 Canonica della chiesa
Grazie;--- 19a casa cantoniera delle Ferrovie dello Stato;--- 19 e 22a
Balbi;--- 20 e 21 Pissardi A.te;--- 22 Carlevaro Giuseppe;--- 23 eredi Bodda
(insieme al seguente, hanno « al 23 una fabbrica di cemento);--- 24
Frassinetti;--- 25 Piccardo vedova Rovereto;---
26 e 27 marchese Pallavicini (viene
descritta una cappella (vedi Cibeo) di proprietà della marchesa Vittoria che si
potrebbe chiamare privata e pubblica avendo l’accesso in via Demarini, “alta,
spaziosa, ben architettata e decorata di buoni affreschi, capace di tre altari
quantunque uno solo ne esistesse. In questa cappella si ufficiava pubblicamente
nei passati tempi massime dell'anno 1849 e 1850 quando si stava costruendo la
chiesa di N.S.delle Grazie. Certamente che allora non si prevedeva lo stato
deplorevole in cui venne indi ridotta e come presentemente si trova”) ;--- 28 e
29 Piccardo Giovanni (nel palazzo del
cavaliere Piccardo Giovanni, sito in Montegalletto, viene descritta l’esistenza
di una cappella ove talora si celebra la s. Messa con speciali privilegi
dell’oratorio privato);--- 30 Oneto Francesco (con « officina di costruttore
meccanico e fonderia in ghisa);--- 31 32 e 32abc conservatorio delle figlie della Carità ; ---33 e 35a eredi Lombardo
(f.lli , fu Raffaele, con « fabbrica di saponi e sego);--- 33abd Bulgarello;---
33c Carbone e C.;--- 34 Sanguineti Lodovico
(con & C. « fabbrica di conserve alimentari»);--- 35,36,37,38 Piccardo
Giovanni ;--- 35b eredi Alvigini .
Nel Pagano 1902, oltre quelli sopra, si leggono:--- 8 Tosetti P.’ fabbrica
casse in legno e litografo;--- al civ.11 i costruttori meccanici e fonderia in
ghisa rispettivamente Balleydier Frères’ con telef.n.593;--- 13 f.lli Rossi’ negozio e mediatori bestiame
(singolare
la storia verificatasi a metà del 1300 riguardante il macellaio
Ruby ovvero Rossi, e dei due suoi figli Antonio e Bartolomeo divenuti
speziali: in quegli anni la corporazione dei macellai fu assai potente
inserendosi per due secoli e più, nella vita politica genovese, come nuovo
ceto mercantile o artigiano, comunque ‘popolano’ (populares, distinto dai
nobiles) avendo avuto notevole partecipazione nell’elezione a doge di Simone
Boccanegra: riuscì ,1359, a far eleggere Ruby quale ‘anziano della Repubblica'
facendogli ricoprire in Genova la carica di viceduce. Tra i 18 Sapienti, tre
erano macellaiuno dei primi atti del nuovo governo fu il condono –ai macellai-
dei fitti arretrati dei loro banchi, in quanto “multum profuerunt ad faciendum
statum presentem”. Anche il figlio Bartolomeo alla fine di quel secolo divenne
‘anziano della Repubblica’. Tutti e tre vennero sepolti nelle chiesa di NS
delle Vigne nel cui chiostro ancor ora si può leggere la lapide munita di scudi
araldici: “+ S(epulcrum) Q(uondam) D(omi)NI ANTH(oni) RUBY – MACELLAR(ii) D(e)
S(ancto) PET(ro) – ARE(n)A ---continua con
→ qui obiit
MCCCLX die X Januarii et Antonii et Bartholomei speciariorom fratrum et
filiorum dicti q.Antonii et heredum filiorum dicti q.Antonii et heredum suorum,
quorom anime requiescant in pace amen, et qui autem eius filii decesserunt
MCCCLXXII die XX Augusti”).
Ci sono dei Rossi, ascritti con i Grimaldi nel 1528, ma hanno una arma diversa
da Ruby);
--- 21 la Fabbrica Nazionale di Accumulatori Elettrici brev.
Tudor (ancora attiva nel 1912);--- e negozio vetrami di Rothpletz e Frey (fino
al 1908);--- 25 Moro Tomaso e Figli (ancora
nel 1912) hanno fabbrica di conserve alimentari e sono commissionari e
rappresentanti (in genere) nel ° rimane tel 8 per conserve alim; e 822 come
rappresentanti;--- 30 Oneto Franc’ costruttore meccanico;--- 33 Lombardo f.lli
fu Raffaello fabbrica di candele di sego;---e Cavalca V. e C. hanno negozio di
biacca, vernici e colori;--- NON segnato il civico: albergo ‘del Toro’ di Rossi
Giuseppe fu Em. (nel 1919 di Guano Ettore; dal 1921 ed ancora nel 25, di Rossi
Umberto);--- angolo via Marina, la farmacia Bassano GB Diovuole--
Nel Pagano/1908’ vengono citati 34 fabbrica conserve alimentari di Sanguineti Lodovico;--- civ.33
fabbrica di saponi e di candele di sego dei fr.lli Lombardo fu Raffaele-- 69r
negoziante di legnami con segheria a vapore Rastelli e Bagnasco telef.n.304--
Nell’elenco stradale comunale del 1910, si legge
che “via Demarini, dal largo Lanterna fino a via Iacopo Ruffini” aveva civv.
sino a 30 e 59 (quest’ultimo cancellato con un tratto a penna, ma non
corretto).
Nel Pagano 1912 (§ nel 1919; ¨1925) nella
strada compaiono: all’8 Tosetti P. fa
litografie su latta (non + nel 1925);- -- al 9-11r commestibili di Brasoni (o Biasoni) GB.§¨;---
al civ. 11 i costruttori meccanici e
fonderia in ghisa Balleydier fréres, tel 593 (nel Pagano/19 ci sono, nel/20 non
cè più);--- 12-14 la farmacia
Bassano GB Diovuole angolo con via Marina (mai
esistita, quest’ultima via e corrisponde a via Cassini -allora via Manin- dove,
dal 1925 compare );--- al 13 i fratelli Rossi mediatori di animali con negozio di
bestiame presenti anche nel 1919;--- 16r commestibili di Cerinto Carlo ancora attivo nel 1925;--- 20 la levatrice Mortara Teresa; e poi il pizzicagnolo Olivieri Angelo aperto ancora
nel 1925;--- 21 la ‘Fabbrica
Nazionale di Accumulatori Elettrici’ brevettati Tudor ed il negozio-gross. di
vetrami Rothpletz e Frey;--- 30-D il
costruttore meccanico e fonderia in ghisa Oneto Franc.;--- civ.33
i fratelli Lombardo fu Raffaele (nel 1919 e 25,
anche al civ.24) fabbricano candele di sego e saponi;--- 34 fabbrica e negozio di conserve alimentari di
Sanguineti Lodovico e C. (nel 1919 è al civ. 30, tel. 12-90, poi nel 1925 ha 41-353);---
36r un forno per la produzione del pane
di Pozzuolo G. attivo ancora nel ‘25¨;--- 49-51r commestibili di Dagnino Oreste presente fno al 1919;---
59 ‘Cappellificio Ligure’ (§
tel.30-93) negozio e fabbrica;--- 69r Rastelli e Bagnasco negoziano in legnami, lavorano con una sega a
vapore e col telef. n. 304 (nel 1919-25 sono diventati Bagnasco e Masnata,
importazione diretta dall’America, Svizzera Rumenia-tel. 41056);--- 76r
la Wax Walser e C. acciaieria, tel. 46-61;
81-83r commestibili di Mossi Emma che lavora ancora nel 1919;
Non specificato il civico: E.Roggero e C. gestisce lo
stabilimento ‘Standards’ dei scaldabagni Roggero;--- la residenza del pittore
scultore Bassano Luigi di nuovo è segnalato nel
1919 (e forse anche dello scultore Roncallo Pietro).---
Il Pagano 1925¨ aggiunge : al civ. 27 Moro Tomaso
e figli, tel.41282 sono rappresentanti e commissionari “in genere” e compaiono
non ancora impegnati nell’olio;---al 43 Bagnasco
Antonio ha docks (magazzini per deposito) marittimi;--- al 44r Bacigalupo e C. sono costruttori meccanici generici
(mentre Bacigalupo Salvatore è costruttore
navale); ---al 155r Bosio Costantino ha
un laboratorio di marmi (anche in via JRuffini);---non specificato il civico: Moizo Attilio fa il droghiere;-
Nello stesso elenco comunale, pubblicato nel 1927
quando tutte le strade erano incluse nella Grande Genova, vi viene segnalato un
omonimo ‘vico’ in Centro; e la nostra di 4a categoria.
Nel Pagano 1940 si segnalano: civv. neri=
civ. 8-Oli combustibili; 14A raffineria e olii di G.Costa; al 9 levatrice; al
43 un chimico. Civici rossi= tre osterie; due commestibili;
autotrasportatore, latteria, tabacchino, parrucchiere, calzature, trattoria. (A
Genova esistevano anche un vico ed una piazza omonimi ma con cognome tutto
attaccato)
A ponente della strada ferrata, il tracciato è rimasto
intatto fino ad oggi. Al contrario, sostanziali modifiche ha subito il
tratto a levante: incroci e sovrappassi; tagli ed accorciamenti; costruzioni e
demolizioni; gloria ed abbandono. In particolare il secondo taglio fu
effettuato dall’apertura di via di Francia (che
non trovò ostacoli architettonici o storici degni di mantenimento); il
terzo, anche lui è un soprapassaggio, dell’elicoidale; quarto la completa
demolizione del quartiere e cambiamento dell’itinerario.
STRUTTURA: procedendo
dal mare, inizia da via Pietro Chiesa per oltre 100 metri costeggiando a
ponente l’elicoidale; indi curva a 90° sovrapponendosi finalmente per 200 metri
ancora, l’identico antico tracciato, fino a sbucare in via di Francia.
In sostanza l’antica
strada è ora divisibile in quattro tratti, da levante: il primo da via P.Chiesa
a Passo di via di Francia è nuovo, in quanto ancora nel 1961 era chiuso ed
impraticabile. Il secondo è sovrapposto alla primitiva ‘via De Marini’, ed
arriva sino al WTC; il terzo è spianato da via di Francia; il quarto è divenuto
nel 1935 ‘via L.Dottesio’.
Era doppio senso veicolare; nel 2009 è senso unico
Viene descritta essere completamente in territorio di
proprietà del CAP
CIVICI
la
numerazione in antico andava dalla Lanterna al centro; oggi invece è invertita
e va dal WTC a via P.Chiesa. Seguiamo quella antica
¶¶1)
da largo Lanterna al sottopasso dell’elicoidale:
===civv.
2,4,6,8 ; erano i civici posti più a levante del quartiere della Coscia e
quindi del borgo; per chi arrivava da Genova, la strada iniziava subito dopo
Largo Lanterna, indirizzata verso nord, fiancheggiata a ponente per cento
metri da questo lungo caseggiato popolare a 5 piani, senza terrazzi, la cui
unica caratteristica era un terrazzino d’angolo in largo Lanterna che fu
costruito come prua di nave (similare esiste solo nell’angolo tra via P.Reti e S.Bertelli).
Al civico 6, sino al
1961 c’era una Associazione Italo-scandinava. Ultimi proprietari del
caseggiato, appaiono le soc. SVIM ed ARMID e la SCI costruttrice ma già nel
1999 in liquidazione.
La storia dei primi abitanti del caseggiato, è la storia della
Coscia e di SPd’Arena.
Drammatica è invece la storia agonizzante degli ultimi
vent’anni.
Già abbandonate le case a metà degli anni 80, il palazzo
rimasto abbandonato fu presto occupato dai gatti e marocchini, altrettanto
presto sostituiti da rumeni ed albanesi, via via cresciuti in famiglie e
divenuti più di 200: disperati extracomunitari (appunto da chiamarla
popolarmente ‘la casa degli albanesi’) pressoché tutti arrivati a Genova
clandestinamente e purtroppo dediti ad attività troppo spesso e genericamente
illegali.
Pochi anni dopo si era tentata la muratura di tutte le
entrate e finestre, ma le attese di demolizione favorirono il clandestino
rientro, e con loro ovviamente una impennata della criminalità tra loro e della
microcriminalità con la popolazione. E’ sul Secolo XIX del lontano marzo
1998 che nelle case pericolanti e murate furono ritrovati 150 infiltrati
clandestini, tra cui 10 bambini, viventi in miserande condizioni senza servizi
–luce ed acqua in particolare- ma anche toilettes per le quali venivano adibiti
i piani alti, senza ovviamente ripulirli. I vigili vennero costretti ad operare
continuamente controlli e ‘censimento’ di questi disperati, finché il Comune
addivenne alla necessità di eliminare il problema alla radice, visto che recidivava
con immediata sequela.
Ovviamente si innescò la sterile diatriba su quella povera gente sfrattata e
con rischio del rimpatrio; nonché sul “centro storico distrutto e non
restaurato o quantomeno non riutilizzato in modo opportuno”. La demagogia di
chi ci governa, lenta come sor Tentenna, indecisa nel prendere drastiche ma
vitali soluzioni, era riuscita in pochi anni a trasformare un quartiere da
ambiente di rudi pescatori, minolli, e marinai ma onesti, nello squallido e
fatiscente covo di delinquenti; rendendo alla memoria del nome della Coscia la
peggiore insegna di gogna e ghetto. Non era certo mantenendo pietosamente
questa situazione che si aiutava un immigrato ad inserirsi. Dei 200, 80 se ne
andarono spontaneamente prima dell’arrivo delle ruspe; 16 donne ed 11 bambini
in albergo; gli altri quasi tutti senza lavoro né documenti.
Gli animalisti di ‘Zampatesa’ minacciarono di far sospendere
i lavori, per salvare i 25 gatti inselvatichiti e randagi, ospiti anche loro
dei ruderi: sui giornali “i gatti stoppano le ruspe in marcia sui ruderi della
Coscia”.
Il 21 mar.1999 la soc DemolScavi di Rapallo (la stessa che già aveva sbancato la
vicina zona di san Benigno: otto operai, tre scavatori, due pale ed una pompa
capace di spruzzare 700 litri d’acqua a/ minuto), sotto i reiterati colpi di una ruspa scavatrice,
munita di un braccio d’acciaio lungo 22m, ha abbattuto, azzerandolo il
palazzo. Come scrisse il cronista del Secolo, “il passato di Sampierdarena
scompare di buon mattino nelle fauci di una ruspa”. In una settimana tutto il
triangolo di 11mila mq tra via DeMarini-via Balleydier-ex via Chiusa, furono
abbattuti, lasciando le macerie per impedire una baraccopoli. E già allora, fu
prospettato in zona il futuro Mercato del pesce.
Da queste case e quelle attorno, questa povera gente di
extracomunitari si era riversata nel vicino piazzale san Benigno: al posto del
parcheggio della cooperativa AldoNegri, si era creato un
campeggio-accampamento abusivo. Camioncini fatiscenti, roulottes, tinozze di
plastica e panni stesi, bambini a giocare, i vicoli intorno intesi come latrina
pubblica: era diventato il nuovo ‘luogo della vergogna’. Nel luglio 1999 la
polizia dovette intervenire anche lì, sgomberando pure questa zona, disperdendo
i nuclei familiari, cercando di evitare il loro assembramento fautore di
lordure e risse, nonché ricetto di sbandati, balordi ed irregolari.


1999 v. De Marini a destra; via De Marini è
diagonale in alto (con sopra la Nuova Darsena)
quello alto è il palazzo in Il getto d’acqua,
schizzato da Largo Lanterna serve per abbattere
demolizione nella foto a fianco la polvere del palazzo
in demolizione
.
Nel 2003 tutta SPd’Arena è divisa in ‘proprietà della mala’;
la zona della Coscia-san Benigno, appare sempre in mano ai rumeni, a
confrontarsi con gli albanesi di piazza Barabino e gli ecuadoregni di Prè.
Li vicino c’è un albergo a quattro stelle, una strada di
gente normale ed una Coop di lusso.
Da dopo l’anno 2002, largo Lanterna praticamente
non esiste più; quindi la strada è continuativa perché non ha più un punto
preciso di inizio; è contornato da ponente dalle macerie dei palazzi rasi al
suolo, e da levante dal muro di cinta de ‘la nuova Darsena’.
Dopo questo centinaio di
metri, la strada prima incrociava via Balleydier, poi passava sotto un alto
fornice del raccordo anulare necessario per salire dalla strada a mare
all’autostrada (che appare alquanto decentrato rispetto l’asse viario); dopo il
tunnel a destra inizia verso monte il ‘passo alla via di Francia’.
¶¶2) dall’elicoidale alla
ferrovia
dopo il tunnel
dell’elicoidale la strada diveniva per 300 metri circa, una stretta viuzza
rettilinea (una fila di
auto in sosta dal lato ponente, e lo strettissimo passaggio per la viabilità a
levante) che arrivava sino a via di
Francia.
Nel Pagano/1933 risultano aperti sulla strada questi
esercizi: al civ.24 fabbrica di sego,candele e saponi dei fr.lli Lombardo fu
Raffaele; al 27 Tomaso Moro e figli hanno fabbrica di conserve alimentari;
Moizo Attilio esercita come droghiere non si dice dove ma appare anche come
confettiere in via Manin; al 30 Sanguineti Lodovico ha fabbrica e negozio di
conserve alimentari; al 32r Costa Giacomo fu A. ha una raffineria di olio
d’oliva che sarà ancora attiva nel 1950; al 43 Bagnasco Antonio ha dei docks
marittimi; al 69r Bagnasco e C, sono negozianti in legname (importatori diretti
dall’America,Svizzera e Rumenia (sic), con segheria). Non è citata la trattoria
del Toro.
Nel Pagano/1950 a significato della perdita di importanza come
traffico, vengono segnalati una sola osteria (16r di Bonfiglio Italia. Una sola in quest’anno, ma
nell’ antico erano i locali dove si rifugiavano gli uomini finito il lavoro;
dove erano tipici i “quartini” bevuti direttamente dal pirone (pirrun) –il cui
effetto era direttamente proporzionale a quanti ne erano stati ordinati-, si
giocava a briscola, a tressette o a braccio di ferro, si discuteva di lavoro,
politica o mutuo soccorso; per molti era un luogo di progresivo abbrutimento) ed una sola trattoria al 49r di Filippini C. (vedi sotto).
Il
Pagano/61 pone al 6 l’assoc. Italo-scandinava; al 12 la
scuola di avviam N.Barabino; e ai civv. rossi 1r Bartolini&C off.mecc: 9-11r
Losi P. oggetti usati; 16r osteria Bonfiglio I; 18r Anelli M. commestibili; 28r
Bonfiglio I. latteria; 31r Riccardi G
demolizioni navali; 32r Costa G. raffineria; 33r Bonardi E.pennelli; 37r
Pastore O. comm.li; 39r Polverini M. parrucch.; 41r Crosa f.lli trasporti; 43r
Simoni G.calzolaio; 49r Filippini M. ristor. del
Toro; 49r Aretusi G. autotrr; 51r Benassi B. rottami metall.
===civv.8a,10,12,16
demoliti nel 1985;--- i 5,7,9,11,13,15 nel 1987;----
il 58 nel 1994;---- 81,
83 nel 1995;--- 75, 77, 79 nel 1999)
A lato levante c’era :
===civ. 49 r:
l’antica trattoria del Toro:
caratteristica e notissima, perché una delle più vecchie di tutta Genova, e
che -in città- non aveva uguali in fama (se non ‘la Gina del Campasso’,
finché fu attiva): trattamento rustico da amici, in maniche di camicia, sempre
allegria, battute vivaci, genuinità e semplicità.

Nel 1908 era gestita da un Rossi
Giuseppe fu Em. discendente di una famiglia di
armaioli o archibugieri (chiamati bûxè); si scrive che, essendo un buono, usava
la forza per contrastare i prepotenti e raddrizzare i torti; e quindi
facilmente protagonista di situazioni enfiate a leggenda, tipo che avesse
abbattuto un minaccioso toro ( da qui il nome) con un pugno e con le dita
piegasse in due le monete di rame (le famose “palanche”, con il profilo di re
UmbertoI); di carattere mite, se però c’era ‘da darsi’ non si tirava indietro e
vinceva sia a pugni che a testate, e quindi spesso soggetto a sfide di primato
con i camalli ed altri dal mestiere da forzuti, tipo “mi, me vorrieva dâme con
vöscià”. Da lui aveva tratto il nome di ‘locanda del Toro’, dove il viandante
poteva dormire, mangiare e cambiare cavallo; anche le diligenze facevano tappa
ristoro e stallaggio; il punto era diventato famoso perfino ai ‘foresti’.
Rilevata
pochi anni dopo da Ettore Guano, classificato
‘il più forte di SanPier d’Arena’, ma la cui più nota qualità era solo tra i
fornelli.
All’interno,
dopo aver superato la cucina visibile da tutti e separata da un bancone di
marmo, si accedeva ad un ampio locale con unico tavolone centrale; da lì due
altre lunghe stanzette anch’esse corredate non da tavolini ma da lunghe
tavolate che obbligavano –salvo rare possibilità- a mangiare tutti assieme,
ricchi e poveri, in comitiva o in coppia, serviti in forma molto semplice e
familiare; alle pareti, tra i mobili della nonna, centinaia di quadretti
testimoniavano gli avvenimenti più svariati con foto o gagliardetti, o
ritratti firmati di tutti i personaggi famosi divenuti clienti, attori,
musicisti, politici, scrittori, sportivi (era in genere un covo di sampdoriani (la squadra vi si riuniva ed
organizzava annualmente una festa per i bambini orfani), e la famiglia Guano era
blucerchiata in ogni componente compreso il genero, terzino della squadra, e che chiamandosi
Podestà –per evitare ricordi politici irritanti, lo chiamavano Sindaco; i
genoani venivano regolarmente bistrattati, ma era loro convenienza accettare le
verdine per poter mangiare come si deve- o meglio anche della ‘Sampierdarenese 1946’, visto che di
ambedue aveva la foto di gruppo di pressoché tutti gli anni di attività,
essendone –il figlio Checco un socio fondatore
e fautore del Morgavi). Tutti questi
ricordi non si sa dove siano (alla forzata pensione conseguente lo sfratto e distruzione del
caseggiato, il Checco, che aveva proseguito con altrettanta bravura la traccia
paterna, fu costretto ad un pensionato-albergo a Manesseno, fino al decesso,
secondario a banale caduta avvenuta nel luglio del 1995; tutti quei ricordi
saranno speriamo in casa degli eredi, in attesa di qualche ricercatore di
memorie).
Piatti
tipici erano il classico minestrone ( quello che tiene diritto il cucchiaio immesso verticalmente
come un palo); lo stocca; la buridda di
seppie calamari e piselli; il berodo coi pinoli; le trippe e la sbïra; il
bianco e nero (budellini
di agnello con fegatelli, rognoni e ciccioli); le frittate fatte con la semplicità di un rito (dallo sbattere le uova con una
forchetta di stagno, al fermare lo sbattimento all’istante giusto, al rilevamento
del primo ”scuttuzzu”, che ne sanciva la differenza). Remo Borzini nel suo libro (‘Osterie genovesi’)
ricorda quei piatti dove il sentire anche un vago senso di inappetenza, era il
massimo dell’offesa per il cuoco. Il palazzo fu demolito nel 1987.
===civ.
26 r nel 1933 viene segnalato esserci stato un club ricreativo “Manovratori a
cavallo”.
Di fronte a ponente,
===civ. 32r negli
anni 1930-80 sulla strada si apriva -ed era fiancheggiata- lo stabilimento Oleificio Costa di Giacomo, fu Andrea; famiglia originaria di
SantaMargherita Ligure di antica tradizione mercantile. Giacomo Costa nella
seconda metà del 1800 aprì in Genova l’attività per il commercio dell’olio
d’oliva (specie esportazione negli USA ed America del sud, Argentina in particolare)
e tessuti; e –non so quando- il grosso oleificio in SPdA.
Nel 1925 l’impresa iniziò ad investire anche nel settore
armatoriale e quindi con stessa titolazione e stesso indirizzo –per gli
uffici-. Attività marittima che ebbe grande sviluppo e divenne autonoma
rispetto l’oliaria nel 1936.
La presidenza di questa seconda attività fu assunto nel 1940
da Angelo Costa, nato a Genova il 18 aprile 1901; terzogenito –di sette- di
Federico –uno dei figli di Giacomo-; laureatosi nel 1924 a Genova con lode, in Scienze
economiche e commerciali con una tesi sull’olivocultura. Tenutosi fuori dalla
politica attiva, si dedicò interamente alla produzione di olio allargando
l’azienda del nonno da piccola e a conduzione familiare al colosso industriale
con raffinerie e lavorazione delle sanse. L’allargamento dell’impresa lo
obbligò sia nel 1927 all’iniziale acquisto di due navi –perdute nel conflitto
mondiale-, per il trasporto dell’olio acquistato da altri paesi mediterranei e
poi esportato dopo la raffinazione-; e sia nel 1940 a non disdegnare
l’interesse verso l’alcol e la produzione del vino.
Ma fu nel periodo postbellico, dopo il 1947, che ebbe
l’intuizione felice di finanziare l’acquisto di navi Liberty (usate dagli
Alleati nel conflitto e poi giacenti inutilizzate) utilizzabili anche per il
trasporto passeggeri; e, poco alla volta divenire figura portante della “Linea
C” e della industria italiana (Confindustria, Confederazione italiana armatori).
Famiglia, onestà e carità erano la triade di base del suo
impero; ma la formazione religiosa non lo distoglieva dai dettami prioritari dell’economia:
produttività, non dispersione, equa distribuzione (e non assistenzialismo
cieco),
Qui
c’era solo il vasto impianto di raffineria, che per tanto tempo ha contribuito
ad ammorbare l’aria con l’acre e nauseabondo odore tipico di olio, da loro
raccolto in recipienti di latta lavorata, e stampata nello stesso
stabilimento. Negli anni iniziali aveva telefono n° 41.154. Nel Pagano/61 è
compreso ne: esportatori-importatori; fabbr. saponi; negoz. gross. di olio
d’oliva; latta e litografie su latta.
La
ruspa abbatté gli edifici, iniziando simbolicamente il 4 maggio 1984 con la
torre metallica, vecchia ed arrugginita (che resistette più del pensato e fu
abbattuta con gran fatica) quale prima parte dei totali 100mila mq. di terreno
(ancora i Docks Liguri erano in attività sul fianco a mare), iniziando la
rivoluzione prevista per realizzare il complesso di san Benigno.
Dei Costa si ricorda anche un Armando, grosso commerciante
-la cui attività iniziata agli inizi del 1900 è passata al figlio- in quanto
aveva l’hobbi della poesia, dell’improvvisazione di rime solleticato da
banchetti, riunioni, avvenimenti, per i quali creava improvvisi
acrosticiraccolti poi in un libro titolato “O giardinetto”.
===civ.
12 il palazzo della villa De Franchi:
Famiglia patrizia
genovese che dal 28 gen.1393 (data di fondazione dell’ Albergo De Franchi con capostipite Giovanni
Sacco, i cui tre figli per giochi araldici e di potere, si fecero chiamare
definitivamente De Franchi), troviamo
negli annali ricchissima di beni e di illustri personaggi (ben sei dogi della Serenissima
Repubblica, mercanti, uomini d’arme, diplomatici, e sacerdoti: della famiglia è
il famoso “Padre Santo” domenicano ).
Mons.Francesco Bossio (vescovo
di Novara, eletto delegato pontificio di Gregorio XIII per tutte le chiese
della diocesi, col fine di constatare l’applicazione delle disposizioni del
Concilio di Trento), nel 1582, in una sua relazione, ricorda in San Pier
d’Arena l’esistenza di questa casa; nel momento di un Gerolamo q. Cristoforo De
Franchi-Toso divenuto doge (dal 21 ott.1581 al 20 ott.1583; ed a sua volta padre e nonno di altri
dogi).
Nella carta vinzoniana del 1757, appartiene
ancora al “magnifico Giuseppe De Franchi” imparentato presumo con quelli che
possedevano in salita Belvedere la villa Crosa-De Franchi-oggi Istituto
Antoniano.
Nelle campagne
militari tra francesi ed austriaci, senz’altro fu occupata da ufficiali,
accasermati nei locali, così ben vicini alla città.
La proprietà DeFranchi Giuseppe viene segnalata nel 1813
per il possesso nella villa (erroneamente localizzata in vico della Coscia,
inesistente) di una cappella privata, sinonimo di ricchezza e distinzione.
L’edificio era a parallelepipedo, a tre piani, con tetto in ardesia a
padiglione; in parallelo con le tre ville poste più a ponente, fu chiamato “la
semplicità”. La facciata si apriva a sud, ed offriva in via De Marini
il lato posteriore, caratterizzata da ben otto finestroni (sei centrali e due
lateralizzati); il primo piano era sottolineato da un bugnato che era esteso a
tutto il fianco del palazzo. Il giardino arrivava ovviamente sino al
mare e rimase inalterato finché non fu deciso nel 1852 l’apertura di via
Vittorio Emanuele II, da Largo Lanterna alla piazza Bovio (piazza N.Barabino), che lo tagliò trasversalmente.
Possedeva
anche una torre (non più riscontrabile però nelle carte ottocentesche),
posta originariamente più a ovest della villa e che faceva parte del sistema di
vigilanza della marina.
Nel settecento la famiglia dei De Franchi (come poi anche i Doria e Spinola)
era da catalogarsi tra ‘i meno fortunati’ o patrizi poveri (forse addirittura tra i poveri ex
nobili, beneficiari di un sussidio dall’amministrazione napoleonica; comunque
al punto che della famiglia nel 1809 la prefettura francese annoverava tra i
giusdicenti, solo Carlo Nicolò q.Gerolamo (nella cui ulteriore ascendenza –di
origine corsa- non risulta il nostro Giuseppe), ormai
ottuagenario ma sempre bisognoso di lavorare (nato 1725, nel 1762 viene segnalato ai dati fiscali
‘di condizione non disprezzabile’; come giusdicente aveva peregrinato nel
territorio comandando Pieve, Diano, Voltri, Ovada, Levanto, Savona, ultimo a 72
anni, podestà di SestriLevante)).
Sempre nel 1813 appariva esserci una ‘cappella DeFranchi Giuseppe
alla Coscia’, forse nell’interno della villa, meno probabile la Cappelletta
vicina..
Il
Gazzettino dice vi fossero andati ad abitare i Balleydier (lo conferma l’elenco dei
proprietari sopra esposto), quando il
retro (rispetto la
strada; ma il davanti rispetto la villa)
dava ancora sul giardino (per
alcuni ‘il giardino Balleydier’ ) e
sugli orti, distesi sino al piano ed a piazza della Coscia.
Dagli anni dopo
l’ultimo conflitto, ed ancora nel 1950, fu
adibita a scuola second. femminile di
“avviamento professionale industriale”, intestata a N.Barabino.
L’oleificio Costa si
sviluppò tutto attorno senza distruggerla, occupandone solo l’ampio terreno:
così inglobata nel complesso divenne un magazzino di loro proprietà finché
abbandonata a se stessa fu deciso demolirla nel 1985
per far posto al complesso centro direzionale di san Benigno.
Subito dopo (dalle foto
pubblicate, appare collocata nel tratto a ponente della via subito seguente la
villa DeFranchi, quasi di fronte alla trattoria del Toro), sulla strada si apriva una chiesuola o cappelletta che fu scelta
quale
secondo tempio parrocchiale dedicato a di NS delle Grazie
(della prima chiesa in ordine cronologico vedi sotto, a
pag. 84-85; della terza in via L.Dottesio)
Più
bello, alto, austero ma ‘allegro’. Fu costruita ristrutturata (si
legge infatti una nota spese (di lire 394)
datata 9 maggio 1817 relativa a perizia
eseguita “per il ristoro da farsi alla Cappelletta diroccata sopra delli primi
rastelli della Lanterna per portarsi in città”; ovvero andando verso il mare, a
destra prima della villa) utilizzando i
proventi derivati dall’esproprio effettuato dalle ferrovie per l’apertura della
galleria di san Benigno, e dalle offerte dei fedeli (specie i famosi minolli),
e su gratuiti disegno ed assistenza dell’arch.A. Scaniglia (lo stesso della chiesa della
Sapienza, del palazzo del Municipio e del teatro Modena) con iniziale forma rotondeggiante, fu munita di
tre altari (non certo in marmo ma sicuramente di terracotta).
Fu
aperta ai fedeli il 20 mag.1849 dal sac.
Francesco Lanzetta (già
prevosto di san Biagio, e che lasciò scritte delle memorie utilissime alla
ricostruzione storica dei fatti), in
sostituzione del primo tempio da pochi anni sfrattato dalla soc. ferroviaria (in quell’anno in fase risolutiva,
vicina a funzionare), quando era non
ancora autonoma (ma
inizialmente succursale della parrocchiale della Cella in cui era arciprete don
Stefano Parodi, poi divenuto canonico della Metropolitana di san Lorenzo), col nome popolarmente usato (ufficialmente non concesso) e continuativo di “santa
Maria” ma in più “delle Grazie” (in virtù della presenza del quadro
omonimo, che lentamente aveva acquisito nel popolo una particolare e vasta
venerazione: il ritratto della Madonna, col Bambino seduto sul ginocchio
destro, e sul cui fondo è scritto “s.Maria de primo quarterio Sancti Petri
Arenarii”era stato dapprima posto dal sac. Giuseppe Ardito nella precedente
chiesuola nel 1824, e poi trasferito in questo secondo tempio all’atto del
passaggio delle consegne sacerdotali; questo prete poi nel 1831 venne
trasferito a Ventimiglia quale segretario del vescovo locale GB D’Albertis).
Nel 1851 successe, per quattro anni col
titolo di rettore custode, don Terrile, già curato alla Cella e da alcuni anni assistente, gestore
del catechismo domenicale e di una scuola privata per i ragazzi. Gestire una scuola era ancora un retaggio dei sacerdoti precettori, per
procurarsi un minimo di sovvenzione ecomomica specie se la chiesa era in zona
di povera gente, e lo Stato assente.
Nel 1855 arrivò don Angelo Ricchini da
Voltaggio, già parroco
a Certosa. Egli portò al culto dei suoi nuovi fedeli il beato Giovanni
Battista de Rossi, un proprio conterraneo poi divenuto santo, la cui immagine
era stata presa dalla sua casa paterna dei nipoti, a Voltaggio. Decretò inoltre titolare, l’effigie di N.S. delle
Grazie, la cui festa solenne veniva celebrata la seconda domenica dopo Pasqua,
con grande affluenza di popolo da tutto il borgo; molto si adoperò sia affinché
il titolo ufficiale della chiesa cambiasse da «santissimo nomen Virginis
Mariae» in «sancta Maria Gratiarum», e sia per ottenere la titolazione
parrocchiale (occorreva dimostrare avere entrate o possedimenti che
garantissero l’autonomia). L’arcivescovo Charvaz, seppur favorevole, trovò non
poche difficoltà a riconoscergliela, avendo contro il consiglio Comunale e –non
certo favorevole- il parroco della Cella. Così di quest’ultimo progetto se ne
fece nulla.
Per
ventitre anni, questo zelante sacerdote compì con serietà la sua missione nella
chiesuola, battendosi perché diventasse parrocchia.
Fu
per opera sua che nel 1864 nacquero le
Figlie di Maria, la fabbriceria (quest’ultima fu successiva,mente trasformata
nel 1881 in Confraternita si s.Vinvenzo de’ Paoli e nominata a beato GB
Rossi).
Però
si ammalò e dopo due anni di penosa infermità morì il 25 sett. 1878 a 58 anni. Fin dai primi tempi della
loro venuta a San Pier d’Arena, e per otto anni (due durante la malattia del prete, e sei anni dopo
la sua morte, sino al 1884), i salesiani di don Bosco (incaricati furono don Michelangelo Braga; poi don
Luigi Bussi -prefetto del collegio di san Vincenzo de Paoli, e poi parroco di
san Gaetano-; ed ultimo il prof. don Giovanni Galfrè che gestì gli uffizi
spirituali ed economici anche per quei quattro mesi intercorsi tra la nomina a
parrocchia e la nomina ufficiale del primo parroco), non potendo il parroco della Cella, aiutarono
questo sacerdote incaricato, quasi quale fosse diventata una succursale di san
Gaetano; l’ambiente era già frequentato anche da tanti fanciulli d’ambo i
sessi, in un Oratorio di stile salesiano ( tanto che morto il sacerdote il 25 set.1878, all’età di 58
anni, dopo due anni di penosa infermità (il dattiloscritto salesiano dice nel
1884), e avendo questi
lasciato eredi i salesiani, nacque uno strascico legale aperto dai parenti (specie il fratello prete don
Angelo) arrabbiati ed
ingelositi: il processo che seguì le accuse, diede ampia ragione ai sacerdoti
di don Bosco e fece punire per calunnia e ricatto i parenti ed alcuni
giornalisti che l’avevano sostenuti) .
Nello stesso anno 1884, l’arciv. Salvatore Magnasco invitò i
salesiani a proseguire nella cura della chiesa: essi rifiutarono pur
mantenendovi per oltre 10 anni un sacerdote qualche chierico e collaborante a
compiervi lavori: esteriormente vennero eseguite tante modifiche, senza
una precisa struttura architettonica del tetto e delle pareti (mutò l’aspetto, da rotonda ad un
rettangolo irregolare -a destra le cappelle erano strette ed anguste, a
sinistra decisamente più larghe- avendola allungata di un terzo fino alla
strada ed allargata ai due lati); quindi in definitiva ridultò ingrandita ed
allargata per necessità via via contingenti. Interiormente fu arricchita da due nuovi altari –alla Madonna
del Rosario ed alle Anime del Purgatorio-, da decorazioni ed ornali vari tra
cui soprattutto un affresco sulla volta pare con la collaborazione diretta del Barabino, con l’immagine dell’Adorazione dei Magi, opera di Luigi Gainotti  PRESEPIO–bozzetto dell’Adorazione dei Re Magi. (nato a Parma il 28ott.1859, ancora
bambino si trasferì col padre –pure lui pittore-, a vivere a San Pier d’Arena,
collocato come apprendista-discepolo del Barabino ( assieme col Vernazza e
GBTorriglia) che lo invogliò a frequentare l’Acc.Ligustica di B.Arti (dove poi,
nel 1893 verrà proclamato Accademico di merito nell’insegnamento della scuola
del nudo).E’ considerato l’ultimo conservatore dell’arte ligure dell’ottocento
–giudicata parente poverissimo rispetto l’Italia- rifiutando l’avventura
innovativa e rivoluzionaria del novecento. Morì ottantunenne nel 1940
lasciando una figlia, pure lei pittrice.Da giovane fu attivo nell’affrescare
tempi sacri (fu chiamato “pittore delle cento chiese”; in una di esse vide
precipitare il cognato-collaboratore DeLorenzi. Il pittore aveva decorato nel
1892 anche il soffitto del CarloFelice -dipingendo dei putti volanti, sopra
l’affresco del Barabino rovinato dai ceri e fumi-, poi andato distrutto pure
lui col bombardamento-. Vedi anche a Pro.115 )
PRESEPIO–bozzetto dell’Adorazione dei Re Magi. (nato a Parma il 28ott.1859, ancora
bambino si trasferì col padre –pure lui pittore-, a vivere a San Pier d’Arena,
collocato come apprendista-discepolo del Barabino ( assieme col Vernazza e
GBTorriglia) che lo invogliò a frequentare l’Acc.Ligustica di B.Arti (dove poi,
nel 1893 verrà proclamato Accademico di merito nell’insegnamento della scuola
del nudo).E’ considerato l’ultimo conservatore dell’arte ligure dell’ottocento
–giudicata parente poverissimo rispetto l’Italia- rifiutando l’avventura
innovativa e rivoluzionaria del novecento. Morì ottantunenne nel 1940
lasciando una figlia, pure lei pittrice.Da giovane fu attivo nell’affrescare
tempi sacri (fu chiamato “pittore delle cento chiese”; in una di esse vide
precipitare il cognato-collaboratore DeLorenzi. Il pittore aveva decorato nel
1892 anche il soffitto del CarloFelice -dipingendo dei putti volanti, sopra
l’affresco del Barabino rovinato dai ceri e fumi-, poi andato distrutto pure
lui col bombardamento-. Vedi anche a Pro.115 )
.
L’arcivescovo Magnasco, e sempre nello stesso anno 1884, il 16 giugno (il decreto, confermato dalla s.Sede
Apostolica, fu definito dall’ordinario Diocesano il 25 seguente), deliberò per erigere la chiesuola a parrocchia autonoma (chiamandola ‘detta del Quartiereto, succursale della
Cappelletta e Chiesa della Coscia’), con
limiti territoriali da san Benigno sino a via Larga-via Imperiale, e con circa
5 mila abitanti in
contemporanea fu nominata anche quella di san Giovanni Battista vulgo san
Gaetano (anch’essa con 5 mila anime. Delle 24 mila anime, 14mila facevano parte
del territorio della Cella). Ma nel 1885
il sindaco di San Pier d’Arena spronato da 20 consiglieri su 21 -tra cui il cav
Romairone- (malgrado
una certa opposizione del solo consigliere Giovanni Lombardo, assessore anziano
che non vide approvato il progetto morendo l’11 sett.1880), fece ricorso al regio sub-economo
del distretto di Genova contro la decisione, non riconoscendo opportuno né
conveniente l’erezione di due nuove parrocchie giudicando quella unica di san
Martino-Cella sufficiente alle necessità di tutta la città (40mila anime) e
giudicando ancora che le due nuove parrocchie con le loro fabbricerie non solo
avrebbero recato discordia e turbamento (che si sarebbe riversato a spese del Comune) ma che non avrebbero avuto i fondi
per provvedere alle proprie spese (a parte appunto la chiesa di NS delle Grazie che allora
godeva di una rendita dello Stato di lire 800 quale eredità della signora
Nicoletta Casabuona, cifra appena sufficiente a provvedere all’onesto e
decoroso sostentamento del sacerdote; e che avrebbe potuto arrivare ad altre
1000 lire con gli ‘incerti di stola’); e che la popolazione era indifferente a questa scelta.
La protesta comunale, evidentemente non fu ascoltata in
Curia (non indifferente
era il peso di una giunta comunale prevalentemente di repubblicani mazziniani,
ma anche garibaldini), anarchici, libertari, che vedevano nella scissione un
potenziamento dell’influenza della Chiesa nel tessuto urbano mirato a divenire
laico). L’arcivescovo, dopo aver invano scelto tre sacerdoti
che ne rifiutarono l’incarico, nominò come primo parroco, il prevosto Costantino
Zerega, proveniente dalla parrocchia di san Martino di Zerega, a Cicagna
nella Fontanabuona ma genovese di nascita del 1850 (era stato ordinato sacerdote nel
maggio 1875; prese possesso dell’incarico
il 9 ottobre 1884; sul Bollettino Parrocchiale viene riferito l’episodio della
sua presentazione al sindaco il comm. Torre Giuseppe il quale ben chiaro gli
espose che ‘deplorava la sua nomina’; al ché il sacerdote, con umiltà ma
fermezza gli rispose che lui obbediva a decisioni superiori e di conseguenza
non commentava i giudizi ma che -ben tosto- era intenzionato a fare il suo
dovere. Una epidemia di colera e vaiolo, e la conseguente necessità di persone
volenterose e dedite all’assistenza, favorì il suo inserimento; ma per
ulteriori lunghi anni il Comune ignorò ufficialmente l’esistenza della
parrocchia nella sua autonomia funzionale. Ebbe l’aiuto di due curati: don
Eligio Grosso e don Luigi Garbarino (economo); ed aveva collaboratori nel cappellano delle Suore di Carità don
Rebora Luigi e nel proprio fratello don Giuseppe Zerega.
Nel 1892, una violenta
alluvione aveva inondato la chiesa: il torrente del fossato san Bartolomeo,
scorrendo in prossimità della chiesa, straripò scavando il sottosuolo, tanto
che il pavimento dell’edificio si abbassò di 20cm.; la balaustra dell’altare
maggiore si spezzò in tre punti e l’altare si inclinò in avanti. Nell’elenco
sopra scritto, delle proprietà, dice che a fine 1800 subito dopo la villa
DeFranchi –allora divenuta Balleydier-, c’era la ‘canonica della chiesa delle
Grazie’ .Rimase Parroco Prevosto per 19 anni e mezzo, sino alla morte avvenuta
alle ore 11,55 del 14 aprile 1904.
L’inventario degli arredi con resoconto al 31 dic. 1903 finanziario
evidenziarono un debito della parrocchia verso il sacerdote di ben
£.14.545,56).
Nel vuoto occupazionale ufficiale,
risultano spese nel 1907 ben £.5000 per
l’acquisto di un altare in marmo che andò a sostituire il precedente fatto di
pietre e terracotta.
Successivi furono Nicolò
Molfino (1910, Una relazione riporta che al suo
arrivo, la chiesa aveva 5 altari -di cui solo il maggiore di marmo (e corredato di tappeti e poltrone)- con i propri addobbi e arredi (candelabri, icona, carteglorie,
portafiori, ecc.); non
c’era campanile ma solo una piccola elevazione sul tetto arredata di tre
campane (di cui una
rotta); un organo;
quattro confessionali (dei
quali uno imprestato dalle suore della Carità); panche e sedie; un fonte battesimale racchiuso da
una cancellata di ferro, rappresentato da un marmo ai piedi di una tela
rappresentante il battesimo di Gesù. Vicino c’erano una sacrestia con armadi
idonei; e la Canonica posta al piano sopra la sacrestia ma in locali infelici.
Chi stese il rendiconto, sottolineò che era in “grande decoro il SSSacramento”;
che ci “si reca agli infermi con tutto quell’apparato che le circostanze
esigono”; che tutto era “tenuto a dovere” (registri di battesimi, matrimoni, cresime; meno ordinato
era il registro dei morti, non si sa perché). Il Parroco teneva due messe festive con spiegazione del
Vangelo (ore 05,30 e 10,00); catechismo al pomeriggio ai bambini ed agli
adulti. La Conferenza di s.Vincenzo (dedicata a GB Rossi) -composta da operai-
assisteva 16 famiglie riunendosi in sacrestia. Nel 1914 risulta aiutato dall’appena
ordinato, in qualità di vicario cooperatore, don Giovanni Dellepiane (che poi
diverrà mons. e vescovo, prima in Turchia, poi in Africa ed Austria ove morì
nel 1961)
Il sacerdote acquistò per 27mila £. (in 3 anni), nel giu.1916 un appezzamento di terreno vicino, di
500mq, già di proprietà della “Società Fonderia e Costruzioni Meccaniche
Navali Balleydier”, su cui era eretta una piccola cappelletta, con la
previsione di una migliore e definitiva sede; ma alla fine tutto fu inutile
perché i progetti di ulteriore allungamento furono classificati inattuabili
‘per scomodità e sfregio all’arte’. Aveva come aiutanti don GB
Gazzolo (il famoso
prae Baciccia di SBdF)
e d. Antonio Bertolotto. Nel 1912 aveva istituito il Circolo interno, chiamato
di ‘NS delle Grazie’ che poi divenne l’Azione Cattolica. Nei primi giorni del
1920 don Molfino fu trasferito, con la carica di abate, in Santo Stefano.
E così dopo di lui, rimase per pochi mesi affidata ad un
economo, finché don Gio Bono
Schiappacasse subentrò
il 25 lug.1920, nominato dall’arciv. mons.
Boggiani -o Baggiani) e che riuscì a vendere a buon prezzo l’area della chiesa
da distruggere. Al suo arrivo, i parrocchiani –a mezzo di alcuni fanciulli
vestiti da pescatori come voleva l’antica tradizione del luogo- gli regalarono
una somma.di £. 281 a simbolo del desiderio di un nuovo tempio): già il 3 ottobre dopo, in
Fabbriceria si registra il possibile acquisto di un trerreno idoneo,
considerando la chiesa insufficiente ai bisogni della cresciuta popolazione,
fuori centro del rione,circondata da magazzini perde di decoroed attrattiva.
Per poter costruire in altra sede ed in modo decoroso,
divenne necessario vendere la chiesuola. Secondo disposizioni legali (risalenti
al Legge 19.5.1831), occorreva chiedere autorizzazione al Procuratore del Re
presso la Corte d’Appello allegando documentazioni, specie quello del
reinvestimento del denaro.La pratica venne inoltrata nel febb.1922.
Due anziani
sampierdarenesi, il sig.Fravega e Viglienzone ricordano che negli anni 1920-30
frequentavano la chiesetta, sede del terzo riparto degli scouts, e, per loro
quella ‘era la parrocchia delle Grazie’
Così, aumentando la popolazione, approvato l’erezione di un terzo
edificio ecclesiale (l’attuale) da parte dell’arcivescovo, -malgrado i
plurimi inutili “tapulli” -la chiesuola divenuta piccola (veniva chiamata “la cappelletta”), fu deciso abbandonarla.
Si
promosse così la vendita al miglior offerente, dapprima i DocKs Liguri malgrado un decreto di esproprio da
parte del Consorzio Autonomo, poi alla
fam. Costa per £. 50mila (originariamente
era stata valutata 380mila. Come la villa, anche la cappella divenne parte
dell’oleificio Costa, che però le conservò integre essendo ambedue al margine
della struttura industriale; la villa proseguì la sua attività scolastica).
Quello che non fece Costa, lo fecero i progettisti del
complesso di san Benigno, per la cui erezione ne decretarono la distruzione.
Maledetti! Forse sono anche laureati e si fregiano di un titolo di architetto:
all’università si, ma nella professione...Non li accuso di peculato... no. Ma
di insensibilità, si; ma evidentemente a loro foresti, gliene fregava niente.
Nell’opuscolo prima e nel libro poi, pubblicati dalla
attuale Chiesa, c’è ripetuta confusione iconografica e storica tra questa
chiesuola e quella dei Cibo, vicine ma distinte; più volte viene
nostalgicamente pubblicata la foto di questa chiesuola, detta anche
‘Cappelletta bruna’ (quindi l’immagine è di questa seconda chiesa) ma il
sottotitolo e racconto inneggiante la cappella dei Cibo che fu la prima e della
quale non esistono vestigia iconografiche ma –vedi l’elenco dei proprietari di
fine 1800: dopo la villa e la canonica (civici pari, a mare), e poi la già
trasformata cantoniera delle ferrovie (civico dispari, a monte della strada,
descritta qui sotto di seguito).
Sulla
strada, di fronte alla chiesa su descritta, si apriva il cancello che con un
viale -lungo oltre cento metri, orientato verso nord-est- portava ad una delle
tante, villa Lomellini, dal Vinzoni
attribuita al mag.co Stefano q.Carlo (non è lo Stefano divenuto doge nel
1752, il quale era figlio di Gio.Francesco; sul Battilana, l’unico Stefano
figlio di Carlo –e di Battina Lomellini q.Filippo- è il quarto di sette
fratelli dei quali: 4 femmine monache, 1 sposata, uno maschio ma anche lui
-come il Nostro- non sposato e quindi senza prole). Sulla stessa carta del Vinzoni, il mag.co Stefano
Lomellini q. Carlo appare proprietario anche di terreni posti sul lato di
ponente di via san Martino, proprio di fronte alla antica abbazia, con due case
piccole (agricole). Interessante che essi prima di essere del Nostro, erano di
Giacomo DiNegri, stessa famiglia dello sposo di sua sorella Dorotea (ella sposò
Agostino di Negro q.GiulianoAndrea: evidemnti passaggi in famiglia di terreni
ereditati e poi comprati).Vedi Pacinotti-129
Considerata
la posizione, l’edificio risulta a levante della villa Pallavicini, sottostante
le nuove mura, sulla direttiva -e quindi sovrapposto all’attuale via di Francia-
poche decine di metri più ad est della attuale stazione ferroviaria di san
Benigno.
Non
è stata catalogata nel libro “Le ville del genovesato”.
Poco distante
verso il monte, si trovava una cappelletta della famiglia dei Cibo (vedere in vico Cibeo), giudicata dal Remondini quale prima chiesa di NS delle Grazie (però divenuta con questo nome solo
dopo il 1800), perché inizialmente nata
privata appunto della famiglia Cibo; corrisponde forse alle casupole ancora esistenti nella parte
a monte della ferrovia subito dopo il sottopasso di vico Cibeo. Si potrebbe
identificare nella sua parte absidale al muro ancora esistente nell’area di un
demolitore di automobili, affiancato al retro del casello delle ferrovie.
Un Guglielmo Cibo, figlio di Lanfranco (non citati in Dizion. biograf. Liguri
- III. p.385; conte Palatino, banchiere, commerciante e
benefattore. Nel 1250
era in Africa, quale ambasciatore del Comune genovese col fine di concludere un
trattato commerciale; in quell’anno compare tra i proponenti la maestosa
abbazia eretta ad Assisi in onore di san Francesco; a Genova fu anziano
consigliere, tra gli otto nobili del comune; possedeva un palazzo in via del
Campo dove abitava con la moglie Giacomina e con i figli Cibino, Lanfranchino e
Francesco. –vedi vico Cibeo) poco prima del 1300 aveva fatto erigere una chiesuola dedicata alla
beata Vergine, e detta del Quartieretto (o
quarteretto) dal nome della località suburbana (documentata dal 30 marzo 1289 in virtù di un attestato del papa Nicola IV che accordava
alla ‘chiesa della preclarissima et mobilissima famiglia Cibo’ la facoltà di
tenere un cappellano nella villa di Pedefaro, dove con la famiglia dimoravano
molti mesi all’anno. Nuovamente citata nel 1360 quando il cardinale Albornoz
Egidio, quale legato apostolico, concesse si facessero collette nella chiesa a
testimonianza che già allora non era solo privata, ma usufruibile dal popolo,
essendo assai lontana la chiesa parrocchiale di san Martino. Ed ancora del 1387
un altro documento –catalogato al n. 350- che la cita perché soggetta a pagare
la somma di un soldo, per ogni cento di redditi. Si scrive in un ritratto
storico della chiesa delle Grazie che in questi tempi era proibito dalla Chiesa
sia di ‘consacrare edifici pubblici’ (?), sia di dare il nome di Maria alle
bambine, per conservare ad Ella il massimo del rispetto: solo tre secoli dopo
un decreto del Senato genovese comandava una festa speciale in nome di Maria
sbloccava questo limite).
Nei quasi trecento anni di ulteriore vita sacra, seppur succursale svolgeva un
ruolo importante per le poche centinaia di persone distribuite sul territorio,
essendo l’unica parrocchia, di san Martino, tendenzialmente lontana; ed in
questi trecento anni, la storia martirizzò molte volte il borgo, con lotte
fratricide, pestilenze, carestie e -riferito al mantenimento degli immobili-
difficoltà economiche della nobiltà in genere divisa tra Spagna, ducato di
Milano e Francia.
Nel
suo giro di ispezione fu visitata (?controllare) da mons. Bossio, 1582, senza ulteriori commenti (visto probabilmente i propositi di
lavori di ripristino; il giro comprendeva alla pari delle altre chiese del borgo, da
san Martino al Campasso, alla Cella, san Giovanni (vico san
Barborino-demolita), del Sepolcro (piazza Monastero-demolita), sant’Antonio
(via Demarini-demolita), san BdFossato (distrutta), ssCrocifisso? (forte
Crocetta-demolita).
Nel 1585 Alberico Cybo (neanche
lui citato nell’opera su detta. Principe di Massa e Carrara, nato a
Genova il 28.2.1532 da Lorenzo e Riccarda Malaspina; divenuto cognato di
Guidobaldo, duca di Urbino; nipote di papa Innocenzo VIII (pure lui un Cibo,G.B., regnante tra
il 1484-92); dimorante
per gran parte dell’anno a Genova; presente a tante manifestazioni pubbliche
cittadine, da processioni, a nomina del doge, tornei, feste carnevalesche,
rappresentazioni teatrali e musicali (amico
dei letterati più illustri dell’epoca quali il Foglietta, Manuzio, Giustiniani,
Oldoini), nella casa di
via del Campo luogo definito dal Senato della Repubblica il più adatto ad
ospitare regnanti o persone di riguardo di passaggio; morì 91 enne nel 1623) trovandola ovviamente assai deteriorata la fece restaurare essendo chiesa gentilizia per la sua
famiglia, e vi appose a memoria una lapide (che ora è murata nella sacrestia della attuale chiesa delle
Grazie, con su scritto “ HAS AEDES DIVAE VIRGINI - DICATAS NIMIA VETVSTATE -
FERE COLLAPSAS CLARISSIMAE ATQ ANTIQVISSIMAE CYBO - FAMILIAE MONVMENTVM -
ALBERICVS CYBO IMPERI I - ET MASSAE PRINCEPS PRIMUS - INSTAVRANDAS CVRAVIT -
ANNO MDLXXXV = questo tempio dedicato
alla beata Vergine, resosi ormai troppo vetusto e quasi cadente, dalla
chiarissima e antichissima famiglia Cybo, fu da Alberico Cybo primo principe
dell’Impero e di Massa, fatto restaurare e rinnovare nell’anno 1585“).Era da poco finita la peste che aveva falcidiato i tre
quarti della popolazione.
Alla sua morte, avendo il figlio Alderano sposato Marfisa d’Este, risiedendo
stabilmente a Ferrara e rinunciando al titolo, ereditò la corona di Massa il
nipote Carlo, che sposò Brigida Spinola, figlia di Giannettino, e trasferì
in quella città la residenza definitiva, scomparendo anche lui dalla vita pubblica genovese; un loro figlio Alderano, divenne
cardinale ed anche lui espatriò vivendo molto a Roma.
Affidata da sempre al clero secolare, sappiamo che l’8
marzo 1608 da Emilio
Cibo fu stilato testamento (ritrovato nell’inventario fatto nel 1622: lasciava la
dovuta somma affinché si celebrasse messa tutti i giorni, si mantenesse una
lampada perennemente accesa, si costruisse una balaustra all’altare maggiore, e
si chiudesse la porta che dava accesso alla proprietà di Tommaso Pallavicini).
Nel 1622
(dall’inventario risulta esserci stato un solo altare con balaustra ed appesa
nel coro, una ancona della Madonna con san G.Battista e Giuseppe) ne aveva
cura il sac. Andrea Tealdi dei Chierici regolari di san Paolo. Ma
questi, considerando fosse localizzata in zona ‘insalubre’, chiese ai
proprietari (Alberico
duca di Massa e Carlo Cibo duca di Aiello, tramite il notaio Giacomo Cuneo) di cedere la gestione.
Cosi, fu che i nobili Cybo nel marzo 1622 la concessero ai Barnabiti nella persona di Antonio Benenato
di san Salvatore, prevosto di san Paolo in Campetto. Si scrive che essi ressero
questo impegno sino al 1644. Ma qualcosa deve non aver funzionato in questo
passaggio, poiché risulterebbe che i Barnabiti non sono subentrati, e che i
Chierici di san Paolo avessero proseguito l’impegno:
a) il Tealdi viene nominato come ancora gestore della
chiesuola nel 1638 in un “Stato della
Chiesa Archiepiscopale di Genova” fatto redigere dal card. Durazzo quando
prese possesso della diocesi proveniente da Ferrara. Non sarà un errore se
-invece di essersene andato nel 1622- si fosse stilato un accordo tra il prete
ed i Barnabiti visto che anche loro dopo pochi anni abbandonarono l’impegno)
b) è datata 1644 una
lettera di esplicita domanda di disimpegno (indirizzata al principe di Massa,
dal preposto in Genova della Casa di san Paolo -don Paolo Andrea Ferrari):
«Ill.mo et Ecc.mo Signore, si compiacque S.E. più anni sono di gratiarci d’una
sua chiesa o cappella in San Pietro d’Arena. Havendo noi visto che li nostri
instituti non potevano sodisfare compiutamente a quello ch’altri havranno
fasilità a maggior gloria di Dio, habbiamo pensato se così piacerà a V.E.
rinuntiarla a’ PP di S.Francesco di Paola stimando che da V.E. non sii se non
di gusto come la supplichiamo assicurandola che per questo non si
disobbligheremo di raccomandare al Signore la sua casa».
Comunque, ad essi, subentrarono (notaio GB Badaracco) nel maggio 1644 i Minimi di s.Francesco da Paola, nella persona del
p.provinciale Francesco Maria di Negro, che tentò introdurre la
devozione al suo santo fondatore.
Con bolla datata 15 ottobre 1652 papa Innocenzo X ordinò
la chiusura dei piccoli conventi e monasteri nei quali risiedessero pochi
monaci (“ne quali
risiedono solo due o tre religiosi e ne quali per ciò non s’osserva clausura
invece d’accrescere la devozione, la fanno talora totalmente cessare, per
essere in arbitrio delli stessi a viver a lor capriccio, introdurvi gente di
ogni sesso di giorno e di notte”. È probabile che i Minimi appartenessero a questi,
inclusi nei ‘troppo pochi e nei poco impegnati’. Infatti il 24 sett.1653 (solo nove anni dopo l’incarico), Carlo
Cibo scrisse che il frate p.Gervasio Pizzorno da Rossiglione
co-rettore del convento di s. Francesco di Paola, era stato allontanato.
Da
un suo inventario, risulta che i frati avevano aggiunto una icona di
s.Francesco da Paola per un nuovo altare, eretto per lo scopo; ma poi ritolto.
Così, il 4 nov.1653 il sig. Vincenzo Giannini,
procuratore del principe, la assegnò al sac. DeFerrari Giacomo, del clero secolare, prevosto di san Donato che però morì
di peste; cosicché il 15 apr.1658 lo
successe p. Beluzio (o Belluzzi) Vincenzo.
L’Accinelli, in Liguria Sacra, vol.II pag. 443 scrive che il
DeFerrari lasciò la chiesuola ai Barnabiti, e da essi poi passò ai pp.Minimi:
sbaglia i tempi)
Il 28 mag.1676
Carlo Noceto, vicario della curia arcivescovile, dopo il decesso del rettore V.
Belluzzi, confermò l’elezione di don Antonio Pallenzona da Tortona, quale
rettore di s.M.del Quartieretto, fatta dal patrono principe Alberico Cibo-Malaspina
Una relazione del Cancelliere dell’Arcivescovato, datata 1749, dei vari frati sopra, scrive «sed
centum ab hinc annis amotis disctis RR.PP. relatum fuit erectum fuisse in
beneficium ecclesiasticum da iure patronatus excellentissimae Familiae Cibo =da oltre cent’anni è noto ai RRPP
che era statoistituito un beneficio di patronato dalla ecc.ma fam. Cibo)
Un altro restauro ebbe negli anni 1756-58 (sulla lapide fu aggiunto solo “RESTAVRATA - ANNO -
MDCCLVIII”) .
Nelle carte vinzoniane del 1757,
appare addossata al muro di cinta di levante della proprietà dei Pallavicino,
ma con un viale di accesso proprio, iniziante in via DeMarini poco più a
levante dell’attuale vico Cibeo.
I Cibo, nel 1764
diedero la chiesuola in gestione a don GB Orecchioni, che però non aveva
compiti parrocchiali: Fu accusato dai Cibo: “Certo apparirebbe che chi di
dovere, poco curava le anime, a fatica toglieva il ss.Viatico agli infermi,
raramente celebrava messa”. Ovvero di scarsa frequenza. Evidentemente la
chiesuola rendeva poco, perché fosse assistita a dovere. Le messe avvenivano
praticamente solo nel periodo di novena per il Nome di Maria (titolare) e per
s.Francesco (introdotto dai Minimi).
Il 2 maggio 1798
il segretario generale del Direttorio trasmette l’inventario degli ori e
preziosi vari requisiti a tutte le 20 chiese-oratori della municipalità; tra
esse compare anche la chiesetta a cui erano stati sottratti beni per la somma
più bassa di tutte: lire 15, di fronte alle 18.018 dell’oratorio di san
Martino e le 6.048 della Cella.
All’inizio del 1800,
divenne succursale della Cella; nel 1837
l’arciprete Antola scrisse che tutte le Domeniche un sacerdote andava a
predicare. Tra essi, un rev. Ardito, che regolarmente officiava da 7
anni, divenne segretario di mons.DeAlbertis, vescovo di Ventimiglia: da lui la
chiesa ebbe in dono un quadro della Madonna (ritratta col Bambino seduto sul
ginocchio destro) alla cui base era scritto ‘S.Maria de primo quarterio Sancti
Petri Arenarii’, che attrasse la pietà dei fedeli e nominata N.Signora delle
Grazie. Benché nata
come privata, si può quindi considerare la prima perché è in essa che fu
esposto il primo ritratto della Madonna, chiamato ‘delle Grazie’, che diede il
nome alle due successive.
All’Ardito successe per 3 anni il sac. Stefano Ricci
che alloggiava vicino in una casetta di due piani proprietà della chiesa; a
lui seguì il sac.Lanzetta che però due anni dopo, nel lug.1849 fu allontanato per esproprio
dall’amministrazione della strada ferrata perché intralciava la prossima
costruzione della ferrovia
(il Lanzetta, nel 1893 scrisse le sue memorie, riportando i
fatti su descritti. Nel descrivere il quadro, precisa «la Mafdonna seduta su di
un trono invisibile, tiene sul ginocchio destro il Bambino Gesù, seduto sulla
mano di Lei, sembra che da tempo fosse presente, in attesa che si ritirasse la
tenda che la ricopriva, per apparire in tutto il Suo splendore di Madre. In
atteggiamento tranquillo appare di ritorno dall’Egitto, fiera del Divin Suo
Figlio, certa che nessuna potenza umana potrà più strapparlo da Lei. Un ricco
manto copre la Veneranda persona, aperto sul davanti. Un paffuto, sorridente,
roseo, biondo bambino, colla destra alzata in atto di benedire, stringente una
piccola croce colla mano sinistra, è l’autore della Grazia, il divino Infante.
E ai piedi di lei sta scritto “Sancta Maria del 1° Quarterio S.Petri Arenari”»
Descritta anche dai Remondini, fu giudicata ‘miserabile
cosa: assai piccola, con un solo altare di cotto, dipinta esternamente di
rosso, con un’aria di soverchia meschinità’. L’Alizeri nel 1875 ne descrive la scomparsa e segnala
l’esistenza di una lapide, riposta dentro le sale della Ferrovia su cui si
faceva cenno ai restauri del 1585 (infatti alla sconsacrazione la lapide fu tolta e collocata
nella sala d’attesa della terza classe nella stazione principale locale; nel
1922 mons.Schiappacasse la richiese alla Ferrovie che la restituirono da porre
nella seconda chiesa; infine fu posta nella sacrestia della attuale terza
chiesa). Però
nell’elenco delle case scritto all’inizio della storia di questa via, appaiono
a fine 1800 al civ. 16 (
di allora) esservi la
canonica della chiesa delle Grazie, seguita dal civ. 19a della casa cantoniera
delle Ferrovie; quindi potrebbe significare che la chiesuola non fu ‘distrutta’
ma trasformata in casello ferroviario. Infatti la costruzione fu tramutata in
abitazione per due guardiani ferrovieri (e probabilmente qui nacque Antonio Cantore, combaciando
alcune vaghe notizie sui suoi genitori) e poi infine realmente o demolita o lasciata a sé.
Furono i Minolli a prestare il massimo dell’opera di
trasloco: in particolare l’immagine della Vergine (che predispose il nome della
nuova parrocchia, di NS delle Grazie) ed il quadro di san Francesco da Paola
loro protettore.
L’apparato religioso venne tutto trasferito in una vicino,
piccola chiesa di via DeMarini, costruita (ma meglio dire ristrutturata) con i
proventi dell’esproprio; ed aperta al culto il 20 maggio 1849 nei pressi, un
po' più a ponente e chiamata anch’essa santa Maria -e per l’ effige miracolosa-
, delle Grazie, succursale della pieve di san Martino-Cella. Nominata
parrocchia da mons Salvatore Magnasco il 16 giu.1884. Ma anche questa,
inadeguata, venne sconsacrata nel 1928 ed abbandonata quando fu inaugurata del
1929 la terza chiesa dedicata alla Madonna: quella attuale, sempre vicino,
però ancora più a ponente .
La numerazione fu
risistemata nel 1992, con assegnazione a nuove costruzioni, dei numeri dal 2 al
22 (1992) , del 60-62 (‘94) , del 61(‘96).
Questo il tracciato, -da Largo Lanterna a via di Francia, ed escluso
ovviamente la rampa per l’autostrada-, è stato totalmente demolito, e da dopo
il sottopasso, sostituito col Centro San Benigno.
Questo, posto in posizione strategica nel crocevia di direttive ferroviaria,
stradali, autostradale, aerea e portuale, è stato realizzato da un consorzio di
privati, con varie società. In particolare vi si apre il grattacielo del WTC,
davanti al cui ingresso praticamente oggi inizia la strada. Questo nome dato
dall’impresa al centro, per la gente indaffarata e sempre di corsa e per questo
disattenta ed indifferente, rischia nel dare nome alla zona, e di scalzare
quello più antico e da mai dimenticare della Coscia.
===civ.
1: assegnato il 23 ott.21987 al WORLD TRADE CENTER, la prima torre del complesso
‘san Benigno’ (per San Pier d’Arena è il terzo grattacielo) costruito da Recchi
e la soc. SCI (Società
Costruzioni Immobiliari; presidente Emanuele Romanengo, con
50% del capitale); progettato(un primo progetto fu presentato al
sindaco ed autorità varie nel 1980, ed era firmato dal giapponese di fama mondiale
Minoru Yamasaki, similare al WTC di New York. Al suo posto succedette nella
progettazione l’arch. Raul DeArmas (prevedeva l’edificio a strisce e con un
tetto a cappuccio a pagliuzze dorate) della soc. SOM, Skidmore, Owings &
Merril. Fu offerto uno stage -quale borsa di studio, con primi tre mesi alla
Skidmore di New York- a due universitari italiani di architettura con alte
valutazioni negli esami) infine dallo
studio Gambacciani-Piero-Garibaldi-Cruzzi (gli stessi della Corte Lambruschini) e dalla Seicom; ha 24 piani da terra (sul Gazzettino è scritto 23 da
terra+1 sotto; oppure 24 di cui 5 a parcheggio e 15 ad uffici), per una altezza di 110 m. (il più alto in città), con posti auto sotterranei, elegante ristorante ed
aula congressi al 19° piano. Il primo ‘colpo di ruspa’ per abbattere le
strutture dell’oleificio, iniziarono nel 1984.

La struttura divenne ospitante - nei suoi 800mila mc., dal dicembre 1987 - le
più prestigiose società, come la ERG Petroli (fondata nel 1938, attualmente amministrata dal cav.
Riccardo Garrone, occupa quattro piani ed alcune decine di dipendenti), l’Italia navigazione; la Nokia; la Domecq; riso
Gallo e la Ericsson; la camera di commercio italo-iraniana; la Marconi (occupava un piano; abbandonò il
grattacielo nel 02 causa ridimensionamento della propria struttura); la H3G (colosso della telefonia che occupa 5 piani avendovi il
quartier generale del nordovest d’ Italia, con 6oo dipendenti); la Ansaldo Automazione (vecchio nome di una parte
dell’Ansaldo, poi venduta all’americana Robicom); la Motorizzazione civile (proveniente da c.so Sardegna, occupa dal 2001 il 13° piano-
già della soc. costruttrice SCI- pagando d’affitto per i 1450 mq, la modica
cifra di 300milioni l’anno); ed altre
numerose nel settore
merceologico, come la Blu Trading e la
Accent nelle
progettazioni microelettroniche (leader italiana nel campo).
Il
nome deriva da ‘World Trade Center Genoa, spa’: centro di elettronica e
telematica integrata, che occupa il 5° piano, fondato dalla Camera di Commercio e mirata a
favorire la nascita di nuove imprese; sovrintendente a tutte le principali
funzioni del grattacielo: impianti energetici, climatizzatori, antincendio,
ascensori, collegamento con tutte le banche dati cittadine , nazionali ed
internazionali, nonché all’affitto ‘chiavi in mano’ alle imprese che cercano
uffici già arredati e collegati con tutti i servizi. Questo centro nasce da una
associazione formatasi a New Orleans nel 1968, con sede principale a Manhattan
di New York e altre diffuse in tutto il mondo tra cui la nostra, -seconda in
Italia dopo Milanofiori -locata ai primi piani del nostro grattacielo; il
nome inglese vuol essere anche simbolo di una città che -piaccia o no- cambia,
e guarda al futuro. Di struttura metallica e cemento,
ottagonale, facciate in granito con pannelli di vetro, copertura a cuspide di
rame. L’ultimo piano, a terrazza, doveva divenire di uso pubblico panoramico.
Promosso come operazione immobiliare, è in collegamento con la sopraelevata,
metropolitana ferroviaria, (che alla sua altezza dal 2004 sta aprendo una
stazione in via di Francia), autostrade, AMT.
Il Consorzio del porto, permutò parte del suo terreno in
cambio di una costruenda torre del CAP costruita in zona più ‘litoranea’.
Per
la sua erezione, furono sfrattate 121 aziende che lavoravano nei lotti del
progetto, per le quali fu obbligo ricercare sistemazione alternativa.
Anche
la villa De Franchi, seppur monumento storico-artistico e teoricamente
inalienabile, nella quasi totale indifferenza (un articoletto sul Gazzettino, a cose avvenute) fu demolita, con l’approvazione (lug.1983) del Comune. Gli abitanti dei caseggiati, alcuni
furono soddisfatti in liquido, altri con l’assegnazione di una casa comunale (si narra di un anziano morto di
‘crepacuore’ e di una novantenne che dall’ospedale passò ad un istituto per
vecchi; altri subirono per ‘poca umanità’ disagi non indifferenti: lasciati
nelle vicinanze dei canteri tra polvere, chiasso e saltuari sgombri per
pericolo di crollo, dovettero aspettare alcuni anni per una sistemazione
onorevole).
Causa infiltrazioni d’acqua e pericolo di implosione determinate dalla
eccessiva rigidità delle strutture metalliche rispetto quelle in cemento (oscillazioni e sbalzi termici;
portando il grado di dilatazione da pochi millimetri attuali a 12), nel 2003 fu programmata la sostituzione delle
5mila finestre (pari ad
una superficie di 10mila mq.) per una
spesa prevista di 4milioni di euro tramite uso di pontili ad ascensore esterni
verticali per evitare impalcature. Nel 2004 risulta essere il più complesso e
costoso intervento del genere in Europa.
===civ.16 si segnala la presenza della soc. ‘Frisia Italimpianti spa’ con alto fatturato, è addetta alla
dissalazione, bonifica e smaltimento di rifiuti, fumi, tossici. Occupa da 200 a
400 dipendenti
¶¶3)dalla ferrovia alla via Larga (via Palazzo della Fortezza), oggi via Dottesio (vedi).
L’antica via prima del 1850, andava con dolce curvatura a
virgola attraverso l’attuale via di Francia ed arrivava sino all’incrocio con
la via Larga ed il palazzo della Fortezza. In quella data la ferrovia la tagliò
perpendicolarmente passandole sopra con un viadotto che in tempi successivi fu
raddoppiato, lasciando a monte la villa Pallavicino (vedi vico Cibeo); lo ‘stradone di san Bartolomeo’;
le varie ville compresa la Negroni-Carpaneto e la Spinola; le chiesuole di santa Maria della Vista e di sant’Antonino
(distrutte); le Officine Meccaniche Navali di Salvatore Pittaluga del 1898
(distrutto); due edifici abitativi (innalzati nel 1906 e -d’angolo- nel 1907,
disegnati dall’arch. A.Petrozzani, di proprietà rispettivamente Zaccheo e
Porcile (non so se ci sono ancora? ***); fu eretta la chiesa di santa Maria
delle Grazie (tutte
descritte in via L.Dottesio). Il torrente cambiò tracciato e fu interrato con via Cantore.
Al
civ. 26 (vedi numerazione quadro 142) vi nacque il 28 lug.1883 Vittorio
Giuseppe Valletta (figlio di Federico impiegato delle FFSS e di Quadrio
Teresita); trasferitosi a Torino nel 1910 in età universitaria, dovendo
lavorare per mantenersi; solo nel 1919 si laureò in economia e commercio,
dedicandosi dapprima all’insegnamento ed al risanamento di società
fallimentari, divenendo poi grande ed inimitabile imprenditrore-manager.
Assunto alla Fiat nel 1921, fece rapida carriera: direttore generale,
amministratore delegato, ed alla morte del senatore Giovanni Agnelli,
presidente ed infine presidente onorario a vita. Fu l’artefice della
ricostruzione post bellica dell’azienda e dell’espansione in Russia (uno
stabilimento a Togliattigrad); si ritirò a vita privata ad 83 anni. Morì il
10 ago.1967 a Marina di Pietrasanta. Il Comune lo insignì nel 1962 dell’ “ulivo
d’oro”, riconoscimento annuale concesso ai liguri che rendono onore alla loro
terra ed alla loro gente.
Alla fine, che dire. Povera antica strada; è stata
snaturata dal progresso! perché anche se è stato conservato il nome per metà
dell’antico tracciato, c’è un distacco enorme: troppa indifferenza e freddo,
troppa fretta e chiasso: manca ad essa la poesia, l’odore di mare e della
fatica, i volti sereni di animi più puliti, l’ amore per la propria terra.
Vengono ricordate in epoca 1800esca anche l’esistenza di
una ‘stazione di posta’; le stalle del ‘Baciara’; la locanda ‘Tre Corone’; lo
stabilimento di oli minerali Reinach. Nel 1921 l’impresa trasporti Bagnasco
Emanuele; lo stabilimento lavorazione latta di Casanova Giacomo; le costruzioni
navali Piaggio Alessandro; fabbrica conserve Sanguineti Lodovico; la gestione
legnami della soc.an. Gio Ansaldo; la soc.an. DeAndreis di lavorazione latta.
Questa. Attività fu iniziata da Gottardo e seguita dal figlio Menotti –che
recatosi a lungo in Inghilterra- introdusse per primo la stampa litografica su
metallo: vinse così un concorso internazionale proposto dall’azienda Martell
per il proprio cognac, il cui cartello fu proposto in tutto il mondo.
Nel
settembre 2004 si annuncia l’approvazione alla costruzione sull’area
demolita dell’ulytimo grattacielo mancante alla zona oggi chiamata “san
Benigno”. L’81enne arch. Piero Gambacciani ha progettato un edificio alto 103m
a tetto, per 24 piani; due piani sotto terra; fuori, uno zoccolo formato da un
corpo unico da cui si innalzerà il grattacielo a forma triangolare; nella parte
sono collocati i servizi. Servirà al Comune per parcheggi; area custodia
veicoli rimossi, mezzi dei VV.FF.; uffici per servizi comunali vari;
DEDICATA all’antica FAMIGLIA (scritta in vari modi: inizialmente ‘di Marino, poi De
Marini, Demarini, de’ Marini) che appare presente in Genova negli
anni attorno al mille, e già allora molto ricca -possedendo case, ville e beni
sparsi nel territorio-. Cappellini scrive che l’origine
è germanica, con prime notizie del 1039. Bedocchi – riportando la genealogia
descritta dalla Scorza- la pone come ipotesi: che «secondo antichi genealogisti,
discendevano da Ido Visconti attraverso Guglielmo e il figlio Baldo che generò
Marino detto Della Porta: questi fu più volte console nel Comune di Genova tra
il 1130 e il 1148. Pare che i De Marini ricoprissero generalmente la carica di
consoli dei Placiti, cioè addetti all’amministrazione della giustizia nella
civitas e nel burgus».
Nei primi anni del XV
secolo, in particolare nel 1414, appare
scritto nel ‘cartulario possessionum’ del Banco di san Giorgio, che –schierati
con i guelfi- per sopravvivere nelle fierissime inimicizie private, alcune famiglie
si unirono lasciando il proprio cognome per assumere quello dei più forti, e
per formare così l’Albergo De’Marini furono: Castagna, Ganduccio, Pessagno,
Triadano, Vegio (esse seppur derivate da antiche e
celebri famiglie consolari, erano però piccole e deboli; abbandonarono il
proprio stemma per aggregarsi in una più forte casata adottandone lo stemma
costituito da tre cingoli trasversali). Di queste nessuna riprese il suo
nome primitivo. L’ ‘albergo’ in quella data possedeva in S.Petro Arene ben
quattro palazzi, quattro case e quattro casette; a Genova aveva il
giuspatronato della chiesa di san Domenico.
Dal 1528, furono posti da Andrea Doria a capo dell’8°
albergo, delle 28 casate principali, detto “Albergo dei nobili” istituiti nella
neocostituita Repubblica aristocratica formata dalle famiglie Bozzoli;
Carrega Benedetto (gli altri entrarono nei Sauli); Lavagna; DiEgra (da poco
venuti dalla Germania); Ferrecchi; Gallo; Giamboni; DeMarchi; Malocelli;
Montano; Paggi; Pansano; Pellerano; Raffo; Cassana; Rivarola; un ramo dei
Torre. Dopo il Garibotto, e poi ancora con la ‘riforma di
Casale’ del 1576, gli
‘alberghi’istituzionali’ vennero aboliti, cosicché tutte le prerogative
-cognome, stemma, rendite- dal Senato furono cooptate in una persona che fu
iscritta nel ‘libro d’oro della nobiltà genovese’).
A Genova l’abitazione principale della famiglia, catalogata
come ‘seatieri, legati agi Usodimare’, aveva sede –dapprima in zona s.Lorenzo-
poi, dopo le prime decadi del 1500, e dopo aver demolito casa e torre di un
certo Bertoldo di s.Salvatore, nel palazzo sito nell’omonima piazza vicino a
san Pietro in Banchi, zona Molo (piazza che popolarmente venne
chiamata pure “marmorea” perché vicina a depositi della pietra pregiata,
sbarcata in porto).
Il Dizionario biografico conferma che la casa era nella
parte bassa della contrada san Lorenzo, ai confini col mercato di Banchi.
Ebbe in tempi
successivi tanti componenti, tutti estremamente
versatili e capaci di coltivare contemporanei interessi economici, politici,
diplomatici; e molti con voce decisiva nell’amministrare la città.
La Scorza riassume i titoli, descrivendo che nel 1236, erano conti di
Gavi; anno 1400, Paolo di Ambrogio era arcivescovo di Genova; 1414, erano
Albergo; 1528, erano l’8° Albergo; 1616, Domenico, arciv. Di Genova; 1641,
Gio.Agostino di Gerolamo era doge; 1715, Carlo di Gioffredo cardinale. Aggiunge
che l’arma era “d’argento a tre bande ondate
nebulose di nero”
L’Alizeri
e don Brizzolara presuppongono che la strada sia stata dedicata -quale
“onesto tributo di gratitudine” – a:
===De Marini Carlo cardinale, munifico signore
che «beneficò questo popolo, di parecchi legati, e che istituì discipline
munifiche...».
Il Dizionario ecclesiastico del
Ceccaroni-Milano- scrive che era stato un nobile genovese, alla corte di Roma
con papa Clemente XI da cui fu creato cardinale nel 1715 di santa Maria in
Aquirio; e che resse anche le Legazioni di Ravenna ed Urbino; passato a miglior
vita nel 1747. Anche il Novella cita ‘il cardinale Carlo DEMARINI quale
fondatore di una pia opera per dotazione di fanciulle povere’ . Ma nel
Dizionario biografico ligure su citato, non appare questo Carlo. Anche
DeLandolina/1922 suggerisce la dedica a Carlo (forse copiandola dall’Alizeri
considerate quasi uguali alcune frasi): «Cardinale di S.M. in Acquiro (sic, ma non esiste nelle
enciclopedie), il quale
beneficiò Sampierdarena di molti legati e istituì discipline proficue nel suo
palazzo stesso che ancor’oggi sorge sul poggio di Montegalletto».
Più volte, al paragrafo VIII, XI e XIII del testamento
del Cardinale, si fa riferimento ad un suo ‘palazzo’ senza precisare dove era:
considerato che la collina di Montegalletto a SPd’A era posta a ponente del rio
del Fossato, si può presumere che sia stato quello abitato dalle suore e poi
distrutto (vedi via M.Vinzoni) oppure quello dei Francavilla prima che
divenisse Piccardo. Don Brizzolara precisa che essendo il Cardinale anche
Abate di Promontorio, dal suo palazzo «situato in cima a Monte Galletto
prospettava l’abbazia del Fossato e tutta la spiaggia di San Pier d’Arena.
Anche nei nostri giorni (1916) sull’architrave della porta d’un
locale interno di detto palazzo-ospedale si legge questa iscrizione: «Jam non
estis hospites et advenae; sed estis cives sanctorum et domestici Dei:
superaedificati super fundamentum Apostolorum ed Prophetarum, ipso Summo
Angulari lapide Christo Iesu. Eph.II v. 19,20». Questo prezioso documento fu
abbattuto dai ‘discoli’ nell’estate 1916. Ai nostri giorni i sovversivi di San
Pier d’Arena, a pochi metri di distanza dal palazzo-ospedale, indicato dal
testamento del card. DeMarini vollero impiantare il vasto nuovo ospedale, dal
quale vorrebbero che fosse estraneo lo spirito della Chiesa cattolica».
Un altro ‘Memoramdum’ manoscritto dell’abate di Promontorio don Giovanni
Brizzolara fu GB., copiato da eguale conservato nell’archivio parrocchiale
della Cella, e con riferimento bibliografico di p.GB.Semeria (vol.1 intitolato ‘nei secoli
cristiani della Liguria’), precisa che
Carlo – patrizio
genovese e Commendatario di s.Bartolomeo del Fossato di Promontorio (quando l’abbazia aveva tutte e copiose rendite da vasti possedimenti,
anche in Basaluzzo e Pastorana (AL) e nel Banco di san Giorgio (che pagava il curato vicario fisso))
-, morì nel 1747 a 80 anni dopo 32 anni di cardinalato. Nel testamento nominò
papa Benedetto XIV erede fiduciario di centomila scudi; Egli con fedeltà fece
eseguire le volontà dell’estinto che comprendevano l’istituzione di 15 pie
fondazioni da soddisfare con 15mila scudi, parte in Genova - amministrati dal
Magistrato di Misericordia (istituito nel XVI secolo dall’avo Pileo, arcivescovo di Genova. Della
cifra avuta, duemila lire
annuali sono consegnate alla Congregazione di Carità che li eroga ai poveri del
Comune di San Pier d’Arena) - parte in
Roma. Le spoglie mortali del cardinale giacciono nella chiesa della ss.
Nunziata. “Per 47 anni (1700-1747) fu abbate
Commendatario di san Bartolomeo del Fossato di Promontorio; nel giorno avanti
la sua morte, che avvenne il 15 gennaio 1747, fece suo testamento da lui
chiamato: ‘memoria da farsi presente a sua Santità Benedetto XIV di quello che
io ho desiderato testare’: in detto testamento il De Marini nomina il detto
Pontefice suo erede fiduciario, con tutte le più ampie facoltà. Il Sommo
Pontefice nel giorno 4 di febbraio del medesimo anno delegò Monsignor
D’Angennillieres a raccogliere l’eredità, pagare i debitori, ecc.. Quindi il
giorno 14 luglio 1749 con suo chirografo molto onorifico per l’arcivescovo di
Genova (mons.Giuseppe Maria Saporiti 1746-1767) e per Magistrato di
Misericordia, determinò quali, delle quindici fondazioni ordinate dal suddetto
Cardinale in Genova e nel suo Dominio, dovessero eseguirsi, eguali essere
riformate , ed eccone la distinzione:
I. Premio di lire 50 ogni mese al giovane o alla giovane,
che daranno prova di essere meglio istruiti nella Dottrina cristiana in San
Pier d’Arena... ... ...
totale £. 600
II. Cappellania per l’anima della q. Teodora Gentile
.... .... 332
III. Altra cappellania perpetua ...
.... ... ...
332
IV. Esercizi spirituali ogni anno nella Chiesa della Cella
... ... 150
V. Distribuzione denaro a poveri di s.P.d’A. il giorno
anniversario della morte del Card. 600
VI. A detti poveri, Pagnotte N.50 ogni giorno
... ... ... .. 1800
VII. Aiuto di costo di Medico in S.P.d’Arena per la cura
dei poveri, annuale ... 600
Indirettamente conferma Tuvo quando segnala che nel 1765,
nel Castello, fu nominato per la durata di tre anni medico per San Pier
d’Arena, Antonio Capponi: “il medesimo si obbliga di servire tutti quelli della
detta Comunità, da quali sarà chiamato senza poterne pretendere pagamento
alcuno disponendo delle seicento lire lasciate dall’ecc.mo cardinale De Marini
al medico attraverso il Magistrato della Misericordia”.
VIII. Per tre crociferi, due sacerdoti e un laico, che
abiteranno nel palazzo del cardinale in S.Pier d’Arena affinchè assistano agli
infermi ed ai moribondi ... ... ...
... 1500
IX. Messa perpetua ai RR.PP. della Cella, quando sussista
che il testatore ne abbia debito ... ...
... ...
...
.... 240
X. Altra cappellania in Novi, quando così si debba
... ... ... 240
XI. Tre mute di esercizi in San Pier d’Arena in detto
palazzo per otto persone persone di ogni muta, a Paoli 7½ sottosopra per ogni
persona compresi i servienti ed il Direttore (sic) 1280
XII. Per tre Missioni con
tre sacerdoti, che dovranno farle ovunque si sia ...
... 900
XIII . Premio da darsi a
quel Prete che nell’esame da farsi ogni anno da PP.Gesuiti nel detto Palazzo in
Teologia morale sarà trovato migliore tra i concorrenti in quell’anno
... 900
XIV . Per un computista
... ...
... 400
XV. Per un Direttore delle suddette opere pie, che dovrà
nell’indicato Palazzo del Cardinale 600
Tutti ricevuti direttamente dal
Magistrato di Misericordia.
totale 10,174
Il Papa apportò queste modifiche: all’I = alternativa
un mese ai maschi ed uno alle femmine secondo regolamento determinato dal
Magistrato di Misericordia; al II e III = l’Arcivescovo è incaricato di
nominare i cappellani; al IV, V, VI = decide il Magistrato e non altrimenti;
VIII contrario alle Costituzioni pontificie per lo scarso numero dei Religiosi:
dovrà l’Arcivescovo deputare 2 sacerdoti per 400 lire annue cadauno; al IX
=ridotta a metà, e da eseguirsi conforme alla prima osservanza della sua
fondazione; X = annullata; all’ XI e XII = annullati. Il capitale consegnato
all’Arcivescovo per risanare le Chiese danneggiate dalla guerra del 1747; al
XIII = annullato. Da darsi a quel sacerdote che insegni Teologia morale nel
seminario di Genova; al XIV e XV = commutati. Giudice il Magistrato per
sopperire le spese che potessero occorrere per difendere i capitali, con che
l’avanzo sia dovuto ai poveri. Totale £. 5934
Don Brizzolara scrive : I capitoli di questa dispensa
erano scritti anche in Francia, Vienna, sanGiorgio e Londra. Ma dopo la
rivoluzione francese la proprietà divenne ‘poco florida non superando le 3700
lire. Per questo nel 1811 fu fatta un’altra deduzione di tutte le somme
dovute, giudicando quali le più importanti: la I = ridotta a £.150 che ritira
il parroco della Cella; II e III = invariati; IV= in favore dei Missionari; V e
VI = invariati ma si eseguono colla distribuzione delle cartoline; VII = non
eseguito benché confermato da papa Benedetto XIV; VIII = ridotto a £.200 che
ritira il Parroco della Cella; IX confermato ma solo £.120; da X a XV
annullati. Totale £.3684
Fino al primo di Luglio 1891 i legati pii del cardinale
Carlo De Marini in San Pier d’arena erano percepiti dall’arciprete di san
Martino e santa Maria della Cella ed erano i seguenti:
1. Legato di 50 Messe annue con la limosina complessiva
di lire 91 e cent.36 nette da riscuotersi presso il Magistrato di Misericordia
in due semestri con fede in carta bollata da cent. 60.
2. Legato di £.105 e 50 annue nette, in due rate pei
fanciulli della dottrina cristiana, che sono insaccati ed estratti 4 per ogni
domenica -£.0,40 a ciascuno dei presenti
3. Legato per le fanciulle della Dottrina cristiana,
insacate che si estraggono ogni anno in novembre e ricevono dal Magistrato lire
18 circa ciascuna: se ne ammettono 16.
4. Legato per gli infermi, che giova
a compire l’onorario del del Prete sacristano, ed è di lire 154 annue nette in
2 semestri –dal magistrato- dello Sacrista era l’ora fu D.Nicolò Daste riceveva
ogni semestre £. 77,12.
Quella speciale di beneficenza,
dopo una ventina d’anni fu passata alla Congregazione di Carità, con
conseguenti lagnanze circa la fedele distribuzione dei sussidi
Negli ani 1891 – 1892 – l’ arciprete di san Pier d’Arena
riscosse ancora in ciascun anno £. 445,68 per 25 Messe - £.52,75 per la
Dottrina cristiana e per gli infermi £.77,12. Il Rev.mo Arciprete di San Pier
d’Arena in data 4 genajo 1892 notava nel registro del suo archivio quanto
appresso.
«Il legato della Dottrina cristiana per i maschi e la dote
per le figlie della Dottrina cristiana, essendo che oramai non corrisponde più
al fine inteso dal testatore, è a desiderarsi sia dall’autorità competente
rivolto ad altro buon fine. Urgerebbe aver da pagare più tosto alcuni
catechisti, ora che dalla maggioranza bastardamente cattolica non si
sanno più i Misteri principali. Lo stesso Rev.mo Arciprete nella stessa data
notava pure: il Legato De Marini pei poveri dal Magistrato di Misericordia
viene pagato (non conosco la cagione di ciò) alla Municipale ‘Congregazione di
carità. Si capisce: è una congregazione laicale. Se è vero che furono eletti
finora, generalmente parlando, onesti amministratori, non cessa il pericolo che
possa diventare, e forse presto, cosa tutta massonica. Il legato è ridotto a
lire 2008 alla quale somma van sottratte le tasse !!!»
===Controversa l’attribuzione della nascita della famiglia:
per alcuni genealogisti (Scorza e Belgrano), capostipite apparirebbe
===Marino
di Baldo q.Guglielmo
degli Alinerii, detto Marino della Porta di origine viscontile (del ramo derivato da Oberto di
Manesseno); fu console
del comune di Genova negli anni 1130, 1141, 1146, 1148.
Per altri (Giustiniani, Dellacella), capostipite fu Ogerio
De Marini, console nel 1130 che ebbe tre figli, Lamberto (che fu nominato principe di Peveglio , consigliere
del Comune nel 1146 e partecipe del pedaggio di Voltaggio nel 1149); Guglielmo (che
appare qualche volta come firmatario di importanti trattative come quella di
tregua -ripetutamente violata- tra i cittadini genovesi mentre la Repubblica
era minacciata dall’esterno, specie da Pisa); e terzo più importante fu Beltrame, il primo di cui con sicurezza si
hanno notizie di comando e valore: divenne console, in particolare del
‘Placiti’ ovvero gli addetti all’amministrazione della giustizia per le varie
compagnie genovesi, cittadine (Castello, Piazzalonga, Maccagnana, san Lorenzo) e burgensi (Porta, Soziglia, Porta Nuova, Borgo). Appare anche firmatario di molti
giuramenti come console della repubblica: uno nel 1146 nella promessa al conte
di Barcellona -dopo l’impresa di Almeria- di intervenire all’assedio di Tortosa
(la convenzione
prevedeva che le conquiste, la città ed i castelli, sarebbero state divise in
tre parte di cui, due al conte ed una al comune di Genova; nell’accordo, anche
la chiesa avrebbe beneficiato a parte); l’altro ne1 1157 assieme ai fratelli ed altri 298
cittadini quando sottoscrissero un trattato con Guglielmo I re di Sicilia
obbligandosi di non allearsi con l’imperatore di Costantinopoli, in guerra con
il re; un terzo, col fratello Guglielmo, appaiono firmatari il 30 agosto 1157
di un’altra convenzione con il conte di Ventimiglia Guido Guerra, disposto a
donare al Comune di Genova i suoi domini di Roccabruna, Gobbio, Poggiopino e
Penna. Fece parte anche di una ambasceria presso Federico Barbarossa nel 1162,
per stabilire come prestare aiuto all’imperatore e ricevere in cambio privilegi
vari come il possesso della città di Siracusa; fu presente al giuramento fatto
all’arcivescovo di Genova dal marchese Opizzo Malaspina e da suo fratello
Moruello, di fedeltà e di obbligo a mantenere libere e sicure le strade di
accesso alla città e, in caso di guerra, armare a proprie spese 15 cavalieri e
300 arcieri; ultimo, nello stesso anno, fu firmatario di accettazione di una
sentenza arbitrale, sulle indennità ai marchesi Malaspina e sulle controversie
per il castello di Monleone. Anche un figlio di Beltrame fu console per tre
volte con partecipazione ad alleanze, protezioni, e giuramenti vari. Mentre
===Pasquale, forse figlio di Beltrame (altri
dicono fratello), divenne nove volte Console, nel terribile periodo delle lotte
con Pisa ed alleanze con Lucca .
===Montano, grande navigatore del 1200 (mercante di
mervci di valore), un po’ pirata contro i pisani ed i veneziani, un po’
politico nelle lotte cittadine. Parteggiando per i guelfi e, sconfitto, fu
espulso; catturato dai veneziani riuscì a capovolgere la sua posizione
facendosi nominare podestà di Padova. Morì in Turchia, nelle colonie genovesi
ove era stato inviato dal nostro Senato.
=== Marino, (sono più d‘uno gli omonimi menzionati in
quell’epoca dai documenti genovesi); viene ricordato in particolare un Marino o
Marietto come valoroso combattente nel 1240 comandante una squadra di 10 galee
nell’epica lotta contro Federico II di Svevia nell’assedio del castello della
Pietra (Ligure); annalista (nel 1256), ma soprattutto giureconsulto, testimone
ambasciatore di innumerevoli trattative in Italia specie con Venezia (che
accusava enova di pirateria) e Vaticano; poi ‘clavigero’ assieme ad altri sette
nobili come consigliere del podestà (allora, il bolognese Rambertino Buvalello);
nel 1283 assistette al ritrovamento delle reliquie dei corpi di san Siro e san
Felice vescovi di Genova; capace di accumulare un cospicuo patrimonio che
investì nel commercio e nell’acquisto di beni immobili in città; morì nel 1293
Nel 1236 figurano essere titolati ‘ conti di Gavi’.
===Le prime notizie di un Ambrogio risalgono al 1370 quando esercitava attività commerciali nel
Mediterraneo (vino), nel mare del Nord (grano) ed in Oriente (zenzero); bancherius,
civis et mercator Ianuæ divenne poi ambasciatore della Repubblica in Portogallo;
ed infine governatore della Corsica in tempi difficili e sediziosi, ove morì
nel 1403.
===Suo figlio Pileo
(nato da Violante
Fieschi; Semeria
scrive ‘nato intorno all’anno 1370’).
Il
30 nov.1400, appena trentenne, (altra fonte dice ventitreenne; altra dice 1 dicembre) divenne arcivescovo di Genova
previa dispensa del papa Bonifacio IX (altre fonti dicono erroneamente Bonifacio VIII). Fu persona scomoda, quasi mai
silenziosa e discreta, scarsamente arrendevole sia al potere politico che
religioso, eppure meritevole di alti ed esaltanti elogi, specie per la
coordinazione delle opere pie, per l’istituzione del magistrato di
Misericordia, e per il restauro della sede arcivescovile. Fu però coinvolto
negli intricatissimi rapporti sia di potere (volubile era la politica locale, costantemente in
lotta sanguinosa tra le fazioni dei guelfi e dei ghibellini) sia religiosi tra la sede romana e
quella avignonese inizialmente dichiarando obbedienza a quest’ultima (presumibilmente perché sottoposto
a pressioni –specie da parte del canonico di san Lorenzo Giovanni da
Godigliasco suo protetto- e fors’anche minacce visto la pressione che la
Francia esercitava su una Genova dominata. Lo scisma sconvolse tutta la vita
religiosa locale, dal 1404 fino al 1417 quando col concilio di Costanza venne
deposto l’antipapa francese Benedetto XIII (al secolo Jean Le Meingre detto
Boucicaut, o Pietro di Luna, dichiarandolo spergiuro, eretico, scismatico).
Benedetto XIII era venuto a Genova il 12 mag.1405, proprio per incontrare il
DeMarini). Pileo fu ovviamente destituito dal papa romano, ma schierandosi
poi apertamente col neoeletto terzo papa –fedele a Roma- Alessandro V nel
concilio di Pisa (1409), fu evidentemente perdonato e reintegrato. Infatti
partecipò nel 1414-17 al concilio di Costanza, tenuto per ricomporre lo scisma, a cui fu messa la
parola fine, quando unanimemente nel nov.1417 fu eletto a capo della chiesa
universale Martino V).
Se pur approfondendo gli studi classici, favorì -in quegli
anni di trapasso tra il ‘300 e ‘400- la penetrazione nell’ambiente culturale
genovese dei nuovi ideali umanistici; diede vita al Magistrato della
Misericordia per opere di carità e pietà (nelle assemblee aveva diritto a due voti: l’incarico era di
‘invigilare’ le pie dispense annuali affinché fossero ‘fedelmente e con buon
ordine distribuite à poveri dell’uno e dell’altro sesso per loro sovvenimento’), nonché fu promotore dell’ospedale
di Pammatone (o di
santa Maria de Misericordia, voluto da Bartolomeo Bosco nell’anno 1420). Entrato in contrasto col duca di
Milano Filippo Maria Visconti, lente e corrosive furono le divergenze col
potere politico locale e religioso centrale, al punto che nel 1426 fu
allontanato dalla cattedra e portato forzatamente a Milano. Tornato verso
Genova, a Voltri si mescolò ai ribelli senza poter entrare in città. Dopo
allora il papa Martino V nel 1429 nominò al suo posto un altro arcivescovo
spiegando la successione ‘per obitum’, senza precisazione di dove, quando,
perché (Semeria lo fa morire in città, nel 1436).
===Giovanni
Battista,
rinunciatario del cognome antico di Castagnola, nato a Chio nel 1540, nominato
grande elemosiniere del papa). La famiglia si estese anche fuori della
Repubblica: vengono ricordati dei De Marini a Milano, Torino, Napoli, Venezia.
===Tomaso (1499 (Bedocchi scrive 1475)-1572) fu il figlio di Luchino (valente
banchiere, col fratello Giovanni arricchiti a
Milano nei lunghi anni di pace sforzesca), e ne curò e continuò i lucrosi
interessi (il suo
fastoso palazzo è oggi sede del Comune). Discendente dei Castagna, la più antica casata tra tutte
quelle che si riunirono nei De Marini, seppe abilmente spremere denaro ai
contribuenti (e con il commercio del sale) che travasava nelle casse assetate
del duca, del papa, del governatore, ed investendo gli ampi guadagni in
proprietà sparse in tutta la Lombardia (compreso un marchesato, di
Casalmaggiore, 1544), nel genovesato ed a Roma. Riuscì a malapena a districarsi
nell’aver partecipato alla congiura di Gian Luigi Fieschi contro Andrea Doria
del 1547; ma pochi anni dopo, recidivo, fu bandito –1551-2- da Genova obbligandolo
a Milano. Fu graziato nel 1555 e dal Senato fu coinvolto nella difesa della
Corsica invasa dai francesi. Ma era a Milano il suo vorticoso giro di soldi,
che lo portavano ad interessarsi di tutto ciò che poteva produrre grossi affari
, dai quali dipendevano per il governo le paghe dei soldati mercenari,
costruzioni di cinte murarie, le grosse imprese pubbliche: era genericamente
considerato un approfittatore senza scrupoli, abile nello sfruttare i tempi e
l’economia anche quella neonata con il nuovo mondo, protetto dai ‘bravi’. Nel
1588 diede via ai lavori diretti da Galeazzo Alessi, per l’erezione di un suo
palazzo in Milano, che doveva essere ‘il più bello della cristianità et
costargli un pozzo d’oro’. Ma un po’ l’età, un pò le tragiche vicende familiari
(ambedue i figli omicidi, uno di un servo e l’altro della moglie nobildonna
spagnola), un po’ la congestione ed il disordine nell’intricato groviglio delle
sue innumerevoli contabilità, la sua morte e quella dell’Alessi, determinarono
che il palazzo non fu interamente completato e, nel 1577 confiscato (ma nel 1615 a conti ultimati, ne
venne fuori che i crediti superavano di
gran lunga i debiti).
===Leonardo fu grande teologo dell’ordine dei Predicatori, fu nominato
vescovo di Laodicea nel 1550; attivo partecipe al concilio di Trento (1562) ed
inviato più volte quale nunzio apostolico alle corti europee specie di Spagna e
Portogallo; è noto per aver preso parte –assieme a Muzio Cabino, arciv. Di
Zara- alla compilazione del Catechismo Romano e nel confutare gli errori della
dottrina di Lutero. Morì a Roma nel 1575.
===Giovanni
Agostino 1572-1642; per
poco meno di un anno (in cui raccolse fondi per un pubblico contributo del
riarmo navale: riuscì a allestirne venti; ed ordino che tutti, nobili e
popolani, si salutassero sollevando il cappello), doge dal 1641 interrotto per
decesso. Nel 1616 era stato incarcerato nella torre del Palazzo Ducale, per
aver prso le difese del fratello Domenico,
arcivescovo, che voleva essere seguito da scorta armata anche durante le
funzioni religiose. Suo figlio Francesco
divenne gesuita e letterato (scrittore di commedie, recitate dai nobili)
===Un GB (1597-1669) divenne maestro
generale dell’ordine dei Domenicani; ===mentre Giovanni Filippo (1608-1682) fu un gesuita missionario
e scrittore che morì a Macao in Cina dopo essere stato molto tempo nel Tonchino
(nord Vietnam).
===Nacque illegittimo a Venezia Giovanni Ambrogio nel 1596 (in alcuni testi è citato
con il cognome senza il ‘de’): divenne sacerdote e letterato (il più noto e celebrato romanziere
genovese del seicento essendo le sue opere oggetto di numerose ristampe;
frequentatore a Genova dell’Accademia degli Addormentati di Anton Giulio
Brignole Sale e “de’ Disperati”; numerose le opere letterarie e scientifiche a
lui dedicate da vari autori). Fu sepolto in san Lorenzo.
===Nato a Genova
(1540-1604) Giovanni Antonio, attivo uomo d’affari, proprietario di trireme, usato
dalla Repubblica come ambasciatore: nel 1602 fu inviato a Valladolid per
ottenere copia del testamento di Cristoforo Colombo conservato a Madrid da
Scipione Casanova; ma là, raggiunto da malattia, vi morì. Nel testamento,
lasciò una casa in San Pier d’Arena a suo fratello.
Nel 1600 acquisì
importanza il patrizio Claudio, nato in Francia nel 1574 circa e che fu promotore
della ‘congiura dei De Marini’. Filofrancese per motivi natali, in una città
filospagnola per convenienza , essendo di personalità complessa e turbolenta e
di carattere rissoso e violento, gli costò in varie tappe processi,
perquisizioni della casa, arresto ed esilio. Finché nel 1610 poté risiedere a
Genova (non come ambasciatore ma solo
come ciambellano e consigliere di stato di Luigi XIII, perché la Repubblica
ammetteva rapporti solo con l’ambasciatore spagnolo); in tale veste fece rappresentante politico della
Francia nelle guerre dapprima contro, poi a favore dei Savoia fino a divenire
ambasciatore francese a Torino e consigliere dei Savoia nel ricercare ‘lo
sbocco al mare del regno sabaudo’ attaccando Genova: forti dell’appoggio francese,
il re Carlo Emanuele I con un esercito piemontese di 14mila fanti e 2500
cavalieri, guidati dal connestabile di Lesdiguières e dal maresciallo DeCréqui,
nel 1625 attaccò le mura; ma in soccorso arrivarono 70 galee spagnole che
costrinsero i piemontesi a rientrare dei loro territori. Fallito l’atto di
forza, il re tentò di impadronirsi della città con l’inganno pagando un parente
De Marini Vincenzo che lavorava come
direttore generale nell’ufficio postale della repubblica, affinché aprisse la
corrispondenza e rivelasse i contenuti; l’infedele fu scoperto, arrestato,
sottoposto a tortura e decapitato nella torre del palazzo Ducale ed in più
depennato con gli eredi dal Libro d’Oro della nobiltà; anche Claudio fu
processato in contumacia e confiscato dei beni: la casa in piazza Salvago rasa
al suolo (al suo posto sorgerà la chiesa
di san Bernardo; altrettanto dura sarà la risposta del re di Francia contro
Genova poiché mise al bando i genovesi in Francia e ne sequestrò i beni). Morì a Torino nel 1629.
===Contemporanei a Claudio,
due patrizi omonimi Domenico; uno studioso e scrittore di scienze, di teologia e
filosofia. Divenuto vicario generale dell’ordine dei domenicani, fu consacrato
nel 1648 arcivescovo di Avignone.
L’altro Domenico anche lui avviato alla
vita ecclesiastica perché secondogenito, arrivò ad essere vescovo di Albenga
nel 1611, governatore di Perugia nel 1612 ed arcivescovo di Genova nel 1616-35:
fu partecipe di un grave attrito diplomatico tra la Repubblica e lo Stato
Pontificio quando quest’ultimo aveva chiesto -tramite l’arcivescovo- l’arresto
in città del prete secolare Antonio Montenegro, nobile cittadino genovese
dimorante a Napoli, reo di aver pubblicato libelli antipapali: il senato
genovese accondiscese purché si procedesse solo all’arresto e non alla pena
capitale prevista nel caso; ma appena il sacerdote fu trasferito a Roma, fu
decapitato nel Castel sant’Angelo. Fu questo arcivescovo che ricevette in
grande solennità la reliquia di san Bernardo abate in Chiaravalle che nel 1625 era
stato eletto a patrono della città per decreto votivo legato alla guerra con i
Savoia dello stesso anno (una vertebra, distratta dalla teca conservata dai
frati del santuario di Chiaravalle e consegnata al console genovese marchese
Agostino Centurione). Morì a 72 anni; e fu tumulato in san Lorenzo nel
febbraio 1635.
===Di DeMarinis Giorgio, è testimonianza una lapide murata nel
corridoio alla sacrestia della Cella, ove si legge pure lo stemma della
famiglia; il nobile -nell’anno 1619- per sé e per la moglie Nicoletta Grimaldi,
ordina delle messe all’altare di san Francesco da fare in perpetuo.
===Un altro Marino,
nato illegittimo a Venezia da ignota nobildonna locale durante una missione
diplomatica del padre in quella città; poi riconosciuto legittimo ed ascritto
al patriziato genovese. Troppo spesso fuori città per fuggire i creditori, è
famoso perché nel 1634 inventò una nuova bombarda (interessante e di attualità in un
periodo assai inquieto -era ancora recente l’assalto dei piemontesi del 1625- ,
più leggera -quindi facilmente trasferibile sulle mura e laddove occorresse-,
ed anche meno costosa: prevedeva minimo impiego di metallo limitato alla bocca
da fuoco, alla parte interna della canna, ed alcuni anelli intervallati, il
tutto circondato da corda impeciata e doghe di legno coperte di cuoio, con
rivestimento esterno di carta pecora dipinta a finto bronzo; regalata
l’invenzione al Senato della Repubblica, ebbe in cambio il brevetto ed una
catena d’oro del valore di 1200 lire; l’efficacia bellica però risultò
deludente, e l’arma non fu riprodotta).
===Gian
Agostino, (il
Gazzettino dice Gian Domenico, figlio di Gerolamo) doge nel 1641, ricevette
dall’imperatore l’ambito titolo di ”serenissimo”, titolo che rimase poi sempre
ai dogi genovesi; durò in carica solo un anno e di lui si ricorda soprattutto
aver dettato obbligo a tutti di salutarsi levandosi il cappello (cosa che era
obbligata solo al ceto inferiore di fronte a quello superiore; con non poche
dispute, specie tra i cittadini più arroganti o superbi)
===De Marini Francesco, nato
a Genova nel 1630, battezzato in san Pietro in Banchi, seguì la vocazione
sacerdotale con una rapidissima ascesa tanto che a 25 anni era già vescovo di
Albenga. Di carattere zelante ma focoso e puntiglioso, assai poco diplomatico;
in attrito con tutti , spesso con alterata e scomposta reazione sia contro gli
amministratori della città, sia i suoi stessi sacerdoti anelanti maggiore
autonomia; arrivò a interdire il culto della messa in cattedrale perché
contrastato nella scelta di un predicatore (con una breve pontificia fu
obbligato a ripristinare l’officio), e lo stesso fece a Pietra Ligure nel 1658
quando arrivò anche ad alzare le mani addosso e poi scomunicare un frate
superiore cappuccino con cui era venuto a diverbio (fu richiamato a Roma per un anno ove dovette
giustificare il suo operato; e nel 1660 il tribunale ecclesiastico gli diede
torto negandogli anche lo ‘ius visitandi’ per Pietra Ligure). Trasferito a Molfetta, preferì ritirarsi a Roma ove
seguì la carriera ecclesiastica fino a divenire arcivescovo di Theodosia nel
1676. Forse è di lui che cita il notaio GB Badaracco, parlando dell’arciprete
Gio.Vittorio Angeletti, figlio di Angelo da Vezzano, “familiare
dell’arcivescovo De Marini: il 23 sett.1647 riscuote la decima dei pesci dai
pescatori di Sampierdarena”.
===Paolo Battista Gerolamo Maria, fu ambasciatore in Francia quando Luigi XIV
approfittando della debolezza della Repubblica non più protetta dagli spagnoli,
espresse richieste provocatorie e lesive alla sovranità genovese; grande errore
del DeMarini fu il non aver capito la gravità degli eventi ed i preparativi di
una flotta a Tolone ed a Marsiglia (ma
anche a Genova non si erano accorti degli innumerevoli pittori, turisti,
commercianti, studenti francesi che con le più disparate scuse spiarono ogni
difesa, punto debole delle fortificazioni, i traffici del porto e quant’altro
potesse offrire vantaggio militare in caso di offesa da terra o dal mare): il re ordinò una azione punitiva rinchiudendo il De
Marini nella Bastiglia; facendo bombardare la città dal 15 al 20 maggio 1684
sparando su essa ben 13mila colpi; e concludendo il tutto con l’umiliante
condizione di una possibile trattativa solo se il Doge si fosse recato
umilmente a Versailles: il De Marini, liberato (aveva dimostrato nel carcere la fierezza dei genovesi, mai umiliandosi
ed anzi –seppur censito nei messaggi alla Repubblica- generoso invitando il
doge di ‘non prendersi alcuna pena per lui perché contento di soffrire se
necessario per aver ben operato per la patria’), ottenne che la delegazione fosse considerata una ambasciata di puro
ossequio e ricevesse gli onori riconosciuti ad una grande potenza; così il doge
Gian Francesco Maria Imperiale Lercari, con quattro senatori (Giannettino Garibaldo, Agostino Lomellino, Paride
Salvago, Marcello Durazzo), poté recarsi
il 15 maggio 1685 a Versailles, ove col famoso ‘mi chi’ riparò il grave disagio
e l’umiliazione diplomatica con un successo personale (vedi anche a Imperiale). Il DeMarini, tornato a Genova, divenne senatore nel 1690 e poi anche
padre del Comune negli anni 1693-4 e 1701.
===De Marini Ferdinando (1718-1800), collocò la
famiglia nell’alto patriziato genovese, ricoprendo numerose magistrature e
divenendo senatore; coltivò anche interessi letterari, componendo sonetti.
=== Un De Marini Domenico Vincenzo,
nato nel 1763, definito ‘nobile e gran proprietario, dotato di eminenti qualità
e di grande sensibilità culturale’; fu abile amministratore e politico nel
periodo della caduta della Repubblica: sia con gli austriaci che con i francesi
e poi dopo con i reali torinesi ottenne cariche di alto prestigio, fino a
senatore, consigliere regio, e sindaco di prima classe nel 1828; durante il
suo mandato fece collocare lungo le scale dell’Università molte antiche lapidi
di grande importanza storica (che furono rimosse dai successori). Morì nel 1847
quando ancora era in piena attività .
===Paolo Ferdinando fu funzionario del regno di Sardegna , intendente
generale della Divisione di Genova ed insignito della croce di cavaliere
dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; fu anche presidente della Camera di
Commercio e di molte altre istituzioni cittadine .
===Cappellini aggiunge un Domenico
vissuto nel 1449, patriarca di Gerusalemme dopo essere stato legato dell’Umbria
e governatore di Roma. GiovanniAgostino,
1572-1642, doge 1641-2, fratello dell’arcivescovo Domenico, sventò le mire di
conquista di CarloEmanueleI di Savoia. GiovanniAmbrogio
fu nel XVII secolo sacerdote e letterato lasciando molte prose e poesie. Girolamo di Francesco 1595-1668?, senatore,
scrittore nel 1666 dell’operetta ‘Genua’ descrivente il dominio ed il governo
della Repubblica. Oliviero del XVI secolo, benefattore e fondatore nel
1538 di un collegio per orfani. Pietro domenicano,
uno dei primi 12 teologi dell’Università di Torino fondata nel 1405, priore di
s.Domenico.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Guida illustrativa per la città...-Sambolino.1875-pag. 642
-Annuario
generale d’Italia-F.lli Pozzo.1953-pag.1124
-Archivio
parrocchiale di san Bartolomeo della Costa
-Archivio
Storico Comunale
-Ascheri
GA-Notizie storiche delle famiglie…-DeFerrari.2003-pag.XVI.8
-A.sconosciuto-Guida
del porto di Ge.-Pagano.1954-pag.732
-A.sconosciuto
storia del trasporto pubblico a Ge.-Sagep.1980-pag.23nota4
-AA.VV.-Annuario.Guida
archidiocesi –ediz/94-pag.401—ed./02-pag.439
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-pag.20
-AA.VV.-1886.1996
oltre un secolo di Liguria-Il SecoloXIX-pag.504
-AA.VV.-Stradario
guide Gallery-vol.II-18.104
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda
-Battilana
N.-Genealogie delle famiglie nobili..-Pagano.1825-vol.III-p.28
-Bedocchi&Profumo-I
caruggi di Genova-NewtonCompton2007-pag.192
-Bitossi
C.-Personale e strutture dell’amministr....-SocLiStPatr.1987-p.203
-Borzini
R-OsterieGenovesi-Liguria.1959 –pag.63
-Brizzolara
don G.-appunti personali manoscr.-Archiv.Ab.Promontorio
-BricolaGrosso
R.-la Parrocchia di SMdGrazie a SPdA-Status.04-pag.15
-Cambiaso
D.-i Vicari generali degli arciv.-Atti SLSP.1972.fasc.II-pag.24
-Cappellini
A.-Dizionario biografico di genovesi ill.-Stianto 1932-p.50
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza..1922-pag.40
-De Rita G-Angelo Costa etica e impresa- Erga
2001-pag.17
-Di
Negro GF B-l’araldica a Genova-Liguria 1983-pag.96
-D’Oria
S.- Sampierdarena SanTeodoro-DeFerrari.2001.pag.42
-Forchieri
G.-Dogi Governatori Procuratori-Tredici &C.1968-pag.89
-Gazzettino
S. : 2/73.4 + 10/73.7 + 1/80.8 + 3/81.3 + 7/835 + 2/84.1 +
5/84.1 + 7/84.9 + 2/86.8 + 7/86.3 + 4/87.7 + 3/88.3 + 5/88.10 +
4/91.3 + 2/92.7 + 9/92.3.7ritratto papa e stemma +
3/94.15 + 7/95.15 + 2/96.6 + 10/03.5 + 10/03.3 + 03/04.8 +
-G.Bianchi-Poleggi-Una
città portuale del Mediterraneo-Sagep.1980-p.181
-Il
Secolo XIX : maggio e giugno 1984 + 12.9.97 + 5 e 10.3.98 + 18.11.98 + 09,
16, 21, 23 e 24.1.99 foto + 30.7.99 + 02.11.99 + 24.2.00 + 17.9.01 +
10/01/02 + 6/6/03 + 13/9/04 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 26
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.141
-Miscio
A.-La seconda Valdocco-Elledici.2002.vol.I.pag.75.98.122
-Novella
P.-Strade di Ge-Manoscritto boibl.Berio-1900-pag. 17.34-5
-Pagano/08–pg.873-79; /40-pg.273; /33-pg.246.770.873.1510; /1961-p.583.1436
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge-Tolozzi.’85-vol.II-p.579
-Pescio
A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.116
-PiastraW
&C-Dizionario biografico Liguri-Brigati.1992-vol.V-pag.325 --Poleggi E.
&C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.52
-Puncuh
& AAVV-il cammino della Chiesa genov-Q.Franz.1999-p.234
-Puncuh
D.-carteggio di Pileo DeMarini-SLSPatria-v.85
-Regina,
Lunario genovese del signor –ediz.1889-pag.360
-Riva.Rocchiero-Luigi
Gainotti-opusc.Gall.d’Arte sAndrea, 1960.
-Roscelli
D.Nicolò Barabino-soc.Universale.1982-pag.156
-Scorza
A.MG-Le famiglie nobili genovesi-Olivieri.1924
-Semeria
GB-secoli cristiani della Liguria-1843-pag.163.257
-Tealdi
G.-Gli anni di Savignone-CittàDelSilenzio 2009-pag.18
-Tuvo
T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani 1983-pag.80
-TuvoCampagnol-Storia
di SPd’Arena-D’Amore.1975-p. 36.39.49.98.134
-Vitale
V.-breviario della storia di Genova-SLSP.1955-vol.I-pag.318
=non
citati su Enciclopedia Motta; Enciclopedia Sonzogno; Grillo-origine storica
località; catalogo ville genovesi
=parte
della bibliografia delle due prime chiese di NS delle Grazie sono in via
Dottesio (da cui
provengono le relazioni, ma dove sono rimasti i riferimenti bibliografici)
DERCHI
via G.B. Derchi
TARGA: San Pier
d’Arena – via - G.B. Derchi – pittore – 1879-1912

targa posta alla sommità della strada

QUARTIERE ANTICO:
Promontorio
 Da Vinzoni, 1757. In verde, tratto
di via Imperiale (v GB Derchi); giallo salita DConte; rosso abbazia SBdFossato;
celeste, abbazia di Promontorio
Da Vinzoni, 1757. In verde, tratto
di via Imperiale (v GB Derchi); giallo salita DConte; rosso abbazia SBdFossato;
celeste, abbazia di Promontorio
N° IMMATRICOLAZIONE:
2769 CATEGORIA 2

da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 22160
UNITÀ URBANISTICA: 27
- BELVEDERE
 da Google Earth 2007. In celeste,
via MFanti; giallo, via BCarrea
da Google Earth 2007. In celeste,
via MFanti; giallo, via BCarrea
CAP: 16149
PARROCCHIA: (civ.2)
Promontorio
STORIA: è la strada
più diretta per il pedone che - dal levante della marina, della Coscia - voleva
ascendere a Promontorio; quindi che questo tracciato sia antico non c’è dubbio,
anche se oggi assai poco frequentato. Però non è da sottovalutare che
l’abbazia, in via Promontorio si presenta con il retro, essendo la facciata e
la porta rivolte verso salita S.Rosa come a testimoniare a quest’ultima una
priorità di nascita e di funzione.
Nelle prime mappe ottocentesche il sentiero già appare quale tratto terminale
in alto di ‘vico Imperiale’, che in ascendere proseguiva la ‘crosa Larga’ ed
arrivava a Promontorio allo stesso incrocio di ora. Questo lungo vicolo fu
cambiato di nome in ‘via E.DeAmicis’.
Nel Pagano/1940 compare già la delimitazione: ‘da corso O.Scassi a sal Dante
Conte’.
Solo il 7 genn.1955 il tratto in salita da ‘corso O.Scassi’ ebbe il nome di
‘via M.Fanti’ il cui tracciato aveva interrotto la stradina con uno sbalzo da
dover costruire delle scale; così in contemporanea venne delimitata anche la
‘via GB. Derchi’.
Assai poco frequentata, è spesso soggetta a deterioramento ed invasione di
erbacce; l’ultimo restauro dell’acciottolato risulta del 1995.
STRUTTURA: in
discesa, va: dalle via Promontorio-salita D.Conte a via B.Carrea.
Unica in tutto il genovesato, non fu pavimentata a risseau-mattoni
ma a lastre di granito tagliate a losanga, ancor ora sufficientemente composte
fino alla scalinata. Il motivo forse è dovuto ad una pavimentazione più tardiva
e quindi più mirata al lato economico
Dall’alto potrebbe essere doppio senso veicolare, ma in
basso finisce con una scalinata che la rende non transitabile se non
pedonalmente; comunque è totalmente così stretta da lasciar percorrere un solo
veicolo di medio piccola cilindrata.
Pochi metri dopo l’inizio in alto, su un pilastro c’è una nuova
edicola della Madonna che pare sia stata posta di recente, essendoci dietro le
tracce di una più antica, forse andata perduta. Subito dopo l’edicola, si
costeggia la sommità dell’ex villa Scassi, ora proprietà dell’Ospedale.
CIVICI
2007=
UU27= solo il civ. 2
===civ.1
: demolito nell’ apr.1959
===civ
2 villa coltiva di modeste proporzioni, ma segnalata nella planimetria del
Vinzoni, compresa nella proprietà Imperiale, all’altezza della peschiera del
parco di villa Scassi.
Nel
Pagano/40 non vi sono segnalati né civici neri né rossi.
DEDICATA al pittore
sampierdarenese, nato il 4 giu.1879 da Antonio Martino (a sua volta figlio di GB Derchi e
Maria Perasso, fu per 40 anni capo meccanico dell’Ansaldo, decorato con “Stella
del Lavoro” e meritevole per serietà professionale di essere personalmente
presentato a Mussolini quando come capo del governo venne a visitare Genova. Un
suo fratello fu garibaldino) e da
Eleonora Palazzo, in via Cristoforo Colombo 85. Ebbe due sorelle, Luigia e
Maria. Iniziò a frequentare le elementari e poi l’istituto tecnico a Palazzo
del Monastero.
Quattordicenne (nov.1892) lo iscrissero ai corsi serali dell’Accademia
Ligustica delle Belle Arti’ divenendo allievo di C.Perosio pittore di paesaggi
e miniature. La sua frequenza appare irregolare probabilmente perché doveva
lavorare per consentirsi di proseguire gli studi; però conseguendo ogni anno
menzioni onorevoli, riuscendo ad esternare la sua vocazione artistica, specie
pittorica (nell’anno scolastico 1893-4 ebbe una ‘menzione onorevole’ di terza
classe; l’anno dopo –l’ultimo di frequenza- di prima classe nel disegno
geometrico e di terza nel disegno a mano libera.
Lavorò per un breve periodo all’Ansaldo come disegnatore meccanico (godendo
stima ed apprezzamenti; ma lasciò l’occupazione per motivi di salute,
presumibilmente tubercolosi).
Preferì proseguire come autodidatta interpretando a modo suo le crose e la
campagna sopra la città; e –per vivere- negli anni 1901-4, accompagnò come
aiutante, a pitturare caffè e teatri nonché chiese e ville, i bergamaschi
decoratori Fermo Taragli (operoso
in chiese e ville del genovesato e bergamasco ove in quel periodo fervevano
lavori di decorazione; tra essi la commessa del conte Vimercate Sozzi per il
quale il Nostro adornò assieme ad altri artisti alcune stanze della villa posta
in santa Lucia Vecchia; e così pure in una chiesa di Bergamo; più importante
era poter essere all’aperto, ma d’inverno faceva troppo freddo per lui) ed Achille Filippini Fantoni (sua la volta decoratore dei portici
di via XX Settembre, di teatri e chiese. Morì cadendo da impalcatura nel
teatro Paganini).
In quegli anni appare un frequentatore del caffè Centro e Roma di piazza
Vittorio Veneto, animato dal critico d’arte Lucifero Bagnara; e frequenti i contatti
con i ‘grigi’ (sopratutti
E.Rayper) e con i ‘macchiaioli’(tramite A.Varni legato all’ambiente
fiorentino di N.Barabino): così Eugenio
Olivari, Ercole Vallebona, LuigiAdolfo Bertorello e DanteMosè Conte. Invece si
sentiva denigrato e non apprezzato dai più quotati Angelo Vernazza e C Orgero.
Nel 1905, risulta abitare in via del Campasso (allora dapprima via nuova del
Campasso, poi via Giordano Bruno, al 20).
Nel 1911 gli fu commissionato - dal comune di San Pier d’Arena - il lavoro di
restauro di un affresco in villa Lomellini-Boccardo, (in via Cantore 39 (vedi): “il ratto di Elena” di Luca Cambiaso); l’operazione di ‘strappo’, assai complicata e delicata per la
posizione e le condizioni del materiale, fu completata alla perfezione con
grande soddisfazione degli amministratori comunali e sotto il vigile sguardo di
un “garsonetto” d’eccezione, GB Bassano (detto Maestro Ave, scultore e pittore, divenne accademico
di merito della Ligustica). L’affresco fu poi restaurato e
trasferito -scrivono- dapprima a villa Scassi.
Probabilmente già minato dal male, dovette limitare le
uscite alla zona di residenza: iniziò a rifrequentare villa Scassi ed il suo
parco con assiduità, divenendo essa un soggetto frequente e dominante sia nei
disegni che nelle tele, lasciandoci pertanto una sostanziale testimonianza dei
giardini all’epoca. Francesca scrive: «E sulla tela fissa anche
l’aristocratica umiltà delle ville vicino casa, dei giardini dalle piante
conosciute e comuni, dei volti aspri e fieri della gente di Sampierdarena».
Comunque non mancò di riprendere ampiamente sia ritratti che paesaggi di
colline e giardini liguri, nonché -con corretto stile floreale- decorò le
pareti del caffè Roma, in piazza Vittorio Veneto.
Suoi dipinti sono riscontrabili nelle varie quadrerie private (alcune
arricchite con “prelievi” da collezioni non opportunamente protette come
sembrerebbe sia stata quella dell’Ospedale (si legge sui libri che nel nosocomio si trovano “molti suoi
dipinti”, qualcuno ne contò una ventina; ma alla risultanza in loco se ne
contano molti meno)).
 tomba nel cimitero della Castagna
tomba nel cimitero della Castagna
Morì trentatreenne, il 22 feb.1912, dopo una vita breve, ma intensa di
produzione artistica ed interesse. Sempre Francesca interpreta il momento «in
una fredda sera di febbraio Derchi – stanchi i polmoni di rincorrere
faticosamente l’aria – si mise a letto, ad ascoltare la musica che le dita del
vento suonavano con le foglie, con le inferriate, con le statue, con gli archi;
temi da lui tante volte dipinti, sollecitato da quell’amore che è uno dei
segreti dell’arte. Si permise un sorriso un pò sgualcito, e così si addormentò,
senza paura o mistero, in un ovattato scalpiccio di ricordi».
La sua valutazione, come spesso accade nei pittori, avvenne postuma e tardiva:
una accurata retrospettiva iniziò solo nel 1957, con mostra di 68 opere alla
Galleria Genova, quando già la città lo aveva ricordato dedicandogli la strada
ed una copertina della rivista ufficiale del Comune.
Altre
presenze in esposizioni risultano nel 1958-9, 1961-5. Una mostra fu
patrocinata dalla Camera del Commercio di Genova nel 1967 e disposta nel
palazzo comunale della delegazione (ordinata da Vitaliano Rocchiero, ed
intitolata “ i sampierdarenesi”): questa sancì definitivamente le spiccate qualità
artistiche, inserendolo autorevolmente nella storia dell’arte locale
(cataloghi, enciclopedie e testi d’arte pittorica). Altre 2 presenze nel 1968,
fino alla mostra dell’ambito barabiniano, che avvenne nel 1976 nei locali
dell’Universale G.Mazzini.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica
-AA.VV-Ambiti barabiniano e
novecentesco-mostra-1976-pag.21
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.401---ed./02-pag.439
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-pag.124
-Bruno
GF.-La pittura in Liguria dal 1850-Stringa.1982-pag.67.442
-Francesca
R.-Vite immaginarie-DeFerrari.1997-pag.55
-Galotti
F-Pittura e scultura d’oggi in Liguria-EAR.1970-pag 36 +
-Gazzettino Sampierdarenese-
8/85.10 + 3/95.2
-Genova Rivista municipale-
3/38.26 + 5/67.Copertina.48 +
-Pagano/ 1940-pag. 274
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985.pag.584
-Piastra W&C.-Dizionario
biografico dei Liguri-Brigati.1992-vol.V-p.524
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.23.35
-Praga
C.-Andar per creuse a Genova-Sagep.1997-pag.93
-Rocchiero
V.-Derchi GB e “villa la Bellezza”-Fassicomo/1987-pag.34.35.
DIAVOLO crosina del
Diavolo
Il
nome compare solo in una cartina redatta “a complemento di progetto di case
operaie, al Campasso”, stilata nel periodo 1915-30.
Non
compare in alcun altro testo antecedente né come annotazione né ovviamente in
senso ufficiale.
La
crosa su quella carta è posta sul retro, a levante delle case popolari da erigere
in via Pellegrini. Iniziava nella piazzetta che c’è retro-laterale della
chiesa; ma non è completa di dove arriva verso monte.
Comunque
nella suddetta piazzetta, esiste un cancello (a lato di quello in uso per
entrare nei giardini di recente costruzione e che salgono sino a via Baden
Powell): bloccato, perennemente chiuso ed arrugginito, riaggiustato ma non
rimosso negli anni 2000, limita inutilmente una riviera, sul ciglio di un
muraglione che delimita le case, e su cui potrebbe esserci stato un sentiero .
A
voce, viene ricordato che effettivamente il sentiero c’era e portava ad una
villa, bella, ora scomparsa, detta popolarmente “u cason”; fu demolita per
costruire i piloni dell’autostrada. Viene ricordata che era in bella posizione,
e riccamente affrescata sui soffitti.
A
Genova esiste una omonima, ed il nome viene ascritto al fatto che era
particolarmente deserta
Negli
anni 1995-2000 il sentiero era stato riattivato da extracomunitari, che avevano
riaperto la via a qualche casa soprastante, abbandonata.
BIBLIOGRAFIA
-Balletti-Giontoni-Una
città tra due guerre-DeFerrari.1990-pag.152
-Dolcino
M.-I misteri di Genova-NEG.2002-pag.105
-Poleggi
E.&F.-Descrizione della città di Ge. da...-Sagep.1969-pag.293
XVIII
NOVEMBRE
Via Diciotto Novembre
Fu dato questo nome in
ricordo della data delle sanzioni economiche imposte nel 1935 all’
Italia dalla Società delle Nazioni (consesso di 52 Nazioni, con sede a
Ginevra), su irrigidimento inglese volto a stornarci dall’impresa coloniale,
in seguito all’occupazione italiana dell’ Abissinia. Furono interpretate dal
governo di Mussolini da affrontare con fierezza e come un vanto di fronte ad un
torto subìto. La municipalità fascista inventò la partecipazione popolare
dedicando la giornata alla donazione della fede nuziale in cambio di una
similare in minerale povero; ‘oro alla Patria’ fa chiamata la giornata a
sostegno dell’economia nazionale; e gli alti gerarchi furono i primi a dare
l’esempio anche se poi non si sa bene dove finì tutto quel prezioso minerale
raccolto.
Era
successo che, in seguito all’aggravarsi della situazione di frontiera tra la
Somalia italiana (il 5 dic.1934 un migliaio di abissini attaccava il presidio
di 70 somali ad Ual Ual; e lo stesso successe il 29 genn.1935 ad Afdub) e
l’Etiopia (Abissinia è un termine improprio perché è una parte della nazione).
Con questi incidenti presi a pretesto, il governo italiano aveva deciso di
inviare uomini e materiali in Africa Orientale, dando inizio il 3 ottobre alla
campagna coloniale di conquista dell’ Etiopia stessa.
Il
gen. Rodolfo Graziani fu nominato governatore della Somalia: il 3 ott.1935
varcò il confine (zona chiamata Mareb), ed avanzò nel cuore dell’Etiopia,
spezzando le resistenze dell’armata abissina ed entrando dopo aspre battaglie
ad Addis Abeba il 5 maggio; l’ 8 maggio le ultime vittorie completarono il
dominio italiano, concedendo al re anche il titolo di imperatore d’Etiopia.
Dal
Pagano/1940 si rileva che la titolazione fu data all’attuale via T.Molteni,
quando andava da via dell’Industria a via N.Barabino; mentre ora unisce via
S.Dondero con via San Pier d’Arena. In questa data (Pagano/40) sono riportati
solo civici neri = tutti di privati o professionisti o rappresenanti di ditte.
Di rilievo al 3/18 la s.a. calderai Ramai.
Fu
modificata e dedicata al partigiano, con delibera della giunta comunale il 14
mar.1946.
Tutta
l’operazione fu resa vana dallo scoppiare della seconda guerra mondiale nel
1940: l’Etiopia era troppo lontana, troppo isolata e circondata dai domìni
inglesi già meglio organizzati. Il Duca d’Aosta, nominato vicerè, resistette
sino al finire delle munizioni e viveri, ma dovette arrendersi ad Amba Alagi -
seppur con l’onore delle armi - per andare a morire in prigionia a Nairobi (Kenia).
L’ultimo contingente italiano resistette sino al 27 nov.1941.
Alla
fine della guerra, l’imperatore Hailè Sellasiè, aiutato dagli inglesi, poté
tornare a ripristinare la precedente monarchia; e nel 1950 l’Assemblea dell’
ONU, sancì questo ripristino, concedendo al Negus anche la sovranità sull’
Eritrea, come unità federata.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Pagano
1940- pag.274
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1202
-Stradario
del Comune di Genova edito 1953-pag.69
DIECI via Dieci
Giugno
È
stata la titolazione dell’attuale via di Francia dal 1943 a 1945
In
origine, dal 19.3.28 appena finito il tracciato, le fu dato il nome della terra
dei cugini d’oltralpe.
Nel
periodo di governo fascista con delibera del podestà il 31 lug.1940, la
titolazione alla Francia fu sostituito con dedica al nome del fratello del
Duce, Arnaldo Mussolini.
Dopo
l’ 8 sett.1943 ovviamente la titolazione fu ridecisa, eliminando la precedente e dando il nome a ricordo della data
fatidica.
Il
nome originario, fu poi ripristinato con delibera del sindaco il 4 mag.1945.
DEDICA:
espressa per onorare la data del giorno dell’anno 1940 in cui l’Italia,
rompendo gli indugi, dichiarò guerra alla Francia ed all’ Inghilterra,
schierandosi a fianco della Germania, nel momento in cui quest’ultima prevaleva
su tutti i fronti di guerra.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica
-Enciclopedia Sonzogno
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.736 --Stradario del Comune di Genova
edito 1953-pag.79
DISPERATI
vico
Disperati
(DISPERSI
vico Dispersi )
 da Vinzoni, 1757 in fucsia via
NDaste; in giallo via A.Scaniglia; in celeste via CRolando.
da Vinzoni, 1757 in fucsia via
NDaste; in giallo via A.Scaniglia; in celeste via CRolando.
Il
nome è citato nel libro ‘Storia di Sampierdarena” di Tuvo, a delimitazione dei
Quartieri dell’Eguaglianza e della Fratellanza, secondo un decreto del 24 lug.1798
da parte del nuovo governo filofrancese della Repubblica Ligure, mirante a
ristabilire l’ordine pubblico e la tranquillità in quegli anni di grave
confusione politica. Così fu decisa la divisione del borgo in tre quartieri,
genericamente con eguale proporzione di abitanti, dando ad essi nomi nuovi, ma
usando limiti territoriali vecchi e preesistenti: l’ Eguaglianza era dalla via
della Pietra al vico dei Buoi (a mare) e vico dei Disperati (a monte); a levante era il secondo
quartiere della Fratellanza, sino a vico sant’Antonino (a mare; si sottolinea
la confusione tra s.Antonio e s.Antonino)-vico san Barborino (a monte); il
terzo, posto all’estremo levante dalla Coscia , era il quartiere della
Libertà.
Alla fine dell’anno 1801, in epoca di dovuta convivenza con i soldati
francesi, il concittadino Gaetano Bignone, per motivi non conosciuti chiuse
arbitrariamente l’inizio della crosa, ponendovi un ‘rastello’ (cancello in ferro o in legno) che la municipalità gli impose di rimuovere essendo
essa di spettanza pubblica.”Se l’ordine non verrà eseguito si farà eseguire
l’atterramento”.
Il
vicolo è confermato in un elenco delle strade esistenti il 29 maggio 1817
(firmato dal neosindaco Mongiardino Antonio): “inizia dalla strada provinciale,
finisce nell’ultima villa vicino a Belvedere” (ovvero l’attuale via GB Monti; e la villa –ora
abbattuta- era dove attualmente è il civ. 20).
In una ‘statistica dei cholerosi, morti a domicilio nel 1867’, stilato
ad uso del Comune di San Pier d’Arena, si annovera un caso, avvenuto nella via,
quindi ufficialmente riconosciuta.
Anche in una lettera, con cui la Curia Vescovile scrisse la sua approvazione
all’erezione della nuova parrocchia di san Gaetano –che sino ad allora era stata prima
chiesa privata, poi sconsacrata ed infine acquistata da don Bosco, e per i
suoi fini riattivata, abbellita, resa funzionale e pubblica ma non ancora con
l’incarico specifico parrocchiale-: in
data 20 mar.1884 , si leggono i confini; ed oltre a strade conosciute,
viene citato il “Vico Disperati“.
Una cartina del 1899 evidenzia la stradina “vico dei Disperati”, in
corrispondenza delle attuali via C.Dattilo (che poi fu allargata)-E.Rayper fino a via G.B.Monti. Iniziante dunque in via Mercato (poi
-già nell’anno 1900 da via A.Saffi), subito dietro la villa Carpaneto, con
all’angolo la casa Ferrando (citata anche nel regio decreto del 22 magg.1857 con cui re Vittorio
Emanuele II accettò la delibera comunale di San Pier d’Arena per la
nomenclatura delle strade, in base a cui ‘via del Mercato’ dalla crosa della
Cella arrivava fino ’alla casa Ferrando all’incrocio con via san Cristoforo’) e, per tutto il percorso, la proprietà
Rebora-Cristofani a nord, ed orti a levante.
Arrivava
in ripida diritta ascesa, e con un tornante alla fine, a levante della villa
Lomellini Bocci (vedi
via GB Monti, 20; per pura ipotesi, forse trasformata in lazzaretto). Forse finiva a quel livello ma da carte posteriori
sembrerebbe che continuasse in salita -anche dopo il taglio effettuato dalla
neonata via GBMonti- proseguendo in scaliata Pisacane (poi Filangieri) fino al
tornante superiore della stessa via GB.Monti.
Lo
stesso autore Tuvo, sul Gazzettino S., dà interpretazione del nome risalente
forse ad una epidemia di colera durata due anni, e durante la quale la
popolazione ebbe un calo del 60% con ovvia disperazione dei salvati che avevano
cercato rifugio a monte del borgo nella speranza di essere in zona isolata ed
al riparo dal cataclisma (se
l’ipotesi dell’epidemia è giusta quale causa del nome, segnaliamo che la più
grande strage o il più luttuoso avvenimento che abbia mai patito Genova in
tutta la sua storia e, durata un anno, fu senz’altro l’epidemia di peste del
1656-7, descritta a san Gaetano e che ridusse la popolazione locale del
75%: non colera, ma peste; quella che nel genovesato vide rifulgere l’opera
assistenziale del sestrese padre Antero; drammaticamente uguale a quella
‘manzoniana’ che però avvenne a Milano nel 1630, quando Genova allora ne fu
preservata; dentro le mura di Genova, da 70mila anime ne erano rimaste 15mila
(più alcune migliaia che erano riuscite a fuggire).
Da fonti storiche si sa che epidemie in Genova –di peste o
colera o tifo- , da dopo l’anno mille e di gravi ne erano già venute sette:
1348, 1383, 1481, 1493, 1528, 1579, 1580, ma tutte meno aggressive rispetto
quella del 1656.
Gli
infettati, tipicamente erano dei disperati. Venivano innanzi tutto isolati in
un lazzaretto -alla Fiumara (in genere le
fosse comuni venivano scavate ai margini del mare, che col vento ‘depurava’ la
zona) o al Campasso (ove è adesso il mercato dei polli), o ospitati nelle chiese (vedi san Gaetano in via Rolando,
dove anche il 90% dei soccorritori, morì);
senza assistenza specifica, e nella speranza –scarsa- di sopravvivere, non solo
alla malattia ma anche a tutte le complicazioni allora sconosciute legate
all’alimentazione, all’acqua, all’igiene, alla robustezza fisica, ecc.).
Tutto
lascia quindi pensare che mentre vico dei Disperati ha una storicità, non
altrettanto sia per “vico dei Dispersi”; o fu un lapsus tipografico, o
calligrafico di quei tempi (le scritture a mano non sempre sono facilmente
leggibili; e se anch’esso sempre riferito alla peste, fu dedicato a qualche imprecisato
episodio di salvati di una famiglia distrutta o separatasi in conseguenza
dell’evento.
Nel
dic.1900 fu deciso dare alla strada ufficialmente la dedica a “via
Pastrengo” .
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-A.sconosciuto-Dattiloscritto
parrocchia s.Gaetano-Bosco-vol.I.pag.85
-Gazzettino
Sampierdarenase- 9/87.18 + 2/91.3 + 7/93.4
-Romano
da Calice-La grande peste-Bullesi.1992-
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.52
DOGANA
piazza
della Dogana
TARGA:
non c’è più
 da Vinzoni, 1757. Il palazzo e la piazza del Monastero con la Marina,
dove delimitata dal Baraccone del sale, sorgerà la piazza.. Dall’angolo con la piazza del Monastero, molto malamente si leggono i
proprietari di alcune case: verso ponente sino alla crosa dei Buoi= ecc.mo
principe Centurione; sig.r Simone Morta; Francesco Rumero; (nella parte più
larga) sig. Batti(sta) R...i; sig.r Daniri Grongivia; sig. Sebastiano Galiano;
sig.ri Giacomo Fras...; ecc.mo Pri.pe Centurione.
da Vinzoni, 1757. Il palazzo e la piazza del Monastero con la Marina,
dove delimitata dal Baraccone del sale, sorgerà la piazza.. Dall’angolo con la piazza del Monastero, molto malamente si leggono i
proprietari di alcune case: verso ponente sino alla crosa dei Buoi= ecc.mo
principe Centurione; sig.r Simone Morta; Francesco Rumero; (nella parte più
larga) sig. Batti(sta) R...i; sig.r Daniri Grongivia; sig. Sebastiano Galiano;
sig.ri Giacomo Fras...; ecc.mo Pri.pe Centurione.
QUARTIERE
ANTICO: Canto
 da Pagano/1961
da Pagano/1961
N° IMMATRICOLAZIONE:
2779 CATEGORIA 3
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 22700
UNITÀ URBANISTICA: 26
- SAMPIERDARENA
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: NS della
Cella
STORIA: Nella carta
del Vinzoni, si vede che era tutta spiaggia, senza alcuna costruzione se non - a
ponente, il Castello, o palazzo del Municipio- Con la costruzione del
Baraccone del Sale e dei palazzi ad est di esso, si formò un primo spiazzo anonimo
che solo ai primi del 1900 acquisì un nome molto probabilemnte legato agli
uffici specifici.
Quindi,
la piazza c’era già all’inizio del secolo e citata dal Novella, quando da
quella parte a mare della strada, le case attuali ancora non erano state costruite
tutte, come ora . Siamo in pieno quartiere del Canto.
Unica, una guida di san Pier d’Arena del 1914 che testimonia che per
andarci, da piazza VVeneto (allora p.zza F.Ferrer),
occorreva seguire l’itinerario “da via N.Barabino (via Carzino), voltare a sinistra in via Cristoforo Colonbo (via San Pier d’Arena), 2ª a destra” (oggi corrisponderebbe allo stacco tra il Comune ed il
palazzo del Sale). Non ho trovato altre
fonti che attestassero dove altrimenti fosse esistito una dogana sulla
spiaggia: si presume indichi quindi direttamente la parte a ponente del Palazzo
del Sale, chiamata anche “Deposito delle Gabelle”.
Questa localizzazione, potrebbe indurre a limitare l’esistenza dell’ufficio,
solo al traffico del sale, seppur importantissimo ovviamente. Ma poiché il termine “dogana”
significa un punto organizzato per la riscossione di tributi per merce che
entra o esce da uno “stato” ( mentre si chiama “dazio” lo stesso
tributo, ma posto ai limiti di zone interne come era il servizio sul ponte di
Cornigliano oppure in via Campi al limite con Rivarolo ed ai piedi della
collina di san Benigno), offre
la possibilità di pensare che dentro alle possenti mura del baraccone si
ospitassero degli uffici ad ampio spettro merceologico; e poiché non certo a
San Pier d’Arena potevano essere i confini della Repubblica Genovese a parte
quelli provenienti dal mare, si va a chiarire che sulla nostra spiaggia anche
senza pontili particolari, arrivava merce che veniva imbarcata o sbarcata
direttamente dai navigli, senza usufruire dei servizi del grande porto del
capoluogo.
Si legge che il nostro borgo (e poi città), anche senza pontili, aveva un
movimento navi piuttosto rilevante ed assolutamente indipendente da Genova. In una lettera del dic.1761
viene fatta una denuncia da parte dei “famuli” ossia “Cavalleri delle Gabelle
della Casa serenissima di san Giorgio”, perché un bastimento di Loano, dopo
aver sbarcato dell’olio da consegnarsi al sig. Cambiaggio Stefano, poi avevano
raccolto sabbia per la zavorra in luogo proibito.
Nel
giugno 1838, il Consiglio Comunale decide costruire dei baracconi per le
regie Dogane, con restrizione dei punti di imbarco e sbarco dalla spiaggia.
Ancora negli anni a
metà secolo (1850, circa), gli armatori cittadini avevano sbarcato
ben 542mila tonnellate di sale da Cagliari; e sempre direttamente sulla
spiaggia anche 7.500 tonnellate di foglie di tabacco da lavorare nell’appena
costruita Manifattura Tabacchi (di via E.Degola);
sappiamo che altri comandanti di bastimenti da cabotaggio facevano lucroso
traffico con i porti del basso Mediterraneo; e di altri che muniti di grosse
scune o piccoli brigantini andavano sulle coste di Tripoli ad acquistare
partite di sparto indirizzate alla Carena e Torre
nata in quegli anni.
Con moderno macchinario costruiva cavi, dai più sottili ai più grossi, per il
fabbisogno di qualsiasi bastimento anche attrezzato per navigazioni
transoceaniche. Posta alla Marina, dove forse poteva operare direttamente lo
sbarco del materiale suo necessario, nel 1847 le nacque adiacente
l’officina metallurgica del Taylor e Prandi e con loro ebbe delle controversie
per l’occupazione dell’arenile (si legge che Taylor –malgrado avesse ottenuto
il finanziamento statale per aprire una officina solo ad uso costruzione e
riparazione locomotive e quindi senza utilità della marina- era riuscito ad
assicurarsi (e quindi aveva idee espansionistiche in direzione navale) l’uso
della spiaggia antistante il suo Meccanico, grazie all’intervento dell’Azienda
Generale delle Strade Ferrate che avevano dato l’ordine all’Intendente Generale
di non rinnovare alla corderia la concessione di quel tratto di litorale
necessario per il maggior sviluppo dello stabilimento metallurgico eretto in
quella località). La diatriba si risolse quando l’Ansaldo ricorrendo
all’esproprio per pubblica utilità, obbligò la Carena a spostare tutta
l’azienda al Campasso. L’edificio della Carena fu demolito nel 1916 dalla ditta
Valverti & Cerruti (con l’intenzione di costruire uno stabilimento per
trattamento termico dei proiettili prodotti dal vicino proiettificio, ma finita
la guerra, non fu eretto ed il lotto fu usato come balipedio).
Vi sbarcavano anche semi oleosi da raffinare, ed olio ( la città era il vero deposito in
materia, di tutto il commercio genovese . Sempre a metà 1800 circa, affluivano
in zona più di 61mila barili d’olio, dei quali più della metà veniva
riesportato; e solo per questa merce, la dogana introitava più di 1000 franchi
al giorno); e materie prime per i 17
saponifici esistenti (che
richiedevano 20 mila barili di olio e 578 tonnellate di soda, per produrre 2000
tonnellate di sapone); ed infine anche
materiale per i cantieri navali (sicuramente già esistenti dal 1248 con traccia scritta di un
certo Guglielmo di Coronata; sino all’ultimo, più noto fu tal Francesco
Casanova (vedi C45), i cui eredi però furono tosto obbligati a trasferirsi a
Sestri ).
Nel 1922 DeLandolina scrive «vi sorgono gli
uffici doganali»; il suo testo è pieno di errori, ma qui sembra decisamente
sicuro della loro presenza.
Nel 1933 nella piazza al civ. 2 vengono
descritti esserci: il ‘Deposito generi di Monopolio (sale)’ ed un ‘Ufficio
compartimentale per i servizi commerciali e fiscali’, ambedue gestiti dalla
regia G.di Finanza.
Era in questo slargo, che si esibivano i comici-clown Fagiolino e Padella, in
concorrenza reciproca nel tentare di strappare delle risate negli anni del
dopoguerra (un piccolo palco, due baracche qualche panca e sedie sparse).
Sempre, nel 1940 andava da via N.Barabino al mare, ove al civ.2 erano i
Monopoli di Stato, e l’’uff. compart. serv. comm. e fiscali Monopoli Stato’.
STRUTTURA e CIVICI:
2007-
civici dispari da 1 a 3; pari da 2 a 4
La
piccola piazza è posta tra via San Pier d’Arena e lungomare G.Canepa, a ponente
del Palazzo del Sale.
Nell’anno 1900 fu ufficialmente proposto il nome di “piazza della Dogana” a
quella che già veniva chiamata “piazzetta detta della Dogana”, posizionata a
ponente del Palazzo del sale. Evidentemente fu accettata apparendo così chiamata
nel primo elenco delle vie e piazze pubblicato dal Comune nel 1910, nel quale è
genericamente posta da ‘via C.Colombo al mare’ e con un solo civico, il 2.
Nell’anno 1927 appare inclusa nelle strade della Grande Genova, senza ‘della’,
classificata di 5a categoria.
Il Pagano 1950 segnala nella piazza al civ. 2 la presenza del ‘Monopolio di
stato Cartine e Tubetti per sigarette’.
Al fianco ovest del ‘Baraccone del Sale’ ancora negli anni 1990 era attaccata
una piccola appendice-casetta che improvvisamente crollò causando anche una
vittima: venne così rasa al suolo ed eliminata, lasciando il segno sul muro
esterno; forse con essa, anche con la targa della piazza, visto che non c’è
più.
L’unico civico nero, il 2, fu soppresso nel 1974, murando la porta. Ed è ancora
a questo numero che fa riferimento la Soprintendenza per i beni architettonici
per vincolare e tutelare lo stabile dal 1984 (erroneamente chiamandolo ‘palazzo
manifattura Tabacchi ex depos.Sale’).
La società bocciofila che si apre nel piazzale, ancora nel 2004 reclamizza la
sua sede in ‘piazza della Dogana’.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica
-Cevini-Torre—Architettura
e industria—Sagep.1994—pag.125
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.40
-Gazzettino
S. : 4/98.4 +
-Gazzo
E.-I 100 anni dell’Ansaldo-Ansaldo.1953-pag.39
-Lamponi
M. –Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 63
-Novella
P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.17
-Pagano/1933-pag.246--/40-pag.276--/50–pag.514---/1961-pag.565
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.50
-Tuttocittà
cartina
-Tuvo
Campagnol.-Storia di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.38
-non c’è = nella cartina di Pagano/61 (quadro 120) + Annuario
archidioc./94.402
DONDERO via
Stefano Dondero
TARGA: via – Stefano
Dondero – caduto per la Libertà – 1924-8/4/1944
via - Stefano Dondero – caduto per la Libertà – 1924-8.4.1944

 angolo via A.Pacinotti
angolo via A.Pacinotti
 fare panoramica e dire
dov’è
fare panoramica e dire
dov’è
QUARTIERE ANTICO:
Coscia
 da Vinzoni, 1757. In giallo la
creusa dei Buoi; in celeste ipotetica via Pacinotti; fucsia via s.Cristoforo
(Scaniglia-Degola). In verde ipotetico tracciato di via SDondero
da Vinzoni, 1757. In giallo la
creusa dei Buoi; in celeste ipotetica via Pacinotti; fucsia via s.Cristoforo
(Scaniglia-Degola). In verde ipotetico tracciato di via SDondero
N° IMMATRICOLAZIONE:
2771

da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 22920
UNITÀ URBANISTICA: 26
– SAMPIERDARENA
 da Google Eatrh, 2007. In giallo,
piazza VVeneto; celeste via APacinotti.
da Google Eatrh, 2007. In giallo,
piazza VVeneto; celeste via APacinotti.
CAP: 16151
PARROCCHIA: NS sM.
della Cella
STRUTTURA: senso
unico veicolare, da piazza Vittorio Veneto a via A.Pacinotti. Prima della
ristrutturazione della zona, del 1935, a mare era fiancheggiata da vecchi
edifici (civv. 2,4,6) dei quali il primo era il palazzo dell’orologio seguito
dalle vie Imbriani e Balduino che delimitavano la piazza Tubino.
STORIA: non ha storia
particolare se non il riconoscimento di essere nata, come via G.Buranello,
costeggiando il muraglione della ferrovia, e di portarsi da piazza V.Veneto in
zona Crociera.
Nell’ott.1895, l’UITE acquisendo i beni della Compagnia
Generale Francese, si impegnò di collocare i binari anche nella “nuova strada”
(quindi allora senza un nome preciso ancora).
Ma in quegli anni di tardo 1800 era già popolarmente intestata allo statista
piemontese: infatti quando all’inizio del secolo 1900 fu ufficializzato il nome
di via Cavour, si precisò confermare la ‘strada cosiddetta Cavour’, da piazza
Omnibus a via Garibaldi. Questo avvenne senza dubbio nell’ondata di
manifestazioni inneggianti al Risorgimento ed in ringraziamento della politica
dello statista favorevole agli impianti industriali (che il buon Dio lo crogioli nelle
fiamme dell’inferno: sicuramente a lui poco importava di Genova e nulla di San
Pier d’Arena; quanto piuttosto cosa e quanto avrebbero potuto fornire -dalle
locomotive, alle navi , alle armi- al Piemonte impegnato si nella strada verso
l’Unità d’ Italia, ma anche ricco di ambizioni espansionistiche e contenti di
aver finalmente –dopo secoli di inutili tentativi- ‘conquistato il mare’ in
spregio a ‘quella vil razza dannata’ dei genovesi).
Il nome, essendo già presente a Genova nel centro, fu cambiato il 19 ago.1935
con via dell’Industria; stigmatizzando il pieno accordo e volontà di tutti, di
continuare a sfruttare la zona ovest del borgo, a fabbriche (si scrive che Genova ha sempre
goduto e ritenuto privilegio possedere l’industria pesante. Nel conservare,
ampliare e sostenere con i denti queste, fino alla loro consumazione
determinata a livello internazionale, lasciandoci alla fine con un pugno di mosche
in mano (pensionati a 50 anni, disoccupati, non peso politico ‘a Roma’ troppo
spesso unico committente del prodotto, declassamento culturale per
emarginazione dei piccoli imprenditori, ecc.)…non si può non
leggervi un ben deciso disegno di pochi ma potenti imprenditori (spesso neanche
genovesi) e politico mirato alla primaria fornitura di voti, e quindi di
potere, anziché preoccuparsi del territorio e della sua produttività. Troppo
spesso l’Ansaldo trovava ossigeno solo nelle produzioni belliche ordinate dal
Ministero della ’difesa militare’ (dalla Crimea al Risorgimento, da Tripoli
alle colonie, dalle 2 guerre mondiali…alla chiusura). Sull’altro piatto, in
tutto il secolo del 1900, troppe le grandi e piccole società emarginate e
costrette a fuggire da Genova, soprattutto per ragioni di spazio, servizi e
tasse soffocanti e non promozionali.
Questo titolo, rimase fin dopo l’ultimo evento bellico, quando
l’amministrazione comunale decise il 14 mar.1946 di cambiarlo a favore del
partigiano, e passare la strada dalla 3ª categoria, alla 2ª.
Pochi gli insediamenti comm-artigianali: sul
marciapiede a mare, sotto i portici c’è Buffetti ed ex saloni di aste e di auto
ora dimessi ed abbandonati; altri pochi negozi si aprono vicini al mercato (un
macellaio, un caffè).
Nella strada sono state girate alcune scene del film “Il
giorno dello sciacallo”.
CIVICI
2007-
neri = da 2 a 8 (manca 6)
rossi = da 1 a 65
(aggiungi 41B); e da 2 a 34 (aggiungi 34ABC)
===civv.
dispari rosso: sul marciapiede della ferrovia, inizia e -finisce dove era il
giornalaio (dal 2007 trasferito di fronte)- una serie di baracchette di
micronegozi per lo più di abbigliamento, bijotteria, cartoleria e similari;
appoggiate al muraglione: nacquero in attesa di collocare il mercato, e da
provvisorie divennero definitive quando dentro l’area del mercato non c’era
posto per inserirle al coperto e forse anche per diversa destinazione d’uso del
mercato stesso (alimentari). Per fare questo, tutte le piante che decoravano il
marciapiede furono nottetempo segate per permettere erigere la struttura in
cemento.
Nel
tratto finale dentro i fornici ferroviari netta prevalenza di officine
meccaniche.
===C’erano
una trattoria all’11r Nel Pagano/1950 la trattoria
era di Ghio E.;--- una autorimessa
‘Vittoria’ al civ.12; ---la sede locale dell’ACI
al civ.18r; ---la banca di Sicilia al 24r; ---un droghiere al 30r;
---seguito da un pizzicagnolo al 34r. (Lamponi
ne cita altri, ma non dice di quale epoca; essendo tutte figure ed attività
tendenzialmente fugaci).
Negli anni del 1970, sfruttando vani preesistenti aperti sotto la
stazione ferrovia, fu aperto l’accesso al sottopasso che conduce direttamente
ai binari e sbucare anche in piazza N.Montano.
===civv.
2 e 4 fu costruito nel 1936-7, presumo riferendomi alla descritta
sulla rivista Genova “casa tra le vie dell’Industria e Nicolò Barbino, progetto
della SA Immobiliare Aedes Sampierdarenese, ing. Carlo Montano”. Negli anni
1960 al 2/12 abitava il pittore Canepa Mario Antonio (nato a SPd’Arena il 22 agosto 1895,
si spense il 6 marzo 1967; per le sue innate doti artistiche ebbe da giovane il
primo premio di viaggio di istruzione rilasciato dalle Belle Arti; partecipò
alla 1° guerra mondiale nel genio; amico del Derchi, dipinse solo quello che lo
commuoveva, fuori dalla speculazione. Le sue opere (ritratti, paesaggi, marine)
furono, coronate da successi, premi nazionali ed internazionali, onori
accademici. Anche decorò grandi navi (Conte Grande, Michelangelo, Angelina
Lauro) e locali (il Giunsella)).
Viene
anche detta casa Lo Faro***(credo fosse questo nome riferito al vecchio palazzo
dell’orologio)
===civ.
8 (’casa, e
sottostante mercato al minuto’)
approvato nel 1951, fu assegnato alla nuova costruzione il 17 sett.1953.
Interessante
e tutt’ora presente il grosso mercato
rionale a cui furono destinati i fondi del pianoterra. Comprende numerosi
‘banchetti’ di generi alimentari (polli, verdure, dolciumi)
===Il civ.10 nasce
e fu costruito contemporaneo al civ. 8; fu però poi trasferito a via D.Salucci
, nel 1959.
===Dall’altezza del voltino che reca in stazione fino a
via Pacinotti: a mare non vi sono entrate; sotto la ferrovia ci sono i civv.
rossi dal 43 al 65,
praticamente adibiti a garage auto (civ.55);
officine (civv.45-63 della Piaggio per riparazione
e tagliando di motocicli); box (57-59-61.65); o chiusi da tempo (con vecchie insegne scritte
di ‘auto’(47), ‘carrozzeria’ (49), o saracinesche sconnesse e raffazzonate (51-53)).
DEDICATA: al giovane
partigiano sampierdarenese chiamato Stea, nato nel Fossato il 4 giu.1924 da
Gigin pescatore e da Giulia. Ebbe tre sorelle.
Avviato
al lavoro senza neanche finire le elementari, divenne ansaldino.
Arruolato (o al fine di sfuggire all’arruolamento forzato messo in atto dalle
forze repubblichine di Salò), disertò e decise di fuggire in montagna aggregandosi
con i partigiani della 3.a brigata Liguria accettando il nomignolo di Mea.
Combatté con valore nella zona delle Capanne di Marcarolo.
Il parroco di Voltaggio, don Pietro Zuccarino, lasciò un tragico diario di
quello che successe nel paese in quei giorni: arrivati in forze nel paese, i
tedeschi occuparono il seminario installando -in una palazzina- un Tribunale
Speciale: nel pomeriggio (7 aprile 1944) già avevano dei prigionieri tra i
quali Stefano; furono interrogati e tenuti nella prigione dei Carabinieri a
Voltaggio, sino a sabato 8; senza un approfondito o particolare processo.
Il giovane Dondero fu fucilato lo stesso giorno 8, era Sabato Santo, assieme
ad altri sette compagni, contro il muro del cimitero del paese: a due a due,
dopo essere stati comunicati dal sacerdote, caddero gridando “morte ai
tedeschi” oppure “viva l’Italia”.
I soldati rimasero a Voltaggio sino all’ 11 aprile, fucilando in quella mattina
altri otto rastrellati; poi, dopo aver incendiato delle cascine, rubato tutti
gli apparecchi radio, cibi e vestiti, se ne andarono.
I familiari seppero della sua sorte, ben quindici giorni dopo.
A lui era dedicato un circolo ricreativo posto dietro l’abbazia in via s.B.d.Fossato
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica
-A.sconosciuto-Storia
del trasporto pubblico a Genova-Sagep.1980-p.157
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.402—ed./02-pag.440
-Ferrero
V.-Viturin, un ragazzo del Fossato-SES.2006-pag. 3
-Gazzettino Sampierdarenese
: 1/73.10
-Gazzo E.-I 100 anni
dell’Ansaldo-Ansaldo.1953-pag.38
-Genova, rivista del
Comune- 3/37.62 + 10/51.31 + 11/51/48 + 1/56.38
-Gimelli G.-Cronache
militari della resistenza-Carige.1985-vol.III-pag.71
-Pagano/1961-pag.190.444
-Poleggi E. &C.-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.33
DONNE
Rotonda Donne Di Teheran


A Teheran (ma in tutto il vasto oriente - con
religione diversa dalla cattolica – specie se esasperate dall’interpretazione
restrittiva - oggi chiamata ‘integralismo talebano’), succedono fatti - probabilmete sempre successi
nella storia del paese, compresi quelli limitrofi e- in antichità anche da noi,
e che ora vengono alla luce mondiale in virtù della telematica.
In occidente, l’evoluzione
dei diritti dell’uomo è stata lenta, ma c’è
stata; in particolare sono considerati fondamentali i concetti di “diritto al
lavoro, alla sicurezza, alla cultura ed all’eguaglianza – e, quest’ultima, senza
discriminazioni di razza, religione, sesso, lingua”.
Questi avvenimenti nel
lontano oriente, da loro giustificati non sulla nostra base (del diritto dell’uomo) ma su quello “divino” del Corano (e quindi insindacabile né
criticabile – anche se poi interpretabile a proprio uso e consumo) provengono sicuramente da pesanti risvolti politici
qualificabili nel “potere” o “dittatura” (ovvero nella capacità insita -in alcuni uomi (il charma, magnetismo, trascinatori
– fino ai capipopolo)
di sapersi proporre come interpreti della massa degli altri; e la religione è
l’arma più semplice per avere la mano pesante sui non consenzienti); ed urtano contro l’educazione ed emancipazione dei
diritti individuali ai quali si ispira l’occidente.
Si sono formati così
movimenti di ribellione a questi fatti giudicati di arretratezza; e le
manifestazioni – di piazza o cortei mirano a sensibilizzare sempre di più sul
tema, la gente agnostica e superficiale. Unico lato negativo di questa
reazione, è che con troppa frequenza ed evidenza viene guidata dagli interessi
politici locali (politicaly no correct): anche noi non abbiamo del tutto
superato le barriere nord.sud-padania-altoadige.sudtirolo. Così, mentre si osteggiano
irruentemente situazioni particolari, se ne ignorano tantissime altre, altrettanto
pesanti (come la pena
di morte -vigente negli Usa, in Cina ed in questi paesi medioorientali- e sia
le stragi che si effettuano in Africa. E ne cito solo una minima parte); si recrimina e ci si mobilita per quelli che
motivano questa lapide ma nessuno si muove per il Tibet, per i Curdi e per
tante altre minoranze violentate.
Ovviamente questa ‘protesta’
crea a sua volta una controreazione di irrigidimento, che –dicono loro- si professa
inflessibile ed a salvaguardia dei principi e della fede religiosa, e non lascia
microaperture di autocritica allegando messaggi ben chiari: non si accettiamo
ingerenze.
|
L' iniziativa genovese (inserita nella ‘settimana
internazionale dei Diritti’ promossa dal Comune) nacque l' 8 marzo 2010 grazie a Mariam Molavi
della comunità iraniana nel capoluogo ligure (duecentocinquanta persone).
Dalla cronaca, dai tam tam
di internet sono così emersi i nomi di Neda (Neda Salehi Agha-Soltan in
persiano: ندا
آقاسلطان, nata a Teheran il 23 gennaio 1983 – morta il 20 giugno 2009. Studentessa di filosofia era in
compagnia del suo insegnante di musica Hamid Panahi partecipando alla protesta
contro l'esito sospetto delle elezioni. Alle ore 19:05, nel viale Kargar,
all'incrocio con via Khosravi e via Salehi, un membro dei Basij, la milizia armata, le
ha sparato uccidendola. La sua morte ebbe subito reazioni internazionali a
causa di un video amatoriale diffuso via Internet che
testimoniò gli ultimi istanti della sua vita. Il suo nome - Neda significa "voce" o "chiamata"
- è velocemente diventato un grido di protesta, scandito dagli oppositori al
governo del presidente Ahmadinejad[, che
riconoscono in Mir Hosein Musavi il reale vincitore delle elezioni
presidenziali, accusando il presidente in carica di brogli. Per questo la
donna è stata definita come la "voce dell'Iran" e "un simbolo
dei manifestanti per la democrazia che stanno attaccando il regime islamico),
e di altre due studentesse, uccise nella capitale da una
sparatoria notturna da miliziani, che colpì nel mucchio del dormitorio
universitario. Nonché della giovane
curda Shirin, impiccata nel maggio scorso dopo un processo a
porte chiuse e il cui corpo non è mai stato riconsegnato alla famiglia; delle tante donne e giornaliste imprigionate; e
di Zeinab, che potrebbe essere impiccata da un giorno all' altro.
|
Alle rimostranze per via
diplomatica, si stanno aprendo correnti di pensiero e di fatto in tutto il
mondo occidentale che hanno scelto questo nome generico “Donne di Teheran” per
indicare tutti i suprusi fatte alle donne per qualsiasi motivo, foss’anche
religioso.
La Giunta genovese, con
sindaco in testa (Marta Vincenzi) ha accettato di collocare una targa a questo
movimento nel marzo 2010, trovando uno spazio ove collocare una statua-totem
che riporta il volto di Neda e una targa.
La statua fu scoperta il 20
luglio 2010, con solenne cerimonia, presenti
tante madri in lutto che,
mostrando centinaia di immagini di giovani vittime, hanno testimoniato il
dolore e l' orgoglio di un paese che non è quello rappresentato dalle
informazioni riportate dai nostri media ma solo il 5% di quella reale. In
giornata è stato anche insignito di laurea ad honorem e cittadinanza,
l’avvocato Shirin Ebadi, che nel 2003 - prima
donna musulmana è stata insignita del Nobel per la pace «Questa targa porta il
nome della libertà» ha detto, ringraziando «e il nome delle donne che negli
ultimi tredici mesi hanno lottato per la libertà iraniana... i loro nomi non
saranno dimenticati. I governi vanno e vengono, i popoli rimangono: e questa
piazza rimane come un legame eterno tra le donne iraniane e quelle genovesi,
italiane ». Promettendo il Comune, che in primavera nell’aiuola rotonda della
Fiumara fioriranno i tulipani rossi, scelti come simbolo della lotta iraniana
per la democrazia, e il sangue versato dai loro martiri.
La targa, è stata
uficialmente inaugurata il 16 dicembre, presso una aiuola circolare in via
Mantovani, all’altezza del Mazda Palace.
Ai nomi su citati,
altrettanto clamore desta da mesi la condanna a morte, emessa nel 2006,
mediante lapidazione della donna iraniana Sakineh
Mohammadi Ashtiani, 43 anni di Tabriz (nord-ovest dell’Iran), accusata di adulterio e
dell’uccisione del marito.
Sakineh
Mohammadi Ashtiani fu condannata per la prima volta il 15 maggio 2006, da un tribunale di Tabriz, per il reato di
"relazione illecita" con due uomini in seguito alla morte del marito.
Fu condannata a ricevere 99 frustate, e la condanna venne eseguita. In
seguito, nel settembre 2006 ricevette una nuova condanna quando un tribunale
penale accusò uno dei due uomini per il coinvolgimento nella morte del marito
di Mohammadi Ashtiani. Per questo venne condannata per concorso in omicidio
mentre ancora sposata, e condannata a morte per lapidazione. Il mondo intero
occidentale e gli stessi stati musulmani più progressisti si sono ribellati a
questa sentenza mettendo in atto manifestazioni popolari, striscioni, appelli
in Internet e sui media, comitati (il più importante
con sede in Germania) specifici contro la pena di morte.
Questa onda
di sdegno, ha indotto il governo iraniano – non senza risentimento per
ingerenza definita ‘politica’ ma in realtà religiosa – a rimandare
l’esecuzione; con alterne decisioni ma con la ‘talebana’ decisione di portare
alla realizzazione la condanna (interpretazione estremista del Corano,
trascurando laddove lui parla di positiva convivenza e rispetto); sino alla
beffa del 10 dicembre 2010 quando si annunciò la liberazione della donna (che
invece era solo stata portata a casa sua perché registrasse – sul luogo del
crimine – la confessione della ‘pianificazione’ dell’omicidio. Decisione che
si presta a trutte le interpretazioni, ottimistiche e pessimistiche). Anche il
figlio della donna, Sajjad fu arrestato nel 2008 con l’accusa di
partecipazione, e rischia l’impiccagione, mentre sono in cacere anche
l’avvocato della donna Javid Hutan-Kian assieme a due giornalisti tedeschi
catturati mentre la intervistavano (il primo avvocato – la su citata Shirin
Ebadi – era stata costretta a esiliarsi in Norvegia perché contestata dalle
autorità avendo difeso la donna).
BIBLIOGRAFIA
-Google-Sakineh e Neda
-Il Secolo XIX quotidiano :
11.12.2010-pag. 7
-Repubblica - sezione: GENOVA
- 22.07.2010-pagina 7
DORIA via
Andrea Doria
La strada non è più a San Pier d’Arena,
ma a Prè. Corrisponde all’attuale via G.Giovanetti.
Nel 1700 ancora non esisteva, e la chiesa si
affacciava rientrata, sull’antica via, omonima ad essa.
Nella prima metà del 1800,
costruiti i palazzi, la strada già era stata aperta ed intestata col nome del
principe (delimitata a monte da “via
sant’Antonio”(via N.Daste), ed a mare da “via Cristoforo Colombo” (via Sampierdarena)); ovviamente col fondo
in terra battuta; aveva la facciata della chiesa ancora “rientrata” e
diversa da quella attuale (cioè il tempio non
era stato ancora allungato, e la facciata non ancora rifatta totalmente).
Nella strada, appoggiate alla
parrocchia, esistevano ben due Confraternite: ‘delle Anime del
Purgatorio’ ; e quella ‘del S.Rosario e della Dottrina Cristiana’ .
Nel tratto a monte, nella
seconda metà del 1800, si aprirono la farmacia, allora chiamata
col nome della moglie del proprietario Milanesio Luigi (per il Pagano/1908 si apriva in via s.Antonio; più
dettagliato, vedi via Giovanetti); a levante, la fabbrica di
liquori di DeAmicis Clotilde in Parodi (erano
anche grossisti di liquori e sciroppi). Il
cappellificio di Bagnara Ermillo (nell’
edizione Pagano/02, risulta ancora in via VEmanuele 14b (via G.Buranello).
La fabbrica faceva allora concorrenza alla più rinomata Borsalino).
Il palazzo sovrastante la farmacia deve essere della seconda metà del 1800: il
cornicione a grossi mensoloni di sostegno, è oggi protetto dalla S. alle Belle
Arti.
Poco prima dell’anno 1900,
vi erano solo cinque case, i cui proprietari
furono: civ.1 , Testa, Storace, Vernazza e C.;--- civ.2 : Repetto Stefano;---
civ.3 Tubino Arturo (forse quello dei metalli e rottami in via Dottesio 14r
ancora nel 1950);--- civ. 4 Danovaro Lorenzo; ---civ 5 Dellepiane fratelli .
Il Pagano 1902 segnala : al civ.1
l’intagliatore in legno Canepa Enrico*°;---4 l’unico elettricista a San Pd’A Morando G.*°; al 5 il negozio calzature di Arvigo Gioacchino’ ;--- cNP
il floricoltore Pittaluga Giuseppe*°;---negozio di mode di Gatto e
C.’;---negozio di frutta secca ed agrumi di Monteverde Giovanni;----
Nel 1908’ (con ancora
nel 1911* e 12°), il Pagano segnala al 3 l’orologiaio Dacqui Luigi;--- civico non
specificato: un deposito di birra e bottiglieria di Palleari Pietro*¨;--- ‘fabbrica cappelli soc.an. già Bagnara e figlio’ che occupava quasi tutto il lato a ponente della
strada, oggi i civv. 6, 8, 10). Per il Pagano, nel 1912 diventò:
«‘Cappellificio Cinzio Bagnara’; nel 1925 fu “cappellificio Bagnara” (fabbrica
cappelli di feltro e paglia). Fabbrica a Sampierdarena via A.Doria (superiore)
telef. 41107. Succursali Milano-Genova»; la stranezza architettonica ne fa un unico in tutta la
regione: un misto tra parigino, napoletano, carcere--- il negoz. vini di Giuseppe Vernazza*¨;--- il
confettiere Moizo Attilio (con negozio in
via DeMarini di droghiere; nel *°¨ è anche in via Manin);---.
Trovo scritto che vi era aperta la sede della Ardita Juventus (un circolo ciclistico locale che darà vita a gare ed
attività di spicco per la città a livello nazionale; e vivrà sino al 1924.
Direttore sportivo divenne Augusto Morselli bolognese trapiantato e per tutta
la vita grande sostenitore dello sport ciclistico; e “sponsor” particolare fu
un Florio, fabbricante di biciclette con officina posta nella stessa via).
Nel 1910 la ‘via Andrea
Doria, da via C.Colombo a via sant’Antonio’ aveva civici sino al 10 ed al 15.
Nel Pagano/ 1912°
compaiono nuovi (vedi 1908) 1-3r (angolo
via CColombo) i coltellinai fratelli Mas騤 specialità affilatura coltelli per
macchine;--- al 28r l’orologiaio
Valcasale Antonio¨¤;--- al 29r
commestibili e forno di eredi di Caneva¨¤ (Canepa?) Giuseppe;--- al 40r la merciaia Noli Maria¨ e figl (veniva
chiamata’Nettin’ ed era madre di ‘Menego’ uno dei due sacrestani della Cella) .
Con
civici non specificati: il ‘lampista’ e
lattaio (lavora la latta) Canale Pietro (nel ¨= neg. di lampade; fu uno dei
primi ad impiantare questa attività artigianale);--- il parrucchiere Canali
Cesare¨ (era ricordato per una speciale
spazzola cilindrica, unica nel genere, con la quale ‘domava’ ogni tipo di
capigliatura).
Nel Pagano 1925¨ si segnalano: all’ 1-3 (in angolo con
v.C.Colombo, il negozio ferramente,e coltellinai f.lli Masè (appassionati di
montagna, furono i primo ad aprire in città una rivendita di articoli
sportivi);--- al 10-1 la levatrice Saracco Clotilde;--- al 39r la
tipografia-cartoleria di Barbieri Luigi (anche legatoria, fornitura completa
per uffici; nel ¨¤ è specialità biglietti da visita, consegna istantanea e
forniture complete per uffici, arredi sacri.
Su una etichetta incollata in ultima pagina di un libretto di preghiere da
comunione; vi è scritto «cartoleria, tipografia, legatoria libri / Guglielmo
Tacchini / via Andrea Doria / San Pier d’Arena»; non è specificato dove era –si
presume qui- né di quando. Potrebbe essere quella che negli anni 1950 era del
padre di Toletti Enrico).--- civico
sconosciuto: l’officina della fabbrica metalli di Gatti Epifanio fu L. ( succ. f.lli
Gatti C. e E. fu L. e dopo ancora,
DeMarchi) fabbr. Lig. strumenti per
pesare e costruz. metalliche (uffici e depositi in via VEmanuele 187r);--- il
pizzicagnolo Lanza Angelo¤;---una seconda tipografia di Nencioni &
Palmieri;--- le cantine Paleari nella ‘strada superiore’;---
Nell’elenco delle strade
comunali edito nel 1927, appare la via Andrea Doria, di 1a categoria,
assieme ad altre cinque, dedicategli dal Centro, Bolzaneto, Nervi, Pegli, Rivarolo.
Nel 1933¤ al civ. 47 l’importatore-esportatore nonché fabbrica di liquori
DeAmici Enrico & Parodi; al 49-51 il
deposito e fabbrica di liquori c.te Chazalettes & C.(nel 1925 il deposito
era in via Vitt.Eman,54); al 59r il
droghiere Orengo Maria; civ.60r mobilificio
di Repetto Ferdinando; civ.76r c’era una
fabbrica di Marzola Celso che lavorava in
ghiacciaie; ed al civ.79r aveva sede la
soc.an. coop. Carlo Rota con vari negozi al dettaglio (in v. A.Doria 37r, cso
DAlighieri 42, GBMonti 14, v.Pellegrini 7, v. DeMarini 1, v.Umberto I,147).
Non
specificato dove un negozio di ‘apparecchiatori
a gaz, elettricità con lampade, idraulica’ Canale Pietro (dal 1911), ottoniaio;
un pizzicagnolo Lanza Angelo¨; una fabbrica di
registri
di Palmieri Romeo¨; l’orologiaio Pavese (che aveva l’incarico della
manutenzione degli orologi comunali).
Roncagliolo, storico del
Gazzettino, ricorda nella via (ponendo i ricordi
negli anni 1920-40, non fa distinzione tra via Doria e via Giovanetti) =’Luigi’
con la friggitoria; Caffè Zino detto ‘Gigio’ (ritrovo di sportivi, di calcio,
nuoto, pallanuoto, ciclismo); Fanti (negozio di alimentari; imparentati con i
Masè); Pasta (la signora, chiamata ‘Milann-a’ vendeva ricami, pizzi, indumenti
intimi der la donna); Tosi (era la signora Pia a vendere calzature per
bambini); ‘o Baciccia’ vendeva droghe; Marchelli (articoli di abbigliamento,
mutande, ecc);‘da ‘ä pippa a-i denti’ vendevba pane, focacciua, farinata,
castagnaccio…non aveva fama di grande igienista); Vernazza bottiglieria;
Roncallo macelleria; Noli (vendeva stoffe dette ‘parmì’. Era stata preceduta
nel locale da una agenzia della Banca Nazionale di Sconto, poi fallita; e fu
seguita da Danovaro Tranquillina); Savelli bar; da ‘a Gigia’ trovavi trattoria
con alloggio. Personaggio famoso nel tratto inferiore era ‘o Padella’, uomo di
spirito allegro e dalle battute mordaci e pronte,barzellettiere e maestro
pernacchiatore; caratterizzato dalla paglietta con nastro multicolore,
fazzoletto al collo e dalla carrozza munita di gabbia per trasporto dei
detenuti tra caserma dei carabinieri e vari carceri).
Il 19 ago.1935, con delibera del podestà, la
strada venne intestata al Giovanetti, per non avere doppioni con il
Centro da quando -dal 1926- la città entrò a far parte della Grande
Genova (nel Novella, si cita ancora la vecchia
strada ma -tra parentesi- si accenna alla nuova.).
Da vecchi sampierdarenesi (inizi del 1900) la zona
veniva chiamata “da o zeugo da balla” perché in mancanza dei palazzi gli spiazzi
venivano utilizzati per il gioco del tamburello o altri giochi simili (tipo
‘balla velenosa’); che di volta in volta dovette spostare prima in piazza
Galoppini poi in piazza d’Armi.
DEDICATA ad uno
dei più illustri personaggi della storia genovese, riconosciuto quale
benemerito e “padre della patria”, grande condottiero ed ammiraglio, principe
pirata.
LA FAMIGLIA: da già
potenti nei primi decenni dopo l’anno mille– si presume commercianti –
acquisirono enormi ricchezze con l’incarico di gabbellieri per l’Imperatore
(l’aquila come stemma e san Matteo come protettore). Divenne così una delle più
celebri della città; in più, immortalata
universalmente dal suo figlio Andrea, determinante la storia locale ed
internazionale (meno per quella nazionale) per l’incisività delle sue
decisioni.
Dal latino «de Auria», derivato dal fatto dei
possedimenti dentro e fuori la ‘porta Aurea’ (dalla quale anche il rione
Portoria) sarebbe più giusto chiamarla alla latina ‘de Auria’ e quindi D’Oria
come ancora fanno tanti per tradizione e –oggi- per anagrafe; ma per uso
corrente, quasi tutti adottano la forma senza apostrofo.
La stirpe sarebbe nata ai tempi delle crociate – Cappellini
scrive 1089, la prima; la leggenda aggiunge la storia del un conte –o visconte
francese- Arduino da Narbona (Nùarbon),
il quale venne in città per peregrinare (o di ritorno) in Terrasanta.
Ammalatosi però gravemente, fu allora ospitato nella casa DellaVolta (famiglia che poi accettò divenire Cattaneo) e
curato in particolare dalla fanciulla Oria (o Orizia). Il nobile prese in sposa la giovane (la cui madre era divenuta vedova, e forse per curare i possedimenti e gli altri figli –fuori città-
erano divenuti “de Oria”, e si fermò in città. Ebbero quattro figli, dei
quali il primo fu chiamato Ansaldo (e
nelle ‘Istorie genovesi’ di Paolo Interiano, anche lui, “de Auria”), ufficialmente capostipite della famiglia genovese. Fu
console per quattro volte, ed ambasciatore in Sicilia. Postosi al comando di
una flotta, conquistò Almeria (1147) e Tortosa (1148).
La storia della famiglia (essendo assai prolifica, in
appena due secoli era già così vasta da non riconoscersi più legami di
parentela) si avvale di innumerevoli personaggi, dogi (GiovanniStefano 1633-5,
l’uomo più ricco d’Italia; Nicolò 1579-81, primo serenissimo; ), consoli,
sacerdoti, ribelli (GioAndrea nel 1576 provocò la riforma del
governo locale; Branca, ricordato da Dante; Filippo ucciso nei moti del 1797
lottando contro il governo aristocratico), scienziati, annalisti,
ammiragli (Oberto vincitore della Meloria; Lamba vincitore dei veneziani;
Corrado di Oberto del sec.XIII fu determinante nella vittoria contro Pisa). Non
ultimo, Giacomo fu sindaco di Genova nel 1891.
Da me non conosciuta (ahi, Tosini!) il ramo che si
interessò, visse e determinò buona parte della storia di San Pier d’Arena,
dalla chiesa della Cella, alle ville (Franzoniane, don Daste, ecc.).
IL NOSTRO nacque
secondogenito (primogenito fu Davide) ad
Oneglia (signoria della Repubblica) il
30 novembre 1466 (Cappellini scrive 1468)
da Ceva a da Caracosa dei Doria di Dolceacqua, allora ramo minore
economicamente “debole”, dell’illustre famiglia genovese (Si è scritto che le nobili origini di questo ramo
imperiese sono state scoperte risalendo sino all’anno 960, ma –come già scritto
in altre occasioni- diventa nebuloso e frequentemente falso l’accertamento di
qualsiasi documento anteriore agli anni del prima del 1100. DeLandolina/1923
scrisse che nacque nel 1468; e -riferendo lo storico Canale- aggiunge che fu
discendente da un oscuro della nobile famiglia, caduto in povertà e
trasferitosi ad Oneglia (mentre conferma che il capostipite della famiglia
sarebbe stato del casato principesco di Arduino visconte di Narbona).
Nuvolari-Valenziano, raccontando la “saga dei Fugger” –potente casata
mercantile danese- propongono la possibilità che Andreas sia stato figlio
adottivo di Ceva Doria, ricevutolo dal ricco mercante Markus Fugger,
naufragato col bimbo davanti a Oneglia, e –nell’impossibilità di rientrare in
Danimarca col bimbo- lo affidò in cambio di ripetute rimesse di denaro). Visse
poi a Genova fino all’età di 94 anni, ove morì il 5 nov.1560 (altri scrive 25 nov; erediteranno i fratelli
GioAndrea (il marchesato di Tursi, il
protonotariato del regno di Napoli, le galere, il palazzo di Fassolo) e
Pagano (feudi appenninici e contea di Loano)).
Alla sua nascita, era da più di
un secolo che la Repubblica cercava una propria identità, dignità, e libertà,
da maturare rispetto lo stato feudale precedente. Mentre fuori le mura
l’attività prosperava abbastanza rigogliosamente con grosso afflusso di beni
(malgrado i corsari barbareschi ed i giochi internazionali tra Papa, francesi,
imperatore), in città i ricchi beneficiari di questo benessere, potenti gruppi
aristocratici, si combattevano tra loro per mera questione di potere e-di
conseguenza- di alleanze: il patrimonio andava destinato al lavoro (il Banco di
san Giorgio, fondaci e navi) ed all’immobiliare (la villa con la torre, la
propria chiesa, le case per i sudditi). In particolare l’albergo dei Fregoso
c(dei quali a Cesare, Andrea offrì il favore il 22.8.1527) contro quello degli
Adorno (espulsi da Genova dal Doria in nome del re di Francia) sanguinosamente
alternandosi al punto che la Repubblica per difendersi si era dovuta appoggiare,
e quindi soggiogarsi di volta in volta, ai francesi di Carlo VI (1396), al
marchese di Monferrato (1409), ai Visconti (1421), al francese Carlo VII
(1458), agli Sforza (1466), a Lodovico il Moro, ai re francesi Luigi XII e
Francesco I (1528).
Da giovane, come tutti i
benestanti, fu educato culturalmente ed alle armi ed il mare. Diciassettenne,
rimasto solo, fu raccomandato a Roma nel 1483 quale aspirante uomo
d’armi nelle guardie pontificie mettendosi al servizio di Innocenzo VIII (un genovese
pure lui: GB.Cybo). In vent’anni di questo impegno, dimostrò attitudine
al comando e capacità degne di un capitano di ventura; ed in tale veste fu
assunto dal duca di Urbino, Federico da
Montefeltro, e poi da don Ferrante d’Aragona, dalla Francia (contro Consalvo di
Cordova ed il duca Valentino Cesare Borgia); ed infine -1503- dal Banco
di san Giorgio (con il grado di prefetto del porto, e con l’impegno di domare i
corsi, ribelli al Banco proprietario dell’isola).
Anche abile marinaio, con un
Fregoso doge (1512-5), fu assunto
per comandare le uniche (chi dice due, chi
quattro) rimaste galee genovesi contro i pirati, al servizio del re di
Francia Francesco I di Valois che lo nominò ammiraglio (Il re francese e l’imperatore CarloV d’Asburgo, furono i personaggi più
potenti del cinquecento. Nel febbraio 1525 il francese fu sconfitto e preso
prigioniero a Pavia dagli imperiali; tornato libero, usò il Doria per
riconquistare i genovesi, divenuti da colonizzatori e mercanti con l’oriente a
banchieri, arrestando l’ultimo doge perpetuo Antoniotto Adorno e dando il
comando di governatore a Cesare Fregoso). Però il sire francese non solo
non accettò di pagare il servizio, ma neanche nascose l’ambizione di
sottomettere la nostra Repubblica, a proprio uso e comando. Pertanto il Doria
nell’anno 1528, si svincolò a sorpresa dall’impegno col regnante
d’oltralpe e stilò un accordo (‘asiento’: ovvero affitto delle proprie navi) con
l’imperatore (e re di Spagna) Carlo V d’Asburgo, quello
sul cui dominio non tramontava mai il sole. Nel 1529 il
Doria con 15 galee e 400 uomini era andato a Barcellona a prenderlo per
portarlo a Genova –ove arrivarono 67 galee trasportando 4mila soldati di
scorta; qui ristettero dal 12 al 21 agosto prima di ripartire per Bologna ove
essere incoronato Imperatore. Continuamente bisognoso di soldi per pagare le
innumerevoli iniziative (indebitamento sia per necessità di sempre migliori
navigli per i traffici atlantici nelle nuove terre; sia per continua guerre in
Europa; sia per la corte), facilmente divenne debitore del Doria, che ricambiò con
parte del debito (25mila scudi), onoreficenze (Toson d’Oro e ducato di Melfi (Basilicata; che produceva 40mila ducati l’anno) ma soprattutto con la promessa –a lui molto
conveniente- dell’indipendenza della Repubblica genovese con dominio –ovvero
“piena sovranità”- su Savona, e parità, nei commerci in tutti gli stati
dell’impero, con propri sudditi). A Madrid il 10 agosto firmò un
patto di collaborazione; il 13 settembre guidando tredici galee entrò nel
porto di Genova e sollevò la popolazione contro i francesi conquistando la
fortezza di Castelletto, facendo eleggere un doge biennale e riportando alla
totale autonomia il comando del Comune che divenne Stato, ovvero Repubblica; il
28 ottobre rase al suolo le mura di Savona per una sua sottomissione
definitiva.
Capì così nel frattempo, che
troppa confusione regnava tra i potenti nobili e padroni dell’economia; e che
era quindi necessario prima di tutto riformare l’interno dell’ordinamento
dello stato repubblicano onde riuscire a mantenere un minimo di autonomia ed
indipendenza politica.
Come detto, il comando della
Repubblica fu affidato ad un Doge (ma con carica
biennale), sorretto da persone scelte tra le famiglie nobili e di
cospicui capitali (esclusi i Fregoso e gli
Adorno); il Doria partecipò a formare un ordinamento tale da
disciplinare i poteri della casate nobili, eliminare così rivalità e
malcontenti e mettere ordine nelle gerarchie del governo: raccolse i popolari
in 5 casate ed i nobili in 28“Alberghi” (per farne parte occorreva possedere
minimo sei case in città; ed accettare il cognome di uno dei ventotto).
(Furono popolari i
DeFornari, DeFranchi, Giustiniani, Promontorio, Sauli.
Furono alberghi i
Calvi, Cattaneo, Centurione, Cibo, Cicala, D’Oria, Fieschi, Fornari, DeFranchi,
Gentile, Giustiniani, Grillo, Grimaldi, Imperiale, Interiano, Lercari,
Lomellini, DeMarini, DiNegro, Negrone, Pallavicino, Pinelli, Promontorio,
Salvago, Sauli, Spinola, Usodimare, Vivaldi. Per un totale di 600 cognomi e 861
cittadini.
Furono aggregati le
famiglie nobili: DeLagnello, DeRado, DaLecca, DeSanMatteo, Re, Castigliona,
Inurea, Riccardi, Segno, Galeana, Cantalupo, Bergona, Foresta, Piacenza,
Clavexana, Mottina, Rovere, Noce, Berinsona, Marchese, Bertorotta, Brocarda,
Novara, Sperona, Bozola, Cornera, Chiavaria, Malaspina, Chiarella, Fossa.
Mancano 4 famiglie delle
quali non vienere riportato il nome,
La Repubblica, grata, gli donò un palazzo (ancor oggi eretto in piazza san Matteo; non usato
perché in zona pericolosa), gli innalzò una statua (distrutta in tumulto del 1797, è stata rifatta ed
esposta all’ingresso del palazzo Ducale), lo nominò ‘padre della patria’
e Priore perpetuo del Magistrato dei Sindacatori, esentandolo (forse unico al
mondo) dal dover pagare le tasse. Era divenuto così, senza essere doge, l’unico
vero dominatore della Repubblica; Paolo III Farnese gli donò una spada con
l’elsa arricchita di gemme, conservata nella chiesa di san Matteo. Con
C.Colombo, sono i navigatori più rinomati del ‘500 italiano.
Da mecenate, contribuì ad
abbellire la sua casa nel palazzo fuori mura, con opere d’arte (Perin del Vaga, allievo di Raffaello, su tutti).
Nel 1533 ebbe ospite Carlo V, con
seguito di mille persone, fornendo a tutti sfarzo e ‘signorate’ varie
Da buon condottiero, difese il
commercio e la navigazione combattendo nel 1534, a 66 anni, i pirati barbareschi
guidati da in genere crudeli corridori come Dragut, Auroudj Barbarossa,
Saracino (ed altri minori dal nome bizzarramente fantasioso come Camalicchio,
Mezzomorto, Maezzamamma, Sinãm il giudeo) che infestavano le coste. Nominato
Sommo Ammiraglio della flotta, guidò 72 galee (del
Papa, del regno di Napoli, genovesi di casa Doria, spagnole, portoghesi),
e 60 navi da carico con 18mila arruolati. Da buon politico seppe amicarsi e
farsi rispettare dai potenti del tempo, tanto da permettere che la Repubblica
rimanesse autonoma e fortissima (il re di Spagna
già gli aveva concesso il titolo di Principe di Melfi; da cui il nome della
piazza, in zona Fassolo, ove c’è ancora il suo grosso e ricco palazzo. É
l’unica persona che nella storia della Repubblica ha avuto e portato questo
titolo monarchico. Gli attribuì anche il ducato di Tursi –Basilicata-).
Ovviamente ci furono i
malcontenti: di essi i più fieri furono Gian Luigi Fieschi (guelfo, conte di Lavagna, il 2 gennaio 1547 quando il
Doria era ultraottantenne. L’ipotesi era riunire le truppe fliscane in città e
far sollevare i galeotti nel porto e bloccare le navi dei Doria; uccidere sia
Andrea e Giannettino Doria che Adamo Centurione banchiere di CarloV; nominare
doge Barnaba Adorno e tornare sotto la Francia. Il Doria fuggì a Masone da dove
diresse il ricupero dell’ordine alla morte di GianLuigi e fuga dei Fieschi a
Montoggio); ed in tempo successivo Giulio Cybo (marchese di Massa e Carrara cognato dei Fieschi); ambedue
alleati di Francia e Parma, tentarono invano di sovvertire l’ordine da lui
instaurato.
Ultime due iniziative, prima
di dare le consegne al nipote GianAndrea (figlio di Giannettino)furono: far
approvare una nuova legge, detta ‘del garibetto’mirata a ridare ordine ed
evitare di alterarsi con l’imperatore che voleva un suo presidio militare in
città, mirato a garantire la fedeltà alla Spagna; e ultima a 87 anni la
riconquista della Corsica
Morì 94enne alle ore 10 di
lunedì 25 novembre 1560 (Ascheri scrive 22),
nel palazzo in Fassolo, distrutto dalla notizia
della sconfitta da Dragut ed Ulug-Alì Gerbe, che pregiudicava il dominio del
Mediterraneo.
La sua tomba è posta nella
cripta della chiesa di san Matteo.
La sua figura viene riproposta in
vari busti e targhe nella città; tra tante, la statua posta sopra la galleria
N.Bixio di Corvetto (opera di E.Baroni del 1929).
Nel 2009 il principe
-erede dell'ammiraglio- è Jonathan (1963- )Doria Pamphilj; ha una sorella
Jesine (-.-) entrambi figli di Orietta Doria (1922-2000)
che nel 1958 aveva sposato un ufficiale di marina inglese, di sangue non
nobile, Frank Pogson. La coppia non ebbe figli; ed i due risultano ambedue
adottati in orfanatrofio (dove il nome del
ragazzo era Archibald, e quello della sorella, Mary; e nessuno dei due ha preso
il cognome inglese, ma quello nobile della madre). La madre Orietta ha
loro lasciato l'eredità familiare con una sola clausola: la non dispersione
dell'immenso patrimonio (più vistosi, il palazzo
genovese e quelli romani). Entrambi vivono a Roma nel loro palazzo in
via del Corso ove sono ospitate mirabolanti ricchezze (tra cui, quadri di
Velazquez, Raffaello, Caravaggio, Rubens, ecc.) in una situazione complessa
coinvolgente non solo la discendenza nobiliare ma anchele sceltecomportamentali
e legali. La legge italiana è chiara per alcune parti del problema, meno su
altre e sulle quali sta infuriando la polemica politica (=famiglie alternative):
-Gesine ha sposato Massimiliano Floridi (esperto d'arte) dal
quale ha avuto 4 femmine (Anna-199e4; Elisa-1995; Orietta-2002; Irene-2004).
-Jonathan, celibe,
dichiaratamente ed apertamente riconosciuto omosessuale (presenza in prima fila al gay pride di Genova 2009+
assoc.genitori di omosessuali; libertà intellettuale, orgoglio, intelligenza,
indifferente della provocazione che pone)
vive con il suo partner, il brasiliano -Elson Edeno Braga- a cui è unito a
Londra da civil partnership. Per meglio rappresentare la continuità dinastica,
ha rinunciato al nome del padre ma non al passaporto inglese desiderando
avere una progenie, ha adottato un sistema concesso in alcuni paesi esteri:
ovulo (da una donatrice) ed utero (in affitto, da altra donatrice. Metodo proibito ed
illegale in Italia, punito col carcere e dove una coppia gay non può formare
famiglia e quindi neanche adottare).
Ha avuto così - dopo aver consultato una clinica
specializzata californiana- prima Emily, nata a
Wichita nel Kansas il 12 ago.2007 (in un articolo di 22 ottobre 09, si scrive
nata nel 2006; e quindi 2007 per il fratello). Poi, selezionando
geneticamente da avere la sicurezza maschile, FilippoAndrea, nato in Ucraina
il 20 ago 2008. Ambedue con due madri (una
donatrice dell'ovulo; l'altra dell'utero) e con passaporto inglese per
evitare che -quando in Italia- siano sottratti al genitore. Infatti, con due
papà e nessuna mamma (maternità surrogata), debbono per molto tempo vivere in
Brasile.
Poiché la legge italiana riconosce come madre la
partoriente, Gesine nel 2007 (solo per Emily ché FilippoA era ancora da
nascere) ha denunciato la situazione illegale del fratello trascinandolo in
tribunale (Procura di Roma) col fine del non riconoscimento italiano dei due
figli di Jonathan ed in più nel timore che la madre (sconosciuta) di
FilippoAndrea, esca all'aperto.
La discendenza del nostro
Doria, sintetizzata, inizia con
--Niccolò
--Emanuele 1282
--Antonio
--Ceva
--Francesco sposa Chiaretta
Doria
--Ceva sposa
Caracosa Doria
-----Andrea I
(Oneglia-1466-1560) principe di Melfi – sposa Peretta Cibo ved. DelCarretto
-----Giannettino (-.1547)
sposa nel 1537 Ginetta Centurione
-----Giovanni Andrea I
(1540?-1606) sposa nel 1558 Zenobia DelCarretto
-----Andrea II (1570-1612)
sposa Giovanna Colonna - principe di Melfi
-----Giovanni Andrea II (Pagano;
1607-1640 ) sposa Maria polissena Landi – vicerè di Sardegna
-----Andrea III (1628-1654)
sposa Violante Lomellini nel 1652
-----Giovanni Andrea III
(1653-1737) – sposa Anna Pamphilj
-----Andrea (1675-1737)
sposa Livia Maria nel 1703
-----Giovanni Andrea IV
(1705-1764) sposa Maria Giovanna Doria di Tursi nel 1726; poi
Eleonora Carafa dei duchi di Andria nel 1742
-----Andrea IV (Giorgio;
1747-1820) sposa Leopolda di Savoia Carignano nel 1767
-----Luigi Giovanni Andrea V
(1779-1838) sposa Teresa Orsini di Gravina nel 1808
-----Filippo Andrea V
(1813-1876) sposa Mary Talbot dei conti Shrewsbury nel 1839
-----Alfonso (1851-1914)
sposa Emily Pelham Clinton dei duchi di Newcastle nel 1882
-----Filippo Andrea VI
(1886-1958) sposa Gesine Mary Dykes nel 1921
-----Orietta (1922-2000)
sposa Frank Pogson nel 1958
-----Jonathan (1963-
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio StoricoComunale Toponomastica - scheda 1646
-Ascheri GA.-Notizie storiche delle
famiglie…-DeFerrari.2003-pag.XI
-Boccardo P.-A.Doria e le arti-Palombi.1989
-Bono Raffo E-personaggi genovesi nella storia-per
LiosClub2006-p.30
-Borghesi V.-Vita del principe GAndrea Doria-C.d.Librai
1997-p.XLVI
-Cappellini A.-Dizionario biografico di genovesi
ill.-Stianti.1932-pag.53
-DeLandolima GC-Sampierdarena-Rinascenza.1923-pag.40
-Durante A.-Don Nicolò Daste-DonDaste.1984-pag.16
-Gadducci&D’Oria-san Matteo-SES.2005-pag.69
-Grendi E.-A.Doria uomo del Rinascimento-SocLigStP.1979-fasc.I-pag91
-Lamponi M-Genova in bicicletta-Valenti.1977-pag.82
-Museo s.Agostino-archivio toponomastica
-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto
bibl.Berio.1900-pag.16.19
-Nuvolari&Valenziano-La saga dei
Fugger-DeFerrari.1993-pag49
-Pagano 1911+1912+1919+1925+1933-pag.246+
-Pasolini A.-Semmo da taera de Colombo-NEG.1990- pag29
-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag. 32
-Rivista ‘Genova’ : 2/44.1 + 12/67.24 +
-Rota A.-Enciclopedia dei Liguri Illustri-ERGA.vol.II-Andrea
Doria
-Scriba G.-Memorie storiche su Caffaro del 12
ago.1881-SocLigStPatria
DOTTESIO via
Luigi Dottesio
TARGHE:
via
- Luigi Dottesio – patriota - martire – 1815-1851 – già via De Marini
via
– Luigi Dottesio – patriota - martire – 1815-1851


sottopasso all’ angolo con via di Francia



angolo via GDCassini



angolo via Palazzo della Fortezza
QUARTIERE ANTICO:
Coscia
 da Vinzoni, 1757.
da Vinzoni, 1757.
In fucsia via Demarini; celeste via sBdFossato; blu via
Spinola; rosso crosa Larga (Palazzo della Fortezza); giallo via NDaste.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2772

da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 23140
UNITÀ URBANISTICA: 28
– s.BARTOLOMEO
 da Google Earth 2007. In giallo via
palazzo della Fortezza.
da Google Earth 2007. In giallo via
palazzo della Fortezza.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria
delle Grazie
STRUTTURA: strada
comunale, carrabile con senso unico veicolare , da via di Francia a via
N.Daste. La carreggiata a mare, è adibita a posteggio libero di mezzi
motorizzati.
Lunga
285 m ; larga 5,50 m . Con due marciapiedi.
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
STORIA: Nel regio
decreto emesso nel 1857, con cui si sancivano i nomi delle strade cittadine,
questo primo tratto della “strada Superiore” che da Largo Lanterna arrivava
alla Crosa Larga, era tutto chiamato “via De Marini”.
L’apertura di via di Francia, tagliò in due la vecchia
via, con conservazione della titolazione in ambedue i tratti.
Fu ufficializzato - con delibera del podestà il 19 ago.1935
- la conservazione del nome della famiglia genovese al tratto a levante;
mentre il secondo tratto che comincia dal sottopassaggio della ferrovia,
assunse il nome attuale di L.Dottesio (nel 1937,
l’esperto storico che tratteggiava sulla rivista ”Genova” le strade cittadine,
alla descrizione di via Balbi Piovera scrisse che iniziava da via Bottisio).
Nel 1940, sul Pagano, non sono scritte le strade
delimianti. Riporta i numeri neri= da 1 a 41 e
da 2 a 42, con in particolare al 2 Moro Tommaso e Figli, olii; al 10 f.lli
Lombardo fu Raff., sego; all’11 Repetto trasporti e ‘Santina’ prmanente; al 18
i Sanguineti L&C cons(erve); senza civico NS delle Grazie (parr.).
Dei numeri rossi= al 28r e 53r soc.an.coop.
Carlo Rota; 30B Molino N demolizioni auto; patate, 3 macellaio, 2 commestibili,
metalli, 2 parrucchiere, 3 fruttivendolo, 3 drogheria, friggitoria, drogheria,
tripperia, salumificio, panificio, pollivendolo, bar, stiratoria, 2 merceria,
carbonaio, 2 cantina vini, olii saponi, pescivendolo, marmista.
Subito dopo la ferrovia, la prima ad incontrarsi
sulla destra è via GB. Carpaneto: era l’inizio dello Stradone san Bartolomeo,
che portava in origine alla abbazia omonima nell’interno del vallone,
costeggiando l’omonimo rivo che nel 1930-5 –per fare il piazzale
dell’Autostrada- fu spostato un pò più a ponente.
CIVICI
2007= NERI = da 7 a
13 (manca da 1 a
5) e da 2 a 18 (mancano 4, 6)
ROSSI = da 11r a 65r e da 2r a 66r (manca 14; aggiungi 2A(B)→F,
30AB, 62A→D)
A MONTE da via di Francia a via N.Daste
=== civ 1. A destra , la prima costruzione è la villa Negrone, poi
Moro.
Essa,
ormai aprendosi nel retro, è descritta in via Pedemonte
===civ.
3: demolito nel 1972. Era la villa
Pallavicino, poi Moro: nella carta del Vinzoni, è indicata
proprietà del magnifico Nicolò Pallavicini;
ed alla sua famiglia rimase finché nella prima metà del 1800 divenne parte
dell’oleificio Moro che la adibì a scopo industriale (cosa che a mio avviso
meriterebbe l’erezione di una novella “colonna infame” sul posto). Le
caratteristiche architettoniche permettono di far risalire la costruzione alla
seconda metà del 500. La facciata aveva una loggia, poi murata, e dei poggioli
le cui mensole di sostegno erano ornate di mascheroni finemente scolpiti; la
parte inferiore aveva un portale sormontato da un fregio e stemma della
famiglia, circondato da finestroni con grosse inferiate.
Il
giardino si estendeva verso il monte, sino a poco oltre dove ora passa via
A.Cantore; fu occupato dall’oleificio; alla sua chiusura, quasi tutto lo spazio
venne adibito alla costruzione del grattacielo, detto Torre Cantore.
La
concessione ad uso industriale, in pochi anni riuscì a completare tutto il male
che non aveva compiuto la natura in quattro secoli: la casa raggiunse un
degrado tale da renderne impossibile il ricupero -o comunque non vantaggioso
secondo gli esperti-; così fu demolita per far posto ad un caseggiato; gli
architetti tentarono di conservare la propria dignità lasciando (1971) eretta
la parte inferiore della facciata, che interessando a nessuno, sta andando in
assoluto degrado pure lei .
===civ.
9: l’edificio, costruito in stile primi anni del 1900, ospita la scuola
materna comunale Maria Mazzini. Nell’elenco degli immobili di proprietà comunale del 1890 e
1896 compare la voce ‘locale per la sala di musica’; nel 1908 diventa ‘locale
per la sala di musica affittato all’Asilo infantile’. Non si conosce, ma si
presume sia riferito a questi locali; se fosse, dimostra che l’edificio c’era
già nel 1890.
Subito
dopo era una cappella, sacra a sant’ Antonino,
già presente negli anni attorno al 1200. Questi, soldato nella legione tebea (vedi a Maurizio, in via GBMonti), divenne martire; però il suo
nome, confuso con quello più popolare di sant’Antonio, perdette di importanza a
vantaggio del secondo e postumo)
La
cappella (NB controllare se fu una cappella a se
stante, o invece si fa riferimento al monastero omonimo che era 4-500 metri più
a ponente), nel 1300 era sotto il patronato della famiglia Grisolfi, a cui
rimase sino all’estinzione, nel XVI secolo; ne prese cura allora mons.
G.B.Cicala, già vescovo di Albenga e poi cardinale a Genova: così poi, nel
1586, papa Sisto V concesse il patronato ad Alessandro Cicala, promuovendola
contemporaneamente a Commenda.
Minacciando
di rovinare per vetustà, nel 1582 (?) la famiglia Lercari provvide a farla
ristrutturare dando l’incarico ai maestri Giorgio e Stefano Storace; nel 1621
ospitò il corpo di sant’Innocenzo martire portatovi da Paolo Serra, persona
non oltre conosciuta; subentrarono alla cura della chiesa i padri Agostiniani del
convento di Belvedere, che vi rimasero sino al 1797, epoca in cui gli
sconvolgimenti politici franco-rivoluzionari, obbligarono la cessazione del
culto. Così abbandonata, nel 1826 venne trasformata in abitazioni, e poi
distrutta.
=== civ. : in via DeMarini,
(vedi vico Cibeo) in epoca fine 1800, vengono descritti i vari
proprietari in questa zona: vi compare “proprietà delle FF.SS” e dovrebbe
essere qui dove ebbe natali il gen. A.Cantore .
===la chiesa di santa Maria delle Grazie. Il
tempio vede nella sua storia, tre edifici diversi come posizione geografica,
anche se poco distanti ciascuno. L’edificio è protetto da vincolo delle Belle
Arti.
A
Voltri esiste un omonimo convento e santuario, retto dai frati Minori
Cappuccini
Il primo ed il secondo
, vengono descritti nella via DeMarini.
Il terzo fu
costruito nel terreno ove già prima esisteva una cappella
dedicata a santa Maria della Vista:
piccola ma abbastanza alta, ricca solo di un altare in marmo , e di uso
pubblico, era posta in capo alla crosa della Catena (poi via Manin, ora via
G.Cassini), e vicino al piazzale d’ingresso della villa Spinola. Inizialmente
-ma non si sa da quanto-, la cappella era dedicata a san Girolamo (vedi in via
DeMarini la cappella gentilizia nel palazzo Neuroni). Nel 1749 il vescovo mons.
Saporiti Giuseppe, ne interdì l’uso, non si sa perché . Solo
cento anni dopo ,nel 1850, fu riaperta al culto, acquisendo però il nuovo nome
di “santa Maria della Vista” in virtù di una immagine omonima della Madonna
collocata nel tempio (dopo averla prelevata da una casa posta nelle vicinanze,
in demolizione causa la costruzione della ferrovia). Allo scopo, un prof.
Rebuffo scrisse l’epigrafe : “ D.O.M. - IMMAGINEM - AB ANTIQUITATE - CULTAM -
VIRGINIS MATRIS A VISU - EX VIARUM CONVICIO - IN HANC AEDICULAM - PATRONAE
OPTIME MAXIME - DECENTIUS COLENDAE CAUSSA - CLIENTES - PECUNIA COLLATITIA -
INTULERUNT ANN. MDCCCLIX “
Nel 1886 fu ristrutturata con pitture ed affresco sulla
volta, ma con una sostanziale riduzione in altezza per costruirvi sopra l’
abitazione ed alcuni stanzini per il rev. cappellano, senza riguardo
all’estetica e “con gusto quasi vandalico”, degenerando l’aspetto del tempio a
simil bottega o magazzino. I fedeli vi accedevano comunque offrendo lampade e
candele; e la frequentavano in forma solenne in occasione della processione del
Corpus Domini. La cappelletta dava punto di riferimento alla strada, chiamata
omonima in un documento del maggio 1817 elencante le strade locali.
Fu infine abbattuta, per permettere l’erezione del grosso ed
attuale edificio)
L’area interessata dalla sudescritta chiesuola, era
divenuta nel frattempo di proprietà della RES (vedi); il cui presidente, ing.
Cuneo, era in buoni rapporti con il parroco GioBono Schiappacasse (parroco dal 1920, insediato nella
chiesuola di via DeMarini);
l’intesa tra i due favorì superare tutte le difficoltà –da quelle burocratiche
a quelle economiche (£.220mila
per il terreno)- che si
interponevano all’iniziativa.
Una prima rata di 50mila lire, era quasi preparata dalla
Fabbriceria, attraverso donazioni, prestiti (di cui uno più ricco e gratuito ottenuto da una benefica famiglia genovese
che completò il campanile)
ed iniziative varie, da dare nel 1922 per
il compromesso (ed a
rate, altre 35+ interessi x tre anni, solo per il terreno. In totale la
Fabbriceria dal 1921 al 1928 spese 225mila (–terreno, notaio, registro, interessi-) + 369mila a Stura (mancanti ancora di 86mila da dare) + 22mila di varie (tra cui uno sfratto al “caffè
Tubino” evidentemente collocato nell’area, non si sa dove). In attivo 311mila in donazioni,
335mila la vendita della chiesuola). Il contratto fu stipulato il 5 maggio 1925 (essendo intervenuti nella RES problemi di liquidazione e
programma di chiusura dell’attività); in attivo c’era solo la vendita della precedente chiesuola
(prima era arrivato una
ingiunzione di esproprio da parte del CAP mirato ad ingrandire i suoi spazi:
si fece opposizione; si erano offerti prima i Doks Liguri, poi l’oleificio
Costa) e -più tardi- anche con contributi (6.XI.1928) a titolo ‘rimborso spese per la
costruzione’ da parte del Comune di Genova. L’impresa edile che si accollò i lavori anche in
precarietà di regolarità dei pagamenti, fu la ditta Stura.
In una area di 1350 mq (di
cui 860 occupati dal tempio e 420 dai necessari distacchi), furono prima scavati 2500m3 di terra e poi eretto
il tempio mariano, ideato dall’arch. Piero Barbieri (lo stesso che progettò il santuario di N.S.della Guardia e che dovette eseguire più di due successivi progetti e disegni: il
primo prevedeva un edificio –con possibilità di essere aperto in via Carducci
se si fosse comperato tutto il terreno- con due campanili ai lati della
facciata; di 43x20m. più un fondo di 3x20 ed un Sancta Santorum di altri 12x20.
Una navata centrale larga 10m ed alta 20m, più due laterali di 4m cadauna
separate da 8 piloni snelli in stile gotico-pisano alternati da sei in marmo
colorato; la volta ad archi acuti era percorsa da una galleria con lo scopo di
aggraziare lo sguardo e dirigerlo verso l’altare) in stile misto gotico e
romanico. Le abitazioni erano sul retro. Nel 1929 un altro progetto vedeva la
facciata decisamente a sud, con nella parte apicale una serie di 12 colonnine
delimitanti finestre ogive, con andamento a V rovesciata parallela
all’architrave§§§ della sommità; sotto esse, un rosone di 4m di diametro, ai
cui lati due bifore per dar luce alle navate laterali e snellezza alla
facciata; in basso tre portali, col centreale più ampio ed alto, di tipo
gotico. La lunghezza diventuta 40m, altezza 20.
Ebbe la posa della prima pietra il 27 giu.1926
(questa, donata dal
sig. GB Frantone presidente degli degli Uomini Cattolici, era di 1m3 e fu
portata in loco da un carro trainato da 4 cavalli adorni, servizio offerto
dalla ditta Canepa. Alle ore 17 su auto offerta da Gustavo Dufour, giunse
l’arcivescovo con l’ing. Tosi preside dell’istituto a fianco, don Raffetto
arciprete, ed altre autorità come Broccardi podestà di Genova, Diana podestà
locale,fino alla banda (della Croce d’Oro; c’era anche il Risorgimento), Luigi
Pasteris commissario degli Esploratori. Fu
benedetta dall’arciv.di
Genova, mons Carlo Dal Maggio Minoretti. Porta la scritta dettata dal prof .
P.Olivari: “ V.Kal. Julias An. MCMXXVI - Pii XI . Pontificatus anno V. -
Victorio Emanuele III. f.f. regnante - Carolus Dalmatius Minoretti - Genuensium
Archiepiscopus - Sacrum auspicalem lapidem - Solenni ritu statuit - huius
curialis aedis - quam - Deo Optimo Maximo - in onorem Virginis Deiparae - ab
inchoato aedificare instituit - Ioannes Bonus Schiappacasse - Curio - ut
ampliori atque augustori loco - Alma Gratiarum Mater - populum suum pecullarem
tueatur ac foveat “ Tradotta : “Il 27 giugno 1926 -- V di pontificato di Pio XI
-- felicemente regnando V.Emanuele – III -- Carlo Dalmazio Minoretti ---
arcivescovo di Genova -- pose con solenne rito -- la prima pietra -- di questa
chiesa parrocchiale – che -- a Dio ottimo massimo -- in onore della Vergine
madre -- Giovanni Bono Schiappacasse --parroco -- imprese ad innalzare dalle fondamenta
-- affinché da più ampia ed augusta sede -- la benigna Madre delle Grazie -- il
popolo suo diletto difenda e protegga”). Nell’interno furono racchiuse una
pergamena, alcune monete di fresco conio 1926, una moneta d’argento da £.2, una
medaglia del Papa.
Il nuovo progetto di rimaneggiamento, fu necessatrio già
dall’epoca della prima pietra, sia per i costi, sia per le dimensioni che per
contrasti con gli abitanti confinanti (il progetto eccedeva di 2 m. il terreno acquistato, ed i
vicini non li concessero; restringendo la lunghezza, ne conseguì anche la
larghezza e quindi sacrificio dei due campanili); e sia il Ministero della P.Istruzione che contestò
ed impose cambiare lo stile goticopisano perchè stonante a fianco del
rinascimentale eretto davanti alla villa cinquecentesca.
Fu eretta in
cemento armato; i lavori videro soste e sospensioni (per otto mesi nel 1927, tre nel 1928,
per mancanza di fondi anche se si era venduto la cappella di via DeMarini ai
Costa, ma il cui ricavato non potè essere utilizzato subito) e venne data incompleta nelle
rifiniture del tetto, della facciata, dei pavimenti, degli alloggil
Lo stesso arcivescovo, il 24 mar.1929,
domenica delle Palme, celebrò la solenne inaugurazione e benedizione
dell’effige della Madonna solennemente trasferita in processione dalla vecchia
chiesuola lungo via Chiusa; le fornì uno stemma col motto “Ave gratiarum
Mater”, dando continuità alla funzione parrocchiale ed inizio alla nuova
residenza. Il campanile non era ancora ultimato, avendo raggiunto 30 dei suoi
55m preventivati
La nuova chiesa, eretta in pieno ambiente di periferia di operai-piccoli
commercianti-donne di casa, diede da subito sicuramente un forte incremento
alla partecipazione alla vita parrocchiale, specie dopo il 1931 con la riapertura dei circoli e la soluzione
del contrasto con il regime: grazie anche alla decennale coadiuvazione con le
‘suore petrine’ per il catechismo, ed alle iniziative della varie associazioni
ospitate (per prima l’Azione Cattolica frazionata in vari circoli secondo l’età
e sesso; le Figlie di Maria fondata nel 1864; due ‘congregazioni’ (dal 1927)
chiamate ‘della dottrina cristiana’ e ‘della Madonna delle Grazie’).
Iniziative ricordate furono un corso di avviamento alla lettura del vangelo(1933);
istituzione di un asilo infantile a condizioni modestissime, spesso gratuite;
un bollettino mensile (dal 1922) con rubriche ad indirizzo personalizzato (tipo
con i ‘cari ammalati’) o culturali (letture di Dante e storia locale);
In data 3 mar.1932, il Comune deliberò concorrere alle spese per le rifiniture
della chiesa.
Il 27 maggio 1934 fu scelto perché
ricorrenza di cinquant’anni della nomina a parrocchia; si approfittò per
benedire le campane mentre in porto entravano in funzione l’Idroscalo e, a
monte, la Camionale; stava per aprire via ACantore ed un notevole fermento
nella zona portuale: nacque così l’idea di sovrapporre una statua della Madonna
sul tetto, a protezione di tutta la zona. Fu dato incarico al direttore
dell’Acc.Ligustica di BA prof. comm. Morera Antonio, di preparare il calco in
gesso, per –appena possibile- trasportarlo in fonderia.
La
statua fece trionfale ingresso in chiesa il 29 sett.1940; in contemporanea,
prese campo -con simpatia a livello nazionale- l’idea di associare gli
aviatori, marinai e motoristi-autisti in genere sotto la protezione della
Madonna, patrona del mondo meccanizzato e motorizzato (12mila iscritti alla s.Lega
dell’Angelus Domini L’impegno era di recitare tutti assieme la preghiera
dell’Angelus alle tre ore del giorno (matt-mezzog.-sera)). L’entrata in
guerra pose freno a tutte le cerimonie di dedica ufficiale ed alla ricerca del
materiale per fondere la statua. Fu invocata anche quale protettriuce nei
giorni di bombardamento..
Coesisteva un ingente debito con gli Stura (interessi, avvocati, tribunale, lavori sospesi e non
finiti).
L’11 maggio 1941 subentrò a parroco don
Alfredo Sozzi. Don
Schiappacasse fu inviato quale Canonico penitenziere della Metropolitana.
I bombardamenti degli anni 1943-44 furono causa di notevoli danni, deturpando degli affreschi
dipinti da GioRaffaele Badaracco e da Lorenzo Brusco posti nel catino, e
distrussero in maniera irreparabile un crocifisso ligneo.
Nel 1953 con la
riparazione dei danni di guerra, si riuscì ad iniziare le rifiniture: per
primo completare l’altare col polittico marmoreo in cui è inserito in trionfo
il quadro della Madonna delle Grazie; poi (1955) donarle il pavimento in marmo; gli
altari apicali laterali di s.Giuseppe e del Sacro Cuore, ambedue con statua
marmorea; gli altari di metà navata dedicati a s.Rita (a sin.) e Madonna della
Guardia (a destra); la via Crucis (1962).
L’8 dic. 1963
subentrò don Eraldo Susto che proseguì l’opera di ristrtturazione (Campanile: alto 56m. fu finito l’8 dic.1967, con
applicazione sulle pareti esterne di mattonelle rosso cotto e oro dorato; la
cella campanaria si apre all’resterno con quattro trifore gotiche bianche; la
guglia ricoperta di ceramica policroma capace di riflettere “lampi di luce
colorata”. Interni: con marmi alle pareti ed alle colonne; eliminazione del
pulpito trasferito a Rivarolo; spostamente del polittico marmoreo portato in
zona del coro; nuovi altari e strutture varie).
Il 19 apr.1980 la chiesa tanto rinnovata,
fu riconsacrata dall’arcivescovo mons. Siri.
Negli
anni 1955-65 tra le attività giovanili, la
parrocchia ospitava gli scouts dell’ASCI del gruppo Ge53. Poi il parroco,
evidentemente sconvolto psicologicamente e soggetto poi ad una triste ed
avvilente fine (1984), non tutelò sufficientemente questa attività, perdendone
i benefici.
Fu
sostituito, fino al 2001, da don Franco
Viganego; e questi, dal 2006?, da don Filippo Monteverde. Nel 2007 il parroco ha avuto l’onore della cronaca
per una antipatica situazione: l’apertura di una balera sotto le finestre della
sua camera da notte, con relativo chiasso notturno, hanno determinato uno stato
di stress tale da impedirgli di dire messa l’indomani mattina
L’edificio è tutelato dalle Belle Arti
ESTERNO La facciata doveva essere tutta in marmo dal progetto
definita ‘armoniosa ed elegante’; rimase invece allo stato grezzo che le dona
d’antico; possiede nel centro un grosso rosone tipico dello stile imposto
(romanico-gotico pisano), e sovrastante il portale a sesto acuto dovevano esserci
un timpano adorno di bassorilievo figurativo, nonché tre statue sacre sul
frontone. Il card. Minoretti voleva fosse apposta la scritta «Totius populi
labor et amor» ma, malgrado l’effetivo impegno del popolo, a facciata mai
ultimata, la scritta non vi appare ancora.
La
robusta porta, capace di isolare l’interno dai rumori stradali, è in
legno massiccio di teck, lavorata dalla scuola dei salesiani sampierdarenesi.
I
muri laterali, hanno le porte a sesto acuto pure loro, dovevano avere
delle loggette cieche nella parte centrale e delle bifore con vetri policromi;
e tra porte e finestre delle formelle a riquadratura mistilinea. Il tetto a
coronamento è spiovente e –nelle parti laterali- decorato con archetti pensili
INTERNO misura 43x20. La navata centrale è lunga 40m e larga 17
; ha un abside di 12m ; il tutto è alto circa 19m . La totale superficie è
suddivisa in tre campi rettangolari: i laterali, sono lunghi circa 10m e larghi
circa 4; sono delimitate da quattro grossi piloni rastremati e da colonnine
incassate negli spigoli. La volta ad archi acuti, prevedeva la possibilità di
essere arricchita nel futuro con mosaici o ornamenti dorati.
Fu
arricchito con tre altari principali: quello maggiore favorito con una
pala di autore ignoto raffigurante la “Madonna delle Grazie” che porta la
scritta “Diva Virgo del quartiere***” ; gli altri dedicati a san Giuseppe ed al
Sacro Cuore.
Il
campanile (progettato dall’arch. Ettore Mazzino), fu eretto negli anni
seguenti, è alto 54m., a quattro piani culminante con una cuspide piramidale e
le sue facciate decorate da finestre bifore e trifore; il tutto sormontato da una prima grossa croce lavorata, alta
4m.. All’inizio era stata progettata l’elevazione suprema di una statua della
Madonna che da lassù avrebbe tutelato l’idroscalo e gli aviatori in genere;
impedimenti vari -specie bellici- fecero optare per una croce che -a sua volta-
fu sostituita dall’attuale.
 area dell’idroscalo
area dell’idroscalo
Ha
un concerto di nove campane (nel 1934 erano sei, acquistate quando ancora non era stato
eretto il campanile: fuse con 8 q. di stagno in buona parte procurato dalla
ditta Nasturzo, e con 34 q. di rame in
buona parte donato dal parrocchiano benefattore GB
Bertorello, demolitore di una sua nave “Stella Maris”; furono lavorate
dalla ditta fratelli Picasso Matteo e Francesco, di Avegno vicino a Recco, e
collaudate dal maestro sac. Stefano Ferro, organista al’Immacolata.
Il provvidenziale supporto economico (35mila £.) di un
benefattore, permise completare campanile e posizionare le campane. Nel 1942 lo
Stato impose consegnare 2220 chili di bronzo.
La prima è in tono di “re grave”; pesa 1175 kg e porta
inciso le parole “in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti - cor Jesus
sacratissimum, adveniat regnum tuum”, e vari nomi di benefattori. Padrini
furono le famiglie Pizzorno (presid. della Fabbriceria) e la moglie Amalia
Lombardo.
La seconda è in tono “mi”; pesa 780 kg ; vi è inciso:” ave
Gratiarum mater Maria - sancte Francise e Paola - ora pro nobis“; fu dedicata
agli aviatori ed alla loro arma. Suonerà l’Ave Maria. Padrino il col.
Carnevali, comandante la prima zona territoriale dell’aeronautica.
La terza, in tono “si bemolle”, pesa 570 kg , ed è dedicata
a san Giuseppe: “Te Joseph celebrent agminam coelitum. Te cuncti resonent ...”.
Padrini la fam. Gardino Guglielmo.
La quarta, in “sol”, pesa 460 kg ed è dedicata alle anime
del purgatorio: ”requiem aetarnam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis
...”. Padrini la fa, Sanguineti Guido.
La quinta è in “la”, pesa 340 kg., dedicata a sant’Antonio,
san Giovanni Battista de’ Rossi, beato Francesco da Camporosso (conosciuto come
Padre Santo); porta una scritta invocante tutti questi santi. È uno dei santi –non comune ad altre chiese- venerato nella parrocchia
è rimasto dalle precedenti sedi. Padtrini la fa, Bertorello GB.
La sesta è in “si” e pesa 240 kg., dedicata a santa Caterina
da Genova, santa Rita e santa Teresa del Bambino Gesù, con preghiera a queste
sante. Padrini la fam. Masnata Romolo.
Nel 1941, in pieno
periodo bellico, il rev. Schiappacasse divenuto monsignore, lasciò le redini al
prevosto Sozzi Alfredo, il quale con l’aiuto
dei cooperatori don Ferrea E., don Bernasconi PL., don Piccardo E., proseguì il
completamento degli arredi, di cui il migliore fu (1953) un grandioso polittico in marmo, in cui venne inserito il
quadro della Madonna delle Grazie, e posto all’altare maggiore. Dietro esso fu
posto l’organo e lo spazio per il coro; si arredarono gli altari laterali
dedicati a san Giuseppe, a santa Rita (a sin.),
al Sacro Cuore ed alla Madonna della Guardia ( a
destra).
Dal 1961 al 1984
reggerà la guida di parroco, don Eraldo Susto;
il quale provvederà a grandi lavori di restauro in particolare la facciata, il
campanile (abbandonata
l’idea originaria della statua della Madonna, fu inaugurato l’8 dic.1967, rivestito di pietra e mattonelle di cotto,
che donano un colore oro-rosso-rosato, i singoli piani separati da spessori in
ardesia, la cella campanaria al sommo con trifore bianche in parallelo con la
componente in stile gotico, con la guglia rivestita di ceramica policroma, ed
all’apice la croce in ferro battuto alta circa 5 m., che dapprima era all’apice
della facciata principale) e l’interno,
rivestito di marmi (come
anche il leggio; alcuni altari laterali; la fonte battesimale -rappresentante
il fiume Giordano con i suoi 4 affluenti e sul cui bordo è incisa la frase: ”
dalla Croce zampilla l’acqua della salvezza: chi si immerge in questa onda non
incontra la morte. Chi è sepolto con Cristo, con lui rinasce alla vita”-;
spostati il polittico marmoreo in fondo, al posto del coro, e vari altari;
nonché eliminato il pulpito che venne trasferito in una chiesa di Rivarolo).
A sin., nell’altare marmoreo dedicato alla Madonna con
le Anime penitenti, è stato inserito un piccolo mosaico rappresentante un
angelo, proveniente dal Tabernacolo del precedente altare maggiore; e la statua
del sacro Cuore viene inclusa nell’altare del SS.Sacramento.
Vicino all’ingresso, venne posto in un altare un grande crocifisso in legno, di
pregevole fattura, la statua di san Giuseppe (che era in altro altare) e di sant’Antonio.
L’attuale parroco è don Viganego Franco,
che cura personalmente varie associazioni di fedeli, di giovani e della
confraternita di san Vincenzo.
===civ.45-47r: una testa
di montone appare come simbolo dell’attività commerciale sottostante (ora un
macellaio con insegna che richiama in dialetto: o maxella); in stile
neoclassico, rispecchia l’uso frequente di queste “insegne”, specie come arredo
esterno, simile anche se più semplice di quello della farmacia di via Cassini.
===civ. 25r
tabacchino Ferrando, dal Pagano /67
===civ.33r nel 1950 il Pagano segnala l’osteria di Ponassi
Maria
===civ.***
l’ultimo della via. ha sulla facciata graziose decorazioni di stile tardo
liberty, sia nel coronamento delle finestre che nella ringhiera di ferro
battuto ad archi intrecciati, dei terrazzi
A MARE
===civ.
2 Di fronte alla villa Pallavicino-Moro precedente, si aprivano le “Officine
Meccaniche Navali”, aperte nel 1898 da Salvatore
Bacigalupo: come tutti a quell’epoca, iniziò a lavorare giovanissimo
come disegnatore, acquisendo in breve la nomina di tecnico navale; intelligente
e tenace, volle dedicarsi totalmente nel 1898 a questo settore di attività,
organizzandosi -assieme ai soci Paselli e Bertorello- in maniera da ottenere
imbarcazioni di prima qualità ed all’avanguardia: fu uno dei primi ad adottare
il ferro-acciaio (i rimorchiatori detti le “barcasse”) e ad adottare la
propulsione ad elica ai piroscafi della Compagnia di Navigazione Grandi Laghi,
in servizio sui laghi del nord Italia.
Il
cantiere genovese era in ‘via san Bartolomeo’: quindi nei pressi; usando il
vallone quando in secca, i rimorchiatori completati, venivano di notte
scivolati su traversine di legno fino alla marina, e varati.
Diede
lavoro a molti operai, divenendo meritevole di considerazione internazionale.
Abitava in ‘via Vittorio Emanuele (via G.Buranello),
civ.10’. Cessò l’attività nel 1918, e morì nel 1932 a Crocefieschi.
Negli
anni 80 la sede (non citata nell’elenco SIP/1972) fu occupata dal Credito
Lombardo; poi da un mobilificio; dal 2007 circa dalla “residenza
protetta per anziani, san Benigno” (ingreso auto al civ.2; pedonale al 2D).


Ospizio suo
posteggio lato ferrovia
===civ. 4r: nel 1950 vi operava la FILEPS (fabbrica ital.
lampade elettriche portatili speciali) di Antonio Bagnasco.
===14r nel Pagano 1950 si descrive l’azienda Tubino
Arturo & Adriano di
metalli, rottami non ferrosi, stagno, piombo, zinco laminato in pani e lastre, ecc.
===civ 20r: presso la trattoria, è la sede dell’ “US
Dottesio calcio” , fondata
nel 1996 , iscritta alla FIGC, con colori sociali bianco-blu-azzurro-celeste ,
milita nella terza ===Civ 28r vi era negli anni della titolazione stradale,
uno dei due spacci della cooperativa titolata ‘C.Rota’ (l’altro al 53r.55r).
===civ.30Br negli anni 1950-70 e successivi, punto di
riferimento era l’officina di Molino Nicola, di vendita di trattori, pezzi di
ricambio per autocarri e vetture, nonché di demolizione auto.
categoria girone A e gioca nel campo Italo Ferrando a
Cornigliano.
Via D.CASSINI
===civ. r : l’ex sala Montecucco, descritta in via
Cassini.
===civ.16 apparentemente senza significato storico; il palazzo
termina con il civ. 62r
===civ.
18, proseguendo verso ponente, a sinistra della strada compare la villa Grimaldi - Sanguineti quale
viene segnalata sulla carta del Vinzoni, ma senza precise informazioni sugli
anni precedenti: solo dai caratteri architettonici, si può presumere una
origine cinquecentesca, munita di ampio giardino che arrivava di fronte alla
Fortezza alla crosa Larga, ed a sud si estendeva quasi al mare.
Sappiamo che Lazzaro Grimaldi, durante il suo incarico di Doge, ebbe autorizzazione
a trascorrere 12 giorni in pace nella sua villa di san Pier d’Arena. Non viene
specificato quale era; e in quell’epoca, oggi conosciute ve ne erano sette di
ville Grimaldi. Escludendo la Fortezza che all’epoca era in mano a Grimaldi GB,
poteva essere una qualsiasi delle sei rimanenti (questa, vDaste 4 poi Rebora;
vDaste 24 Gerace; Carabinieri; e quelle oggi distrutte Salesiani e Cristofori).
Perciò la descrizione viene inserita in questa villa solo perché è la più
vicina a Genova ed allora grande abbastanza da soddisfare un nobile molto
ricco.
Lazzaro
Grimaldi-Cebà: nacque
nel 1520 circa, da Domenico (fu un Riformatore delle casate
nobili nel 1527, ufficiale di moneta, finanziatore di una grande nave; senatore) e da Clara dei Calvi. Suo nonno, omonimo, era stato ambasciatore dal re
di Francia Carlo VIII e da Papa Giulio (rispettivamente negli anni 1496 e
1506). Quando sposò Marzia Centurione di Marco, ricevette il
3 dic.1573 il titolo di feudatario di Masone (con castello,
abitanti e boschi; giurando fedeltà alla Repubblica. Nel borgo costruì la
chiesa, si rappacificò con Campoligure allora feudo non genovese ma imperiale,
fissando i confini). Iniziò come diplomatico, divenne
procuratore della Repubblica e poi governatore (1571) e deputato alle gabelle
(1576). Nella diatriba del Garibetto, si schierò con la vecchia nobiltà e cercò
di difendere questa legge che le dava potere contro i nobili di recente nomina
di estrazione popolare. Durante la peste del 1579-80 non fuggì ma costituì il
magistrato della Misericordia ed occupò l’ufficio di Sanità
ricevendo consensi ed ammirazione. Per questo divenne anche Padre del Comune,
ambasciatore dal neoeletto papa SistoV, Protettore delle Compere di san
Giorgio, ed altre cariche di alta responsabilità.. Nel 1596, imperversando
grave carestia, di sua moneta comperò il grano, un intero carico di una nave,
per soddisfare sia Masone che Genova. L’anno dopo assurse a Sindacatore
Supremo; ed il 7 dicembre 1597 a Doge (36° della serie dei biennali) superando
il candidato dei Doria che non accettò la sconfitta giurando rabbiosa vendetta,
proponendo innumerevoli insolenze cerimoniali da urtare l’eletto senza
offenderlo direttamente, ma frustrando la sua pazienza. Così dovette chiedere
una sosta al Senato: contrariamente alla legge che obbligava alla residenza nel
palazzo Ducale per i due anni in carica senza poter mai dormirne fuori, gli
furono concessi 12 giorni da trascorrere a san Pier d’Arena. Rientrato, dovette
affrontare il pesante incarico di ospitare, per una decina di giorni ed a spese
della Repubblica, 1200 nobili in trasferimento da Venezia ed Austria verso la
Spagna (vedi alla villa Lercari di via N.Daste ove fu
ospitata Margherita la futura regina di Spagna e dove il Nostro andò a parlarle
(tramite un interprete), partendosi a cavallo da Genova col seguito di guardie
svizzere e di 350 nobili genovesi). Al pranzo, effettuato a Fassolo, il
Doria stesso ritornò ad aggredirlo con clamoroso e mordente frasario mirato ad offenderlo, accusandolo di aver disonorato la sua carica e quindi la
Repubblica avendo concesso che la regina fosse accompagnata dal contestabile
di Castiglia, governatore di Milano e non da sé, più alto in carica. L’amarezza
di questo attacco verbale, lo mortificò al punto di sentirsi male: dopo una
settimana, il 16 febbraio 1599, quasi sessantenne -e dieci mesi prima di finire
il suo dogato, morì presumibilmente di infarto-, proprio nei giorni in cui le
maestà ospiti levavano l’ancora. Due giorni dopo, le esequie furono condotte
con grande pompa portando dapprima il feretro in processione per la città, ed
infine dopo altri giorni di cerimonie ad essere sepolto in san Pier d’Arena
presso gli Agostiniani della chiesa di NS della Cella: nella cappella privata
di san Paolo, fu posto assieme al padre ed al nonno (il cui sepolcro porta la scritta “+Jesus Maria 1506. Die 11 Genoariis
Sepulchrum Nobilis Lazari de Grimaldis q. D.Dominici et haeredum suorum”). Il testamento fu assai munifico in beneficenza a tante categorie di
bisognosi (Agostiniani, Teatini, ospedale di
Pammatone, Incurabili, monasteri e poveri, nonché quattro amici in profonda
disperazione sanando i loro debiti). Avendo avuto solo una figlia,
Cassandra (che aveva sposato un Fabrizio Pallavicini ma che morì precocemente),
lasciò il feudo di Masone al nipote Paolo Agostino Spinola, figlio della
sorella Peretta e di Giovanni.
E’ questa villa probabilmente (oppure la Fortezza?), che viene citata perché
munita di cappella privata (sinonimo di distinzione sociale),
nel 1813 proprietà degli eredi del principe di Monaco (un Grimaldi quindi) e posta ‘in cima alla crosa Larga già crosa delle
Catene’ (quindi più a
levante della crosa Larga e quasi di fronte a mare alla villa Spinola).
Dapprima la ferrovia, poi l’attuale via G.Buranello tagliarono una grossa
porzione della proprietà compresa la torre che fu ovviamente distrutta per la
successiva lottizzazione del rimanente.
Nei
primi anni del 1900, fu acquistata dai Sanguineti, per essere utilizzata a
fabbrica di conserve. Fu poi tramutata in due distinti edifici adibiti ad
abitazione, cosicché oggi è divenuta nascosta, in maniera pressoché totale, la
sua origine di villa.
Nel
Pagano/67 persiste l’esistenza dell’azienda Sanguineti
L&C di conserve alimentari e lavorazione latta. Fu il nonno delle
attuali ancora in vita (91 enne) che aprì la manifattura della latta;
acquisendo il palazzo, viene narrato che trovarono dentro il quadro della
madonna che ora è appeso nell’angolo di vico Grandis (scelse così per
protezione della sua azienda ed anche perché tutta la zona era devota a questa
Madonna, e nell’occasione faceva una sagra con luminarie e banchetti di dolci e
prodotti agricoli)
civ. 62Ar Il palazzo
finisce con questo civico.
Vico Grandis
Il
palazzo dopo, verso ovest, non ha portoni neri ed ha ancora due civici rossi 64 e 66r. La strada finisce all’incrocio con la
seguente:
Via Palazzo della Fortezza
DEDICATA al
tipografo nato nel 1814 a Como. Da adulto si trasferì a Capolago ove era
divenuto direttore della Tipografia Elvetica di Capolago, il più importante
centro editoriale dei testi degli scrittori romantici e
dei patrioti della prima metà del Risorgimento.
Prese parte alla campagna militare del 1848 schierandosi con i piemontesi e
mettendosi però in evidenza negli schedari della polizia.
Favorito dalla vicinanza con la Svizzera e con lo spirito cospiratore contro
l’Austria, introdusse in Lombardia e –di qui nel Veneto ed in Italia- scritti,
volumi, articoli, messaggi patriottici dei fuoriusciti Guerrazzi, Berchet,
Rossetti, ecc.
Arrestato dalla polizia austriaca a Maslianico, dopo un lungo processo fu
giudicato colpevole di alto tradimento e, condannato a morte, fu impiccato a
Venezia l’ 8 ott.1851.
BIBLIOGRAFIA
-A.sconosciuto-Dattiloscr.
parroc. s.Gaet.-d.Bosco-pag. 38.59.84.94.140
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi-ed./94-pag.402—ed./02-pag.440
-AA.VV.-opuscolo
della parrocchia
-BricolaGrosso
R.-La parrocchia di SMdGrazie-Status.2004-
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari 2001-pag.47
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese : 3/72.9 + 2/75.8 + 9/93.7 +
-‘Genova’
rivista municipale: 12/28.678 + 4/32.398 +
-IC,
Il Cittadino-settimanale- del 04.06.06 + 07.10.97 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 27
-Levati
PL.-Dogi biennali-Marchese e Campora.1930-vol.I-pag.251----------Medulla
M.-Sampierdarena-DeFerrari 2007-pag. 12
-Mignacco-protagonisti
del calcio genovese-DiVincenzo-2001-pag.133
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.106
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto
b.Berio.1900-pag.34.35.36
-Pagano/40-pag.277---/1961-pag.192.577
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.439
-Poleggi E. &C.-Atlante di
Genova-Marsilio.1995-tav.51
-Ragazzi F.-Teatri storici in iguria-Sagep.1991-pag.218
-Remedi A.-ricerche storiche personali-2010
-Roscelli D.-Nicolò Barabino-soc.Universale.1982-pag.156
-Stringa P.-La Valpolcevera-Agis.1980-pag.91-2
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.98
-Veneruso
D-Azione pastorale e vita relig. ...-SocLStPat.1990-pag.254.258


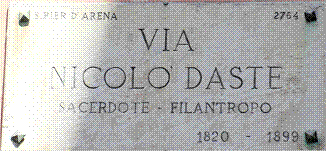 sommità di via Gioberti
sommità di via Gioberti





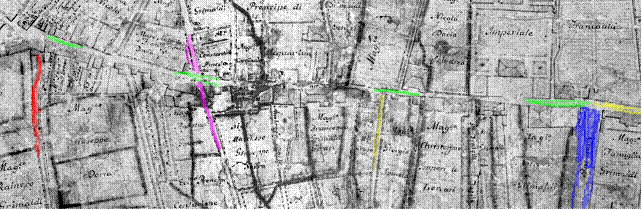


 da Google Earth, 2007. Da rossa, via
S.Canzio a fucsia via Palazzo della Fortezza.
da Google Earth, 2007. Da rossa, via
S.Canzio a fucsia via Palazzo della Fortezza. .
. 































































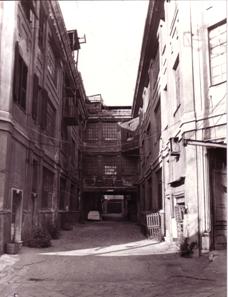











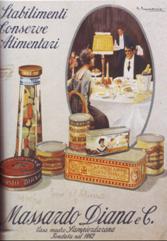















































 .
.





































 Durante
l’occupazione francese del Piemonte visse l’infanzia esule a Firenze, poi a
Napoli; venendo severamente educato dal padre sia fisicamente che nel
controllare le emozioni e ad erudirsi.
Durante
l’occupazione francese del Piemonte visse l’infanzia esule a Firenze, poi a
Napoli; venendo severamente educato dal padre sia fisicamente che nel
controllare le emozioni e ad erudirsi. 




















 da google Earth 2007.
da google Earth 2007.



 PRESEPIO–bozzetto dell’Adorazione dei Re Magi.
PRESEPIO–bozzetto dell’Adorazione dei Re Magi.












 fare panoramica e dire
dov’è
fare panoramica e dire
dov’è

















