GHIGLIONE piazza Antonio Ghiglione
TARGHE:
San Pier d’Arena – piazza - Antonio Ghiglione – patriota - secolo XIX piazza Antonio Ghiglione – patriota – sec. XIX - già Piazza dei Mille


angolo con via Currò

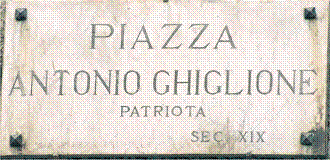

centro piazza


angolo con via Currò
QUARTIERE MEDIEVALE: san Martino
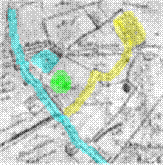 da MVinzoni, 1757. In celeste via CRolando
con posizione dell’Oratorio e pieve di s.Martino; giallo via Currò; verde
ipotetica posizione della piazza.
da MVinzoni, 1757. In celeste via CRolando
con posizione dell’Oratorio e pieve di s.Martino; giallo via Currò; verde
ipotetica posizione della piazza.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2781, CATEGORIA: 3.a
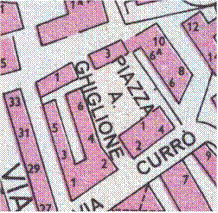
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 29160
UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
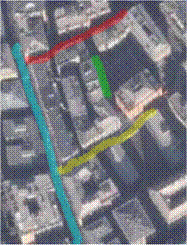 In blu, via C.Rolando; in giallo via
Currò; in rosso, via C.Bazzi, in verde la piazza A.Ghiglione. Da Google heart,
2007.
In blu, via C.Rolando; in giallo via
Currò; in rosso, via C.Bazzi, in verde la piazza A.Ghiglione. Da Google heart,
2007.
CAP: 16151
PARROCCHIA: san Giovanni Bosco e san Gaetano
STRUTTURA: da via Carlo Bazzi (una volta chiamata“via Marsala”) a via Currò, con doppio senso veicolare.
In realtà è una via, e non una piazza (essendo lo spazio totalmente occupato da un edificio con civ.15, ad un solo piano, adibito a civica palestra, chiamata ancora nel 1961 “dei Mille”, gestita dalla soc. Ginnastica Sampierdarenese (nel 1891, tempo della nascita della società di ginnastica, la palestra già esisteva nella piazza allora intestata ai Mille; dovettero andarsene dopo poco, per ritornarvi nel 1901 nella palestra riedificata (pagando lire 5000 di affitto annuo); fino al 1906 , quando si trasferirono nella palestra allegata alle scuole gen. A.Cantore, con entrata da via B.Agnese); la sede da allora divenne per un certo periodo una trattoria detta “del Canto”; finché alla fine dell’esercizio definitivamente fu riservata all’attività fisicoginnica.
Non specificato da quando, l’edificio ‘Palestra dei Mille’ è vincolato e tutelato dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Liguria
Nel 1926 fu deciso sistemarvi il mercato rionale (questi esisteva in piazza dei Mille, ove era stato istituito in seguito alla soppressione dell’altro di piazza Vittorio Emanuele III, e che doveva sopperire alla prevista soppressione di quello di via Arnaldo da Brescia). Il che poi non avvenne.
L’intitolazione della piazza al patriota avvenne quindi il 19 ago.1935 per delibera del podestà.
CIVICI
NERI 1 e da 2 a 6
ROSSI da 1r a 23r e da 2r a 24r
===civ.8 : fu soppresso per distruzione dell’edificio nel 1952
===civv.rossi : dal 20 al 24 furono assegnati a nuova costruzione nel 1952 mentre il 21 e 23, come sopra nel 1953.
Nel Pagano/1940 già era così, da via Currò a via C.Bazzi, con eguali civici neri e, nei rossi una latteria =3r, fruttivendola 4r, legna e carbone 7r, commestibili 10r, osteria 14r, commestibili 18r; in più la Palestra Ginnastica dei Mille” senza civico.
DEDICATA al patriota italiano nato a
Genova il 5 apr.1813, da Antonio ed Anna Borzone.
Frequentando il “collegio reale”, corrispondente alle scuole medie odierne, ebbe come compagni di scuola G.Ruffini, F.Campanella ed il Rosazza: tutti giovani che per primi divennero seguaci di G.Mazzini con cui il Nostro fu compagno universitario in Legge. Con Mazzini in persona si incontrò senz’altro in facoltà, ma decise poi di non terminare gli studi tralasciandoli per gli impegni guerrieri ed una più ardente passione per Lettere.
Aderì tra i primi alla Giovine Italia (quindi molto probabilmente fu carbonaro), ed aiutò l’organizzazione del moto insurrezionale che messo in pratica l’ 11 feb.1834 , fallì: dovette fuggire a Marsiglia e da là a Berna ospite di Agostino Ruffini, ricercato dalla reale polizia. Ragazzo un po' chiuso ma intraprendente, riuscì a sopravvivere usufruendo di un prestito fattogli dalla marchesina Laura Spinola DiNegro, e dalla vendita di una proprietà che aveva nel borgo e che gli fruttò 12mila lire, raccolti dalla mamma del Ruffini.
L’anno dopo essendo nata il 31 marzo a Berna la “Giovine Europa”, sulla scia della Giovine Italia rappresentata dal Mazzini stesso, Ruffini con Melegari ed altri ne sottoscrissero l’adesione rinunciando alla carboneria; e nel 1834 fu inviato a rappresentarla a Zurigo in una grande manifestazione politica organizzata dal solidalizio europeo. Negli spazi di tempo, scrisse il suo prima dramma storico “Alessandro de’ Medici Duca di Firenze”, e collaborò alla rivista “l’Italiano” su cui pubblicò un altro suo dramma : “La testa mi trascina il cuore”)
L’anno dopo ancora, sempre inviato da Mazzini, si portò di nascosto a Napoli per considerare di persona se la piazza era matura per un moto rivoluzionario contro i Borboni; il suo parere evitò un ennesimo fallimento insurrezionale. In tutte queste peregrinazioni, non sfuggì all’occhio delle polizie, anche di quella francese che lo tenne arrestato per un mese ed infine espulso (ma questa estrema condanna, fu alla fine annullata). Però, aveva finito i soldi, e la madre non poté aiutarlo ulteriormente (forse perché non ne condivideva le idee e forse perché risposata).
Cacciato col Mazzini dalla Svizzera, si trasferirono a Londra fino al 1843 quando preferì tornare in Francia sopravvivendo col dare lezioni di italiano.
Durante la Repubblica romana (30 apr.1849) rientrò in Italia con l’incarico di ‘commissario di guerra’ ma preferì combattere attivamente pur essendo ‘balusante negli occhi’ al punto di ‘dover inforcare velocemente gli occhialini ogni volta prima di sparare e poi speculare se aveva imberciato giusto il tiro’; una palla francese riuscì a colpirlo nei glutei e metterlo a riposo sino alla conclusione della prima guerra d’indipendenza.
Ricuperato dalla ferita riuscì a sposarsi ed avere una bambina. Emigrò con la famiglia in America, ma non sorridendogli la fortuna, tornò nel 1855 in Italia tentando di pubblicare senza successo novelle ed opere drammatiche; fu in quegli anni (1856) che a Genova pubblicò una novella in versi “Simone Kenton”, stampata dall’editrice Moretti.
Durante la seconda guerra di Indipendenza, riacquistò direttamente da Garibaldi il ruolo di commissario di guerra, svolgendo il suo ruolo con onore.
Partì con i Mille nella spedizione Medici, battendosi nelle varie battaglie sino a Capua; si meritò la croce di san Maurizio e Lazzaro, il grado di colonnello ed il titolo di cavaliere.
Quando l’Italia fu finalmente unita, si ritirò dalla vita politica e militare dedicandosi a scrivere opere letterarie drammatiche senza però una particolare fortuna, né espressiva, né economica; nel 1883 pubblicò il dramma in versi “i Trecentisti” .
La burocrazia del regno, malgrado l’interessamento degli amici - specie di Raffaele Rubattino - non riconobbe il suo stato di servizio, né invalidante la ferita subita (non essendo compresa nelle categorie che davano diritto alla pensione), costringendolo con una miserrima pensione a concludere la sua esistenza in maniera tristemente modesta; nella miseria più nera, ma con le benemerenze della Patria unita.
Il suo lodevolmente poco, è riconosciuto dalle enciclopedie, che lo ignorano.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale – Toponomastica
-AA.VV.-Annuario guida archidiocesi anno/1994-pag 409; /2002-pag.446
-AA.VV-SPdArena nella sua amministrazione fascista-Reale.1926-pag.71
-Enciclopedie Motta, Sonzogno, Zanichelli
-‘Genova’ rivista municipale - : 1/38.27
-Lamponi M- Sampierdarena- LibroPiù.2002-pag. 136
-NovellaP.-Guida di Genova-manoscritto 1930-pag.17
-Pagano/1940-pag. 299; /1961-pag.226-577
-Pastorino&Vigliero-Dizion. Delle strade di Genova-Tolozzi 1985-pag.849
-Poleggi E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio 1995- tav. 21
-Tuvo Campagnol-Stoiria di Sampierdarena-D’Amore 1975-pag.283