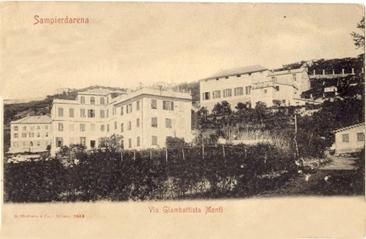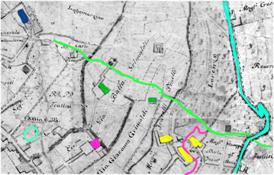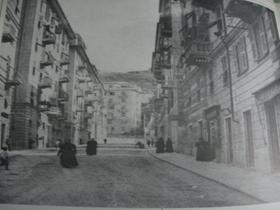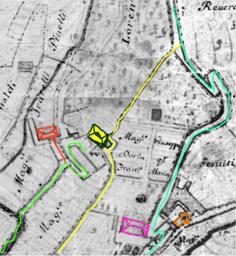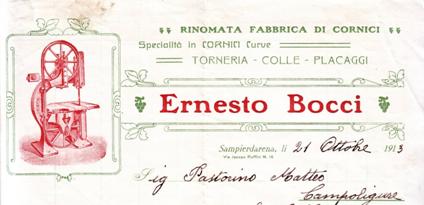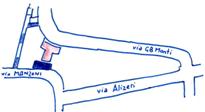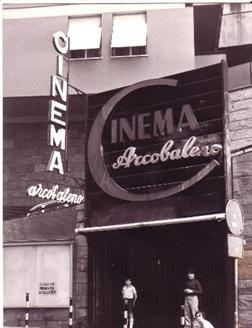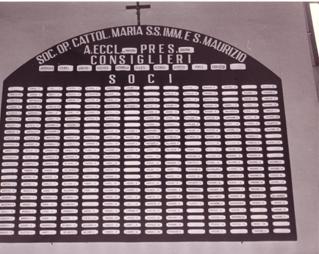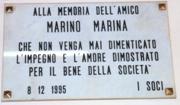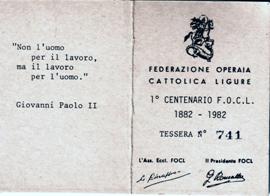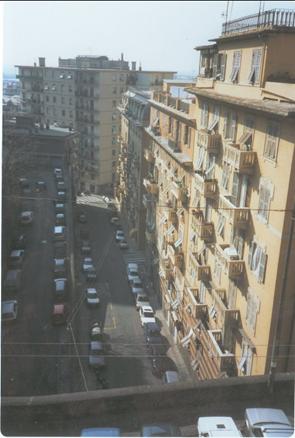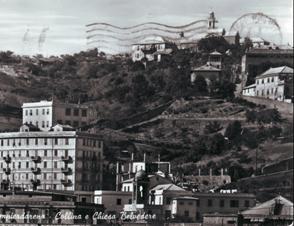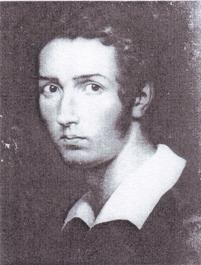Nel
1910, nei fogli comunali viene chiamata “via Gio Batta Monti, da via N.d’Aste
(sic) verso la collina”, con numeri civici sino al 30 e 21 (ma diversi dagli odierni); e con questo nome le fu posta la targa all’inizio
della salita.


--foto viaggiata nel 1912 --
Nelle
prime decadi dello stesso secolo (ancora nel 1933 quando non esisteva via A.Cantore), viene descritta aprirsi da via N.Daste, “verso i
monti”; praticamente finiva poco dopo ove ora è la chiesa.
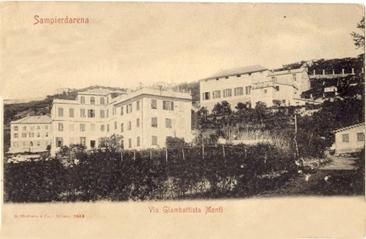
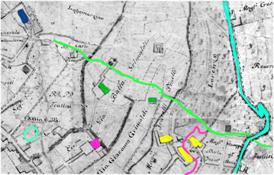
=foto (a sinistra) di via GB Monti (a destra in violetto) quando
– nelle prime decadi del 1900 - ancora si ‘perdeva’ in alto sulle falde della
collina. Tutti edifici poi abbattuti: in alto ed al centro in primo piano, il
collegio Dogliani (nella foto a destra, in giallo). All’estrema sinistra una
villa seicentesca che – in base alla posizione – potrebbe essere (nella carta a
destra) la villa verde dei Moro.
 1923
1923
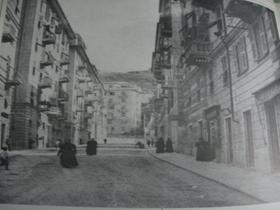
Nel
Pagano/40, la strada è compresa tra via A.Cantore e sal. Belvedere ed
ha, senza numero civico la
chiesa Adoraz.Perpetua; nei civv. neri privati e al 22/1 Ass.Prov.Cacciatori;
23 Tardito G. latta; 25 Stura V. ing.; 36A canc.: ‘casa Famiglia del sacro Cuore.Orfanatrofio
femminile’ e ‘Lavori femminili’. Nei nn.
rossi: senza civico, una
latteria posta “nel casotto rimpetto al 24 nero, Barabino”. Rossi dispari= 1r mat.elettr.Arnaldi; 5r drogheria; 9r maceller.; 11r
merceria Provinciali; 13r polliv.; 15r mode; 17r ottoniere; 19r commestib.;
21r latteria; 23r farmacia dott. Rolando; 25r drogheria; 31r bottiglieria; 33r commestib.;
41r drogher.; 43r offic.elettromecc.; 45r bazar; 49r fruttiv.; 55r parrucch.;
57r stirat.; 59r osteria; 63r giornalaio; 65r Tipo litograf.Don D’Aste (sic).
pari = 6r confez.; 10r bottigl.;
14r soc.an.coop.Carlo Rota commestib.; 16r osteria; 20r legna e carbone; 34r
commestib.; 38r stirator.; 42r bottigl.; 44n comm. (sic); 46r fruttiv.; 48r
macell.; 52r parrucch.; 54r mercerie; 56r commestib.; 58r bicicl.; 70r
commestib.; 74r commestib.; 78r maceller.; 82r fruttiv.; 84r tabaccheria; 88r
parrucchiere; 90r calzol.; 94r latteria.
CIVICI 2007
UU25=NERI
= da 1 a 27 (compresi 5A, 7AB, 23A; mancano 11, 13, 15, 29, 31)
da 2 a 48 (manca 22)
ROSSI =da 1r a 181r
(compresi 13A, 39CD,
63B, 177AB; mancano 67, 157)
da 2r a 108r
(compresi 60rAB, 92rA,
94rABC, 100rAB;
mancano 80r,
82r, 102r)
UU27 = NERI = da 29 a 31 da
50 a 60
ROSSI
= il 183r dal 110r al 146r
Nel Pagano 1911-12-25 compaiono sul Pagano (tra parentesi, l’ultimo anno in cui
compaiono) le levatrici (ricordando che allora il parto avveniva in casa. Al civ. 2 Cambiaso Maria
(1912), Zerbino Margherita (1925), Forno Angela (1925) - ed all’8A-10 la
Galletto Giuseppina (1925); al 20r Dellepiane Agostino (1933) ha una
fabbrica di acqua gassosa. civicoNonPrecisato una impresa trasporti di Grosso Luigi (1912) (che l’anno
prima era presso il Ponte di Cornigliano; nel 1920 è descritto in ambedue le
sedi con tel. 2306; nel 1921 non c’è più); il meccanico Pastorino Romolo (1912) (proveniente -1911- da p.za dei
Mille);
Si descrive esserci stato nella via in tempi successivi (dopo 1925: sul Pagano/25 non c’è), un’altra scuderia di cavalli, della ditta Lanati (ebbe in affitto i cavalli di Casirola
Carlo impresario di trasporti mobili e merci con stalle in corso dei Colli 31,
sampierdarenese del 1878, morto a Dachau, anche lui deportato
il 16 genn.1944)
Questa titolazione stradale esisteva anche a Rivarolo; nella unificazione della
toponomastica del 1926 nell’ambito
della Grande Genova, la nostra città fu favorita nel mantenimento del nome (nella nostra vicina, è divenuta via
S.Botticelli).
Il Costa del 1928 segnala questi
esercizi commerciali. Al : 5r= drogheria di Serafino Andrea---9r= macelleria Roncallo
Giuseppe---15r= merceria Collin&Pittaluga---10= vini
di Facco Teresa---11r= merceria di Garrone Livia---13= pollivendolo Castaldi
Benedetta---16= vini di Ivaldi Tomaso---17r=
calzature di Gavelli Salvatore---18= lavorazione latta di Noce Gaetano---20r= acque
gazzose dei f.lli Dellepiane---22= puleggie di Almonte Cesare---23r=farmacia Rolando Paolo---23= lavorazione latta di Tardito Giacomo e F.---33= commestibili di
Giglio Amalia---34= commestibili di Ferraris Maria---42= vini di Sella Mora---44r= salumiere Costa Amilcare---46=
fruttivendola Cipollina Giuseppina---52r= latteria di Masè Giovanna--- 54r= chincaglierie
di Merlo Emilia---56r=sartoria Rigamonti Amedeo---58r=commestibili di Quaglia
Maddalena---70r= commestibili di Cavalli Francesco---84=commestibili di Rosellini
Emma---86r= mobili di DiClemente Pietro---- non precisato= cordami di Lancerotto
Ernesto (anche in 2r-scalinata Pisacane)-
Nel 1933 appare di 4.a categoria,
ancora indefinitamente indirizzata “ai monti”, con civici neri sino al 48 e 25.
Al civ.2-9 Piccardo
Francesco eserciva armi e munizioni; al civ.35r
c’era la fabbrica di
calze di Veruggio Antonio; al 53 il Consorzio Agrario aveva una
latteria ed al 53r c’era l’azienda di Fava & Roccatagliata di rottami metallici.
Nel Pagano 1950 viene segnalata una
osteria al 16r di Minetto
A. e tre bar: al 10r di Bocca A.; 31r di Tacchino G. ed al
42r di Zaccone Angelo. Nessuna trattoria.
 inizio salita, anni 70
inizio salita, anni 70
===civ.1 il palazzo fu eretto al posto della casa
dell’Istituto Tecnico che reputo corrispondere alla (multifunzionale) ‘villa Boccardo’
descritta a via Mercato e, come
dimostrato dalle foto sopra, che c’era ancora nel 1905.
===civv
dal 3 al 9: Il cav. Narizzano
Alberto nell’ago 1898 vende un terreno coltivo ad orto, con casupole coloniche,
ad Emanuele Palau (già proprietario di altri vasti
appezzamenti di terreno posti a ponente dei confini della villa Doria-donDaste
(vedi civ. 74r; ed anche in via G.Mameli);
da lui -ancora regnando UmbertoI - gli imprenditori sigg. Parodi Luigi e Gambaro
Giuseppe (proprietari
anche in via Mameli di immobili), acquistarono nel lug.1899 un’area di 500 mq posta
a levante di un vialetto interno della proprietà, per erigerci i palazzi
attuali (arch.ing.
Salvatore Bruno; iniziò la costruzione dal 3, poi il
7(ex 3a - finito nel dic.1901) ed il 5(ex 3b) ; completando il 9 (ex 5) nel
1903); firmarono accettazione di alcune clausole sindacali quali il riposo
festivo per gli operai). La parte di
terreno rimasta a levante rispetto le case, entrò a far parte della piazzetta
nel retro delle scuole Tecniche; e quella confinante con la strada principale,
tramite il vialetto su accennato di accesso (già esistente ed
iniziante dalla ‘via del Mercato’ via con il passaggio
sotto un’arcata tesa tra il palazzo delle scuole a levante, nel sito
dell’attuale civ.51*** di via A.Cantore, ed una casupola affacciata sulla via
principale a ponente ). Questo vialetto
fu donato al Comune gratuitamente in cambio delle fognature, illuminazione,
orinatoi e lastricamento della via, con l’impegno di allargare l’ingresso a 7
metri di larghezza (abbattendo
arcata e casupola) e di fornire
marciapiedi con bordo in pietra della Spezia. Ovviamente i vari appartamenti
furono venduti solo a privati agiati cittadini, (essendo proibito l’uso
industriale dei fabbricati) alcuni dei quali firmarono con la croce essendo
possidenti, ma analfabeti (“illetterati”,
come nel 1907 una certa Gestri Rosa che poi venderà l’interno 11 del civ 3B,
ora 5, a Desimone Margherita e Bianco Adele). (vedi
cartina).
===civ.
9 Si descrivono essere esistite
delle ampie cisterne, come d’altronde d’uso nei tempi dell’erezione, legate al
fatto che non esisteva un acquedotto singolarmente diffuso. Nello stesso
stabile (e forse anche al 5) le persiane chiuse sopra il portone, non
corrispondono a finestre ma sono solo decorative.
Con
queste costruzioni, ha praticamente delimitazione definita e quindi nascita,
la via G.B.Monti.
===civ.16r: una lapide
e corona bronzea, poste tre anni dopo (21 nov.1982) ricordano e ribadiscono il
‘no’ della cittadinanza al terrorismo, l’assassinio a tradimento di due
carabinieri: il maresciallo Vittorio Battaglini ed il carabiniere scelto Mario
Tosa. Il mattino del 21
nov.1979, mentre nel bar -allora chiamato “Angelo”- prendevano un caffè, ignari
di qualsiasi agguato, furono barbaramente trucidati, colpiti a bruciapelo alle
spalle da due affiliati delle Brigate Rosse (vedi i singoli).
===20r nel 1931-4 c’era lo ‘Stabilimento Industriale Grafico
/ Tucci-Conticini-Repetto / tel. 41-854
===civ. 23r: la farmacia Rolando: (sul Pagano/20 non c’è) appartenuta inizialmente al dr. Paolo dagli anni 1921, con tel. 41342, pare fino al 1960 quando gli successe il figlio
Emilio laureatosi nel 1928. A questi ancora il nipote Paolo deceduto
prematuramente nel 1998 (fratello
del professore Maurizio oculista, e di Massimo farmacista in via Cecchi).
===civ. 7Ar = per
anni, sino al 2000 circa, sede di un mobilificio: primo (ed ancora nel 1967)
usato come deposito da Gaetano Sabatino, vero ebanista, che fabbricava
personalmente mobili in via Bombrini ove aveva la falegnameria e che poi
vendeva in questa sede. Dopo di lui, negli anni ’70, i locali furono occupati
dal mobilificio Aloisio (un po’ scadendo in qualità).
===civ.
6:
===civv.
8-10-12: costituiscono un unico
edificio, graziosamente affrescato nel sottotetto ed attorno alle finestre, con
festoni di fiori e frutta.
===civ.
11: non esiste più. Era forse la
casa dei Landi?
===civ.15: chiesa di N.Signora
del SS.Sacramento. Coronando un disegno di mons.Paolo
Fossati, dopo averlo idealizzato per tanto tempo, l’ 11 mag.1930 l’arcivescovo di Genova, card. Boetto (il
Cittadino scrive Minoretti anche per la prima pietra), pose la prima pietra
-contenente una pergamena scritta dalle suore Pietrine- della nuova erigenda
chiesa, che sarà gestita dagli “Oblati” (sacerdoti istituiti dallo stesso mons.Fossati, che
inizialmente erano soli presbiteri, nel 2007 sono 10 e si distinguono per due
obblighi in più rispetto i sacerdoti ordinari: il voto dell’obbedienza totale
al proprio vescovo, e la dedizione all’adorazione ed all’apostolato
eucaristico; per questo, il tempio è anche chiamato “ della Adorazione
Perpetua”, il primo in Italia ad avere questo
nome. In una apposita cappella, alla quale si accede dal cancello a monte ella
chiesa, numerosi volontari si alternano giorno e notte –per ottemperare
all’aggettivo ‘perpetuo’ - per continua ed ininterrotta preghiera.
Personalmente ho constatato su taluni devoti la presenza di grossolane
callosità sulle ginocchia per permanenza in quella posizione).


Fu
innalzata nel terreno che faceva parte dei giardini della villa Doria -ora don
Daste (vedi salita
Belvedere)-, e la consacrazione avvenne
il 16 giu.1936, alla presenza del card.
Minoretti; nell’autunno dello stesso anno gli Oblati si trasferirono
definitivamente nella casa, costruita a ridosso, posteriormente alla chiesa.
Alla
guida della chiesa, a mons. Fossati seguirono mons. Giovanni Pedemonte, poi
mons. Giuseppe Mario Carpaneto, mons. Stefano Patrone, ed ora è in servizio don
Nazario Caviglia.
Dal
16 luglio 1961, a firma del card. G.Siri, si
programmava una nuova zona parrocchiale; essa fu concretizzata il 15 ago
quando la chiesa divenne parrocchia
Il
14 dic. 1986 il cardinale Siri celebrò il rito della
dedicazione dell’altare.
Ideata
in stile misto (gotico-romanico-lombardo) dall’arch. milanese prof. Zacchi Adolfo, addetto alla conservazione e
restauri delle opere del duomo di Milano e
sotto la direzione dell’ing. Musso, fu affidata al Vernazza la direzione della
decorazione pittorica -aiutato
dal prof. U.Signorini per la parte ornamentale-. Fu usato per la facciata, del travertino di Rapolano (Siena).
Nella lunetta sotto il portale centrale, un bel mosaico raffigurante la Madonna in adorazione, prodotto dal
veneto Salviati; riproduce fedelmente un disegno su cartone di Angelo Vernazza; sopra, gli altorilievi del Cristo tra due apostoli evangelisti affiancati
dai loro simboli (i simboli sono ripetuti ai lati del grosso rosone); sopra sei
monofore, in alto sotto il simbolo della
Congregazione c’è la scritta CUM***
MAGNUM DOMINUM VENITE ADOREMUS.

 A.Vernazza la
scritta recita “ Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”
A.Vernazza la
scritta recita “ Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”

frontale - foto Pasteris 1937
All’interno,
stupiscono le tre navate, per la fuga di volte che si intersecano, per gli
archi poggianti su superbe colonne (di granito di Baveno dai capitelli che furono lavorati a fogliame comprendente la Croce ed
altri simboli, con marmo bianco di Botticino (Brescia)); per le vetrate (su disegno del prof. Zuccaro, alcune
dipinte ed altre a piccoli tondi celestini furono eseguite dalla ditta milanese
Corvara & Bazzi (subirono gravi danni durante i
bombardamenti nell’ultimo conflitto causa spostamenti d’aria di bombe cadute
vicino)). Le lesene, sono anch’esse di granito di Baveno. Sulla parete
di fondo e nel lacunare sottostante, c’è un affresco di Angelo Vernazza:
questo lavoro nella chiesa fu l’ultima sua opera dove, essendo il pittore
sorretto dal una fede profonda, rivelò le migliori qualità del suo ingegno
nelle interpretazioni di soggetti religiosi (sampierdarenese, nato il 28 aprile 1869 da modesto
commerciante, ultimo di una nidiata avviata al commercio. Di tutti i figli, lui
unico si mostrò insofferente a questa dottrina, prediligendo l’idealismo, la
poesia, la spiritualità. Questi sentimenti crearono un pesante contrasto con i
suoi, mantenuto solo dall’alto senso della famiglia e del vincolo di sangue, ma
a prezzo di una perenne mestizia, di un fondo melanconico, di un rigido
autocontrollo. Dopo l’accademia Ligustica, con la borsa di studio andò a
Firenze alla scuola di N.Barabino, il quale intuì le sue capacità e lo apprezzò
come il migliore dei suoi allievi. Fu ricambiato da una fedeltà a tutta prova,
da un umile continuo osanna all’ombra del maestro. Poi, da Firenze andò a
Parigi, Londra, Venezia, studiando ed imparando, al punto che, tornato a
Genova, fondò una sua scuola d’arte in via XX Settembre nel palazzo delle
Cupole dove – motivato da una passione interna molto forte - cercò di insegnare
a dipingere usando - come Barabino - un metodo che richiedeva - nell’allievo -
una eccessiva rigidità etica e morale, tale da tendere ad imprigionare anche la
fantasia e la libertà espressiva (chiamava aberrante o traviante la recente tendenza a
maggiore libertà; la quale invece - attraverso ai primi dipinti impressionisti
- cercava di liberarsi da quelle stesse leggi che lui invece giudicava
superiori e dominanti).
Le sue opere venivano richieste da una committenza sempre
più numerosa, specie dalla società ligure, fortemente ancorata alla tradizione:
oltre ad affreschi (al Calasanzio, a villa Hambury di Ventimiglia, al
santuario di Oregina, alla Cella (una “scena biblica” posta nella canonica ed un affresco
nella arcata centrale))
frequente era la richiesta di ritratti (in epoca in cui non esisteva
ancora la fotografia) e di paesaggi, con Portofino meta preferita,
culminati nella meraviglia del panorama di Belvedere (1916).
Quindi un grande maestro dell’emozione e del sentimento
nell’arte pittorica, con tanta e profonda religiosità, ma altrettanto eccessiva
rigidità che nel tempo è risultata perdente di fronte agli impressionisti, ai
“grigi” ed all’evoluzione della libera espressione tipo Picasso. Il massimo del
concesso fu qualche sconfinamento nel liberty.
Sappiamo che per la sua dirittura morale, era assai
spesso usato dal Comune locale per consulenze, come per esempio sostenere la
produzione artistica di Dante Conte con sovvenzioni. Fu forse questa –non
appartenenza, ma- vicinanza con l’ambiente politico che fece peggiorare
la sua figura d’artista: avvenne che quando il fascismo gli presentò l’ideale
simbolico della redenzione della Patria, lui abboccò creando un bellissimo san
Giorgio che uccide il drago, con la pecca che il santo veste la divisa di
soldato della nuova milizia. Come per Massiglio, aver vissuto in epoca fascista
e forse aver forse prodotto disegni a loro uso, gli è valso sino ad oggi un
significativo silenzio (per ambedue, non ci sono prove di stretta
collaborazione col fascio, ma…).
Rimasto vedovo dopo 35 anni di vita coniugale, dopo un
anno morì anche lui sfibrato dal dolore, a Genova il 3 maggio 1937).
In contrasto con la semplicità e nudità delle navate laterali, l’abside centrale
accentra il massimo fastigio: sull’ altare maggiore, il simbolo di un trono dorato e ricco di pietre
preziose, su sei colonnine di marmo, per l’esposizione solenne del Santissimo;
sulle pareti altro affresco del Vernazza che divise la volta in due piani
soprastanti: in alto nel timpano, coronati da cinque cherubini, sei angeli
sorreggono dei serti floreali ed un cartiglio con scritto “GLORIFICAMUS TE”; e veleggiano -significando l’apoteosi del volere
divino- in un cielo chiaro e tenue, interrotto da nubi leggere. Nel sottostante
catino dell’abside, su uno sfondo scuro, al centro si espande l’albero della
vita: sul tronco il cartiglio “ADORAMUS TE” e racchiuso tra i
suoi rami al centro -un ovale irradiato d’oro- con il calice, l’ostia
raggiante, la croce ed i simboli dell’alfa ed omega, la vita e la morte; ai
lati, sei angeli posati su nubi, in vario atteggiamento: adorazione,
meditazione, estasi, preghiera; e che ricevono luce dall’ostia. In quest’opera,
il pittore ha raggiunto il vero ideale della bellezza religiosa. Due pannelli
laterali all’altare rappresentano i simboli di Gesù: in uno al centro la
corona di spine ed il cuore trafitto, circondati con volute armoniose da
vitigni ricchi di grappoli a simboleggiare il sangue di Gesù; ai lati due pavoni
a simboleggiare la Resurrezione, i quali quasi camminano in un campo di grano
simboleggiante il pane e con esso il corpo di Cristo; al centro un cartiglio
con la scritta “QUI
MANDUCAT HUNC PANEM VIVET IN AETERNUM”. Nell’altro dodici pecore, rappresentanti
l’umanità e per lei gli apostoli, che si dissetano e purificano alla fonte
della vita centralizzata dall’Ostia col simbolo IHS, mentre due stormi di
colombe volteggiano nell’aria.
Nei
catini degli absidi delle due navate laterali, su fondo azzurro spiccano
quattro vasi stilizzati con gigli, e quattro cherubini in un alone di luce.
Nei
vari interspazi, si ripetono i simboli sacri, alternati a fregi policromi che
ricordano le pagine disegnate dei canti gregoriani. Tutto, è arte del
Vernazza.
Nell’altare
di destra, si venera una statua in
legno, di Maria, in grandezza naturale, scolpita da Vincenzo
Mussner di Ortisei (Val Gardena); invece in quello di sinistra, c’è una statua di san Giuseppe.
In
una cripta posta lateralmente, si accede alla tomba del fondatore
dell’Ordine (fu
ottenuto il permesso di traslare la salma da Staglieno, nel 1950), sulla cui lapide si vele effigie, e si leggono la
data di nascita (12.6.1873), quella di morte (12.6.1948), il nome ( mons. Paolo
Fossati fondatore Oblati SS. Sacramento), e la frase (“visu sim beatus tuae gloriae”).
Dopo
alcuni anni, con la stessa procedura, si ottenne trasferire la salma del duca Angelo De Ferrari (27.9.1859- 19.12.1927) e, dopo la
sua morte, anche della moglie duchessa Carola De
Ferrari Parodi (21.9.1876- 3.7.1960): essi furono dal 1926, i
sostenitori e finanziatori della nuova congregazione sacerdotale, desiderosi di
operare in silenzio, lontano dai riconoscimenti pubblici.
Nel
maggio 2004 una iniziativa del parroco, vuole
coronare lo scopo fondamentale della Congregazione: la preghiera continuata,
effettuata da un iniziale gruppo di 300 parrocchiani che giorno e notte si
alterneranno in preghiera nella cappellina laterale che non verrà mai chiusa.
===civ.
10: ci abitava Giancarlo Bargoni, nato nel 1936, divenuto celebre pittore astrattista, le cui opere sono state
oggetto di premi ed ospitate in musei d’arte nazionali; Parigi; Danimarca.
Fondò nel 1963 il ‘Gruppo Tempo 3’. Ha lavorato il vetro e ceramica).
Dall’altezza
di questo civico, tutta una ampia fascia di terreno estesa verso monte e nord,
e sino alla fine di via Ardoino circa, era denominata ‘le montagnette’, causa la natura del terreno fatto
in ripida discesa ma a mammelloni; e questo ancora negli anni postobellici
quando poi la zona fu interamente edificata (specie via dei Landi)
===civ.
11.13.15: non esistono (forse uno è
attribuito alla chiesa)
===civ. 14r : si
apriva nel 1933 uno dei sei spacci sampierdarenesi della Cooperativa di Consumo
Carlo Rota.
===civ 65r:
l’ingresso alla tipografia don Daste;
già capace di rotocalcografie e fotolito. Faceva parte del complesso “Orfanatrofi
femminili Divina provvidenza <Don Daste>, di salita Belvedere 2.
Nelle
prime decadi del 1900 reclamizzava con cartolina postale la fornitura di «stampati commerciali comuni, di
lusso, per amministrazioni / cataloghi-opuscoli-relazioni sociali-bancarie-registri
d’ogni genere-blocchi per trattori-biglietti visita-avvisi murali, ecc. ecc.»; telef. 41-144.
Chiuse
la sua attività per ‘sfratto’ al tipografo e dispersione dei macchinari, nel
2005 circa.
===civ.
17: l’ingresso delle scuole materna
ed elementare Don Daste; prima del 1961 era una porta secondaria senza numero.
===civ.
16: la casa, già della famiglia
Mignone (vedi via omonima). Da qui per cento metri la strada è stata delimitata
nel 2002 con paletti, per evitare ‘posteggi selvaggi’ sul marciapiede.
===civ.
19A: assegnato a nuova costruzione
nel ’63 .
===civ.
20: approvato nel 1956 (appare che
la commissione edilizia approvò nell’ottobre 1956 l’erezione di un palazzo
nuovo ‘in scalinata dei Landi’). Fu costruito dagli imprenditori Mignone nel
1958, su sedime di una villa:
-villa Lomellini – Bocci .
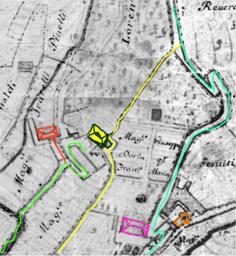

In giallo, la villa (spiegazioni sotto). Foto della villa,
del 1956. Nello sfondo la chiesa. Segnalata.
dal prof. Mancuso Alessandro, e di proprietà fam. Mignone.
A sin. l’inizio della scalinata Filangeri
Nella
carta vinzoniana del 1757 circa, la villa
e proprietà appartennero a Lorenzo Lomellini; e sappiamo che la casa aveva una
cappella gentilizia interna, di proprietà loro.
Secondo la carta↑, seguiamo l’ubicazione orientandosi
sulla base del tracciato celeste che oggi
è l’inizio di caso Martinetti-salita Belvedere; su esso c’è, in fucsia la casa delle suore della Divina provvidenza di
salita Belvedere 2 ed a ponente di essa la chiesuola dei Gesuiti (arancione) -
oggi delle Pietrine - detta S.Pietro in Vincoli.
L’accesso alla villa (giallo) avveniva dalla zona Mercato (strada
san Martino) seguendo un tracciato (verde) presumibilmente carrozzabile visto
i tornanti, che poi venne chiamato “dei Disperati” (vedi). Ma anche da altro più a levante, oggi
corrispondente a via C.Dattilo, presumibilmente sola mulattiera o pedonale perché più diretto, segnato in giallo. A
monte della villa questa mulattiera proseguiva –oggi è scomparso, ma corrisponde
alla parte alta del tracciato della scalinata
Gaetano Filangeri (vedi) quando esisteva. A ponente della
proprietà era la villa di proprietà dei
f.lli Pinelli: essa, considerato il terreno considerevolmente scosceso, si
presume che fosse dove ora è via GB Sasso; ma non è facile ubicarla bene.
Ultimamente
ospitava anche una società di cacciatori.
Si fa generica menzione
di una ‘ospitatiltà
Lomellini, in una villa a SPdA’, senza
specificare quale delle tante, essendocene più d’una.
Si presume non sia stata questa, la villa nella quale venne
ospitata la bellissima ventiduenne Elisabetta Farnese
figlia del Duca, dopo che nel 1714 andò sposa per procura a Parma al re di
Spagna Filippo V (per lui, seconde nozze). Potrebbe essere piuttosto quella di
via SPdArena. (vedi anche in via Mercato, la villa Lomellini-Boccardo)
Descriviamo qui il fatto:
Dalla città di Parma, trasportata in bussola e con un
imponente seguito, era entrata nel genovesato il 25 settembre: dal passo di
Cento Croci era scesa a Sestri Levante, da dove il giorno 30- via nave ‘la Reale’,
scortata da altre 5 galee della seren.ma Repubblica - era pervenuta a San Pier
d’Arena. Dovette sbarcare presso la Lanterna causa il mare agitato, e fu
trasportata con il tiro a sei dell’arcivescovo in villa Lomellini; stanca e col
mal di mare neppure partecipò alle feste preparate in suo onore e per una
settimana rifiutò dame di compagnia e di uscire. Anzi il 6 settembre volendo
sentire l’opera il ‘Tamerlano’ (o ‘Li veri amici’) che si rappresentava al
Falcone, tanto fece che gli artisti e musici dovettero organizzare una replica
trasferendosi in S.P.d’Arena. Lunedì 8 finalmente uscì dalla volontaria
clausura ed in carrozza si portò in cattedrale per le funzioni e venerare le
sacre Ceneri e Catino. Null’altro fece in città, ove rimase fino al 9 ottobre
a spese della Repubblica: rimase felice dell’accoglienza, anche se amareggiata
dalle strade troppo strette e dagli annegati nei giorni di tempesta. Se ne andò
via terra facendo tappa a Voltri, Savona, fino a Ventimiglia.
Il Bocci invece fu un falegname-deposito
legnami, forse
discendente o uno dei due fratelli che avevano una segheria a Genova negli anni
1933.
Negli anni 1911-25 la “rinomata fabbrica di cornici /
specialità in cornici curve / torneria-colle-placaggi di Ernesto Bocci ha sede in via Jacopo Ruffini n. 16 (vedi-via Palazzo della Fortezza).
Nel 1924 all’archivio storico di Palazzo Ducale è
conservata la domanda fatta dallo stesso, di poter costruire un ‘baraccone in
cemento armato ad uso segheria’ nel terreno compreso tra via A.Manzoni (via GB Sasso) e via G.B.Monti. Il disegno allegato fa
corrispondere il progetto nell’imminenza della curva laddove era il civ.20.
Nel 1960 gestiscono una ‘fabbrica di cornici e legno
compensato Bocci Angelo & Mario’ in via Gioberti 51r; lo stesso Angelo che
poi, nel 1970, compare in via GBSasso, ma al 9r (proprio di fronte allo
sbocco di via Farini =non sono in grado di dire se occupavano anche la villa di
via GB Monti, anche se penso siano gli stessi).
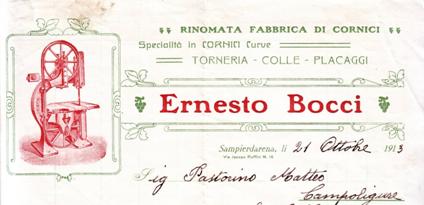
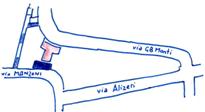
carta intestata della falegnameria riproduzione
del disegno allegato a
domanda-a mare
rispetto la scalinata
===civ.
21: è il cosiddetto “grattacielo di via
G.B.Monti” , di 22 piani, iniziato nel mar.1961, e finito nel dic.1962;
dato abitabile nel feb.’63.
Fu costruito sul terreno a ripide fasce, che da un pianoro soprastante (ove ora scorre la cosiddetta “Quota
40”, c’era una grossa vasca d’acqua, probabilmente alimentata da una sorgente) degradava alla stessa strada, in basso ed in
salita; una ripida scalinata - intestata a G.Filangeri (vedi), prima di
congiungere i due livelli - portava al civ.
23 ove era una fabbrica di scatole di latta
per conserve, con cromolitografie di esse, denominata G.Tardito & F. dal nome del titolare;
palazzo ancora presente (ed operante?= si, nel 1950 solo come c.litografia)
negli anni 1960, che aveva un grazioso giardino posto a ponente
dell’edificio (Di una “grossa società anonima
per le ‘conserve alimentari e lavorazione della latta’ già fratelli Tardito”,
ne parlano Doria e 37.203 riferendo:--- che essa nacque nel 1899 (senza
specificare se da G., dai figli, e se –come si presume- fossero loro i fratelli;
se è la data di nascita della società che rilevò l’attività ‘gia’ f.lli
Tardito);---che questa società aumentò il capitale nel 1905 da 760mila lire a
1,5milioni (questo valore restò eguale fino al 1908 quando improvvisamente si
dimezzò a 630mila nel 1909 per finire nel 1911;--- con, tra altri,
finanziatori Ferruccio Prina, i Tassara, i Cortese, i Raggio (che, dice Doria,
parteciparono alla fine, dal 1910 al 1914) e la Società Bancaria Italiana-;
--- possedeva oltre allo stabilimento di SPd’Arena, un altro ad Alghero (di
conserve) ed un molino a Sassari ed a Cagliari (una grossa somma, allora; che
però a conteggi successivi furono ridimensionati negli anni intorno al 1910
quando andò all’asta per provvedimenti del tribunale avendo cessato la loro attività
e perduto tutto il capitale )).



il grattacielo visto da sotto e dalla torre della villa
Serra Monticelli il piazzale antistante
Nel
piazzale d’ingresso del grattacielo, sul muro di sostegno all’estremità di
levante visibile al di là di un cancello, ci sono sia in alto il segno
inclinato di un tetto appoggiato (forse facente parte della fabbrica), sia un
ampio foro nel muro stesso, con margini di mattoni, come se ci fosse stato un
pozzo o un condotto o altro.
Adibito ad abitazioni private, ospita l’istituto di analisi Emolab e, ancora fino al 1977 vi si aprivano
il “cinema Arcobaleno” ( rimase funzionale dal
1963 all’80 circa) ed una maxi sala da ballo.
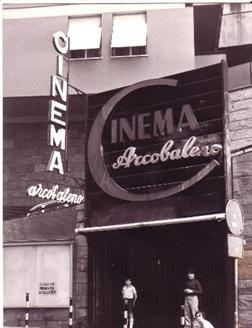

Sul piazzale si alzano due palazzine: ===il civ.19B aperto sul piazzale, che fu
eretto nel 1962 e dato abitabile nel mag.’63; e sulla via principale, nella
curva, il ===civ.23, casa per abitazioni con negozi; fu richiesta nel febb.
1962 dalla IES (Immobiliare
Edilizia Sampierdarenese dei fratelli Vicari,
progettata dall’ing. Smriglio (sic) Ciborio);
con iniziali necessità di sbancamento e costruzione di muro di sostegno a
monte; fu eretta dal dic 62; di soli 4 piani (perché assoggettata alla servitù ‘altius non tellendi’
ovvero che non deve salire oltre il livello della strada di Quota40) e resa abitabile dal nov.’63.
: ===civ. 22: non esiste. Avrebbe dovuto essere
costruito sempre dai Mignone; ma poi non fu eretto, per cause non conosciute.
Ma il Pagano 1950 vi pone al p.t. la “società Tiro a
volo – campo Enrico Canepa”.
===civ.23 Vedi anche sopra, al civ.21. Nel Pagano/50 vi ebbe
sede la ‘Raffineria Ligure Olii Vegetali’ di C.Coletti, telef. 41-396
===23A (quale secondario al 21):
assegnato nel 1963 (probabile sia il portone superiore; controllare***).
===civ.
24 Un volantino, datato 1949, segnala (per un convegno, seguito da una festa campestre in località
Belvedere per tutti i lavoratori, con presenza dell’on. Rumor – presidente
delle ACLI venete; s.e. mons. Siri arcivescovo; circolo mandolinisico
Risveglio- con colazione al sacco o in trattoria) che a questo civico esisteva un “Circolo ACLI ‘Paolo Reti’” la cui
sede centrale era a Genova in via Falamonica
===civ.
25. All’interno 4 la ‘Mondial Tools spa’
fondata nel 1993 (divenne
srl nel 1995 ed spa nel 1998; con oltre 50 persone occupate, si classifica
leader nel campo della ‘utensileria meccanica di precisione per asportazione di
trucioli’); all’interno 10
l’associazione ecclesiale “Giovani Nuovi” con presidente la sig.ra Persico Currò
Carla.
===civv.
30 dalla A alla L, eretti negli anni ‘68-70, nell’82
passarono alla nuova via Battaglini con nuova numerazione
===civ.34B assegnato nel ’99 ad una porta senza numero .
===civ.36A fu demolito nel 1969
===civv. dal 42A al 42H passati a
via M.Tosa con nuova numerazione nel 1982 .
===civv.
50,52,54 assegnati a nuove costruzioni nel 1962 ;
===civ.56
. Idem, nel ‘69
===civ.68r (villa
Lomellini-Bocci) nel 1933 ospitava la S:E:A:M: (società escursionisti “Amici
della Montagna”) affiliata all’ O.N.D. (opera nazionale dopolavoro); e
probabilmente anche la Società cacciatori San Pier d’Arena il cui presidente
era Dario Diana.
===civ.74r: la “società operaia cattolica
Maria Santissima Immacolata, e san Maurizio”, normalmente
abbreviata con “società cattolica san Maurizio”, unica locale di Mutuo
Soccorso a carattere religioso.

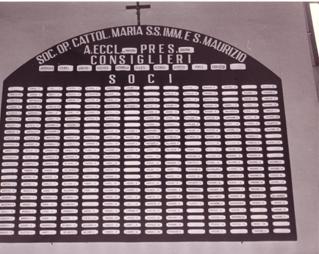
San Maurizio, come san Giorgio fu depennato dal calendario perché
appartenente ai martiri di culto medio orientale e di incerta – non documentata
- verità. Maurizio era a capo (‘primicerius’) della Legione Tebea e l’evento
avvenne tra il 285 (anno in cui Massimiano Erculeo guidò una spedizione
militare in Gallia contro i Bagaudi) ed il 310: tra le truppe c’era una legione
di oltre 1000 uomini proveniente da Tebe d’Egitto, praticamente tutti
cristiani. Quando Massimiano si trovò ad attaccare presso Agauno-Saint Maurice,
essendo cristiani anche i nemici, pretese dai suoi un giuramento agli dei. Al
rifiuto, dapprima fustigazione, poi decapitazione ); Massimiano fu poi
sconfitto da Costantino Magno a Ponte Milvio il 28 ottobre 312. O forse nel 305
(quando venne avviata la grande persecuzione ordinata da Diocleziano). Di
questa strage se ne seppe tardi, ben dopo cento anni; per questo le notizie
sono aleatorie e miste a leggenda. Come Giorgio, è raffigurato in veste
militare romana.
Per volere di Maurizio Dufour,
sampierdarenese molto vicino ai Salesiani, imprenditore cattolico molto
sensibile ai bisogni dei suoi operai oltre il posto di lavoro, il 10 giu. 1877 nacque una società - dapprima intestata ‘Società Operaia Cattolica san Giuseppe’, con sede
in via Saffi, presso i salesiani di don Bosco e subito trasferita in via
Operai, presso la villa Rolla (Morabito scrive l’8 giugno).


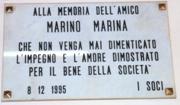

lapidi nell’interno del solidalizio
Per interessamento del
fondatore, assieme ad un pioniere dell’Azione Cattolica Camillo Galliano, fu
tra le prime ad inserirsi nel giugno/1881
in una federazione di società operaie, tutte cattoliche FOCL = federazione operaia cattolica
ligure (un primo ‘statuto delle società cattoliche operaie liguri’
nacque domenica 23 luglio 1854 nella canonica di s.Torpete alla presenza di 13
operai (chiattaiolo, calderaio), commercianti (orefice, merciaio, calzolaio)
nonché un maestro, bibliotecario, scultore, ecc., e 4 sacerdoti (tra cui don Magnasco
Salvatore). La sede sociale fu trovata nell’oratorio di NS del Rosario nella
chiesa di s.Antonio Abate di via Pré e poi in via della Maddalena, 12. Lo
statuto prevedeva aiuto ai lavoratori iscritti, alle vedove, orfani,
infortunati; stendardo, corsi scolastici, circolo ricreativo, banda musicale.
Questo solidalizio assunse il nome di ‘Soc.Op.Catt. NS del Soccorso e s.GiovanniBattista’
ed assunse subito importanza per l’adesione di grosse personalità e nobili.
Nel suo seno nacque nel 1881 una ‘speciale commissione per l’unione delle varie
società parallele’).
I primi tempi furono assai floridi, e si arrivò a creare
perfino una banda musicale.

nella banda verticale appesa alla bandiera sta scritto
«Società Operaia san Giuseppe Sampierdarena»
Ma ben tosto iniziarono numerose difficoltà di
intemperanze e dissidi ideologici, cosicché nel 1882
il fondatore dovette procedere ad una prima scissione, trasferendo la sede in via sant’Antonio presso la proprietà Stagno; ma in contemporanea - ricuciti
i dissidi dal Dufour - si riuscì ad allargare i principi pratici dell’operato,
costituendo in seno alla società la prima Conferenza di san Vincenzo de Paoli (il cui primo presidente fu Gaetano Lagorara, che nel 1888 battezzò la
prima bandiera sociale).
Ma pochi anni dopo, nel
1893 la Federazione dovette intervenire
nella gestione della società, nominando un quadrunvirato che durò in carica un
solo anno dopo il quale, nonostante tutto, si dovette sciogliere l’Associazione
con nomina di un delegato che operò la dispersione dei beni (la cassa, gli arredi e la bandiera)
e purtroppo anche la
bruciatura dei documenti e dei libri contabili, che avrebbero potuto
arricchirci di testimonianze su queste vicende iniziali; infatti alcuni soci si adoperarono per iniziare un’altra società,
chiamata “nostra Signora della Vittoria” -genericamente detta “della
Vittoria”-; ma anche questa dovette soccombere sul nascere, confluendo nella
“società generale Universale” in più floride condizioni, perdendo però così la
definizione di cattolica (e costringendo don Daste al ricupero delle immagini
ed arredi sacri acquistati); altri come il neo presidente Gaetano
Lagorara, tutti fedeli amici di Maurizio Dufour (ad ogni rinnovamento, lui rimase irriducibile promotore della sua
idea originale) preferirono prima -1892 - aprire una ‘Conferenza san vincenzo de’ Paoli’
e due anni dopo rifondare - nel 1894 e
nel giorno dell’Immacolata - un’altra società di mutuo soccorso, con statuto,
intestata a “Maria SS.Immacolata e san Maurizio”
- in omaggio al nome del Dufour stesso, e con matrice sempre prettamente
cattolica, in contraltare delle numerose altre società di mutuo soccorso tra
operai, spesso inserite in ambienti o politicizzati o fortemente anticlericali
(massoneria, anarchici e socialisti costituivano la maggioranza in Comune e
seppure retti da generici principi morali di onestà, avevano in seno estremisti
‘mangiapreti’ e rigidi anticlericali. I cattolici – sia sacerdoti che fedeli
laici ebbero vita dura da dover portare avanti la missione del mutuo soccorso
se pur venivano ammutoliti e messi nell’angolo (si salvava solo don Daste).
Ristabilito un certo equilibrio politico con il Partito Popolare, anche la
società raggiunse una solidità dirigenziale tale da riuscire a decollare: ad aumentare
il numero dei soci; a trovare nuova sede in via della Cella, presso casa
Samengo (gestita da don Daste); ad esprimere e sviluppare una intensa
attività di mutuo soccorso: gratuitamente si prestavano anche il medico dott. Dodero
ed un farmacista non conosciuto (considerato che allora ancora non esistevano le mutue
assistenziali); venivano elargiti sussidi per
malattia e si possedeva una cassa di soccorso -detta di quiescenza- per aiuti a
chiunque abbisognasse.
Nel 1907 fu riveduto
lo statuto ufficiale.
Quando nel 1911
una cooperativa costruì in via G.B.Monti il palazzo detto ‘Palau’ (dal nome del proprietario dei terreni), la società (guidata dal presidente Giacomo
Pittaluga - capo officina dell’Ansaldo Meccanico, poi titolato -1959-
cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica” dal Presidente della
Repubblica- affiancato da Ulisse Repetto e Pietro Boccardi) aderì ai lavori ed il 30 mar.1913 trovò definitiva ospitalità nel fondo di
esso, inaugurando – con l’intervento del card. V. De Amicis - la nuova bandiera
ed i locali con uso del giardino (nel quale è leggibile una lapide con i nomi degli iscritti
alla società, caduti nella grande guerra del 1915-18: Alfredo Carpaneto,
Domenico Cosmelli, Romildo Spotti, Ettore e Gualco Giacomo). Nell’occasione fu sorteggiato – e
vinto da un operaio - un servizio d’argento di cucchiaini, dono del Papa.
I verbali di assemblea denunciano una interruzione di
attività tra il 1920 e 1927.
Gli anni del fascio, 1928-40
e oltre, in una relazione vengono non meglio definiti ‘tempi oscuri’
Nel 1939 la cooperativa che conduceva l’edificio fu
obbligata a sciogliersi : per poter mantenere l’uso dei locali e la loro non
occupazione da parte delle organizzazioni fasciste, fu necessario stilare un
lascito di tutti i beni intestandolo alla parrocchia della Cella (precisando che si riservava l’uso
dei locali per continuare l’attività, anche se mutata in alcune caratteristiche
sociali quali la mutualità e la cassa quiescenza non più in atto dal 1941
perché mutate le leggi in merito).
Durante il conflitto 1941-45, la sede fu usata anche come rifugio
antiaereo per chi non riusciva a raggiungere la sottostante galleria; una bomba
d’aereo asportò un poggiolo del palazzo ma fortunosamente non creò danni ai
ricoverati: questo fatto è ricordato da un marmo che ringrazia per lo scampato
pericolo la protezione di NS della Guardia; il presidente Pittaluga perdette
un figlio disperso in Russia; dopo la resa del 1943,
ospitò alcuni dei soldati e richiamati sbandati che poi andarono a formare i
gruppi partigiani; uno dei soci –Aldo Gaggero- venne coinvolto nelle faide
politiche del fine guerra ed ucciso senza apparente motivo a Campomorone.
Nel salone principale un altro marmo ricorda le riunioni
ivi effettuate dal Comitato Cospirativo per la Liberazione, delle quali
l’ultima fu il 25 apr.1945.
Dopo il 1945,
nell’ambito della san Maurizio tuttora operante, si ricostituì la “conferenza
di san Vincenzo de Paoli” ed il “Circolo ACLI” intitolato a Paolo Reti (la cui attività permise la formazione di una squadra di calcio e di
bocce, ambedue vincitrici di ambiziosi tornei denominati rispettivamente coppa Gaggero
e DelleZotti – e 1° Torneo della Liberazione).
Nel 1954 fu
battezzata la nuova bandiera sociale.
Negli anni 1960
fungeva da assistente ecclesiastico don Masieri; presidente era Enrico Delmonte;
nol 1962 si celebrarono gli 85 di fondazione.
Nel 1966 si aprì
il tesseramento anche alle donne, che oggi rappresentano il 20% circa degli
iscritti (poco meno di 400, di età media di 62 anni) continuando ad intervenire
per aiutare gli emarginati, i soli ed i sofferenti offrendo a prezzi
stralciati una degnissima sede e tanto calore umano.
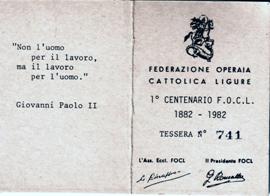
===civv
24-26: un unico edificio, con
caratteristiche decorazioni sulla facciata di stile liberty; già di proprietà
Mignone, fu progettato da A Petrozzani nel 1910 “nell’angolo prolungamento via
GB. Monti”.
===civv
28-30: anch’esso in unico stabile,
leggiadramente decorato, appare posteriore al precedente, risalendo al 1936
circa.

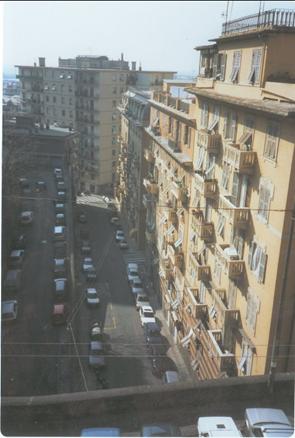
sopraportone del civ. 24
la fila di palazzi dal 24 al 30
A
livello del civ. 30:
a)
la numerazione continua non seguendo la strada, evidentemente costruita dopo,
ma salendo le scalette: infatti il 32-34 è sopra il muraglione, e da lì la numerazione
prosegue verso levante.
b)
inizia la scalinata “Scalinata G.B.Monti”
(vedi) che ha l’onore di una targa sua - ripristinata
nel 2009 dopo anni di assenza della quale si intravedevano i supporti tra le
pietre del muro.
c)
sotto la scalinata l’ingresso di una galleria
che in profondità si unisce a quella che inizia in via dei Landi, e finiscono
cieche; fu usata come rifugio dai bombardamenti durante l’ultimo conflitto
mondiale e poi chiusa, lasciando utilizzabile solo pochi metri per uso privato
(in concessione?).
d)
nello stesso punto, la strada compie una curva a tornante, affiancando opere di
sostegno della muraglia soprastante, tra le cui arcate hanno fatto ripostigli
e magazzini, presumo privati.
e)
a questo livello, il 24 apr.1979 fu “gambizzato” dalle Brigate Rosse il
direttore dell’Ansaldo, ing. Giuseppe Bonzani (persona molto schiva e riservata, onesta e altruista, che abitava in
via Marabotto ed usava il tragitto per andare e tornare al lavoro all’Ansaldo
ove era dirigente; accettò questa ‘punizione operaia’ col sorriso sulle labbra
neanche dovesse essere lusingato da tanto interesse per lui e sopportando tutto
con rassegnata e religiosa determinazione tanto che agli atti dello Stato non
appare nessuna denuncia e quindi neanche il suo nome tra le vittime degli ‘anni
di piombo’). I colpi alle gambe, lo ridussero in fin di vita per emorragia,
avendo leso l’arteria femorale e fu salvato miracolosamente al Pr.Soccorso).
VERSO LEVANTE===civ.
25: è chiamato “palazzo degli Stura”,
anche se di essi ormai più nessuno vi abita. Alla sua erezione, fu occupato
interamente dalla famiglia “Stura G. & figli” imprenditori e costruttori
edili - nel 1933, con questa titolazione
e con indirizzo in corso D.Alighieri = corso Martinetti, 4/3 (i figli erano tre ingegneri - nessuno edile:
Peppino, ing. civile Sandro ing.idraulico e Secondino ing.trasporti che poi nel 1961 abitarono questa casa
rispettivamente agli interni 4,4,10; ed uno medico: Luigi.
Il
Pagano/61 riporta due altri Stura, ing. pure loro: Virgilio – che nel 1933
abitava in corso D.Alighieri 4/6 e poi - come Pietro che compare nel 1967, a
Genova). Questi costruttori (che nel 1967 avevano uffici in via Cantore 8E.1 e
deposito in via Carpaneto 15r), erano vicini alla Chiesa (e forse alla
D.C. politica); molto operarono nella San Pier d’Arena da ricuperare dopo la
guerra (la chiesa di don Bosco, che io sappia, e altri:vedi civ.27).
Nella zona, c’era un edificio
che ospitava una stamperia ed un oleificio (la “Sirov”: soc. ind.le raffineria olii
vegetali, la cui sede rimase nell’edificio ancora negli anni ‘60 ).
===civ.
27: è degli anni 1957-8, eretto dall’impresa Stura sugli orti delle suore
soprastanti l’istituto di don Daste. Tra lo spiazzo sottostante per le auto (limitato da una ringhiera) e la proprietà delle suore, compare
un corridoio sottolivellato (anch’esso limitato da una ringhiera, lungo come il
posteggio e raggiungibile da scaletta, che era accessibile solo da una porta in
salita Belvedere che però è stata murata; rimane il marmo di base del gradino
di un cancello, che dava adito allo spazio; tutto questo spazio – sino oltre la
soprastante via Tosa, inizialmente era della villa delle suore, poi degli Strura
che l’adoperaroro come giardini propri e sui quali poi costruirono il civ. 27).
===
subito dopo il 27, proseguendo a levante, la strada taglia l’antica crosa di
salita Belvedere; la continuazione a monte della salita - causa il taglio, e
dovendo ricuperare la pendenza - fu sostituita da una scalinata di poche rampe.
Seguono,
sul marciapiede a mare tre distinti cancelli delle “suore Pietrine”: per
l’istituto, per l’orto e giardini e per servizi. Bello è il gruppo di alberi di
canfora (un altro è nel
cortile della Croce d’Oro, unici in città),
che mandano i loro rami sulla strada.


le Pietrine angolo
via Tosa
===civ.
48 dopo via Tosa, il lungo edificio
chiamato “dei ferrovieri”, perché inizialmente costruito per questi lavoratori.
Durante l’ultimo conflitto mondiale, fu raggiunto da due bombe che causarono
tre morti.
Immediatamente
dopo, è il ponte che - essendo anonimo, fa parte di questa strada - (è detto anche “ponte di Quota 40” perché già inserito in diversi
piani regolatori per far continuare questa circonvallazione sino al Campasso); solo nel marzo1976 si arrivò ad iniziare i lavori
che furono conclusi nel maggio 1977: passando sopra corso L.Martinetti, fa
concludere la strada -fino ad allora monca-, in corso Magellano. Lungo circa
64m, largo circa 15 con una carreggiata di 13m, fu costruito in cemento armato.
VERSO PONENTE
===civ. 40: non esiste, avendo progettato - ma mai eretto - un
altro palazzo. Viene riferito che il 42, eretto dalla coop. La Vittoria,
era stato progettato e quindi doveva nascere con due portoni distinti. Ma
circostanze non conosciute hanno fatto cambiare e saltare i programmi.
===
civ. 38: detto “dei Mutilati e dei Combattenti”; alcuni stemmi e
cartigli sulla facciata ne caratterizzano il nome e lo scopo per cui fu eretto
dalla soc. coop. Generale Cantore (vedi foto sotto).
===civ. 36 e 36a: il
primo fu costruito dall’impresa Bagnasco, Florio Pietro (proprietario del
terreno) & Balestrero nel 1931.
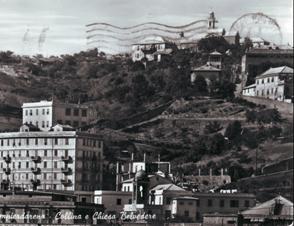

la casa Bottaro è visibile (a sinistra, colorato
rosso, il civ. 38
sopra l’edificio civ. 48) di via GB Monti.
Nel
civ. 36 Negli anni 30 all’interno 19 abitava Bottaro Caterina, direttrice di
una rivista “Lavori Femminili” editita dal 1914 al 1975; arricchita di
‘disegni per tutti i lavori donneschi e letture amene’. Assieme all’Eco di donBosco
erano gli unici periodici editi nella nostra città.
Del civ. 36a, due appartamenti
sovrapposti (uniti da scala a chiocciola)
furono comperati da Bottaro Caterina (o Bottero, nata a Carcare e deceduta dopo frattura
del femore per scivolamento a terra) per iniziarvi aiutata da suore
laiche un rifugio assistenza per orfanelle.


Bottaro
Caterina, fondatrice
della
casa famiglia s.Cuore
Nel 1936 avendo acquistato il
palazzotto retrostante la strada, allora numerato 36A-cancello (oggi
localizzabile in via Battaglini), dopo
averlo munito di cappella privata, riscaldamento, dormitorio ed adeguati
servizi vi si trasferì: nel 1950 risulta chiamarsi “casa
famiglia del Sacro Cuore, per Orfane povere
ed abbandonate”.
L’istituzione fu poi regalata
alla Fondazione di religione ‘Cenacolo Domenicano’ (ente morale, con sede a SestriPonente in via Vado, del quale era stato
direttore il sac. Viola Giuseppe milanese del 1807); questa
congregazione a sua volta cedette l’immobile nel 1966-7 alla soc. san Tomaso d’Acquino
di Sestri che rimase proprietaria per uno o due anni finché lo rivendette
all’impresa Salus, che costruì via Battaglini.
Sulla via GBMonti, tra il civ. 36
e 38 esiste ancora il cancello d’ingresso -seguito da una scalinata privata
che portava alla “casa famiglia del Sacro Cuore”- orfanatrofio femminile ; ove
si stampava pure un periodico intitolato “Lavori
Femminili”(nel 1950 aveva direttrice Rina Bottaro; aveva pagine con dei
ricalchi da –col ferro da stiro- riportare su tela e ricamarli).
Questa proprietà confinava a
nord con quella Boccalatte – che arrivava sino alla salita Belvedere a fianco
della palazzina omonima, e ad est con
quella di Antonio Bagnasco.
All’incrocio
con via Battaglini, la strada trapassa in via dei Landi. La palazzina posta
sopra il muraglione e di pertinenza di via Mignone, però in precedenza delle
nuove strade, era il civico 30a di via GB Monti.
DEDICATA
Ebbe numerosi fratelli, dei quali si
sa solo di uno divenuto sarto; uno capitano marittimo, e due ricamatrici.
A 17 anni entrò all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, nella sezione
disegno, e subito si distinse quale migliore allievo del corso; però essendo di
spirito indomito e di carattere irrequieto ed eccitabile, forse sentendosi
frenato dalla locale prevalente ed indiscussa cultura classica, o incompreso,
preferì trasferirsi a Bologna (del cui soggiorno mancano totalmente tracce e documenti); da qui a Roma, attratto da un’idea di maggiore
libertà espressiva e dal gusto preromantico di Camuccini, e dalla compagnia di
amici (tra cui i
pittori Francesco Baratta e Giovanni Fontana, l’architetto Nicolò Laverneda e
lo scultore Giuseppe Gaggini, tutti inviati colà dall’Accademia genovese: alla caduta dell’impero francese ,
la Ligustica nel 1815 stanziò una somma -promossa dal nobile Marcello Luigi
Durazzo- utile per inviare il migliore alunno per ogni specialità, a studiare e
perfezionarsi a Firenze o Roma); iniziò
a produrre qualche opera, andata oggi dispersa (un “Sansone”); vinse il primo premio per l’anatomia nel 1818;
finché nel 1820 in venti giorni eseguì un “san Gerolamo in atto di
penitenza”, per partecipare ad un concorso di
pittura -indetto dall’Accademia romana di san Luca-: la cronaca ricorda che il
direttore, addirittura Antonio Canova, gli cinse solennemente il capo con una
corona d’alloro (come
era allora in uso per testimoniare il massimo dell’onore), decretando così un trionfo per il giovane e per
l’opera (posta nella
chiesa di san Luca, viene considerata un capolavoro: rappresenta il santo, in
grandezza naturale, in atto di umile penitenza; l’Alizeri ricorda che Vincenzo Camuccini
-valente pittore che già faceva scuola ed da cui il Monti aveva iniziato a fare
il discepolo - lo declamò affettuosamente ma sinceramente “mio maestro”. In
effetti il tratto pittorico appare potente e sicuro, quale fosse stata opera di
un esperto e già declamato pittore).
Intensa divenne la richiesta della sua opera, specie come ritrattista,
divenendo valentissimo, uno dei più significativi del suo tempo, sapendo
cogliere i maggiori risultati di freschezza dell’immagine, rispetto i
cosiddetti tradizionalisti (dipendenti da una cultura accademica più rigida e rallentata in un
periodo in cui il linguaggio pittorico era evidente movimento innovativo). La sua opera si colloca in posizione di spicco del
primo romanticismo genovese.
Non specificatamente attivo nel ramo, però produsse anche affreschi, di cui è
tipico un autoritratto conservato nel Museo dell’Accademia Ligustica e nel
quale viene colto un “progressivo superamento della nettezza disegnativa
accademica, in nome di un uso più nettamente costruttivo del colore”. Sborgi
precisa “personalità più significativa – e tenderemmo a dire unica –
nell’ambito dell’adesione al romanticismo emozionale… formatosi all’Accademia e
morto giovanissimo a Roma dove sembra che seguisse anch’egli gli insegnamenti
del Camuccini”.
Morì appena ventiseienne, il 12 dic.1823 a Roma, dopo giorni di atroci spasmi
e dolori cerebrali (la
morte prematura, e la fama raggiunta rapida a livelli così eclatanti, indussero
a pensare ad un avvelenamento -anche per gelosia professionale; ancora usava
allora, con pochi scrupoli, anche se la diceria proseguiva dicendo che
l’avvelenatore sarebbe morto a sua volta il giorno dopo, precipitando in un
burrone-; la maldicenza mai fu provata, e non appare probabile: rimane quindi
la malattia infettiva -come una otite o meningite- il movente più logico a
giustificare il luttuoso episodio).
Lasciò non molte opere; qualcuna anche negli USA; in Italia persistono solo
alcune tele nelle case private e nelle chiese romane. Alla Ligustica abbiamo
quattro dipinti: due di essi, un “ritratto della sorella Anna” (olio su tela di 46,5x56,2); ed un “autoritratto con colletto
bianco”( olio su tela di
47,5x31, ambedue donati dalla sorella Giulia il 4 lug.1877, anteriori alla sua
partenza) “rappresentano una
significativa, ma non particolarmente emergente, interpretazione in chiave latamente
romantica della ritrattistica tardo-neoclassica”. Gli altri due, la “testa
di vecchio barbuto” (olio su tela, di cm 47x35), ed un “autoritratto” (olio su
parte tela e parte cartone, ambedue del periodo romano ed ambedue provenienti all’Accademia da un legato del 1857, del marchese
mons. Stefano Rossi) “mostrano una
modernità di concezione che è indubbiamente difficile a riscontrarsi in quegli
anni non solo nella cultura romantica genovese, ma anche in quella italiana,
tanto da porre, paradossalmente, alcuni dubbi sulla paternità del dipinto”
E’ opportuno distinguere il Nostro, spesso confuso con un
omonimo pittore genovese nato nel 1610 e morto di peste nel 1657. Quest’ultimo,
lodato da G.Reni; citato dall’Alizeri, in enciclopedie e nel “dizionario
biografico dei genovesi”; fu allievo di Luciano Borzone e condiscepolo del
coetaneo Mainero; incisore in rame sul libro (1644) ‘L’Ateone’ di GB DiNegro.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Notizie dei Professori di disegno in Li –vol.I- pag. 130
-Alizeri
F.-Guida artistica per la città di Genova.-Sembolino.1875-
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 2949
-A.
non conosciuto-Manoscritto chiesa san Gaetano-don Bosco-pag.512
-A.
non conosciuto-dattiloscritto relazione storica della soc.s.Maurizio
-AA.VV.-Mutualismo
e solidarietà-Reg.Liguria.2001-pag.155
-AA.VV.-il
Museo dell’A. Ligustica di B.Arti-CARIGE-1983-.65.262
-AA.VV.-Annuario-guida
archidioicesi-ed.1994.422--ed.2002-pag369.459
-AA.VV.-annuario
generale d’Italia-Pozzo.1953-pag.1124
-AA.VV.-La
pittura a Genova ed in Liguria-Sagep.1987-pag.418-9.421autor
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1976-pag. 84
-Banfo
C.-Storia delle soc.Op.Cattoliche-L’Operaio Ligure-mens. 3/59 p.3
-Beringheli
G-Dizionario degli artisti liguri-DeFerrari 2001-pag. 35
-Biavati.Marasco.Rizzo-Il
segno in trappola-Marietti-pag.148
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.49
-Dellepiane
A.-Enciclopedia dei liguri illustri-ERGA-vol.2-
-Dellepiane
A.-I maestri della pittura ligure-Tolozzi.1971-patg.201
-Doria
G.-Investim e sviluppo econom. a Ge.-vol.II-Giuffré.1973.pag.768
-D
’Oria S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.53
-Durante
A.-don Nicolò Daste-DonDaste.1964-pag.84.86
-Enciclopedia
Sonzogno
-FaldiEF.-Spirito
eletto sotto ruvida corteccia-DonDaste.1975-
-Galotti
F.-Pittura e scultura oggi-Artisti Riuniti.1970-pag.80
-Gazzettino
Sampierdarenese: 1/73.9 + 8/73.5 + 4/76.7 + 5/77.3 + 6/77.2.7 +
7/77.4 + 1/81.11 + 9/82.16 + 10/02.12 + 04/04.6 +
-Genova
-Rivista municipale : 1/39.28autoritratto e 2 quadri +
4/39.1 + 5/67.48
-Gente
di Li.Almanacco.103
-Il
Cittadino, quotidiano. 07.10.1997-pag.9
-Il
Secolo XIX.: 9 lug.1998 + 5.2.02 + .4.04 +
-Lamponi
M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag.189
-Maira
Niri M.-La tipografia a Genova...-Olschki.1998-pag.280.XXX.
-Medulla
M.-Sampierdarena-DeFerrari 2007-pag. 22
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.141
-Miscio
A-La seconda Valdocco- Elledici.2002- pag. 378 vol.II
-Morabito
L.-Il mutuo soccorso- ist.Mazziniano.1999- pag. 432
-Novella
P.-Le strade di Genova-Manoscritto B.Berio.1900-30-pag. 17
-Operaio
Ligure- FOCL- marzo 1959. settembre 1959. luglio 1962.
-Pagano/33-pag.
598.856.1179--/40-pag.347--/50- pag.202.234--/61-pag.247
-Pastorino
P.-Viaggio sentimentale nella GGenova-Tolozzi2007-pag.83
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1250autor
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995.tav. 22.34
-Sborgi
F.-1770-1860 pittura neoclass. romantica in Li-mostra.1975-p.108
-Sborgi
F.-in “Studi di storia delle arti”-Sagep.2003-pag.183
-Sborgi
F.-pittura e cultura artistica nell’Acc.Lig-Quaderni Ist.St.Arte-n°7
-Società
S.Maurizio - relazione storica.1977-
-Stradario
del Comune di Genova- edizione 1953-pag. 119
-Tuvo
T.-SPd’A come eravamo-Mondani.1983-pag.34
-Tuvo&Campagnoli-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.109fot.203
-
non
citato su Enciclop. Motta + Novella non lo include tra i “figli” +
da
cercare:
ed.1991-II-pag. 925=Beccaro
R.-GBMonti- in La pittura in Italia, l’800- a cura di ECastelnuovo
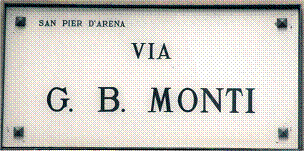





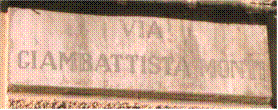




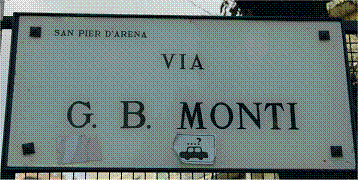
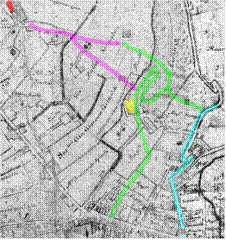 da MVinzoni,1757.
da MVinzoni,1757. 
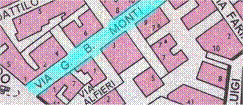
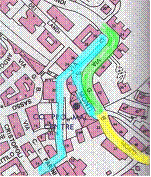
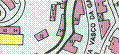


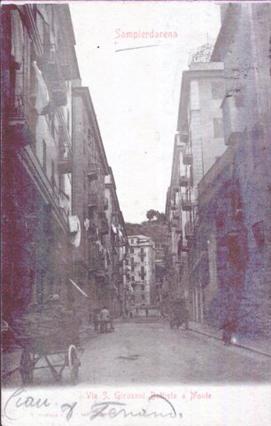 --foto similare alla precedente,
viaggiata nel 1905, ma errata perché indica“via S.Giovanni Battista a Monte”
che non è mai esistita.
--foto similare alla precedente,
viaggiata nel 1905, ma errata perché indica“via S.Giovanni Battista a Monte”
che non è mai esistita.