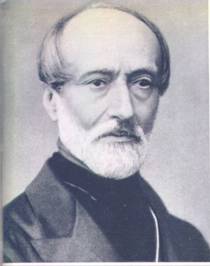MAZZINI Via
Mazzini
Il 26 apr.1946 la Giunta
Comunale decise l’ultimo cambiamento di titolazione della strada, dedicandola a
Bruno Ghiglione.
Non esiste più a
Sampierdarena, una strada dedicata al grande Maestro determinante della unità
e libertà nazionale; e proprio qui dove ebbe i proseliti più umili ma nel
contempo più tenaci e caparbi: Genova fu la città natale, San Pier d’Arena con
l’Universale, fu la culla delle sue idee.
La strada, gli fu dedicata,
senza aggiungere il nome, agli inizi del secolo 1900 ,nel centro storico
cittadino, tra via della Cella e piazza
Modena.
Nel 1901, l’impresa
Barabino,Calvi,Rebora, vi pose la targa in marmo.
In quegli anni il civ. 1, 2, era di eredi Raffetto e C ; 3a, di Merello
Giuseppe ; 4, di ved. Parodi e sorelle; 4a di Nasturzio Silvestro ; 5, di
Casanova Luigi e C .
Dal Pagano 1902 si
rilevano queste attività commerciali: civ. 1 negozio calzature di Aghina Francesco, presente sui
Pagano fino al 1908;---e angolo v.della Cella farmacia Raffetto Angelo;--- 4
negozio calzature di Michelini Luigi;---4-1 ottonaio Casanova Giorgio,
ancor attivo nel 1912;---5 s.lle Tubino con negozio di moda, presente
fino al 1925¨;---
Nel Pagano 1908 (ancora
nel 1911* e 1912°) si descrive esistervi queste imprese: al 2-9 l’armaiolo
Roncallo Attilio con telef 998;—al 12 negozio di frutta secca, agrumi e
verdure di Casale Davide e C, segnalato fino al 1925.
Nel 1910 era “tra via
Cella e piazza Teatro Modena” con civici neri fino al 10 ed al 5.
Nel 1911-12 oltre
quello già segnalato nel 1908: civ. 2 la levatrice Caorsi Carmela;- civ.4 la
levatrice Boccardo Cater.;- al 13r il fornaio Galliano Antonio;
l’ombrellaio Prini Francesco (egli nel 1925¨ è nell’angolo tra via VEman. e via
della Cella).
Al
civ. 3 una cartolina reclamizza un “Albergo Ristorante della Posta Vecchia” in
via Mazzini, n.3 d’angolo rimpetto al Teatro Modena, di Montaldo Pietro
Pasquale
DeLandolina/1922 scrive che il mercato era
intestato a lui.
Nel
Pagano 1925: al civ. 1 compare Morais Aldo con forniture industriali;-- all’1-3
la levatrice Castello Iole;--
All’unificazione del 1926,
ben nove centri si contesero il diritto del titolo che, ovviamente, rimase al
primo (Centro (la galleria ed il piazzale; ed
ora in più il ‘vico alla casa di-‘), Borzoli, Cornigliano, Nervi,Pegli,
Rivarolo, SPd’Arena (di 3.a categoria), Sestri, Voltri).
Ma nel 1933 ancora
esisteva come tale, con civici neri fino al 12 ed al 5. Nel Pagano di quell’anno
appare aprirsi sulla strada solo il negozio di tessuti dei f.lli Conte fu
Lazzaro al civ. 10-2.
Nell’agosto 1935 una
delibera firmata dal podestà decideva chiamarla ‘via dei Triari’, in
ottemperanza alla eliminazione dei doppioni nella Grande Genova.
usanze e necessità diverse, sempre però soggette a
servitù e sottomissione, a tanta confusione ed assai poca dignità.
Si abbisognava di una voce che
risvegliasse la popolazione dal sopore (volutamente ubriacata dagli equilibri
necessari a tante potenze europee per conservare il proprio potere). Si
ridestasse così il valore morale e spirituale della Patria unita, fornisse
l’ideale per cui combattere, ed a cui sacrificare volontariamente, non ultimo
né estremo, la vita stessa
Col motto ‘Dio e Popolo’, la
traccia sembrava precisa, ma in realtà era, specie dentro lui, grandemente
contorta e di difficile spiegazione. Lui non era ateo, ma neppure cattolico (non apparteneva alla massoneria, ma neanche favoriva
‘i preti’ perché li sentiva contrari a lui ed a sua madre convinta giansenista).
Quindi Dio non era un punto fermo, ma un messaggio indirizzato alla
massa del popolo che sapeva religioso al punto che senza quello spirito non
avrebbe potuto neanche iniziare; dovette assecondarsi accettando che potevano e
dovevano convivere una religiosità individuale inserita nella religiosità dei
regnanti (i quali ultimi intimamente sperava
decadessero, per arrivare all’apice del desiderato: la laicità dello stato
repubblicano, ma che pur di raggiungere lo scopo unitario disprezzava essere
intransigente). Popolo. Non era come i politici di oggi che si
riempiono la bocca con questa parola, ed appena al governo se ne dimenticano
preferendo assecondare le necessità del partito. L’evoluzione dei primi
infruttuosi e sanguinosi tentativi di insurrezione armata l’avevano avvertito
che senza il consenso della popolazione l’unificazione non era concepibile; e
non ci volle molto a capire altresì che purtroppo le prospettive migliori
l’avevano i Savoia, e non i ’trecento giovani e forti’, entusiasti ed ardenti,
ma pochi senza il popolo.
Altre parole fondamentali
furono: Dovere, e Patria. Non occorre spiegare.
I tempi divennero maturi con lui. La persona giusta nel
momento giusto.
Come in una orchestra, lui
compositore delle note e direttore d’orchestra, eccolo a dirigere quattro
suonatori autonomi ma finalmente convergenti: le nazioni europee indifferenti o
“distratte”, comunque poco partecipi (il Papato
che coinvolse i francesi; l’Austria contro; i Borboni contro ma prossimi ad
essere travolti dall’evoluzione dei tempi e costumi; L’Inghilterra favorevole
ma solo per equilibrare la Francia; la Francia favorevole sia per l’idea repubblicana,
sia per contrastare i vicini oltremanica); l’esistenza di un primoattore
spregiudicato, pratico e spericolato come Garibaldi; il Cavour che
ambiziosamente era favorevole (dopo la Crimea,
continuava a lavorare sotto-sotto, con quella sua caratteristica piemontese
di “tenere i fili ma non farsi vedere; non apparire direttamente o comunque
mai smodatamente tutto assieme ma solo un po' alla volta”; infine il popolo che non tutto era pronto, ma la cui
parte vivace, giovane ed attiva era anelante di agire.
Sua assoluta fu la capacità di far convivere nell’ideale italiano, un dio con
ideale laico, ed una repubblica con un regno: se l’ideologo era repubblicano,
a realizzare l’idea dell’unione sarebbe stato un re, che ovviamente avrebbe
creato un regno e non una repubblica; problema non da poco perché se mal
giocato poteva frustrare la semenza dei numerosi volontari, in genere
repubblicani ma i cui tentativi isolati erano andati tutti a concludersi
negativamente, incapaci di risvegliare il popolo dal torpore dell’abitudine;
quindi, sempre sotto-sotto, doveva collaborare materialmente alla lotta
fornendo aiuti a quei giovani che agli occhi del popolino erano piuttosto dei
“diavoli” , guidati da un “rivoluzionario e senza Dio”, però in pratica indispensabili
perché affiancati alle truppe regolari seppero essere decisivi in tutte le
battaglie e nella annessione di tutti gli stati fino al sud (escluso la
Repubblica Ligure che era stata annessa senza plebiscito).
La nostra regione è sempre stata e più di ogni altra
regione italiana, ininterrottamente per quasi mille anni, governata unicamente
con una cultura basata sul concetto repubblicano indipendente. E negli anni di
vita del Mazzini, nella nostra città di San Pier d’Arena, fu la società Universale
a sottolineare con incisiva presenza, anche nel lungo periodo del regno
sabaudo, l’essere qui il perno repubblicano. I cittadini sampierdarenesi furono
sempre una spina nel fianco della polizia, regia e fascista; in tutte le
manifestazioni popolari, è stata tra le prime a accorrere e partecipare
laddove si ventilava l’idea mazziniana della Patria una e della libera
democrazia.
Poco raccontata e giudicata marginale è stata la sua vita
affettiva: più d’una sono emerse dalle lettere scritte, fra esse più legato
sentimentalmente fu con Giuditta Sidoli (amore
rivelato dal carteggio; lei nata nel 1814 da un barone napoletano, fu da
giovanissima una figura anticonformista e rivoluzionaria: sposa 16enne con un
carbonaro, ebbe 4 figli e rimase vedova nel 1828. Esiliata, esule si ritrovò
sola, tra gli esuli a Marsiglia ove conobbe il 25enne Mazzini: non bella ma
vivace, colta, solida di carattere e di fisico, anticattolica e calda di furore
patrio, con forte concetto della virtù e del dovere ma anche espressiva e
femminile; tra loro nacque dapprima una intesa di comune idealità, fino a
divenire amore ardente ed intimo ma –per i seguaci- purtroppo anche distraente
dall’impegno politico), si separarono nel luglio 1833, quando Mazzini
scrisse “ho dato congedo a tutte le gioie, a tutti i conforti della vita, e
per sempre...non mi è rimasto che il nudo dovere”.
Nel 1838 fu tra i primi ad usare la parola
‘socialismo’, per indicare umanità, missione o progresso continuo.
Morì a Pisa il 10 marzo 1872, per broncopolmonite,
ospitato in casa di Pellegrino Rosselli in via della Maddalena col falso nome
di Giorgio Brown.
Le spoglie, vestite con
tradizionali abiti neri, fu esposta a folto pubblico sino al giorno 13. Il 17,
in treno e con immensa partecipazione popolare ad ogni stazione, furono
trasferite a Genova e poste in una camera ardente. I leader nazionali
repubblicani dopo scontri di pareri diversi anche all’interno del movimento,
decisero (Bertani su tutti, non esistendo ancora
l’inceneritore che verrà costruito nella prima decade del 1900 ) di
imbalsamare la salma (anche contro l’eventuale
volontà del defunto o dei parenti; l’incarico fu affidato a Paolo Gorini,
inventore di una tecnica diversa da quella classica egizia, chiamtata ‘di pietrificazione’
(l’autore preferiva la parola ‘legnificazione’, consistente nella sostituzione
dei liquidi organici con sali minerali che si induriscono. L’operazione durò
parecchi mesi, da primaver sino all’autunno, vigilata da alcuni garibaldini
tra i quali G.C.Abba e Bertani. Ma il suo operato, intervenuto forse un po’
troppo in ritardo, dopo lunga e laboriosa elaborazione, si concluse in modo
imperfetto, incapace di garantire la conservazione perenne; cosicché fu
impossibile lasciare esposta la salma in forma continua come era nelle
intenzioni originarie. Una ricognizione della salma, effettuata il 19 giugno
1946, descrive il fallimento dell’esperimento di Gorini). Fu esposta
alla cittadinanza anche poche settimane dopo il referendum del 23 giugno 1946,
quando l’Italia –a tardivo ma solenne riconoscimento del valore delle sue
idee-, scelse di essere una repubblica.
La tomba, ubicata nel
boschetto irregolare di Staglieno, fu inaugurata il 10 marzo 1874, nel secondo
anniversario della morte. L’architetto Gaetano
Vittorio Grassi, era allora uno conosciuto artista locale di ferma fede
repubblicana e che per vivere faceva il correttore di bozze. Ideò allo scopo il
severo mausoleo neoclassico con due colonne doriche che sorreggono un
architrave recante in grosse lettere il nome Giuseppe Mazzini; che però non
poté completamente finire per motivi geologici (fortunatamente, a mio parere,
perché secondo il progetto doveva essere coperta da enormi massi a sottolineare
una ‘pesante monumentalità’ che sarebbe stata eccessiva).
Il sarcofago è coperto dalle stesse bandiere che lo accompagnarono
nell’ultimo viaggio da Pisa
A San Pier d’Arena a lui è
stato dedicato uno dei due edifici che fiancheggiano villa Scassi, e che
ospitano le scuole elementari. DeLandolina/1922 scrive che anche il Mercato, in
quell’anno era a lui intitolato.
Essendo ancor oggi vitali le sue idee, la persona
resta immortale. Per l’esattezza, recenti pensatori giudicano tutte le
risoluzioni da lui proposte irrimediabilmente superate in pratica (non più la concezione religiosa dell’impegno civile e
politico; non più una critica ai diritti del singolo individuo; non la
sacralità della patria né condanna del federalismo; non più il concetto che
l’arte debba essere al servizio del bene). Ma dopo le svariate esperienze
di oltre un secolo e mezzo, sia il concetto di famiglia (attraverso diversi e svariati sistemi di istituti di acculturamento);
di patria (l’Europa), di economia (fallimento collettivismo ed incapacità del capitalismo
ad equa distribuzione delle ricchezze); di individualità (oggi esasperata con la privacy, ma problema irrisolto
quando sconfina con l’anarchia degli interessi e delle idee) mantengono
– seppur cambiati nell’impostazione - validi i ‘titoli’ della sua filosofia.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 2718
-AA.VV.-Contributo di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1997-pag.36
-Berengo G.G.-Nessi G.P.-Staglieno-Tormena.2002-pag. 121
-BuonoRaffo E.-personaggi genovesi nella storia-LionsClub2006-p.63
-DeLandolina GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag. 47.48
-Genova, rivista del Comune-Il popolo con Mazzini 1872-1972-
-Il Secolo XIX del 08.09.04
-Mannucci FL-aneddoti di vita letteraria e politica genov.-Liguria.1967-p.69
-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1900-pag.18
-Pagano/1908 –pag. 873-9---Pagano/1933 –pag.247.1690-7
-Pescio A.I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.224
-Repetto S.-pionieri della cremazione...-Microstori
2010-IV-pag.146
-Salucci A.-Amori mazziniani-Vallecchi.1928- pag. 9