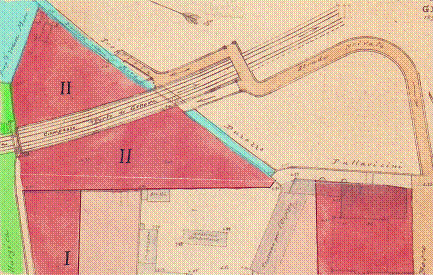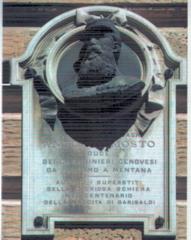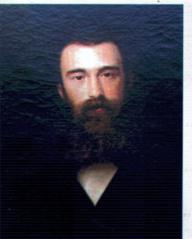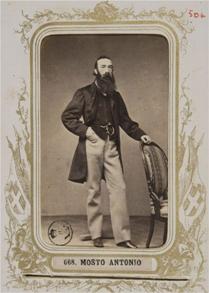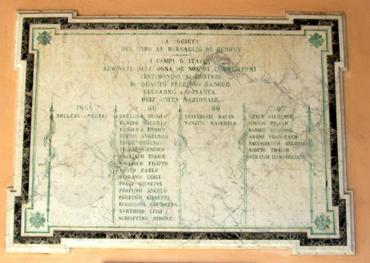MONASTERO via del
Monastero
TARGA: via – del – Monastero – già via Arnaldo da Brescia
S.Pier
d’Arena – via – del – Monastero


sulla
facciata del Teatro
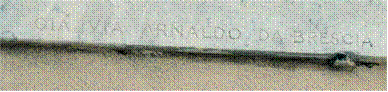

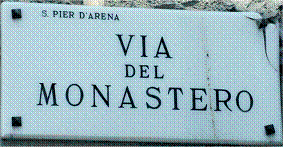
angolo con
piazza Modena

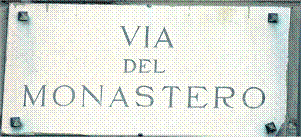
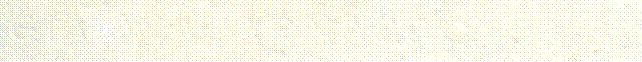
angolo con
la piazza omonima
QUARTIERE
MEDIEVALE: Mercato – Castello
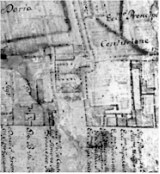 da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero
da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero
N° IMMATRICOLAZIONE:
2808 CATEGORIA: 2
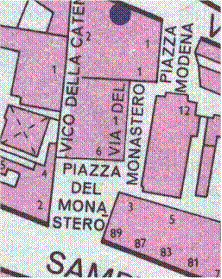 dal Pagano 1967-8
dal Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA – n °: 39600
UNITÀ URBANISTICA: 26
- SAMPIERDARENA
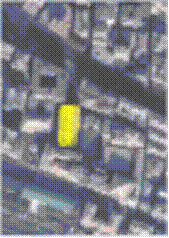 da google Earth, 2007. In giallo il
teatro Modena
da google Earth, 2007. In giallo il
teatro Modena
CAP: 16149
PARROCCHIA:
s.Maria della Cella
STRUTTURA:
carrabile comunale, a senso unico viario dal cancello (che una volta apriva al
mercato comunale) e da piazza del Monastero, a piazza G.Modena, lunga
m.82,65, e larga 4,7, con due marciapiedi larghi un metro e mezzo. I numeri
civici, sino al 5, sono distribuiti inversamente al senso di marcia dei
veicoli.
CIVICI
2007=
NERI: da 1 a 5 (compreso 1A)
ROSSI: da 1r
a 27r; da 2r a 12r
===civ.1
È posto nel cosiddetto ‘palazzo Balbi’ descritto in pza V.Veneto
Era
nel 1933 quando compare già esistere la tipografia
Gazzo Cristoforo al civ 1 (sul Pagano/33 viene erroneamente detta in ‘piazza A.da
Brescia’; Lamponi scrive vi fosse un ‘Atelier musicale’ che sullo stesso
annuario compare ma nella vicina via
Vittorio Emanuele). In questi stessi
anni, viene descritta essere stata esistente una piastra metallica posta a
terra vicino al portone, attestante che quella zona era ancora proprietà
Centurione.
Il
Pagano/40 segnala la tipografia Gazzo al civ. 1/1; e di civv. rossi 1r cinghie;
4r tabaccheria; 9r bar
STORIA: dalle
prime carte, appare che la villa era in comunicazione con la via centrale,
tramite un viottolo a levante della villa stessa; l’identica posizione di
transito verso l’interno, doveva averlo quindi anche quando nel posto c’era
prima il monastero, intermedia tra il quartiere del Mercato e quello del
Canto, in una posizione per secoli considerata quella centrale del borgo: in
pratica è antichissima. E’ quindi logico che sino alla fine del 1800 si
chiamasse Via Centurione. Agli inizi
dell’anno 1800 le fu dato il nome di via Arnaldo da Brescia: agli inizi dell’anno 1900 vi si apriva l’abitazione
del custode del teatro; e con tale nome , di 3.a categoria.
Nel 1940 circa, le fu definitivamente confermato il nome attuale .
DEDICATA alla
villa che la affianca ( vedi “piazza del Monastero”).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-AA.VV.-guida
annuario archidiocesi- anno/94-pag.420 /02-pag.457
-Guida
Sagep 80.2
-Lamponi M- Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 70
-Novella P.-Guida di Genova-Manoscritto 1930- pag. 16
-Pagano/1940-pag.341
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.
34
-Ragazzi F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag. 82
MONTANO piazza Nicolò Montano
TARGA:
piazza
– Nicolò Montano – amministratore mecenate – 1825-1882


angolo con via P. Reti


muragline strada verso la
stazione ferroviaria


portici d’angolocon via
A.Cantore

portici terrazzo davanti a
Salvemini
QUARTIERE MEDIEVALE:
Mercato
 da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;
celeste, crosa dei Buoi.
da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;
celeste, crosa dei Buoi.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2809 CATEGORIA: 1
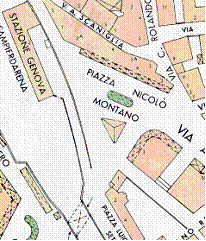 da Pagano 1961
da Pagano 1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 39940
UNITÀ URBANISTICA: 26
- SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007. In celeste,
via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione
ferroviaria.
da Google Earth 2007. In celeste,
via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione
ferroviaria.
CAP: 16151
PARROCCHIA: (2 e 4)=
s.G.Bosco--- (rimanente)=s.Maria della Cella
STRUTTURA: al
centro di un trivio, come in una Y il traffico proviene da via A.Cantore,
piazza Vittorio Veneto e via P.Reti.
La
facciata a levante ha dapprima la piazza Settembrini, il palazzo detto delle
poste ed un altro edificio porticato; il tutto ospita due banche, un bar e da
molti anni una lunga bancarella di libri (nuovi ed usati).
Il
lato a ponente è interamente occupato dal muraglione della ferrovia e stazione.
A nord, la villa è affiancata ad alcune costruzioni delle quali, quella a
levante (a piano terra occupata da Salvemini) ed a ponente da due palazzi, uno
porticato come la villa ed uno senza (quest’ultimo con la caratteristica palma
davanti). Nel centro un residuato degli antichi giardini. Tutto descritto dopo.



anni 1910-20 anni 1920-30 anni
60-70



anni apr./e1936 foto Pasteris anni 50-60
anni 70-80



anni 1910-20 anni 20-30
anni 70-80
STORIA della piazza:
Agli inizi dell’anno 1500, l’erezione della villa comportò l’acquisto
del terreno da parte di Cristoforo Centurione, costituito da una lunga striscia
di terra che dalla casa arrivava sino al mare: dalla loggia, i signori
allargavano la vista sino alla spiaggia, e dalla torretta potevano tenere in controllo
sia il largo del mare che le uniche strade importanti: la via
sant’Antonio proveniente dalla Lanterna (essa poi, scorrendo dietro la villa si collegava e
prolungava con via san Cristoforo (v.A.Scaniglia ma protratta fino al
ponte) e via san Martino (v.C.Rolando); il cancello della villa si apriva nella cosiddetta ‘crosa dei Buoi’ che dal fianco a levante arrivava
alla marina e che in quell’epoca era poco meno di una carrettabile usata dai
contadini della Fiumara per portare le merci al mercato del borgo o a Genova).
Dal 1850, con la ferrovia dapprima che tranciò brutalmente a metà la proprietà ed avvolse la
villa col manufatto a ponte, il muraglione della stazione e la via Vittorio Emanuele; con l’allargamento del tratto terminale della ‘crosa dei Buoi’ (neobattezzata via Nino Bixio (vedi ad essa), che dal Canto arrivava sino al lato
a levante della villa), e con le
costruzioni abitative erette intorno, la proprietà si ritrovò
progressivamente imprigionata, preannunciando i limiti della futura piazza. Essa
acquisì le caratteristiche di una piazza negli anni a cavallo tra 1800 e
1900, via via tagliando ed assottigliando i giardini antistanti e proprietà
della villa Centurione-Carpaneto. Si descrive che l’intero parco aveva oltre
500 piante d’alto fusto, in gran parte di origine esotica.
Progressivamente così il giardino privato, distratto anche del prato a giardino con fontana acquisito
dal Comune cittadino ed adibito ad uso pubblico (piazza Settembrini) è divenuto sempre più stretto: a
fine ottocento seppur ancora ricco di alberi, appare nelle fotografie
delimitato da due vie principali (la via Vittorio
Emanuele (poi Milite
Ignoto) proveniente dalla piazza Vittorio Veneto ed estesa
lungo il muraglione della ferrovia con la linea del tram, e la via N.Bixio (ex crosa dei Buoi) a levante nel cui retro a levante
era la zona detta ‘le stalle’ per l’ampio spazio dedicato a questa necessità di
trasporto) e racchiuso a triangolo da un
muretto con cancellata , comprendente una casupola ed un torrione.
Del 1907 un primo progetto (numerose tavole e relazione esecutiva di metropolitana, allora chiamato “ ferrovia
economica a trazione elettrica
Sotterranea
di Genova” - progettata
da C.Pfaltz,
ingegniere svizzero direttore dell’AEG di Genova quando divenne proprietaria
delle funicolari ed altre attività connesse all’uso della corrente elettrica. Mentre SPdA si propose favorevole alla realizzazione del progetto, non
lo fu Genova, preoccupata per i venti di guerra (il percorso era previsto per
9.140m da percorrere a 30Km/h in galleria e 10 fuori esse; un treno ogni 5’,
con vetture capaci di 40 persone cadauna; gazebi a padiglione alle fermate, in
stile post liberty, facilmente riconoscibili per uniformità. Nel 1912 il
progetto fu allungato sino a Nervi.
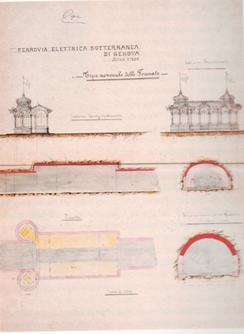
Nel 1911 un altro progetto non realizzato dell’ing Stefano Cattaneo Adorno,
con Emilio Rava, vedeva l’origine della
metropolitana (interamente ‘sotto il suolo stradale, a due binari, dalla nuova
piazza cui doveva far capo la grande arteria prevista (via A.Cantore), per
villa Scassi, sino a san Benigno ove sovrapassando il quadrivio delle
ferrovie, attraversava anch’essa in galleria il diaframma roccioso del colle’).
Forse ne fu fatto un secondo, nel 1924 (vedi via Milite Ignoto) nel quale
–forse constatando la difficoltà di procedere sotto terra, era prevista la
linea in superficie-.
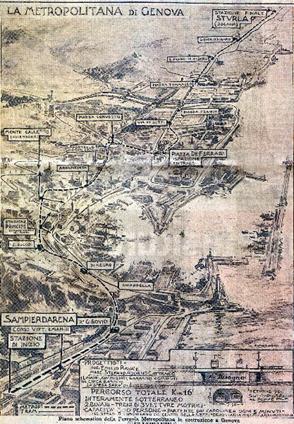
Nel
gennaio 1924 sul settimanale “L’illustrazione del Popolo” (anno IV, n.3, pag. 7 - supplemento
al quotidiano torinese “La Gazzetta del Popolo”) comparve un servizio annunciante che entro sei anni
sarebbe stata realizzata (in quanto approvata e finanziata) una metropolitana con spesa di 120milioni, su progetto
degli stessi Stefano Cattaneo Adorno ed Emilio Rava. Sotterranea, sotto il livello del mare,
lunga 16 km., con varie stazioni Il primo tronco: SPdArena-DeFerrari pronto
entro il 1927, al’epoca della notizia era già stato iniziato. A posteriori
qualcuno ha sollevato il sospetto che non fu realizzata per i reperti
sottostanti; e che comunque, vigendo il fascismo, le notizie negative venivano
censurate.
Nel 1933, ancora la piazza non esisteva come entità a sé, ma lo spazio
era ormai ben delimitato. Negli anni immediatamente a seguire, abbattuti i muri
dell’ala laterale e la torretta, aperta via A.Cantore davanti alla villa a cui
fu aggiunto il porticato, il giardino rimase sempre più avulso dalla villa
stessa; e continuando a rosicchiargli spazi ad uso stradale siamo arrivati a
farlo diventare infine una banale aiola. Rimangono pochi ceppi di magnolie e la
palma (che troneggia
ancora sparuta davanti al civ. 2a, e che dalle foto già appare inserita ai
primi del 1900: ed è quindi pressoché centenaria).
Negli anni 1950, da una foto si legge che nella parte a levante della
piazza, dopo il palazzo semicircolare con i portici, esisteva una casetta con,
nell’angolo, la targa (Canepa scrive che c’era scritto ‘piazza Stazione – poi
piazza Montano’), a tre piani che sarà demolita negli anni ’60; a piano terra
c’era G.Piffaretti – corriere espresso; seguito dal ristorante Gentile poi
Torre del Mangia. Nella stessa foto, dove ora è lo stesso ristorante, c’era la
Provvida e la banca Credito Italiano. E nel centro della piazza ove ora è la
pensilina coperta dei bus, c’era un distributore di benzina, condue colonnine,
dei f.lli Caso.
Nel 1969 si registrava nella piazza il passaggio giornaliero di alcune
diecine di migliaia di veicoli (precisamente 44.600 transiti).
Dalle foto, non antichissime, si vede un vigile urbano, alla fine di via
A.Cantore e l’inizio della piazza, troneggiare sulla pedana a dirigere il
traffico, e –a Natale - circondato da doni: era tradizione nel giorno della Befana, offrire ai vigili
urbani un riconoscimento, a testimonianza di affetto e stima, immutati nel
tempo, ...malgrado –già allora - tutto!

anno 1950; centenario costruzione
Quasi annuale un allagamento della parte a ponente
della piazza, fin tutto il sottopasso ferroviario stradale, evidentemente a
conca, arrivo e bacino di acqua piovana da via Stennio (e oltre) e da via GB
Monti - corso Martinetti.
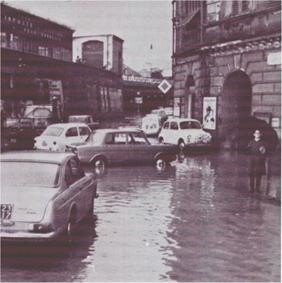
CIVICI
2007=
NERI dal 2 al 4 (compreso 2A). Non esistono
civici dispari
ROSSI da 3r a
25r (mancano da 9r→13r compresi)
dal 2r
al 36r
Fanno
parte della piazza: 1) vari numeri civici
+ 2) salita alla stazione + 3) tunnel pedonale ferrovia + 4) aiuola con alberi, due monumenti, capolinea e
fermata AMT + sottopasso Montano (vedi a sé stante).
Il
Pagano/1940 descrive: essere delimitata da via Martiri Fascisti, via
A.Cantore e piazza Sabaudia. Che ha civv. neri 2,4 e 3,5; rossi = 1r bar; 3r la Rapidissima rip.calz; 5r commestib.; 6r
parrucchiere; 8r trattoria bar Gaia; 26r Credito Ital. Ag, 1; 34r oreficeria
R.Salvemini
Nel
2010:
1) CIVICI DISPARI = collocati sulla
facciata a levante della piazza (una volta facciata laterale di via
N.Bixio). Va, dai giardini a via A.Cantore
=== civ.dal 1r al 7r (appartengono
alla BNL, con ingresso al 7r. Nel 1950 ospitava nell’angolo con piazza
L.Settembrini, il bar di Odino C.
Ha
ospitato uno dei primi uffici pubblici delle poste,
locali poi occupati dalla trattoria Bolognese, seguita da quella del Masini
(che poi si trasferirà sotto i portici aprendo la ‘Torre del Mangia’), ed ora
di una banca
Il
palazzo ha ingresso in piazza Settembrini (vedi) e fu demolito nel 1957.




===civ 3r
nel 1950 viene segnalato il bar Squillari Albino
===civ.
5r nel 1950 il bar di Fogliati Camillo
-------CORRIDOIO
ANONIMO tra due palazzi, con civ. di via URela (vedi)
===civ.15r sotto i
portici, nel 2009 è un bar con veranda nel corridoio
===civ.
3
===civv dal 17 al 25r Banca
Passadore (che ha ingresso al 25r + ulteriori
due civici in via Cantore).


1950 circa
CIVICI PARI la numerazione non è centrifuga come
dovrebbe essere, ma centripeta, iniziando da v.P.Reti.
===civ.2; il palazzo non è antico, ma ha pretese di estetica.
Ritengo risalga ai primi anni del 1900: il portone ha 2 colonne esterne;
la facciata è decorata: a) tra pianoterra e primo piano, cornice con
grossi riquadri riportanti in altorilievo corpi maschili alati con riferimenti
alle arti (musica, scrittura, ecc); a 2° e 3° piano con due lesene verticali e
finestre incorniciate; tra 4° e 5° piano con altrettante due lesene culminanti
con capitello floreato; sopra il 5° piano altra cornice floreale; le scale
con scalini non molto alti, ringhiera di ferro battuto, e non c’è ascensore;

3
appartamenti/piano, con i vani di vaste dimensioni; soffitti alti oltre
3 metri e decorati con affreschi semplici; non c’è bagno (al civico 8, su oltre
10 vani c’è un solo gabinetto, piccolissima stanza con la sola tazza del WC e
senza bidet).



Ai
tempi dell’apertura del sottopasso ferroviario, si parlava demolire il palazzo
per mettere in dirittura via Cantore con il sottopasso stesso e via EDegola.
Tra
questo palazzo e la villa, esiste la facciata di un altro palazzo che non
ha l’ingresso sulla piazza ma è il civ.4 della via retrostante A.Scaniglia
===civ. da 2r a 12r dietro
alla palma, poi negli anni 1950 ed oltre, è stata sede della ‘tipografia
Cartotecnica’. Oggi, 2009, c’è la ‘Sicurmetal’ (porte, finestre,persiane in
metallo).
===civ.
8-12r la trattoria che sino al 1950 era trattoria,
di Gaia N. Nel 1950 la
trattoria appare gestita da Gandio L.
 con
ombrelloni gialli, la trattoria.
con
ombrelloni gialli, la trattoria.
===civ. 22r sotto i
portici (iniziano dal
14r) rivendita di macchine da cucire
===civ.24r il ristorante
‘Torre del Mangia’, gestito fino al 2003
dal sig. Masini, già
titolare della trattoria posta nella stessa piazza ma nel cosiddetto palazzo
delle poste, all’angolo con piazza Settembrini (forse al civ. 8-12r) . Quello
che fa sorridere è che il ristorante, divenuto famoso per la cucina
prevalentemente toscana, inganna gli sprovveduti i quali gli collegano la torre
che sovrasta il palazzo e chiamano quest’ultima come la torre di Siena.
===civ.
4 villa Centurione (vedi sotto)
=== dal 26r al 36r L’orefice
Salvemini con ingresso al 34r che si apre
non sotto i portici ma di fronte alle scale del sottopasso.
2) ===STAZIONE FERROVIARIA: A seguito del Congresso di Vienna del nov.1814, la Repubblica Ligure fu
forzatamente ed unilateralmente unita al regno di Sardegna ; le due mentalità
ed economie –monarchia assoluta e agricoltura a Torino, propensione
repubblicana e commerciale a Genova, entrarono subito in contrasto con attriti
violenti, repressione sanguinosa (1849) e di pesante retaggio. Cavour seppe
cogliere il momento: lavorò con l’alta società ligure, al fine di allacciare
migliori rapporti economici tra le due città; Genova era in piena ‘febbre
industriale’ con grossi capitali a disposizione e quindi grandi opportunità di
investimento; ed i tempi erano maturi perché fosse la ferrovia a riequilibrare
le due diverse nature e necessità.
Costruita
e completata alla fine del 1853 (vedi a via G.Buranello)
la linea ferroviaria Torino-Genova (le prime linee inglesi sono degli anni 30; la prima italiana
Napoli-Portici, del 1839; il primo tratto della Torino-Genova, fino a
Moncalieri, del 1848 : con l’uso di una locomotiva belga battezzata ‘Carlo
Alberto’), all’inaugurazione non fu
prevista alcuna stazione intermedia; però per comodità ed uso, fu d’uopo
spezzare il tragitto secondo le località di maggior traffico e, San Pier
d’Arena fu senz’altro una delle prime, sicuramente quando nel 1865 si
provvide al tracciato verso il ponente (dei due progetti presentati, uno prevedeva addirittura
by-passare la nostra stazione passando più a mare ed innestandosi nella linea
statale con un cancello posto al limite -non si specifica dove- ed apribile
solo al passaggio; per fortuna fu scelto l’altro progetto dell’ing.Parodi che, anche
se più costoso fu più garante la sicurezza pubblica e non creò un altro mostro
lungo il borgo).
La locomotiva a vapore, nata in Inghilterra, fu soggetta ad importazione –sia per pregiudizi di produzione
esterofili ed a scapito del prodotto italiano; sia per fattori doganali :
costava meno introdurre una macchina già fatta che la materia prima grezza; sia
per scarso appoggio e per alti interessi applicati dalle banche agli
imprenditori - finché le officine
Ansaldo (vedi a via
Ansaldo) non furono in grado di produrne
di proprie (classica
nei testi, una delle prime vaporiere italiane, sperimentata nel tratto
Genova-Pontedecimo nel dic.1854, capace di una velocità di 65 Km/h, battezzata
nel 1855 ‘SAMPIERDARENA’; negli anni 1850-60 in Italia esistevano solo 404
locomotive di cui solo una ventina dell’Ansaldo.
Sul Gazzettino è scritto che la stazione ‘poggia
ancora su una fitta serie di cunicoli e celle di un convento del quale si può
ancora vedere la parte esterna ossia l’ingresso alla Stazione’; l’idea di un
convento sopra il viadotto al pari dell’attuale ingresso è illogico; che il
convento fosse sotto e sulle cui fondamenta sarebbe poggiata l’attuale
stazione, è ripetuta voce mai dimostrata ed assai improbabile: che nessun
testo e nessuna carta riportino l’esistenza di una chiesa o similare anche di
minuscola comunità a ponente della villa Centurione, mi appare impossibile;
mentre è più facile pensare che -come sul viadotto che segna via Buranello
hanno aperto numerose celle per negozi-, anche sotto il riempimento della
stazione abbiano creato vuoti ai fini più disparati: da depositi di carbone a
quant’altro, compreso i vani adibiti a stalle posti di fronte alla attuale via
Stennio.



Umberto I e Crispi
ossequiano l’imperatore tedesco Federico III
L’ 11 mar.1888, (Pippione
scrive il 10 marzo, ore 12,15) vi
transitò -proveniente da Sanremo per cura climatica, il principe Fritz (nomignolo affettuoso per il
cinquantenne Federico Guglielmo, che stava tornando in Germania per divenire
l’imperatore FedericoIII, dopo la morte di Guglielmo I Hohenzollern a cui erano
stati intitolati a Genova il pontile e la prima piccola Stazione marittima, ora
“dei Mille”) con la moglie e le tre figlie. In stazione si era portato
all’incontro il nostro re Umberto I proveniente da Roma col suo seguito (tra cui Crispi, presidente del Consiglio e i consoli
tedeschi): si creò per 15 minuti una scena di
alta commozione, sapendo che il futuro imperatore, buono, valoroso, ed amico
del re, era malato di tumore in gola e comunicava solo a gesti o con foglietti
scritti in francese per essere compreso dai nostri: infatti non sopravvisse che
tre soli mesi all’incoronazione avvenuita il 22 marzo successivo, morendo a
pstdam il 15 giugno. Gli succederà Guglielmo II di Prussia, primogenito di
Federico, che aveva idee differenti dal padre, sia sulla Polonia che
sull’Italia (diverrà nostro nemico nel conflitto del 1915), e che già
manovrava per la supplenza prima ancora della dipartita del padre
-Ricordi scritti fanno cenno ad un certo Puin, erculeo
facchino della stazione, che si vantava essere capace di sollevare due quintali
di merce, ma solo al mattino; dal pomeriggio forse, la massiccia muscolatura
cedeva al potere del nettare.
-Per
il Pagano 1902-12 Balbi Francesco gestiva la trattoria ‘alla Staz.Ferr.’
Forse è lo stesso che poi comperò l’omonimo palazzo di piazza Vittorio
Veneto.
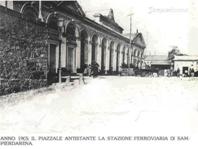

cartolina 1905 1915
-Nei
locali adiacenti, fu operante una sede del Dazio, per il controllo delle merci
in arrivo. Lamponi segnala che durante la guerra del 1915, vi erano
locali adibiti a ambulatorio-assistenza dei militari feriti e transitanti verso
luoghi di cura, curato dal dr. GB Botteri presidente del Comitato distrettuale
della CRI locale.


cartolina
1902 transizione tra
elettrificata e a vapore
Nel Pagano/19-25 la trattoria appare gestita da Paleari Pietro (forse lo stesso del bar Roma di Pza
V.Veneto). Mentre il bar della
stazione era gestito da Paleari Pietro: così nel Pagano/1919-20(tel.44-86)-1925(tel.41309)-1933.
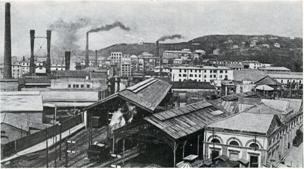



Una relazione del 1926, sottolinea in stazione un traffico di circa 300
treni al giorno (una delle principali d’Italia), purtroppo anche con molte
disgrazie causate dalla mancanza di sottopassaggi e dalla solita
superficialità; divenne
quindi necessario un nuovo progetto, che meglio utilizzasse la grande
superficie occupata dal terrapieno: fu previsto così un nuovo fabbricato -nel
progetto diverso da quello attuale, lungo 120m- , una rampa al piazzale
antistante concepiti un modo “che apportino piccola modifica al giardino
Carpaneto”, lasciando la via Milite Ignoto a distanza di 20m. Sotto i binari si
previde uno svuotamento del terrapieno, inserendo pilastri e volte in modo di
ricavare un vasto locale (80x40 m) ed una galleria - che collegasse via
Milite Ignoto (via P.Reti) con via Cavour (via Dondero) con transito di pedoni
e di veicoli, fiancheggiata di negozi, servizi (sala scrittura, telefoni,
deposito bagagli, pulizia scarpe, albergo diurno, uscita viaggiatori, stazione
taxi). Questo progetto, abbastanza grandioso e pretenzioso nello stile delle
decorazioni , prevedeva pure un allargamento del sottopasso da piazza Vittorio
Veneto ed altri rifacimenti il cui “problema economico era praticamente
risolto” . Il passaggio nella grande Genova, probabilmente infranse la
conclusione del progetto ; alcune parti furono eseguite, per essere
abbandonate, e poi riprese negli anni 80-90***, nel modo attuale; lo sbocco
della galleria che doveva collegare le due strade, a lungo fu occupata da una
scuola guida per auto. In quegli anni, parte dei locali erano occupati dagli
uffici del Dazio, per il controllo delle merci in arrivo con i viaggiatori .
-dalla
loro costruzione, fu necessario punto di riferimento alle linee tranviarie,
quale punto di capolinea o transito di passeggeri.
Non è specificato da quando né dove è, ma il ‘Fabbricato Viaggiatori FF.SS.’
e posto sotto tutela e vincolo della Soprintendenza.
Durante l’ultimo conflitto mondiale fu ovviamente più volte mirata dai
bombardamenti, ma mai ‘centrata’; solo nel bombardamento navale inglese del 9
febbraio 1941, una bomba da 381 esplose su una vettura pronta a partire
per Limone, uccidendo tre sciatori e ferendone molti altri mentre altre - di
minore calibro - fecero solo danni materiali.

 9.2.1941
9.2.1941

 28.4.44
28.4.44
Nell’organo giornalistico del comune, nel 1952 si legge che l’opera è
ormai antica, non più idonea alle esigenze moderne, indecorosa, ingombrante;
che il nudo muraglione toglie ogni attrattiva alla zona e la rampa di accesso,
piantata nel centro cittadino, è una bruttura; insomma che il tutto è ‘da
distruggere senza una lacrima di rimpianto’ . Ma le ferrovie non credo abbiano
nessun progetto di spostare le sue linee che tagliano la città; e ‘more solito’
le cose sono restate e resteranno tali quali.
Nel 1961, il Pagano segnala esistere tre locali pubblici (tabaccheria ATraverso della
stazione; la stazione ferroviaria; il ristorante della stazione gestito da
GaudioL.); 5 civici neri (con citati solo cinque
professionisti); 20 numeri rossi (stazione di rifonimento AGIP di
ACasu; autoscuola LTrompetto; chiosco latteria di SCortellesi; bar della
stazione; al 2r tipografia cartotecnica Montaldo; 3r= trattoria Gentili; 5r=
bar CFogliati; 6r parrucchiere GLavanna; 7r=calzolaio AAltobelli; 8r-12r
trattoria bar NGaia; 9r-11r commerciali Battilana; 13r due corrieri
Leone&Piffaretti; 17r-19r banca naz. Del Lavoro; 18r lavanderia
‘Appennina’;20r banco lotto; 21r-23r tessuti PittalugaE; 22r GhigliaG giornali;
24r la Provvida; 26r-28r ag.1 Credito Italiano; 30-34r SalveminiR orefice.


1975
Nel 1979 ci fu un nuovo restauro, con la chiusura del pronao a mezzo di
grosse vetrate ed unificando la sala d’attesa.
Nel
1998 fu restaurato l’orologio, uno dei pochi in città; fu un elemento
indispensabile, quando solo i ‘signuri’ avevano ‘la cipolla’ nel taschino.
In stazione è installato un moderno impianto elettronico capace di controllare
scambi e passaggi in modo preciso e in tempo reale. I lati negativi ed
insufficienti sul piano funzionale, sono legati alla vetustà dell’edificio, non
certo in linea con l’evoluzione dei tempi.
Non specificato da che anno, il “Fabbricato Viaggiatori FF.SS.” è tutelato e
vincolato dalla soprintendenza per i Beni architettonici della Liguria.
Nel
gennaio 2004 si parla di spendere 2,5milioni di euro per ristrutturarla,
essendo il terzo scalo in Liguria (dopo Principe e Brignole) con 7 milioni di
viaggiatori/anno che potrebbero aumentare in allargamento della metropolitana.
Una plurisocietà, fusa in unica società operativa chiamata “centostazioni”, in
Liguria prevede il lavoro per altre sette stazioni (architetture storiche,
barriere, illuminazioni, servizi, ecc.).
3) SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE Nel nov.1990 fu inaugurato il
sottopasso ferroviario che collega via Dondero con piazza Montano,
utilizzando dei vani ex-deposito di carbone sottostanti la stazione; l’opera,
già prevista nel 1926, finalmente finanziata (con 700 milioni, dalla legge per i campionati
mondiali di calcio), fu costruita dalla
soc. Icogen.
Comprende nel lungo e angolato (a Z) corridoio lungo cento metri abbondanti,
che da avvio alle rampe di accesso ai vari binari senza attraversarli;
comprende alcuni esercizi commerciali (inizialmente furono bar, pizzeria, profumeria, cartoleria,
articoli fotografici, abbigliamento), ed
anche facilita -dalla piazza- l’accesso al mercato comunale.
NOTA=
il sottopasso Montano, di via Cantore, ha una targa a sé ed è quindi inserito
subito dopo la descrizione della piazza.
4) AIUOLA con alberi di fiori (magnolie)
===BUSTO: dedicato a Pietro
Chiesa (vedi). La scritta dice “alfiere di libertà – e – democrazia
-***
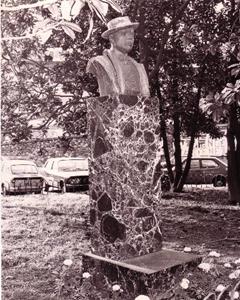
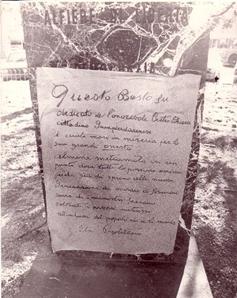
Negli anni 1975 un grosso foglio di carta fu incollato al
marmo: diceva «questo busto fu dedicato a l’onorevole Pietro Chiesa cittadino
Sampierdarenese il cuale mori in miseria per lo sua grande onesta almene
metiamolo in un punto dove tutti lo possono amirare perche sia di sprone alle nuove
Generazioni da andare a governare senza che i ministri facciano soltanto i
propri interessi allinfuori del popolo che ce li manda un Proletario» (gli
errori grammaticali sono riportati tutti conformi).
===LAPIDE: dedicata agli operai deportati, durante l’ultima guerra mondiale, vittime
di rastrellamenti improvvisi da parte dei tedeschi (presenti pochi elementi
della polizia e brigate nere) effettuati venerdi 16 giugno 1944 presso gli
stabilimenti SIAC (raggiungibile
col tunnel di via Chiusone), San
Giorgio, cantiere Ansaldo, Piaggio, OARN, Fonderie e Acciaierie Liguri, ed
altri, devastati dai bombardamenti, e quindi momentanea inoperosità di molti di essi (il
numero di duemila fu stabilito d’autorità tedesca, sommando gli operai che
ricevevano un sussidio di disoccupazione: 1600 quello totale, più 400 quello
parziale). Vedi a “via Giorgio Mignone” che fu uno dei non tornati.
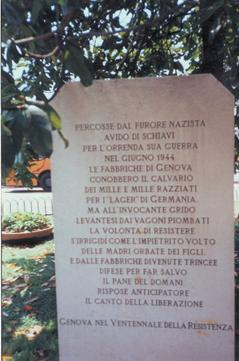
Dall’autorità tedesca, in accordo con il questore, già per
il 10 maggio ’44 (poi saltato e rinviato al 16 giugno) era previsto una
convocazione degli operai nel piazzale, per ‘un appello’: sommariamente
sarebbero stati visitati da 12 medici (che ovviamente poi non furono
utilizzati), e 2000 sarebbero stati fatti salire su una quindicina di vagoni
già pronti e fatti partire ‘come si trovano sul posto di lavoro’; i familiari
sarebbero stati avvertiti in seguito ed avrebbero potuto far pervenire entro
due giorni abiti e suppellettili in appositi pacchi. La Germania in concomitanza aveva
scarsità di mano d’opera: il vasto fronte belligerante aveva
assorbito tutti gli uomini in età produttiva; quindi affidò a Sauckel lo studio
di un piano di risaturazione della mano d’opera, nel quale fu prevista la
deportazione: si trovò nell’operaio italiano tendenzialmente ribelle e
favorevole alla ‘resistenza passiva’ nonché reso inattivo, una soluzione del
problema: prevedendo l’arrivo di oltre un milione e mezzo di persone (in realtà
non superarono le centomila) dapprima propose una emigrazione volontaria con
trattamento alla pari (andata praticamente deserta) e prelevando gli individui
giudicati antisociali (politici) o pericolosi detenuti in questura.
Dopo vari scioperi parziali iniziati a maggio (in genere
per richieste di miglioramenti economici o creazione di spacci aziendali,
rimaste tutte inattese) e proseguiti nei primi 15 giorni di giugno
-interessanti l’Ansaldo elettrotecnico e meccanico e, nella provincia, l’Oarn,
la San Giorgio, i Cantieri Navali, la Siac, l’Ansaldo carpenteria e quello
Fossati, così che quando un focolaio sembrava spengersi se ne riaccendeva un
altro, creando gravi disagi ai fascisti a cui era affidato il servizio
d’ordine; ed in un clima reso confuso dai bombardamenti sempre più disastrosi,
dallo sbarco avvenuto in Normandia, le truppe alleate entrate a Roma, e le
prime azioni terroristiche dei Gap - il giorno 16, iniziarono il rastrellamento
improvviso e violento, concentrando gli operai (dalle prime valutazioni di 5000
in G.Gimelli; il Gazzettino dice 1284; A.Gibelli – citando fonti dell’amministrazione
tedesca - dice tra 1500 e 2000 anche se le testimonianze fanno pensare ad una
cifra superiore; Fucile, uno dei pochi ritornati, scrive 1550 a pag 20 e 1500 a
pag.70; il numero è impreciso sia perché alla notizia dei rastrellamenti molti
fuggirono creando vuoti non valutabili, sia perché mai fu fornito un elenco – Calegari
dice che solo alla fine della guerra fu possibile un bilancio più rigoroso, ma
non indica il risultato, dicendo ‘circa 1500’); su circa 40 carri ferroviari
per bestiame -tristemente noti anche per gli ebrei- e in due convogli li
allontanarono verso Trento, così come erano, alcuni in canottiera, senza
lasciare il tempo di avvertire le famiglie o raccogliere vestiti ed altro,
favoriti dalla ancora iniziale ed inefficiente preparazione delle forze
partigiane. In troppi non tornarono più. Per evitare reazioni, in città fu
imposto il coprifuoco ed un clima di terrore.
La
lapide reca scritto : “percosse
dal furore nazista - avido di schiavi - per l’orrenda sua guerra - nel giungo
1944 - le fabbriche di Genova - conobbero il calvario - dei mille e mille
razziati - per i lager di Germania - Ma all’invocante grido - levatesi dai
vagoni piombati - la volontà di resistere - s’irrigidì come l’impietrito volto
- delle madri orbate dei figli - e delle fabbriche divenute trincee - difese
per far salvo - il pane di domani - rispose anticipatore - il canto della
liberazione -- Genova nel Ventennale della Resistenza “.
===PENSILINA sono due= una quella ferroviaria, modificata nel tempo (vedere
fotografie); attualmente con parziale copertura.
Una
nella piazza, ad uso salita-discesa AMT per le linee dirette verso Rivarolo.
A
fianco di quest0’ultima, è stata lasciato uno spiazzo, ad uso capolinea di
alcune linee locali.
===civ 4: VILLA CENTURIONE-TUBINO-CARPANETO.
1)
storia della villa
Non
si conoscono i dati precisi sull’epoca della costruzione e dell’architetto;
probabilmente fu costruita su antico sedime e dopo la metà del 1500 per Cristoforo di G.B., del casato di Spagna degli Centurione Oltremarini (deLandolina scrive “oriundo di
Spagna” ma non è credibile). Era fratello del banchiere Adamo di
GB (che aveva il titolo
spagnolo di marchese);
già fondatore e possessore
del palazzo in piazza Fossatello: ma nessuno nominato da Battilana in Famiglie
Nobili, poiché descrive solo gli Scotti.
Roncagliolo –storico del Gazzettino- interpone un Luigi
Centurione, che però era dei Centurione Scotto e fu l’ordinante allo Strozzi degli
affreschi della sua villa, ma quella posta in Strada Nuova).
Cristoforo
ebbe figli: primogenito Battista (col titolo –come lo zio Adamo -
marchionale in Spagna e quello del Monasterio); poi seguirono in sei: Filippo, GianGiacomo (deceduto 1644), Adamo (senatore 1629-31; deceduto 1635), Ottavio (fu gentiluomo rappresentante della Repubblica
in Spagna; deceduto 1652) e l’ultimo -
nato e cresciuto in Spagna. Tutti i primi, attivi sulla scena politica
genovese, ed escluso il primo – morto precocemente il 7 dic.1615 - imbussolati nell’urna del Seminario (requisito primario per accedere ai
Collegi direttivi del governo locale).
Famiglia Centurione, originati verso la metà del XIV secolo, erano composti da varie
famiglie tutte ghibelline, tutte ricchissime e potenti non solo in Genova ma in
tutto il Mediterraneo: i Cantelli, i Becchignone, i Bestagno,
ai quali si aggiunsero i Traverso e gli Scotto (divenuti principi del Sacro Romano
Impero nel 1654) e gli Oltramarini
(originari da Paraggi
di Rapallo proprietari di immense ricchezze acquisite col commercio). Nel 1528
formarono il 28° Albergo. Nel 1630, per l’erezione dell’ultima cerchia di mura
attorno la città, i Centurione dovettero partecipare pagando cifre milionarie
di allora, per la relativa tassa straordinaria. L’arma ha una banda d’oro
scaccata di tre file d’argento e rosso; gli Oltremarino hanno in più una rosa
in capo.
Un GB doge nel 1658-60 fu
stimatissimo personaggio di mare e di politica, ambasciatore, inquisitore,
commissario di sanità durante la peste del 1656, si costruì il palazzo -oggi al
civ.5 di via san Lorenzo. Caratteristica la figura di un Adamo di Luciano già ricchissimo cavaliere
arricchitosi con l’usura (prestiti al 60% di interesse) ed alcun bordelli;
sposò nel 1541 la sua unica figlia a Giannettino Doria.
Erano invece dei Centurione
Scotto, Barnaba (nel 1599
marchese di Morsasco per investitura da parte del duca di Mantova e poi
senatore; e suo figlio Luigi che comprerà in
Strada Nuova, dai Lomellini, un palazzo che vorrà far decorare dallo Strozzi e
contro il quale nel 1625 fece causa in tribunale per insolvenza (diverrà
senatore pure lui).
Erano
anni nei quali gli uomini d’affari genovesi – da mercanti e marnai si erano
trasformati in banchieri-finanziatori - si erano enormemente arricchiti nei
traffici con la Spagna, con conseguenti investimenti edilizi di notevole
portata e prestigio, e con abbellimento delle dimore – con committenze
artistiche - parallelo al raffinato modo di vivere.
Originariamente fu costruita nell’angolo nord-est del terreno; ad L per
l’esistenza di un’ala a levante, orientata verso il mare, con volume e
perimetri (specie quelli a nord) stranamente irregolari e apparentemente senza
una logica precisa se non dipendenti dall’utilizzo di qualche costruzione
preesistente (si
conferma infatti che fu costruita “nell’area di più antiche architetture”.
La sua torre angolare ancora conservata era posta
proprio al centro della piazza del mercato, disposta a formare una strettoia
<strategica> con l’opposto palazzo appartenente già alla metà del XVII°
secolo a Gio Luca de Franchi”; e lo spessore di certi muri e la
struttura di alcune volte -poste a levante della loggia - evidenziano
un’origine precedente.


da via C.Rolando il portone, in piazza Montano
La constatazione che questa struttura nel suo retro sia
irregolare solo per un adattamento all’asse viario tangente (che, proveniente
da levante, sul retro della villa si apre a Y, per proseguire verso il Campasso
o verso il torrente), non è giustificata – considerato: sia l’ampio spazio
costruttivo a disposizione, che avrebbe consentito spostarsi a piacimento sino
alla riva del mare; e sia che i nobili di quei tempi, non avevano controparte a
cui rendere conto delle proprie scelte, e non avrebbero sacrificato la qualità
di una villa, per -per loro- inezie simili). Lo stesso Alizeri a pag.362
conferma che l’edificio “fu ricostruito”.
La proprietà era compresa tra le antiche via dei Buoi a levante prima che essa terminasse in piazza del Mercato, via san Cristoforo a nord, il mare ed altri proprietari a sud, altre proprietà
a ponente (nel 1757 erano del magn.co Geronimo e del r.do
Giacomo de Negri). Allora, era
praticamente l’ultima villa del borgo, prima di Cornigliano (non esistono documenti, per
attestare l’età della villa che esisteva nell’attuale via Pieragostini, ma
sicuramente posteriore poiché citata da nessuno).
Morto Cristoforo, ereditò questa villa il
primogenito Battista; ma egli morì il
7 dicembre 1615 senza eredi – si ipotizza
che fu lui ad ordinare gli affresci allo Strozzi; per cui la successione toccò
al secondogenito Filippo (erano tra i più ricchi cittadini della Repubblica, nipoti del banchiere
Adamo, figura di massimo rilievo politico
ed economico del 500 genovese e ‘spalla’ politica di Andrea Doria) e dell’arciv. Alessandro. Era influentissimo
ambasciatore della Repubblica alla corte di Madrid durante i regni di
FilippoIII e IV. Divenne senatore, ovvero Supremo Sindacatore negli anni
1617-22 e di nuovo dopo il 1624, nonché procuratore 1630-1; due volte in corsa (su sei candidati, ebbe però il
minor numero di voti)
per divenire doge nel 1617 e 21) pare in
comproprietà con altri fratelli. Filippo, desiderando fare della villa sua
unica ed esclusiva abitazione (come descrive puntigliosamente nel suo testamento datato 24 aprile
1643), stipulò con gli altri un accordo
di godimento –versando loro del denaro. Fu tra i testimoni a favore del pittore – durante le sue
peripezie legali–: compare infatti Filippo Centurione q. Cristoforo, il 26
marzo 1626 quando dichiarò sotto giuramento essersi servito dello Strozzi “in
far qualche pitture” avendolo conosciuto 3-4 anni addietro; la critica non
collega però queste date con gli affreschi sampierdarenesi potendosi riferire a
quelli genovesi.
Fu Filippo ad ordinare (l’artista aveva appena finito di
affrescare nel coro della chiesa di san Domenico) gli affreschi
al frate Bernardo Strozzi (che poi difese dalle accuse
promosse dall’ ordine dei Cappuccini, giurando per lui, e garantendo col suo
rango -ed un po' con la prepotenza tipica dei potenti- l’innocenza del pittore). Mario Marcenaro scrive che fu
Luigi Centurione, proprietario della casa di via Nuova (palazzo ex Lomellini (? via Nuova a Genova? visto che qui
il palazzo fu costruito per i Cent.) poi Centurione, poi Pallavicini, Raggi, Podestà, Bruzzo) che ebbe litigio e vertenza legale (1625) con lo Strozzi, e questo è vero ed accertato. Però
anche lui scrive che Luigi era proprietario anche a SPd’A (“lavorò per Luigi Centurione nella
villa di Sampierdarena”),
il che confermerebbe vera la tesi di Roncagliolo.
Filippo, nel suo testamento del 1643 (ove raccomanda la sua anima a s.Teresa ed al
beato Salvatore, suoi oprotettori, dopo aver ricordato i
miglioramenti ed ampliamenti effettuati
dal fratello Battista), lascia il palazzo al primogenito Agapito.
Bernardo Strozzi,
detto il Cappuccino: nato a Genova nel 1582 (1581?)
da Pietro e da Ventura (forse nel sestiere del Molo, ma il
registro di quegli anni nella chiesa di s.Marco non c’è); aveva una sorella Ginetta che, in seconde nozze sposò Onofrio
Zino – pure lui vedovo- di Framura ed al quale il pittore pagò per quattro e
più anni gli alimenti per la sorella e i figli –uno, GioAntonio, avuto col
primo marito Pietro Fontana e GioBattista (altrove Giuseppe) col secondo; paese
nel quale comprò una casa e lavorò anche il pittore, dimorandovi.
Definito ‘spirito bizzarro’, abitava
con i genitori negli orti di s.Andrea.
Solo alla morte del padre –che lo
voleva letterato- inizò la prima formazione pittorica, frequentando la bottega
di Cesare Corte e quella del senese Pietro Sorri (presenza accertata per gli
anni 1596-8); ma intorno ai 17 anni, nel 1599, preso da
esaltazione religiosa, si fece frate nel convento dei cappuccini di s. Barnaba
(ma qui, ricerche negli
ambienti religiosi genovesi, non danno alcuna traccia di lui).
Ebbe poi il Soprani come primo
biografo, che lo definì di ‘pellegrino ingegno’o anche “il Cappuccino” perché le sue opere erano firmate ‘prè Bernardo Strozzi’; inizialmente
prodotte di piccole dimensioni ma con con fertilità, soprattutto a tema
religioso, (tipo il lo sposalizio di santa Caterina ed un Cristo Portacroce, oggi al museo diocesano di Chiavari e l’Apparizione della Madonna Odigitria nella chiesa di san Maurizio di
Monti a Rapallo; la Madonna del Rosario nella chiesa di s.Stefano a
Borzoli; e due tele ora di privati con s.Francesco
in preghiera) permisero di mettere in rilievo le
sue doti innate di pittore, e divennero rapidamente così interessanti, da
essere richiesto a lavorare anche fuori del convento. Era nevessario la
dispensa per uscire, firmata dal Priore generale dell’Ordine che risiedeva a
Voltri.
Fuori del convento però, prevalse
“l’uomo d’affari” = acquista, affitta e subaffitta (al pittore Goffredo Waals, una casa
da lui avuta in affitto da Lodisio (=Luigi) Centurione) e
vende case e terreni; presta e si fa prestare soldi; raccoglie commissioni che
non sempre riesce ad onorare. Questo fervore artistico, caro gli costò. Perché
fu accusato di non tornare in convento come e quando era stato pattuito (ad un primo rinvio –1601-
era arrivato avendo dimostrato di star facendo un ritratto ad un suo vecchio
confratello –forse il priore stesso- nel convento di Voltri).
Ottenuta di nuovo negli anni 1608-9
la dispensa ad uscire, inizialmente motivata ‘per sovvenire alle
necessità della madre Ventura e della sorella’, il frate pittore poté
culturalmente aprirsi a maggiori esperienze (entrando in contatto con le varie correnti
artistiche che in quei tempi influenzavano l’arte pittorica in maniera sempre
più evoluta, specie di scuola toscana, lombarda e dal Caravaggio. Quando fuori
convento, viveva e produceva ampiamente stando in zona Campi in una casetta di
famiglia). Poté anche
impegnarsi con diversi committenti (che però lui avrebbe dovuto abbandonare quando nel 1630 la madre morì e avrebbe dovuto rientare in convento. Allora, le regole
di esclaustrazione erano governate da leggi papali severissime ed intransigenti
per chi aveva preso i voti: si concedevano solo per motivi gravi e per pochi
mesi). Così, ancora più rigide erano le regole della sua Comunità, nella quale alti
erano i poteri che aveva per farle rispettare, compreso la carcerazione).
Ne usufruì però anche per investire le somme
acquisite -contro le regole francescane- (che gli permisero impiegarle in una intensa attività di
compra e vendita di immobili: comprando terreni a Framura, per darli in affitto
ma con possibilità di riscatto alla stessa cifra dell’acquisto, oppure li dava
in prestito a basso tasso di interesse (4%); oppure affittando case come al
collega tedesco-fiammingo Waals; oppure poi –1632- donando una casa
“sita nella crosa del Colle” alla sorella, e da lei ceduta ad un rev.
Cristoforo DellaNoce fu Pantaleone al quale ella doveva 450 lire per il fitto
di una casa –dove forse lui aveva uno studio- posta in “via Nova, vulgo delle
Fontane”).
Fu produzione del 2°
decennio del 600 un s.Cecilia ora a Kansas City; una s.Caterina
d’Alessandria ora a Hartford; e del 1615 che ebbe la commissione dai
Centurione per la villa sampierdarenese e per altra genovese dove gli impegni
gli impedirono di rispettare i tempi cosicché compare una protesta di un Luigi
Centurione comprendente anche la somma pattuita (lire mille) ormai superata di
oltre 570 altre lire. Impegnato era anche con GioStefano
Doria a cui affrescò la volta con il trionfo di David; e con il
collezionista GioCarlo Doria al quale nel 1622
affrescò una cappella nella chiesa di s.Domenico.
Fu accusato di lavorare per lucro;
di dipingere temi non consoni alla sua dignità sacerdotale. Inutilmente tentò
varie strade, sia con domande di ritardare il rientro all’osservanza
claustrale; sia facendo domanda di cambiare ordine religioso cercando di
‘trasferirsi’ tra i Canonici Regolari Lateranensi (ma la regola papale stigmatiuzzava
che un passaggio era possiile solo scegliendo una congregazione con regole più
severe della precedente);
sia, 1632, prospettando l’ipotesi di dover assistere il nipote (Ginetta aveva avuto due figli: il
primo, GioAntonio, dal primo marito Fontana, un pò scavezzacollo perché
fuggito di casa e scomparso senza più dare notizie di sé; un secondo, Giuseppe,
nato da seconde nozze con Onofrio Zino, divenuto non vedente e –per tale
handicap- affidato per via testamentaria dalla sorella al frate con l’obbligo
dell’assistenza (e quindi con la necessità che fosse licenziato dalla
obbedienza ai Cappuccini); questo tentativo fallì perché dal Consiglio
Provinciale dell’Ordine –composto da un padre provinciale e due definitori o
consiglieri- non gli fu concesso spretarsi (ed il ragazo cieco passò
all’assistenza del terzo marito della sorella -ambedue procuratori dei suoi
affari-, il pittore
Giuseppe Catto, allievo dello Strozzi assieme a GiovanniFrancesco Cassana che
invece lo seguirà a Venezia).
Morta la madre e sposata la sorella,
con mille altri pretesti, cercò scusanti per non rientrare in convento (essere
ammalato; domanda di dispensa papale; visite ad infermi). Le reiterate minacce
di punizione, alimentate da invidiose insinuazioni dell’ambiente artistico, si
concretizzarono con la presa di posizione del Vicario Generale della Diocesi,
Alessandro Sperelli il quale il 25 agosto 1630 emise un mandato di
cattura e di arresto, da scontarsi nel carcere del convento (gli atti del processo, all’archivio
diocesano non ci sono più).
Così, tra altre suppliche ed altre concessione di pochi mesi di proroga, visse
libero ma quasi segregato per tre anni nel monastero di s.Barnaba, finché
abilmente riuscì a fuggire all’estero, imbarcandosi per Venezia (non ci sono prove scritte; lo
storico L.Alfonso presume che sia scappato prima di essere preso; comunque è
chiaro che Bernardo subì salatissima multa perché si era cacciato in un
gravissimo guaio di competenze fra autorità civili ed ecclesiastiche quando
ciascuna delle due aveva proprie prigioni, competenze ed armati; altri valuta
più probabile un provvedimento ‘dall’alto’, addirittura del Nunzio Apostolico,
visto l’arrivo in laguna munito di valide commendatizie ed il titolo di
monsignore. La non conoscenza precisa dei fatti, ha dato modo di romanzare la
fuga e le motivazioni che la determinarono).
In Venezia, per quindi
ulteriori anni, conosciuto come ‘il prete genovese’ diede sfogo a nuova vena
creativa, fondando anche una florida scuola nella quale lavorò proficuamente
(opere quali Allegoria delle arti nella biblioteca Marciana da
interpretare come inno alla libertà; nonché il capolavoro de la Parabola dell’invitato a nozze –nella chiesa dell’ospedale degli
Incurabili; un s.Sebastiano curato
dalle pie donne nella
chiesa dei s.Benedetto e Scolastica ; una Vanitas (ora a Mosca) e numerosi ritratti.
Fino alla morte il 3 agosto 1644;
fu sepolto in santa Fosca: “pictorum splendor – Liguriae decus – hic iacet”,
lasciando eredi la sorella Ginetta (e dopo la di lei morte, al nipote Giuseppe, ai quali lascia
“quella poca facoltà che Dio gli ha concessa”) ed il signor Pievano di S.Fosca (quale depositario delle sue
“robbe”).
Sue opere sono conservate nei musei
italiani e di Amsterdam, Belgrado, Berlino, Chicago, Londra, Mosca, New York,
Parigi, SanPietroburgo, Vienna, Zurigo.
Nel
1757 appare proprietà di un altro
mag.co Filippo Centurione (vedi carta
in Stringa-pag.97).
Nell’800, subì dei restauri sulla fronte a mare; fu rifatta l’ala ed il
torrione, posti al lato est a delimitazione del parco antistante
ridimensionato dalla strada a mare e poi dalla ferrovia.
Negli anni 1820-50, il parroco della Cella in un suo ‘stato delle anime’ del
borgo, chiama la villa ‘casa detta la Torre dal Mercato’.
Nel 1859 era passata alla
famiglia Tubino; di questa famiglia,
GioBatta - avvocato e poeta- divenne anche sindaco della neonata città;
probabile che fu lui l’occupante.
Nel 1875 infine divenne proprietà
di GB.Carpaneto (all’inizio del 1900, era ubicata in via Milite Ignoto).
La
famiglia Carpaneto probabilmente ha
origine dall’oltregiogo (esiste
un paese dal nome Carpaneto Piacentino di circa 6mila abitanti, con nulla di
storico-artistico).
Lo
stemma nobiliare – riprodotto nell’affresco del salone (vedi sotto alla descrzione degli
interni)– fa pensare ad una origine
nobiliare, di rampollo venuto in città per utilizzare al meglio le proprie
risorse. Vede un albero (probabilmente
un carpino: pianta d’alto fusto, delle betullacee nei boschi cedui, che resiste
bene al freddo ed alle potature ed il cui legno è ottimo combustibile) affiancato da un leone rampante (il leone è rappresentato anche
sulla balaustra al caposcala del piano nobile).
Da
allora la villa è stata occupata da questa famiglia.
Il
personaggio GB lo troviamo anche
come titolare di una strada sampierdarenese (ved. Le
prime titolazioni comunali, risalgono all’anno di inizio secolo 1900; prima di
allora le strade assumevano il nome di quello che c’era in essa di maggiore
rappresentatività; e dopo tale data a molte furono confermate seguendo l’uso
popolare (via s.Antonio, vico Raffetto, via R.Parodi, ecc)).
Non
si rammenta nè si hanno documentazioni che GB abbia acquisito particolari
benemerenze a livello sociale o cittadino; quindi la titolazione stradale fu
ovvia conseguenza della sua presenza e proprietà di vasti magazzini-doks,
localizzati - sia alla Coscia che nella zona attualmente di via Avio-Molteni.
Per iniziare tale impresa appare ovvio che fosse gà ricco di famiglia – ed lo
stemma nobiliare lo giustificherebbe; ma fu anche un abile imprenditore,
dimostrando essere capace di ampliare la fortuna iniziale con due fiorenti
depositi merci.
Ultima
ad abitarci – con servitù – sino al decesso avvenuto nel 1972 fu la penultima erede della famiglia.
Dopo essa la casa rimase vuota perché l’ultima erede, sposata con l’avvocato
torinese Mazzuchetti è andata a vivere nel capoluogo piemontese (e là risiede ancora
nel 2011).
Per
il Pagano/1925, era civ.4 di via
N.Bixio e si scrive fu abitazione in affitto
dell’ing. comm. sen. Eugenio Broccardi
(vedi a via CRolando).
Dal 1934 il palazzo è vincolato e
tutelato dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Liguria
Nel 1937, per completare via
A.Cantore, avvenne una transazione amichevole tra Comune e proprietari privati
- eredi Carpaneto -: il primo espropria il giardino e fa demolire la stretta
ala a levante del palazzo, pagando la cifra dei danni; gli altri provvedono ad
erigere il porticato eretto con pietre di Finale, sarà
addossato lungo la facciata sud della villa, per restare in coerenza con i
portici di via A.Cantore; il terrazzo verrà annesso all’appartamento del piano
nobile e sarà piastrellato alla veneziana;
restaurano la facciata con
una veste neo classicheggiante, tipica del primo novecento, ed il fastigio al sommo; avranno conservato il
corpo di fabbrica ad est della villa, lungo il quale dovrà essere prolungato il
porticato.
Durante l’ultimo conflitto, la
zona della stazione fu ripetutamente bombardata; ma per fortuna nessuna bomba
andò a ledere gli edifici circostanti Attualmente è in comproprietà dei sigg.
Mazzuchetti e Bussolati di Torino.
Nel
1985 fu primo l’orefice Salvemini a comperare l’ala a piano terra di sua
occupazione.
Nel
1992 il piano nobile fu dato in
affitto alla scuola materna statale, fino al 1996 circa (dopo che i proprietari avevano ingiunto lo sfratto), la quale era stata intitolata al poeta dialettale
Nicolò Bacigalupo.
Nel
maggio 1998, un’ingiunzione
municipale, obbligò i proprietari a restaurare il tetto e le strutture esterne
che perdevano calcinacci. Questo fu l’imput in seguito al quale dopo qualche
anno l’edificio fu sottoposto a completa ristrutturazione esterna, ma in
particolare nei vani cosìdetti della servitù,m ovvero le parti alte, col fine
di frazionarne la superficie per due appartamenti e poterli vendere
separatamente, compresa la torre. E così avvenne.
Nel
2002 si completò la vendita a
privati della parte superiore del palazzo (la cosiddetta zona della servitù e la torre); mentre le sale del piano nobile, ancora nel 2006, nello stato di abbandono, con
persiane più o meno pericolanti, invasione di piccioni dai vetri infranti, ecc.
Questi vani rimasti invenduti – sono però vendibili, dopo che sono diventati
proprietà di una società milanese: le difficoltà di sfruttamento sono
enormi e pressoché irrisolvibili se non intervengono le autorità ad agevolare
un utilizzo o una buona dose di fortuna: non solo per il prezzo base imposto,
che non conosciamo, ma anche l’assenza di posteggio auto; l’obbligo di messa in
regola CEE; vie di entrata e fuga limitate, strette e senza ascensore;
riscaldamento di così ampi vani; assenza di servizi (le cucine erano al piano superiore
e sono state vendute).
Si
dice che il lampadario del salone principale sia stato imprestato al Teatro
Modena e mai più restituito (molto probabilmente distrutto).

___________________________________________________________
2)
Struttura della villa = 2a) esterno
Al
piano terra ospita tre principali attività commerciali; di esse la piùà
importante è:
===civ. 34r-36r
l’entrata (le vetrine
dal 26r al 32r sono sotto il porticato sino al portone della villa; altre sono
in via C.Rolando) dell’oreficeria Salvemini
aperta con ampie vetrine sotto i portici e nell’angolo del sottopasso in piazza
(le volta del negozio a
vela e nicchie, sono maestralmente affrescate con riquadri e decorazione a
grottesche originali del periodo della ristrutturazione rinascimentale, ben
conservate e protette dalla Soprintendenza; il pavimento è in legno d’ulivo;
banconi, cassettiere, credenze e vetrine sono conservate d’epoca. Il negozio è
catalogato bottega storica). Il capostipite venne a Genova nell’
anno 1885 da Molfetta (laddove i familiari possedevano una flottiglia di
pescherecci) quando il futuro orafo Raffaele Salvemini era ancora neonato:
questi a dieci anni andò a scuola da un orologiaio di piazza Ponticello,
divenendo rapidamente un valido artigiano. Viene conservato il suo banco di
lavoro con piano, vetrina e cassetti. Morì nel 1961 ed il negozio che aveva aperto,
divenuto progressivamente gioielleria specie di argenti -anche lavorati in
proprio- e di ceramica la più pregiata in campo internazionale fu rilevato da
Vito, uno dei tre figli (con Giuseppe ed Angela). La terza generazione,
composta dalle figlie Rossella, Marina e Simona, prosegue la tradizionale
esposizione dell’oggetto basato soprattutto sul buon gusto –compresi i
personali piatti di ceramica di Copenhagen con le immagini dei comuni liguri
della quali la prima proprio la villa Carpaneto del primo 1900-. Nel 2006 ha ricevuto l’alta onoreficenza avendo superato i cento anni
di professione. Vengono conservati oggetti originari
della propria epoca come un orologio in bronzo con ‘san Giorgio ed il drago’,
un altro con mensola decorata con motivi floreali, due pendole a muro a
mercurio, un’altra con mobile della Selvanera e due pendole in legno art decò.
Sul retro (laddove il
perimetro della villa volge un cambio direzionale, come in adeguamento all’asse
viario -apparendo una prua sporgente avanzata-) si apre l’ingresso attuale della torre
cinquecentesca, che spicca maestosa sulla costruzione, aggiustata e ridipinta
negli anni 2002-3 dopo essere stata venduta a privati (assieme al piano alto ex della
servitù, ai Mantero pasticceri in via A.Cantore). Apparendo
appunto cinquecentesca -e la villa invece del secolo dopo-, si avvalora
l’ipotesi della sovrapposizione della struttura attuale ad una precedente più
fortificata; dalla sommità della torre, appaiono le botole esterne per uso
difesa in caso di assedio.

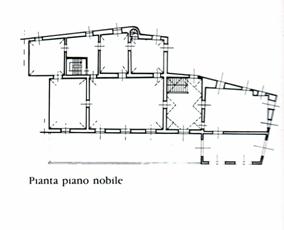
2b)
interno
il
portale, a sud, circondato da pietre bozzute e bugnate, appare ancora
ben conservato; nulla di maestoso per una villa e –stranamente- piuttosto
stretto.
Introduce
in un ingresso anche lui piuttosto ed altrettanto stranamente angusto (a
meno che non sia stato modificato da ristrutturazioni posteriori),

 soffitto scala
soffitto scala
per
raggiungere presto la scala altrettanto stretta ma così originale
essendo decorata sul soffitto; porta al piano nobile che raggiunge, delimitata
dalla balaustra marmorea
Al
sommo della scala, un capitello in marmo completa la balaustra che
delimita la sala dalla scala; ha le caratteristiche stilistiche antecedenti
alla villa e quindi presumibilmente appartenente alla precedenti strutture (è stato oggetto di tentato furto,
ma abbandonato distaccato, forse per l’eccessivo peso non previsto).

il leone qui riprodotto è parte
dello scudo
dei Carpaneto
Al piano nobile La stanza di arrivo salendo le scale, corrisponde probabilmente
alla antica loggia, aperta a levante e mare; tamponata nei secoli
successivi. Il vano ha volte a crociera e arcature su lesene doriche ed il
soffitto riccamente decorato con riquadri e tondi a colori vivaci
presumibilmente relativi al riordino dell’800.
Ai
fornici della loggia corrispondono oggi ampi finestroni (esternamente con
balaustrini in marmo e decorazioni a stucco) o tamponature. Caratterizzano i
saloni interni, le porte comunicanti, alcune decorate di marmo nero
altre con stucchi.





A ponente della loggia, si apre il salone. Poiché nessuno spiega perché
lo Strozzi non lo abbia decorato lui, ci lanciamo in una spiegazione analogica:
lui iniziò da ponente con le tre stanze più piccole laterali, con l’intenzione
di finire col salone: cosa che non avvenne per le difficoltà intercorse
raccontate sopra nella vita dello Strozzi; cosicché il salone rimasto nudo,
infine fu decorato dal De Lorenzi quando la proprietà non era più dei
Centurione, dimostrato dallo stemma del leone rampante dei Carpaneto. Quindi,
più tardiva l’opera di De Lorenzi (dai più, non si specifica il nome – forse proprio perché
non si sa - se Lorenzo o Achille – vedi sopra alla villa Centurione di piazza
del Monastero) che dipinse la volta del
salone, disegnata a vasto sfondato architettonico, con le immagini di un
altissimo porticato che offre l’impressione di alzare ulteriormente il
soffitto.





Altri
tre salotti furono invece antecemente decorati, rispettivamente con tre
affreschi diversi nel soffitto, su ordinazione di Filippo Centurione, da
Bernardo Strozzi
Vedi sopra, la sua biografia. Grande
produttore di tele, i nostri tre soffitti rimangono - dopo la distruzione della chiesa
di san Domenico ed il grave ed illeggibile deperimento -e sottrazione alla
vista da una controsoffittatura- in palazzo Branca Doria, allora abitazione di
Gio:Stefano Doria – in piazza s.Matteo, Genova- l’unica - quale completa - testimonianza attuale
dell’attività affrescante dell’artista.
Recentemente Poleggi scrive per la villa Lomellino oggi in via Garibaldi, 7 (poi dei Centurione): «Infine recenti i brani di
affreschi quasi certamente di Bernardo Strozzi, impegnato nel palazzo di villa
a san Pier d’Arena, e affittuario di una casa del committente Centurione
collocata in un isolato vicino».
Nel 2000 Marcenaro riferisce che due studiosi tedeschi,
guidati da documenti del 1623 che certificano di tre stanze lavorate
“nell’appartamento da bassosopra al portico”, hanno trovato tracce visibili
agli infrarossi: in una stanza, di una ‘Giustizia’, ovvero di una donna seduta
con spada; in altra stanza di un volto di donna-una mano con calice-un putto
biondo; in una terza di alcune figure nelle lunette. Dovettero non piacere al
proprietario che gliele fece rifare più volte ed infine non vennero completate
dal frate, facendo nascere nel nov.1625 una vertenza legale che –per sua
supplica- riconosceva «...non potendo stare in lite dove il m.co sig.r Luiggi
pretende tirarlo, stante che non ha forze di poter resistere a un paro suo
essendo esso povero....». Però scrive che il committente, sia per SPd’A che per
Genova, fu un Luigi Centurione (negli atti è chiamato Lodisio Cent.no), ed il
frate lo chiama ‘capuccino’ in italiano –Zingarelli- non corretto).
Nel aprile 2004 Simonetta Ronco sul Secolo XIX attribuisce
alla studiosa statunitense Mary Newcombe Schleier l’intuizione degli affreschi
dello Strozzi in palazzo Lomellino ma a quel tempo di prorpietà di Luigi
Centurione; assieme all’arch. Merlano fu compiuto un ‘assaggio’ al primo piano.
‘Prevalgono
le tinte chiare, come bagnate da luce cristallina’ e non con prevalenza del
chiaroscuro piuttosto accentuato, come dovevano essere gli affreschi di san
Donato: l’amicizia e la frequentazione dell’Ansaldo, ambedue allievi
dell’Accademia del disegno istituita nella propria dimora da GioCarlo Doria,
sembrano poter essersi influenzati reciprocamente nello stile
dell’organizzazione dello spazio e nella tipologia di alcune figure.
Come d’uso
a quei tempi, si leggono interpretazioni simboliche,
dettate dal committente, di esempi di abnegazione dove il “dovere” prevale
sulle passioni emotive- sino anche al sacrificio dell’amore (Enea e Didone) e
della vita (Orazio Coclite e Curzio Rufo)-. Non si è sicuri, e controversa, la datazione dei nostri dipinti: alcuni critici
mirano agli anni tra il 1624-5; altri anticipano al 1617 e, -Gavazza,
Terminiello ed altri al periodo 1613-15, sulla base di svariate considerazioni
stilistiche, basate sugli accostamenti dei colori
-giudicati assai vivaci, molto contrastanti, quasi asprigni-, e sui
caratteristici chiaroscuri periferici che esaltano con una luminosità centrale
intensa e diffusa le immagini centrali degli eroi. Questi affreschi, sono contornati da grottesche cinquecentesche e da lunette,
illustranti paesaggi di cittadine liguri vicine al borgo (altri scrive ‘di
ispirazione nordica’, opere di Lorenzini
(E.Sonzogno cita un Antonio bolognese, 1665-1740; ed un Lorenzo di Forlì del
secolo XVIII); e da
grottesche capaci con le loro leggiadre sfumature di evidenziare maggiormente
il riquadro stesso. La critica è concorde nel dare a questi affreschi una
importanza considerevole nell’evoluzione stilistica sia dello Strozzi (trapasso
dalla fase genovese al “settecento veneto”), sia di tutta la pittura ligure.
Rappresentano :


panoramica
de “Enea e Didone nell’antro”, particolare al centro del soffitto

nella prima sala laterale, più
a occidente,
“Orazio Coclite che in lotta contro gli etruschi , difende il ponte Sublicio” (il bozzetto è conservato a Londra
dalla collezione Denis Mahon);

nella sala più orientale,
“Curzio Rufo, cavaliere
romano” il quale vedendo le matrone romane gettare inutilmente i loro monili nella
voragine, sperando di così chiuderla, vi si precipita col cavallo.
Da notare i
costumi ed i monili sfarzosi delle dame

Un
quarto salotto, quadrato, fu decorato da Domenico
Fiasella (detto “il Sarzana”) è l’
“allegoria della Fama”; che -volando oltre una balaustra- richiama agli antichi
valori rappresentati da quattro nicchie con altrettanto ritratti di avi di
famiglia, purtroppo anonimi e quindi di impossibile
attribuzione.





Ultimo
salotto comprende un affresco in buona parte rovinato dall’umidità con
raffigurate figure mitologiche




Il
giardino, nel seicento era molto vasto, esteso solo verso sud, ed arrivava
direttamente sino al mare ricco di oltre 500 piante, molte di esse esotiche;
un lungo viale centrale portava dalla casa al giardino e poi alle aree
coltivate ad orto, vigneto,frutteto e boschetti.
Nella metà del ‘700, si aprì una nuova strada (via San Pier d’Arena-Pacinotti) per iniziativa del nobile G.B.Cambiaso; nella metà
del 1800 l’apertura della ferrovia determino gli espropri anche per
l’affiancato asse di via Vittorio Emanuele (inizialmente detta “strada reale per Torino”: via
Buranello-Reti-Fillak-oltre): tutto
questo gradatamente stravolse l’idilliaco giardino, tagliato dapprima al mare,
indi a metà e invaso da una edilizia ossessiva nel periodo a cavallo 1800-1900,
per cui rimase conservato solo il triangolino antistante la villa. Come già
detto, l’apertura di via A. Cantore determinò la separazione definitiva dalla
villa, relegando l’ampio spazio a banali aiuole, con belle magnolie, oggi un
po' vecchie e sofferenti, intossicate dai gas di scarico dei veicoli e dallo
sterco acido dei piccioni.
DEDICATA al ricco e
munifico mecenate, amministratore comunale, figlio di G.B., nato a San Pier
d’Arena nel 1825.
La
sua famiglia nel 1908 gestiva un negozio o/e grossista di olio d’oliva (e forse saponificio; sono citati in
quell’anno un Montano Antonio e Figlio ubicati in via C.Colombo al civ. 14; ed
un Montano Nicolò fu GB nella stessa via al civ.19), e nella quale attività fu avviato, per continuarne
la professione.
Non
so se è di questa famiglia la proprietà che compare in alcune mappe (vedi ‘il don Bosco-pag.57) del 1890, intestata a Montano; con strada
-corrispondente a via Ardoino- chiamata ‘passo Montano-Negrotto; posizionati
all’apice est-nord-est rispetto la proprietà dei salesiani. Che nel 1905 diverrà proprietà Moro,
e 1906 vedova Moro.
Nel
1841 lo leggiamo studente presso gli Scolopi genovesi, compagno di scuola di
Goffredo Mameli e Lazzaro Romairone e con loro vincitore: nei ‘saggi letterari
di comporre’ di Rettorica (gli studenti scrivevano prosa o poesia, latina o italiana, di argomenti
storici, sottoponendosi poi a domande ed obbiezioni); nello stesso anno compose e lesse un sonetto sul
concetto ‘ultima e prima’ durante un trattenimento accademico; lesse pagine
delle Sacre Storie in latino, traducendo e dandone spiegazione, in un saggio
semipubblico; ottenendo ‘honesta mentione digni ‘ nella gara di grammatica).
Probabilmente
fu lui che ampliò l’attività del padre, divenendo uno dei piccoli uomini
d’affari-industriali del sapone, nella cui fabbrica lavorarono numerose
persone.
Citato
(come “Niccolò) nello statuto del 1857 del teatro Modena -stilato nel ridotto del teatro per
la suddivisione dei palchi tra i “soci-palchettisti” - (nella sua qualità di
sostituto causistico e proprietario, nonché come procuratore del negoziante
Sebastiano Dallorso).
Nominato
cavaliere, e nel 1865 –al conferimento del titolo di città- fu sindaco di San
Pier d’Arena (sicuramente
dal 1865 al 1872; fu poi sostituito da L.Balleydier); membro del consiglio provinciale nel 1869 eletto
nel mandamento di Rivarolo; presidente e benefattore dell’ospedale civile (è del 12 gen.1875 un suo invito ai
concittadini perché si facesse appello alla loro beneficenza pro ospedale; era
ovvio che la sovvenzione annua destinata dal Municipio -seppur munifica e di
alto valore morale- non era sufficiente, ed occorreva ricorrere a
sottoscrizioni, doni o promozioni: venne organizzata una ricca fiera a
Belvedere che porterà un utile di lire 12.760,81; ed è del mag.1881 la
donazione personale di mille lire per onorare la memoria della moglie), e dell’opera di don Bosco (fu padrino d’onore-e la moglie
madrina- del primo battesimo amministrato nella rinata chiesa di san Gaetano).
A sue private spese, aprì un asilo e partecipò all’apertura dell’ospedale
stesso nella villa Doria-Masnata, allora aperta in via NDaste, oggi in via
Cantore
Alla sua morte nel 1882, i familiari il 13 ott donarono. all’ospedale mille
lire.
Il cognome e casata Montano ha origine storica legata alla provenienza nel
1400: dei montanari dell’entroterra cittadino. Appaiono già attivi in Genova,
come firmatari di un documento datato 25 dicembre 1173, originari nella zona di
Quarto.
Furono
stabilmente presenti in Genova dal 1300 in poi (vengono ricordati tra i componenti un comandante di
galera, ed un membro del Collegio degli Anziani).
Nel
1528, la famiglia viene ascritta all’Albergo dei DeMarini. Avevano un’arma
d’argento, un leone rosso tenente una lancia nera bandierata d’argento con
croce rossa.
BIBLIOGRAFIA
non citato da Encicl. Sonzogno +
Encicl. Motta + Paolo Novella+
-Alfonso
L.-Bernardo Strozzi- ‘La Berio’-3/1981- pag.12
-Antonini
S.-la Liguria di Salò-DeFerrari.2001.pag.48(n72).170
-Archivio parrocchiale della
Cella – anno 1820-50
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica scheda 2870
-Autore
sconosciuto-Dattiloscritto chiesa san Gaetano Bosco-v.I-pag.14
-AA.VV.-Annuario guida
Archidiocesi-ed./94-pag.420; ed./02-pag.458
-AA.VV.-Bernardo
Strozzi-guida per mostra-Electa 1995-
-AA.VV.-Catalogo delle ville
genovesi-Bertelli.1967-pag.189
-AA.VV.-Guida alle botteghe
storiche- DeFerrari.2002- pag. 129
-AA.VV.-La pittura a Ge. e
in Liguria-Sagep.1987-vol.II-pag.30
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.84 foto
-AA.VV.-SPd’Arena nella sua
amministrazione fascista-Reale.1926-pag.56
-Barrili AG-scritti editi e
inediti di G.Mameli.IstLigStPatria.1902-pag.448
-BuonoRaffo E.-personaggi
genovesi nella storia-LionsClub2006-p.42
-Bottaro.Paternostro-Storia
del teatro a Ge.-Esagraph.1982-vol.I-pg.165nota13
-Cappelli.Gimelli.Pedemonte-Trasporto
pubblico a Ge.-DeFerrari 1991-p.24
-CassianoCarpaneto da Langasco-B.Strozzi e
postille-Sabatelli.1983
-Castagna Masini-Genova,
guida storica-Masini,1929-pag.450
-Castronuovo V.Storia
dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag. 104foto.194
-Cavallaro G.-Ospedalecivile
di SPd’A.-Pagano-16.111-3
-DeLandolina GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.18
-DeMaestri-Polastri-La metropolitana
di Genova-Sagep.1990-pag.24
-Dolcino M.-Storie di
Genova- Frilli.2003-pag 168
-D’Oria S.-Sampierdarena
San Teodoro-DeFerari.2001-pag.20
-Falcone G.-Annuario della
Prov. di Genova -Ferrando.1870-pag.477
-Fucile R.-Dachau: matricola
n. 113305...-Tipog.Provincia-1995-
-Gazzettino Sampierdarenese
: 1/73.9 + 8/73.3 + 1/73.6 + 6/74.10 9/74.6 + 1/75.5 + 4/77.2 +
7/79.1.11 + 6/81.6 + 5/82.10 + 1/83.3 + 1/89.9 + 9/90.14 + 6/92.4
+ 7/92.3 + 8/92.6 + 3/94.9 + 6/94.9 + 9/94.14 + 5/98.3 + 6/98.2
+ 07/02.3 + 07/02.3 + 01/04.7
-‘Genova’ -Rivista del
Comune : 6/37.47.53 + 11/52.19 +
-Gregori M.-Pittura murale
in Italia-San Paolo IMI.1998.IV.pag. 81
-Il Secolo XIX di 8/90 +
22.12.00 + 28.1.04 + 10.4.04 + 04.01.05
-Lamponi M.-Sampierdarena –
LibroPiù. 2002- pag. 137.174
-Marcenaro Mario su Il
secolo XIX del 2.11.00 pag. 21
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930 ca-(pag.12.18)
-Pagano/1908-pag.873-9
/1961-pag.292
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1217
-Pesenti FR-La pittura in
Liguria primo 600-Carige-pag.58.64.84-91
-Pesenti FR-Bernardo Strozzi
nei musei genovesi-Laasana n.1/81-pag20
-Piastra &C-Dizionario
biografico dei Liguri-Brigati.1992-v.II-pag.254
-Pippione L.-L’imperatore di
Germ...-rivista Civitas Sancti Romuli-1988
-Poleggi E.-Genova,una
civiltà di palazzi-Silvana.2002-pag.74
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.34
-Ratti-Instruzione
di quanto...-vol.I-.387
-Rebagliati&Dell’Amico-I
120 anni della linea ferr…-DLF.1988-pag.18
-RotondiTerminielloG.-il
patrimonio artistico di bCarige-Silvana2008-p.405
-Scorza
A.M.G.-Le famiglie nobili genovesi-Frilli.2003- pag.139.150.
-Soprani Ratti-Vite de pittori, scultori ed architetti
gen.-Tolozzi.1965-pg.191
-Stringa P.-La
Valpolcevera-Agis.1980-pag.95
-Tuvo T.Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag.42-3-8.58.78
MONTANO sottopassaggio
Montano
TARGA: c’è apposto lo spazio all’entrata a monte, ma non è
ancora mai stata affissa.

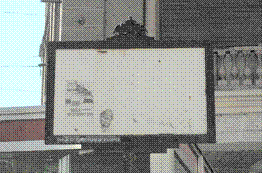
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 39950
UNITÁ URBANISTICA :
26 - SAMPIERDARENA
STRUTTURA: senza
alcuna targa, rimane sottostante la piazza omonima, e collega i due estremi
mare-monte di via A.Cantore al suo finire nella piazza.


STORIA: aperto nel
dopoguerra, fu corredato di alcuni negozi. Venne definito ‘il cordone ombellicale’ della delegazione in
quanto collega la parte a mare con quella a monte nel punto centrale e
nevralgico cittadino; come tale è punto di riferimento per appuntamenti,
studenti in attesa di amici, attivisti per propagandare le idee, ‘vu comprà’
privilegiati al riparo dalla pioggia.
È del 20 apr.1962 la delibera dell’appalto conferito dal Comune alla
ditta Mazzucchelli Natalio di via Luccoli 32, affinché con l’importo di 2
milioni costruisse il sottopassaggio pedonale.
Il 3 settembre 1964 il Consiglio comunale deliberò chiamare il j col
semplice cognome del sindaco sampierdarenese; e l’anno dopo nel maggio 1965
fu variata la numerazione rossa.


dopo allagamento 1970
Non
solo nel 1970, durante l’alluvione che colpì la città, rimase
completamente sommerso. Ripristinato, ad ogni acquazzone un po’ più violento, è
soggetto a mi naccia di riempirsi inesorabilmente.
Gli orti, i prati, le brughiere dxelle colline erano
capaci di assorbire molta dell’acqua piovana e ne rallentavano il defluire in
basso incanalandola nei ruscelletti naturali (nella zona, i più grossi furono
lungo via GB Monti e corso Martinetti-via N.Ronco-via Farini). Gli allagamenti
sono frutto della eccessiva copertura con tetti di abitazione e
dell’asfaltatura delle strade (ancora nel 1920, il 60% delle strade era in
terra battuta ed il restante era lastricato, ma sempre in modo che l’acqua
piovana sempre potesse in buona parte essere assorbita tra le fessure);
l’asfalto ha favorito il transito veicolare ed eliminato il fango, ma il
terreno non assorbe più, ed una goccia caduta a Belvedere arriva pari pari sino
in basso accumulandosi fino all’alluvione.



Nel
1989 raggiunse in pochi anni un buon stato di degrado per abbandono di
manutenzione, vandalismi con scritte murali, allagamenti ad ogni pioggia più
abbondante, cancella e scale rovinate: il cantiere di ristrutturazione fu messo
in atto nel 1989 (rifatte le scale, corrimano e cancelli; piastrellato il
pavimento; ristrutturato l’impianto idrico di scarico ed elettrico); nel 1993
le pareti erano però ancora lordate da innumerevoli e pressoché nessuna
piacevole scritte: fu completato nell’inverno 1995 con l’arredamento di
“murales” , disegnati dagli allievi della scuola liceo artistico ‘Barabino’
seguendo il progetto ‘ColoriAmo’ messo in atto anche da altri licei in altre
sedi, e poeticamente intitolato ‘sogno ed identità’.



foto Gazzettino Sampierdarenese





Causa
i soliti scemi che sovrappongono scritte e stupidità varie, nel 2005 è
stato completamente riverniciato di bianco, cancellando tutti i precedenti
disegni. Naturalmente le scritte sono ricomparse essendo la pianta maligna
della insulsaggine resistente e duratura, anche se cambiano le generazioni.
CIVICI
2007=
nessuno nero; i ROSSI, proseguendo la numerazione della piazza, vanno da 27r al
39r
Sul
lato a levante esistono alcuni box per commercianti.
Molti
“Vu comprà” si assidono invece per terra, sul lato ponente, senza creare
problemi al via vai della gente, anchge se dopo una certa ora il passaggio non
è più costantemente usato da ambulanti e diventa passibile di sfuggire al
controllo del degrado progressivo e della sicurezza: cosicché infatti viene
chiuso alla sera.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica scheda 2871
-Gazzettino
Sampierdarenese 4/77.7 + 8/81.5 + 1/83.4 + 4/89.7 + 6/89.11+ 7/89.4
+ 5/93.5 + 1/94.7 + 1/96.15 + 4/96.8 + 01/03.3 + 02/03.3
-Genova- rivista del Comune-
7/62.39
MONTEBELLO via Montebello
Corrisponde all’attuale via A.Stennio.
Nella strada, non so se già
titolata, si descrive esserci stato nell’ott.1895, uno “stabilimento
centrale” di proprietà della Compagnia Generale Francese, conduttrice delle
linee tranviarie cittadine: consisteva in una proprietà di 8mila mq. (compresa tra un tracciato carrettabile senza nome che
diverrà via Montebello, via Vittorio Emanuele-su cui si apriva-(via P.Reti), e un’altra proprietà a nord (di Roncallo, Storace
& C.)), cintata da muro, e contenente cortili, tettoie, scuderie,
magazzini e fabbricati ad uso uffici ed abitazione del direttore ed impiegati .
Tale proprietà fu poi acquisita
dall’ UITE.
In quegli anni la strada era
abitata solo: dai fratelli Chiesa al civ. 1 e dai fratelli Avogadro al civ.2:
Nel dic. 1900,
decidendo dare un nome a tutte le strade, fu proposto dare ufficialmente questa
denominazione a questo tratto già esistente sino a via A.Saffi ed anche al
tratto neoformato in prolungazione a levante (attuale via C.Rota).
Nel 1901, un’impresa
cittadina vi affisse la prima targa marmorea col nome, agli angoli di incrocio.
Nel Pagano 1902
troviamo: civ.1 f.lli. Avogadro *°¡ con la fabbr, di casse di legno e segheria
a vapore (da distinguere da quelle idrauliche,
ovviamente nessuna elettrica ancora);--- la soc. per le conserve
alimentari f.lli Tardito e C. tel 661 ( senza
precisare il n°, ma nel ’33 sarà al civ.3, di v.A.Saffi, ed anche meccanici e litografici per illustrare le
casse e latte delle conserve).
Nel 1906 fu proposto cambiare il nome del tratto
superiore , tra via A.Saffi e la proprietà Cristofoli , dedicandolo a Carlo
Rota; così la via Montebello rimase da via Umberto I a via A.Saffi, con i
civv. Sino al 7.
Nel Pagano/1908, 1912,
1919, 1920-1, 1925 sono descritti esserci stati: al civ. 1 la segheria e f.lli Tardito e C. (vedi
sopra); e l’impresario edile Puppo GB (casa propria ancora nel 1925).
Nel 1926, unendo
SPd’Arena nella grande Genova, la titolazione dovette lasciare il posto al
quella posta nel Centro.
Ma ancora nel 1933 era
presente, ed andava da via Milite Ignoto a via A.Saffi (però con civici sino al
9, e di 4.a categoria); al civ. 2 (vicino al
deposito tramway) Gotti Lisandro aveva il negozio di macchine per cucire;
al 5 c’era un garage chiamato ‘Autorimessa
Moderna’ gestito da Salvoni e Fertonani; non specificato dove la ‘Soc. per le Conserve alimentari già Fratelli
Tardito e C., con sede anche in via Saffi al civ.3.
Divenne
via A.Stennio per decisione del podestà,
nella delibera del 19 ago. 1935.
DEDICATA alla battaglia avvenuta
nel territorio dell’oltrePo pavese, il 20 maggio 1859 durante la seconda guerra
di Indipendenza, in cui restarono uccisi duemila soldati (di essi, ben 1300
austriaci, ovvero lombardi e veneti; tra le vittime piemontesi, il nipote del
medico Onofrio Scassi, chiamato come il nonno, ufficiale di cavalleria; morì
da eroe e fu fregiato di medaglia d’argento al V.Militare).
La cavalleria piemontese
(reggimenti d’Aosta, Novara e Monferrato) guidata dal gen. Maurizio De Sonnaz,
e la fanteria francese, comandata dal gen. Forey, si distinsero in particolare
tra gli italo-francesi nel rimandare al di là del Po, le più numerose truppe
austriache (due divisioni), guidate dal mar.llo Gyulai (ES dice gen. Stadion),
inviate al di qua del Po per motivi tattici.
La zona già era stata teatro di scontri: il 19 giu.1172 della Lega Lombarda,
vincitrice contro il marchese del Monferrato seguace del Barbarossa; e il 9
giu.1800 quando i francesi, comandati da Massena e Suchet, inviarono il gen. Lennes
(che così acquisì il titolo di “duca di Montebello”) a vincere contro
l’avanguardia austriaca comandata dal gen. Melas.
Attualmente il paese, nel pavese
vicino a Voghera, si chiama “Montebello della Battaglia”; ospita un monumento
ossario ai caduti del 1859.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 2879
-A.sconosciuto-Storia del
trasporto pubblico a Genova-Sagep.1980-p.152
-DeLandolina GC.-
Sampierdarena-Rinacenza .1922-pag. 49
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.18
-Pagano/1908-pag.876---/1933- pag.247.1694
-Pastorio.Vigliero-Dizionario delle strade di
Ge.-Tolozzi.1985-pag.1224
-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.234
MONTE CORNO via Monte Corno
Precedente nome dell’attuale via R.Pieragostini, corrispondente al tratto
da via E.Jursé al Ponte di Cornigliano.
Vi si aprivano a monte lo
zuccherificio Eridania (vedi a via -); ed a mare la soc. anonima Molini Alta Italia (o Esercizio Molini: era un grosso
caseggiato eretto nel 1905 in cemento armato, composto da due fabbricati
affiancati dei quali, uno, il molino vero e proprio; l’altro il silo dove
depositare il grano e le farine. L’opificio era ancora presente alla fine della
decade del 1960). I due grossi stabilimenti determinavano già da allora una
larga partecipazione di treni, autotreni ed operai.
La dedica venne decisa il 19
ago.1935, scalzando la precedente titolazione di ‘via Cesare Battisti’; quest’ultima
essendo già a Genova, venne deliberato dal podestà di allora che a San Pier
d’Arena fosse rimossa; la toponomastica decise a vantaggio della montagna
storicamente collegata al patriota, rimanendo così sempre nel clima di dediche
a strade per celebrazioni di eventi bellici particolari relativi alla prima
guerra mondiale.
Nel Pagano/1940 è descritta
limitare via A.Pacinotti e via Cornigliano. Nei civv. neri c’era al 5/7 la levatrice comun Daneri Alice; al 7
Eridania zuccherificio; senza civico lo
Scalo Merci P.V. FFSS; e Lanati E&C trasp.merci. Nei civv. rossi: 1r polliv., 5r trattoria di Riccardi Edoardo; 9r bar
Motta; 11r Agenzia Autonoma Annonaria; 13r tabacchi; 15r commest., 17r
trattoria Ricci V., 19r fruttiv., 21 parrucch., 23 commestib..
Divenne via R.Pieragostini per delibera della Giunta
comunale n° 72 del 5 luglio 1945.
DEDICATA
La strada divenne
commemorativa della più alta vetta del complesso del Pasubio, al confine con
l’Austria - posta a quota 1765 m., chiamata pure
“cima di Vallarsa”, in posizione dominante la strada nazionale che unisce
Vicenza al Trentino - che fu conquistata dopo violenti scontri nel
maggio 1915 subito dopo la dichiarazione di guerra; ma sulle cui balze le
battaglie si susseguirono a lungo con alterne fasi, tanto che il 10 lug.1916,
durante un attacco austriaco, vi furono fatti prigionieri Cesare Battisti (vedi strada) e Fabio Filzi. Oggi la cima si
chiama appunto “Corno Battisti”; e sul punto della resa dei due redenti,
all’atto di uno degli audaci tentativi italiani di conquistare la vetta, fu
posto un piccolo cippo a memoria, fin troppo modesto a fronte dell’enorme
costo –morale e di sangue- che il sacrificio dei tanti soldati – dei due in
particolare - suscitò sia nei fanti - animati dal voler conquistare
definitivamente la vetta - che nella popolazione, anche in quella contraria
alla guerra.
Qualcuno ha scritto che si può
considere parte della via Aurelia di ponente, senza proporsi i grossi problemi
di una strada Aurelia in città.
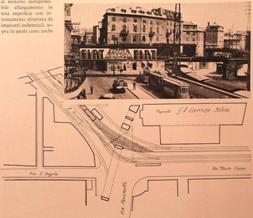 a sinistra
via Degola; a destra via Monte Corno; in verticale via Pacinotti; nel
rettangolo “proprietà S.A. Esercizio Molini”
a sinistra
via Degola; a destra via Monte Corno; in verticale via Pacinotti; nel
rettangolo “proprietà S.A. Esercizio Molini”
Esiste una cima, dal nome perfettamente eguale nell’Appennino Centrale, e ben
più alta di quella alpina essendo a quota 2914 m. É infatti il nome del monte
più alto del Gran Sasso, detto anche Corno Grande – per distinguerlo dal
Piccolo alto 2637m. - anch’esso sede di un evento storico: la liberazione di
Mussolini. Il Duce era stato arrestato per ordine del re Vittorio Emanuele III
il 25 lug.1943 a villa Savoia, e trasferito isolato in un albergo sul Gran
Sasso; da là fu liberato da aviatori tedeschi il 12 settembre dopo. Andò, dapprima
ospite di Hitler, poi in Italia settentrionale per costituire l’effimera
Repubblica Sociale Italiana (detta pure “repubblichina” perché
contemporaneamente dichiarava decaduta la monarchia; oppure “di Salò”, dalla
località della sua istituzione).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica,
scheda 2880
-AA.VV.-Stradario del Comune di
Genova, 1953-pag.117.139
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Genova (La Grande) - Rivista
municipale : 5/24.299 + 6/37.46.52
-Pagano/1933-pag.445 ;
/40-pag.343
-Pastorino&Vigliero-Dizion.
strade di Genova-Tolozzi 1985-pag.124
MONTEGALLETTO via
Montegalletto
Nell’archivio parrocchiale della
Cella, nel libro stilato dal Parroco negli anni 1820-50 relativo ai
‘giri di benedizione pasquale’ durante i quali stilava lo ‘stato delle anime’
cioé un vero e proprio censimento delle famiglie sampierdarenesi, compare la località
o via, citata come tale quando ancora non esistevano nomi ufficiali delle
strade.
Nell’elenco delle proprietà
esistenti nella città, stilato dal Comune all’inizio del 1900, compare
al civ. 29 (di allora) di via De Marini, l’ingresso alla proprietà “cav. Piccardo Giovanni, abitante in Montegalletto”; e
poiché la sua villa era dove ora sorge il grattacielo dell’ospedale, la zona
col nome interessato è compresa tra via GB
Botteri e via SbdFossato; e la
strada più o meno a tornanti segnava il tracciato attuale di via Bottego-via B.Piovera.
A conferma e ritroso, leggiamo su don Brizzolara che “in
cima a Monte Galletto abitava il cardinale Carlo
DeMarini abbate commendatario di Promontorio, e dal suo palazzo
prospettava l’abbazia di san Bartolomeo del Fossato e tutta la spiaggia di San
Pier d’Arena (vedi a DeMarini). Il palazzo DeMarini fu poi abbattuto, secondo
don Brizzolara, “dai ‘discoli’” nel 1916 (ce l’aveva con ‘i sovversivi’
che, a pochi metri di distanza dal palazzo-ospedale del DeMarini, vollero
impiantare il vasto nuovo ospedale civile....).
Ed a riconferma, una planimetria
dell’arcivescovado genovese datata 1926, con la delimitazione dei
confini parrocchiali della chiesa delle Grazie, si legge scritto a mano sopra
una strada posta nella zona più a levante,‘via Montegalletto’, dipartente da
via DeMarini (oggi via Dottesio) sovrapposta (ma porse un poco più a ponente)
ad un teorico tracciato -oggi inesistente-, corrispondente a via
Bottego-scalinata di via Pittaluga-tratto dell’estremo ad est di via DeAmicis (via
B.Piovera), fino all’innesto con
via Roma (via O.Scassi)
poco prima di via M.Vinzoni (che allora portava alla villa delle suore di s.Anna).
Forse la carta fu copiata da
un’altra planimetria generale del piano regolatore della città di San Pier
d’Arena, sulla quale appare inusitatamente lo stesso nome, mai reso ufficiale
da delibere comunali.
Lo storico Persoglio spiega che
il toponimo proviene dai ‘galletti’, cioè le piante di ginestra; ovviamente una
dizione popolare, non ufficiale, determinata dalla presenza di questi fiori,
che in abbondanza crescevano anche sui nostri dirupi come nell’omonima zona
genovese laddove però il nome è rimasto tutt’ora.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Parrocchia s.B:della
Costa- reclami don Brizzolara- pag. 37
-Archivio parrocchiale della Cella -anno 1820-50
-Archivio Storico Comunale
-Pastorino&Vigliero-Dizion strade di Genova-Tolozzi
1985-pag.1228
MONTI via G.B. Monti
TARGHE :
San Pier d’Arena – via –
G.B.Monti
via - Giambattista Monti
via - G.B. Monti
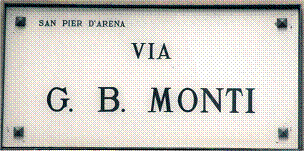


inizio
strada e ramo in salita, in angolo con via C.Rolando. Due targhe.


ramo in
salita, angolo via Farini

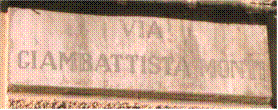
ramo in
salita, angolo con via dei Landi


fine del
ramo in salita, retro del grattacielo

ramo a
ponente, angolo con via Battaglini – confine con via dei landi

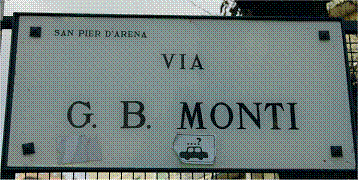
ramo a
levante, a fine strada dopo il ponte, angolo via V. da Gama
QUARTIERE
MEDIEVALE: Mercato
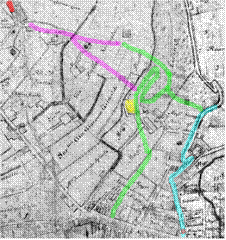 da MVinzoni,1757.
da MVinzoni,1757. 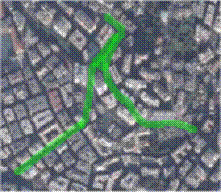
Ipotetico tracciato di via GBMonti in verde; celeste,
da Google Earth 2007.
salita
Belvedere; fucsia ipotetica via dei Landi; gialla
villa
Pallavicini; rossa villa Currò.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2811 CATEGORIA:
2
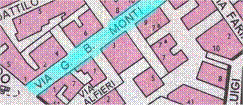
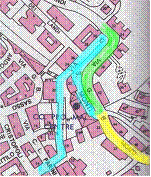
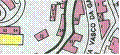
in celeste tratto in salita; verde tratto a ponente; giallo
tratto verso levante
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 41020
UNITÀ URBANISTICA: 25 - SAN GAETANO
27 - BELVEDERE
CAP:
16151
PARROCCHIA: NS del ss. Sacramento
STRUTTURA: lunga strada comunale che da piazza Montano sale fino a via Landi
e corso Magellano.
Doppio senso viario, escluso nei due tratti estremi; è senso unico in
discesa dall’incrocio con via L.C.Farini allo sbocco in fondo tra via
A.Cantore e via C.Rolando (Nel 1973 vi si riversavano solo 7200 auto al dì; e laddove al semaforo
ci aspetta implacabile un giovane slavo immigrato); è invece senso unico in salita dall’incrocio di via
dei Landi – dopo il quale esegue uno stretto tornante - sino al termine, fatto
a T: a sinistra sino all’incrocio con via Battaglini, ed a destra sino oltre il
ponte sopra corso Martinetti all’incrocio con corso Magellano (lo stradario in dotazione ai VVUU
dice erroneamente “fino a salita Belvedere”, valido prima dell’erezione del
ponte). La ristrettezza della strada
crea i soliti problemi di posteggi e traffico, aggravati dagli impazienti e dai
menefreghisti.

il tornante
All’inizio in basso, c’erano due targhe, vicine ma diverse indicanti la via.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
STORIA:
Nell’antica pianta del sobborgo di San Pier d’Arena disegnata dal colonnello
M.Vinzoni e datata 1757, tutta la zona in cui scorre la parte distale
della strada - escluse le case già presenti lungo la via principale, e di
diverse proprietà - appare appartenere al magnifico abate Spinola Nicolò; quella più alta interessa invece
più proprietari tra i quali principalmente il magnifico Giuseppe Doria (con la sua villa, poi Serra ed
attuale Ist.donDaste), ed i magnifici Lorenzo Lomellini e fratelli Pinelli (patroni della abbazia di sd.Bartolomeo del Fossato).
Nel dic.1900, il regio commissario straordinario, propone il nome di via
Gianbattista Monti per la trasversale che sale distaccandosi da via
Mercato, “via già detta del Collegio
(vedi), verso notte (nord) nei terreni detti della Regata”, e messa a continuazione - dal mare verso il colle -
della crosa dei Buoi (poi via
Nino Bixio).
Ancora dal 1902-12 al civ.9-15 vi si apriva il collegio-convitto
Dogliani, con direttore Cesare Chiabra.
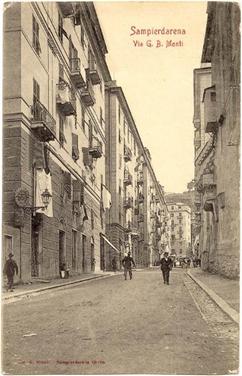
--foto a sinistra: il primo palazzo a destra, ora demolito,
che ospitava le Scuole Tecniche; immagine anteriore al 1905 circa
--foto sotto, similare alla precedente, viaggiata nel 1905,
ma errata perché indica “via S.Giovanni Battista a Monte” che non è mai
esistita.
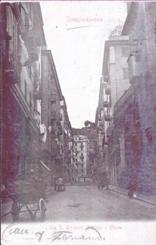
Nel 1910, nei fogli comunali viene chiamata “via Gio Batta Monti, da via
N.d’Aste (sic) verso la collina”, con numeri civici sino al 30 e 21 (ma diversi dagli odierni); e con questo nome le fu posta la targa all’inizio
della salita.


--foto viaggiata nel 1912 --
Nelle
prime decadi dello stesso secolo (ancora nel 1933 quando non esisteva via A.Cantore), viene descritta aprirsi da via N.Daste, “verso i
monti”; praticamente finiva poco dopo ove ora è la chiesa.
Nel
Pagano/40, la strada è compresa tra via A.Cantore e sal. Belvedere ed
ha, senza numero civico la
chiesa Adoraz.Perpetua; nei civv. neri privati e al 22/1 Ass.Prov.Cacciatori;
23 Tardito G. latta; 25 Stura V. ing.; 36A canc.: ‘casa Famiglia del sacro
Cuore.Orfanatrofio femminile’ e ‘Lavori femminili’. Nei nn. rossi: senza civico, una latteria posta “nel casotto
rimpetto al 24 nero, Barabino”. Rossi dispari=
1r mat.elettr.Arnaldi;
5r drogheria; 9r maceller.; 11r merceria Provinciali; 13r polliv.; 15r mode;
17r ottoniere; 19r commestib.; 21r latteria; 23r farmacia dott. Rolando; 25r drogheria;
31r bottiglieria; 33r commestib.; 41r drogher.; 43r offic.elettromecc.; 45r
bazar; 49r fruttiv.; 55r parrucch.; 57r stirat.; 59r osteria; 63r giornalaio;
65r Tipo litograf.Don D’Aste (sic). pari = 6r
confez.; 10r bottigl.; 14r soc.an.coop.Carlo Rota commestib.; 16r osteria;
20r legna e carbone; 34r commestib.; 38r stirator.; 42r bottigl.; 44n comm.
(sic); 46r fruttiv.; 48r macell.; 52r parrucch.; 54r mercerie; 56r commestib.;
58r bicicl.; 70r commestib.; 74r commestib.; 78r maceller.; 82r fruttiv.; 84r
tabaccheria; 88r parrucchiere; 90r calzol.; 94r latteria.
CIVICI 2007
UU25=NERI
= da 1 a 27 (compresi 5A, 7AB, 23A; mancano 11, 13, 15, 29, 31)
da 2 a 48 (manca 22)
ROSSI =da 1r a 181r
(compresi 13A, 39CD,
63B, 177AB; mancano 67, 157)
da 2r a 108r
(compresi 60rAB, 92rA,
94rABC, 100rAB;
mancano 80r, 82r, 102r)
UU27
= NERI = da 29 a 31 da 50 a 60
ROSSI = il 183r dal 110r al 146r
Nel Pagano 1911-12-25 compaiono sul Pagano (tra parentesi, l’ultimo anno in cui
compaiono) le levatrici (ricordando che allora il parto avveniva in casa. Al civ. 2 Cambiaso Maria
(1912), Zerbino Margherita (1925), Forno Angela (1925) - ed all’8A-10 la
Galletto Giuseppina (1925); al 20r Dellepiane Agostino (1933) ha una
fabbrica di acqua gassosa. civicoNonPrecisato una impresa trasporti di Grosso Luigi (1912) (che l’anno
prima era presso il Ponte di Cornigliano; nel 1920 è descritto in ambedue le
sedi con tel. 2306; nel 1921 non c’è più); il meccanico Pastorino Romolo (1912) (proveniente -1911- da p.za dei
Mille);
Si descrive esserci stato nella via in tempi successivi (dopo 1925: sul Pagano/25 non c’è), un’altra scuderia di cavalli, della ditta Lanati (ebbe in affitto i cavalli di
Casirola Carlo impresario di trasporti mobili e merci con stalle in corso dei
Colli 31, sampierdarenese del 1878, morto a Dachau, anche lui deportato il 16 genn.1944)
Questa titolazione stradale esisteva anche a Rivarolo; nella unificazione della
toponomastica del 1926 nell’ambito
della Grande Genova, la nostra città fu favorita nel mantenimento del nome (nella nostra vicina, è divenuta via
S.Botticelli).
Il Costa del 1928 segnala questi
esercizi commerciali. Al : 5r= drogheria di Serafino Andrea---9r= macelleria Roncallo
Giuseppe---15r= merceria Collin&Pittaluga---10= vini
di Facco Teresa---11r= merceria di Garrone Livia---13= pollivendolo Castaldi
Benedetta---16= vini di Ivaldi Tomaso---17r=
calzature di Gavelli Salvatore---18= lavorazione latta di Noce Gaetano---20r= acque
gazzose dei f.lli Dellepiane---22= puleggie di Almonte Cesare---23r=farmacia Rolando Paolo---23= lavorazione latta di Tardito Giacomo e F.---33= commestibili di
Giglio Amalia---34= commestibili di Ferraris Maria---42= vini di Sella Mora---44r= salumiere Costa Amilcare---46=
fruttivendola Cipollina Giuseppina---52r= latteria di Masè Giovanna--- 54r= chincaglierie
di Merlo Emilia---56r=sartoria Rigamonti Amedeo---58r=commestibili di Quaglia
Maddalena---70r= commestibili di Cavalli Francesco---84=commestibili di
Rosellini Emma---86r= mobili di DiClemente Pietro---- non precisato= cordami di
Lancerotto Ernesto (anche in 2r-scalinata Pisacane)-
Nel 1933 appare di 4.a categoria,
ancora indefinitamente indirizzata “ai monti”, con civici neri sino al 48 e 25.
Al civ.2-9 Piccardo
Francesco eserciva armi e munizioni; al civ.35r
c’era la fabbrica di
calze di Veruggio Antonio; al 53 il Consorzio Agrario aveva una
latteria ed al 53r c’era l’azienda di Fava & Roccatagliata di rottami metallici.
Nel Pagano 1950 viene segnalata una
osteria al 16r di
Minetto A. e tre bar: al 10r di Bocca A.; 31r di Tacchino G. ed al
42r di Zaccone Angelo. Nessuna trattoria.
 inizio salita, anni 70
inizio salita, anni 70
===civ.1 il palazzo fu eretto al posto della casa
dell’Istituto Tecnico che reputo corrispondere alla (multifunzionale) ‘villa
Boccardo’ descritta a via Mercato e,
come dimostrato dalle foto sopra, che c’era ancora nel 1905.
===civv
dal 3 al 9: Il cav. Narizzano
Alberto nell’ago 1898 vende un terreno coltivo ad orto, con casupole coloniche,
ad Emanuele Palau (già proprietario di altri vasti
appezzamenti di terreno posti a ponente dei confini della villa Doria-donDaste
(vedi civ. 74r; ed anche in via G.Mameli);
da lui -ancora regnando UmbertoI - gli imprenditori sigg. Parodi Luigi e
Gambaro Giuseppe (proprietari
anche in via Mameli di immobili), acquistarono nel lug.1899 un’area di 500 mq posta
a levante di un vialetto interno della proprietà, per erigerci i palazzi
attuali (arch.ing. Salvatore
Bruno; iniziò la costruzione dal 3, poi il 7(ex 3a - finito
nel dic.1901) ed il 5(ex 3b) ; completando il 9 (ex 5) nel 1903); firmarono
accettazione di alcune clausole sindacali quali il riposo festivo per gli
operai). La parte di terreno rimasta a
levante rispetto le case, entrò a far parte della piazzetta nel retro delle
scuole Tecniche; e quella confinante con la strada principale, tramite il
vialetto su accennato di accesso (già esistente ed iniziante dalla ‘via del Mercato’ via con il passaggio
sotto un’arcata tesa tra il palazzo delle scuole a levante, nel sito
dell’attuale civ.51*** di via A.Cantore, ed una casupola affacciata sulla via
principale a ponente ). Questo vialetto
fu donato al Comune gratuitamente in cambio delle fognature, illuminazione,
orinatoi e lastricamento della via, con l’impegno di allargare l’ingresso a 7
metri di larghezza (abbattendo
arcata e casupola) e di fornire
marciapiedi con bordo in pietra della Spezia. Ovviamente i vari appartamenti
furono venduti solo a privati agiati cittadini, (essendo proibito l’uso
industriale dei fabbricati) alcuni dei quali firmarono con la croce essendo
possidenti, ma analfabeti (“illetterati”,
come nel 1907 una certa Gestri Rosa che poi venderà l’interno 11 del civ 3B,
ora 5, a Desimone Margherita e Bianco Adele). (vedi
cartina).
===civ.
9 Si descrivono essere esistite
delle ampie cisterne, come d’altronde d’uso nei tempi dell’erezione, legate al
fatto che non esisteva un acquedotto singolarmente diffuso. Nello stesso
stabile (e forse anche al 5) le persiane chiuse sopra il portone, non
corrispondono a finestre ma sono solo decorative.
Con
queste costruzioni, ha praticamente delimitazione definita e quindi nascita,
la via G.B.Monti.
===civ.16r: una lapide
e corona bronzea, poste tre anni dopo (21 nov.1982) ricordano e ribadiscono il
‘no’ della cittadinanza al terrorismo, l’assassinio a tradimento di due
carabinieri: il maresciallo Vittorio Battaglini ed il carabiniere scelto Mario
Tosa. Il mattino del 21
nov.1979, mentre nel bar -allora chiamato “Angelo”- prendevano un caffè, ignari
di qualsiasi agguato, furono barbaramente trucidati, colpiti a bruciapelo alle
spalle da due affiliati delle Brigate Rosse (vedi i singoli).
===20r nel 1931-4 c’era lo ‘Stabilimento Industriale Grafico
/ Tucci-Conticini-Repetto / tel. 41-854
===civ. 23r: la farmacia Rolando: (sul Pagano/20 non c’è) appartenuta inizialmente al dr. Paolo dagli anni 1921, con tel. 41342, pare fino al 1960 quando gli successe il figlio Emilio
laureatosi nel 1928. A questi ancora il nipote Paolo deceduto prematuramente
nel 1998 (fratello del
professore Maurizio oculista, e di Massimo farmacista in via Cecchi).
===civ. 7Ar = per
anni, sino al 2000 circa, sede di un mobilificio: primo (ed ancora nel 1967)
usato come deposito da Gaetano Sabatino, vero ebanista, che fabbricava
personalmente mobili in via Bombrini ove aveva la falegnameria e che poi
vendeva in questa sede. Dopo di lui, negli anni ’70, i locali furono occupati
dal mobilificio Aloisio (un po’ scadendo in qualità).
===civ.
6:
il
portone è sormontato da una nicchia con Madonna. Malgrado domanda specifica di
notizie, all’amministrazione, non abbiamo ricevuto risposta.

===civv.
8-10-12: costituiscono un unico
edificio, graziosamente affrescato nel sottotetto ed attorno alle finestre, con
festoni di fiori e frutta.
===civ.
11: non esiste più. Era forse la
casa dei Landi?
===civ.15: chiesa di
N.Signora del SS.Sacramento. Coronando un disegno di mons.Paolo Fossati, dopo averlo idealizzato per tanto
tempo, l’ 11 mag.1930 l’arcivescovo di Genova,
card. Boetto (il Cittadino scrive Minoretti anche per la prima pietra), pose la
prima pietra -contenente una pergamena scritta dalle suore Pietrine- della
nuova erigenda chiesa, che sarà gestita dagli “Oblati” (sacerdoti istituiti dallo stesso
mons.Fossati, che inizialmente erano soli presbiteri, nel 2007 sono 10 e si
distinguono per due obblighi in più rispetto i sacerdoti ordinari: il voto
dell’obbedienza totale al proprio vescovo, e la dedizione all’adorazione ed
all’apostolato eucaristico; per questo, il tempio è anche chiamato “ della
Adorazione Perpetua”, il primo in Italia ad avere questo
nome. In una apposita cappella, alla quale si accede dal cancello a monte ella
chiesa, numerosi volontari si alternano giorno e notte –per ottemperare
all’aggettivo ‘perpetuo’ - per continua ed ininterrotta preghiera.
Personalmente ho constatato su taluni devoti la presenza di grossolane
callosità sulle ginocchia per permanenza in quella posizione).


Fu
innalzata nel terreno che faceva parte dei giardini della villa Doria -ora don
Daste (vedi salita
Belvedere)-, e la consacrazione avvenne
il 16 giu.1936, alla presenza del card.
Minoretti; nell’autunno dello stesso anno gli Oblati si trasferirono
definitivamente nella casa, costruita a ridosso, posteriormente alla chiesa.
Alla
guida della chiesa, a mons. Fossati seguirono mons. Giovanni Pedemonte, poi
mons. Giuseppe Mario Carpaneto, mons. Stefano Patrone, ed ora è in servizio don
Nazario Caviglia.
Dal
16 luglio 1961, a firma del card. G.Siri, si
programmava una nuova zona parrocchiale; essa fu concretizzata il 15 ago quando
la chiesa divenne parrocchia
Il
14 dic. 1986 il cardinale Siri celebrò il rito
della dedicazione dell’altare.
Ideata
in stile misto (gotico-romanico-lombardo) dall’arch. milanese prof. Zacchi Adolfo, addetto alla conservazione e
restauri delle opere del duomo di Milano e
sotto la direzione dell’ing. Musso, fu affidata al Vernazza la direzione della
decorazione pittorica -aiutato
dal prof. U.Signorini per la parte ornamentale-. Fu usato per la facciata, del travertino di Rapolano (Siena).
Nella lunetta sotto il portale centrale, un bel mosaico raffigurante la Madonna in adorazione, prodotto dal
veneto Salviati; riproduce fedelmente un disegno su cartone di Angelo Vernazza; sopra, gli altorilievi del Cristo tra due apostoli evangelisti affiancati
dai loro simboli (i simboli sono ripetuti ai lati del grosso rosone); sopra sei
monofore, in alto sotto il simbolo della
Congregazione c’è la scritta CUM***
MAGNUM DOMINUM VENITE ADOREMUS.

 A.Vernazza la scritta recita “
Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”
A.Vernazza la scritta recita “
Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”

frontale - foto Pasteris 1937
All’interno,
stupiscono le tre navate, per la fuga di volte che si intersecano, per gli
archi poggianti su superbe colonne (di granito di Baveno dai capitelli che furono lavorati a fogliame comprendente la Croce ed
altri simboli, con marmo bianco di Botticino (Brescia)); per le vetrate (su disegno del prof. Zuccaro, alcune
dipinte ed altre a piccoli tondi celestini furono eseguite dalla ditta milanese
Corvara & Bazzi (subirono gravi danni durante i
bombardamenti nell’ultimo conflitto causa spostamenti d’aria di bombe cadute
vicino)). Le lesene, sono anch’esse di granito di Baveno. Sulla parete
di fondo e nel lacunare sottostante, c’è un affresco di Angelo Vernazza:
questo lavoro nella chiesa fu l’ultima sua opera dove, essendo il pittore
sorretto dal una fede profonda, rivelò le migliori qualità del suo ingegno
nelle interpretazioni di soggetti religiosi (sampierdarenese, nato il 28 aprile 1869 da modesto
commerciante, ultimo di una nidiata avviata al commercio. Di tutti i figli, lui
unico si mostrò insofferente a questa dottrina, prediligendo l’idealismo, la
poesia, la spiritualità. Questi sentimenti crearono un pesante contrasto con i
suoi, mantenuto solo dall’alto senso della famiglia e del vincolo di sangue, ma
a prezzo di una perenne mestizia, di un fondo melanconico, di un rigido
autocontrollo. Dopo l’accademia Ligustica, con la borsa di studio andò a
Firenze alla scuola di N.Barabino, il quale intuì le sue capacità e lo apprezzò
come il migliore dei suoi allievi. Fu ricambiato da una fedeltà a tutta prova,
da un umile continuo osanna all’ombra del maestro. Poi, da Firenze andò a
Parigi, Londra, Venezia, studiando ed imparando, al punto che, tornato a Genova,
fondò una sua scuola d’arte in via XX Settembre nel palazzo delle Cupole dove –
motivato da una passione interna molto forte - cercò di insegnare a dipingere
usando - come Barabino - un metodo che richiedeva - nell’allievo - una
eccessiva rigidità etica e morale, tale da tendere ad imprigionare anche la
fantasia e la libertà espressiva (chiamava aberrante o traviante la recente tendenza a
maggiore libertà; la quale invece - attraverso ai primi dipinti impressionisti -
cercava di liberarsi da quelle stesse leggi che lui invece giudicava
superiori e dominanti).
Le sue opere venivano richieste da una committenza sempre
più numerosa, specie dalla società ligure, fortemente ancorata alla tradizione:
oltre ad affreschi (al Calasanzio, a villa Hambury di Ventimiglia, al
santuario di Oregina, alla Cella (una “scena biblica” posta nella canonica ed un affresco
nella arcata centrale))
frequente era la richiesta di ritratti (in epoca in cui non esisteva
ancora la fotografia) e di paesaggi, con Portofino meta preferita,
culminati nella meraviglia del panorama di Belvedere (1916).
Quindi un grande maestro dell’emozione e del sentimento
nell’arte pittorica, con tanta e profonda religiosità, ma altrettanto eccessiva
rigidità che nel tempo è risultata perdente di fronte agli impressionisti, ai
“grigi” ed all’evoluzione della libera espressione tipo Picasso. Il massimo del
concesso fu qualche sconfinamento nel liberty.
Sappiamo che per la sua dirittura morale, era assai
spesso usato dal Comune locale per consulenze, come per esempio sostenere la
produzione artistica di Dante Conte con sovvenzioni. Fu forse questa –non
appartenenza, ma- vicinanza con l’ambiente politico che fece peggiorare
la sua figura d’artista: avvenne che quando il fascismo gli presentò l’ideale
simbolico della redenzione della Patria, lui abboccò creando un bellissimo san
Giorgio che uccide il drago, con la pecca che il santo veste la divisa di
soldato della nuova milizia. Come per Massiglio, aver vissuto in epoca fascista
e forse aver forse prodotto disegni a loro uso, gli è valso sino ad oggi un
significativo silenzio (per ambedue, non ci sono prove di stretta
collaborazione col fascio, ma…).
Rimasto vedovo dopo 35 anni di vita coniugale, dopo un
anno morì anche lui sfibrato dal dolore, a Genova il 3 maggio 1937).
In contrasto con la semplicità e nudità delle navate laterali, l’abside centrale
accentra il massimo fastigio: sull’ altare maggiore, il simbolo di un trono dorato e ricco di pietre
preziose, su sei colonnine di marmo, per l’esposizione solenne del Santissimo;
sulle pareti altro affresco del Vernazza che divise la volta in due piani
soprastanti: in alto nel timpano, coronati da cinque cherubini, sei angeli
sorreggono dei serti floreali ed un cartiglio con scritto “GLORIFICAMUS TE”; e veleggiano -significando l’apoteosi del volere
divino- in un cielo chiaro e tenue, interrotto da nubi leggere. Nel sottostante
catino dell’abside, su uno sfondo scuro, al centro si espande l’albero della
vita: sul tronco il cartiglio “ADORAMUS TE” e racchiuso tra i
suoi rami al centro -un ovale irradiato d’oro- con il calice, l’ostia
raggiante, la croce ed i simboli dell’alfa ed omega, la vita e la morte; ai
lati, sei angeli posati su nubi, in vario atteggiamento: adorazione,
meditazione, estasi, preghiera; e che ricevono luce dall’ostia. In quest’opera,
il pittore ha raggiunto il vero ideale della bellezza religiosa. Due pannelli
laterali all’altare rappresentano i simboli di Gesù: in uno al centro la
corona di spine ed il cuore trafitto, circondati con volute armoniose da
vitigni ricchi di grappoli a simboleggiare il sangue di Gesù; ai lati due pavoni
a simboleggiare la Resurrezione, i quali quasi camminano in un campo di grano
simboleggiante il pane e con esso il corpo di Cristo; al centro un cartiglio
con la scritta “QUI
MANDUCAT HUNC PANEM VIVET IN AETERNUM”. Nell’altro dodici pecore, rappresentanti
l’umanità e per lei gli apostoli, che si dissetano e purificano alla fonte
della vita centralizzata dall’Ostia col simbolo IHS, mentre due stormi di
colombe volteggiano nell’aria.
Nei
catini degli absidi delle due navate laterali, su fondo azzurro spiccano
quattro vasi stilizzati con gigli, e quattro cherubini in un alone di luce.
Nei
vari interspazi, si ripetono i simboli sacri, alternati a fregi policromi che
ricordano le pagine disegnate dei canti gregoriani. Tutto, è arte del
Vernazza.
Nell’altare
di destra, si venera una statua in
legno, di Maria, in grandezza naturale, scolpita da Vincenzo
Mussner di Ortisei (Val Gardena); invece in quello di sinistra, c’è una statua di san Giuseppe.
In
una cripta posta lateralmente, si accede alla tomba del fondatore
dell’Ordine (fu
ottenuto il permesso di traslare la salma da Staglieno, nel 1950), sulla cui lapide si vele effigie, e si leggono la
data di nascita (12.6.1873), quella di morte (12.6.1948), il nome ( mons. Paolo
Fossati fondatore Oblati SS. Sacramento), e la frase (“visu sim beatus tuae
gloriae”).
Dopo
alcuni anni, con la stessa procedura, si ottenne trasferire la salma del duca Angelo De Ferrari (27.9.1859- 19.12.1927) e, dopo la
sua morte, anche della moglie duchessa Carola De
Ferrari Parodi (21.9.1876- 3.7.1960): essi furono dal 1926, i
sostenitori e finanziatori della nuova congregazione sacerdotale, desiderosi di
operare in silenzio, lontano dai riconoscimenti pubblici.
Nel
maggio 2004 una iniziativa del parroco, vuole
coronare lo scopo fondamentale della Congregazione: la preghiera continuata,
effettuata da un iniziale gruppo di 300 parrocchiani che giorno e notte si
alterneranno in preghiera nella cappellina laterale che non verrà mai chiusa.
===civ.
10: ci abitava Giancarlo Bargoni, nato nel 1936, divenuto celebre pittore astrattista, le cui opere sono state
oggetto di premi ed ospitate in musei d’arte nazionali; Parigi; Danimarca.
Fondò nel 1963 il ‘Gruppo Tempo 3’. Ha lavorato il vetro e ceramica).
Dall’altezza
di questo civico, tutta una ampia fascia di terreno estesa verso monte e nord,
e sino alla fine di via Ardoino circa, era denominata ‘le montagnette’, causa la natura del terreno fatto
in ripida discesa ma a mammelloni; e questo ancora negli anni postobellici
quando poi la zona fu interamente edificata (specie via dei Landi)
===civ.
11.13.15: non esistono (forse uno è
attribuito alla chiesa)
===civ. 14r : si
apriva nel 1933 uno dei sei spacci sampierdarenesi della Cooperativa di Consumo
Carlo Rota.
===civ 65r:
l’ingresso alla tipografia don Daste; già capace di rotocalcografie e fotolito.
Faceva parte del complesso “Orfanatrofi femminili Divina provvidenza <Don
Daste>, di salita Belvedere 2. Chiuse la sua attività per ‘sfratto’ al
tipografo e dispersione dei macchinari, nel 2005 circa.
===civ.
17: l’ingresso delle scuole materna
ed elementare Don Daste; prima del 1961 era una porta secondaria senza numero.
===civ.
16: la casa, già della famiglia
Mignone (vedi via omonima). Da qui per cento metri la strada è stata delimitata
nel 2002 con paletti, per evitare ‘posteggi selvaggi’ sul marciapiede.
===civ.
19A: assegnato a nuova costruzione
nel ’63 .
===civ.
20: approvato nel 1956 (appare che
la commissione edilizia approvò nell’ottobre 1956 l’erezione di un palazzo
nuovo ‘in scalinata dei Landi’). Fu costruito dagli imprenditori Mignone nel
1958, su sedime di una villa:
-villa Lomellini – Bocci .
Nella
carta vinzoniana del 1757 circa, appartenne a Lorenzo Lomellini ed aveva una
cappella gentilizia interna
Si presume non sia stata
questa la villa che venne ospitata la bellissima ventiduenne Elisabetta Farnese figlia del Duca, dopo che nel
1714 andò sposa per procura a Parma al re di Spagna Filippo V (per lui, seconde
nozze). Si fa generica menzione di questa ‘ospitatiltà in una villa Lomellini a
SPdA’ senza specificare, essendocene più d’una)
Da Parma, trasportata in bussola e con un imponente seguito,
era entrata nel genovesato il 25 settembre: dal passo di Cento Croci era scesa
a Sestri Levante, da dove il giorno 30- via nave ‘la Reale’, scortata da altre
5 galee della seren.ma Repubblica - era pervenuta a San Pier d’Arena. Dovette
sbarcare presso la Lanterna causa il mare agitato, e fu trasportata con il tiro
a sei dell’arcivescovo in villa Lomellini; stanca e col mal di mare neppure
partecipò alle feste preparate in suo onore e per una settimana rifiutò dame di
compagnia e di uscire. Anzi il 6 settembre volendo sentire l’opera il
‘Tamerlano’ (o ‘Li veri amici’) che si rappresentava al Falcone, tanto fece che
gli artisti e musici dovettero organizzare una replica trasferendosi in
S.P.d’Arena. Lunedì 8 finalmente uscì dalla volontaria clausura ed in carrozza
si portò in cattedrale per le funzioni e venerare le sacre Ceneri e Catino.
Null’altro fece in città, ove rimase fino al 9 ottobre a spese della
Repubblica: rimase felice dell’accoglienza, anche se amareggiata dalle strade
troppo strette e dagli annegati nei giorni di tempesta. Se ne andò via terra
facendo tappa a Voltri, Savona, fino a Ventimiglia (vedi via Mercato, villa
Lomellini-Boccardo)
Il
Bocci invece fu un falegname-deposito legnami, forse discendente o uno dei due fratelli che
avevano una segheria a Genova negli anni 1933. Negli anni 1960 compare un Bocci
Ernesto che gestisce una ‘fabbrica di cornici e legno compensato
di Bocci Angelo & Mario’ ma in via Gioberti 51r; lo stesso che poi, nel
1970, fu in via GBSasso 9r.
Ultimamente
ospitava anche una società di cacciatori.
===civ.
21: è il cosiddetto “grattacielo di via
G.B.Monti” , di 22 piani, iniziato nel mar.1961, e finito nel dic.1962;
dato abitabile nel feb.’63.
Fu costruito sul terreno a ripide fasce, che da un pianoro soprastante (ove ora scorre la cosiddetta “Quota
40”, c’era una grossa vasca d’acqua, probabilmente alimentata da una sorgente) degradava alla stessa strada, in basso ed in
salita; una ripida scalinata - intestata a G.Filangeri (vedi), prima di
congiungere i due livelli - portava al civ.
23 ove era una fabbrica di scatole di
latta per conserve, con cromolitografie di esse, denominata G.Tardito & F. dal nome del titolare;
palazzo ancora presente (ed operante?= si, nel 1950 solo come c.litografia)
negli anni 1960, che aveva un grazioso giardino posto a ponente
dell’edificio (Di una “grossa società anonima
per le ‘conserve alimentari e lavorazione della latta’ già fratelli Tardito”,
ne parlano Doria e 37.203 riferendo:--- che essa nacque nel 1899 (senza
specificare se da G., dai figli, e se –come si presume- fossero loro i
fratelli; se è la data di nascita della società che rilevò l’attività ‘gia’
f.lli Tardito);---che questa società aumentò il capitale nel 1905 da 760mila
lire a 1,5milioni (questo valore restò eguale fino al 1908 quando
improvvisamente si dimezzò a 630mila nel 1909 per finire nel 1911;--- con, tra
altri, finanziatori Ferruccio Prina, i Tassara, i Cortese, i Raggio (che, dice
Doria, parteciparono alla fine, dal 1910 al 1914) e la Società Bancaria
Italiana-; --- possedeva oltre allo stabilimento di SPd’Arena, un altro ad
Alghero (di conserve) ed un molino a Sassari ed a Cagliari (una grossa somma,
allora; che però a conteggi successivi furono ridimensionati negli anni intorno
al 1910 quando andò all’asta per provvedimenti del tribunale avendo cessato la
loro attività e perduto tutto il capitale )).



il grattacielo visto da sotto e dalla torre della villa
Serra Monticelli il piazzale antistante
Nel
piazzale d’ingresso del grattacielo, sul muro di sostegno all’estremità di
levante visibile al di là di un cancello, ci sono sia in alto il segno
inclinato di un tetto appoggiato (forse facente parte della fabbrica), sia un
ampio foro nel muro stesso, con margini di mattoni, come se ci fosse stato un
pozzo o un condotto o altro.
Adibito ad abitazioni private, ospita l’istituto di analisi Emolab e, ancora fino al 1977 vi si aprivano
il “cinema Arcobaleno” ( rimase funzionale dal
1963 all’80 circa) ed una maxi sala da ballo.
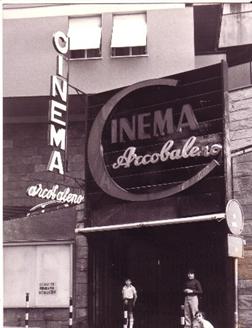

Sul piazzale si alzano due palazzine: ===il civ.19B aperto sul piazzale, che fu
eretto nel 1962 e dato abitabile nel mag.’63; e sulla via principale, nella
curva, il ===civ.23, casa per abitazioni con negozi; fu richiesta nel febb.
1962 dalla IES (Immobiliare
Edilizia Sampierdarenese dei fratelli Vicari,
progettata dall’ing. Smriglio (sic) Ciborio);
con iniziali necessità di sbancamento e costruzione di muro di sostegno a
monte; fu eretta dal dic 62; di soli 4 piani (perché assoggettata alla servitù ‘altius non
tellendi’ ovvero che non deve salire oltre il livello della strada di Quota40) e resa abitabile dal nov.’63.
: ===civ. 22: non esiste. Avrebbe dovuto essere
costruito sempre dai Mignone; ma poi non fu eretto, per cause non conosciute.
Ma il Pagano 1950 vi pone al p.t. la “società Tiro a
volo – campo Enrico Canepa”.
===civ.23 Vedi anche sopra, al civ.21. Nel Pagano/50 vi ebbe
sede la ‘Raffineria Ligure Olii Vegetali’ di C.Coletti, telef. 41-396
===23A (quale secondario al 21):
assegnato nel 1963 (probabile sia il portone superiore; controllare***)
===civ.
25. All’interno 4 la ‘Mondial Tools
spa’ fondata nel 1993 (divenne
srl nel 1995 ed spa nel 1998; con oltre 50 persone occupate, si classifica
leader nel campo della ‘utensileria meccanica di precisione per asportazione di
trucioli’); all’interno 10
l’associazione ecclesiale “Giovani Nuovi” con presidente la sig.ra Persico
Currò Carla.
===civv.
30 dalla A alla L, eretti negli anni ‘68-70, nell’82
passarono alla nuova via Battaglini con nuova numerazione
===civ.34B assegnato nel ’99 ad una porta senza numero .
===civ.36A fu demolito nel 1969
===civv. dal 42A al 42H passati a
via M.Tosa con nuova numerazione nel 1982 .
===civv.
50,52,54 assegnati a nuove costruzioni nel 1962 ;
===civ.56
. Idem, nel ‘69
===civ.68r (villa
Lomellini-Bocci) nel 1933 ospitava la S:E:A:M: (società escursionisti “Amici
della Montagna”) affiliata all’ O.N.D. (opera nazionale dopolavoro); e
probabilmente anche la Società cacciatori San Pier d’Arena il cui presidente
era Dario Diana.
===civ.74r: la “società operaia cattolica
Maria Santissima Immacolata, e san Maurizio”, normalmente
abbreviata con “società cattolica san Maurizio”, unica locale di Mutuo Soccorso
a carattere religioso.

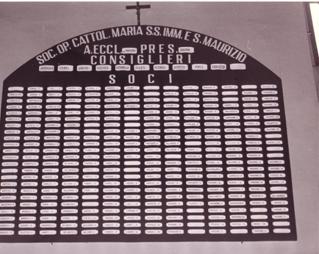
San Maurizio, come san Giorgio fu depennato dal calendario perché
appartenente ai martiri di culto medio orientale e di incerta – non documentata
- verità. Maurizio era a capo (‘primicerius’) della Legione Tebea e l’evento
avvenne tra il 285 (anno in cui Massimiano Erculeo guidò una spedizione
militare in Gallia contro i Bagaudi) ed il 310: tra le truppe c’era una legione
di oltre 1000 uomini proveniente da Tebe d’Egitto, praticamente tutti
cristiani. Quando Massimiano si trovò ad attaccare presso Agauno-Saint Maurice,
essendo cristiani anche i nemici, pretese dai suoi un giuramento agli dei. Al
rifiuto, dapprima fustigazione, poi decapitazione ); Massimiano fu poi
sconfitto da Costantino Magno a Ponte Milvio il 28 ottobre 312. O forse nel 305
(quando venne avviata la grande persecuzione ordinata da Diocleziano). Di
questa strage se ne seppe tardi, ben dopo cento anni; per questo le notizie
sono aleatorie e miste a leggenda. Come Giorgio, è raffigurato in veste
militare romana.
Per volere di Maurizio
Dufour, sampierdarenese molto vicino ai Salesiani, imprenditore cattolico molto
sensibile ai bisogni dei suoi operai oltre il posto di lavoro, il 10 giu.1877
nacque una società - dapprima intestata ‘Società Operaia Cattolica san
Giuseppe’, con sede presso i salesiani di don Bosco e subito trasferita in via
degli Operai, presso la villa Rolla (Morabito scrive l’8 giugno).

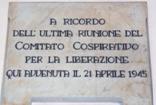
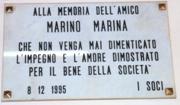

lapidi nell’interno del solidalizio
Per interessamento del
fondatore, assieme ad un pioniere dell’Azione Cattolica Camillo Galliano, fu
tra le prime ad inserirsi nel giugno/1881 in una federazione di società
operaie, tutte cattoliche FOCL = federazione operaia cattolica ligure (un primo
‘statuto delle società cattoliche operaie liguri’ nacque domenica 23 luglio
1854 nella canonica di s.Torpete alla presenza di 13 operai (chiattaiolo,
calderaio), commercianti (orefice, merciaio, calzolaio) nonché un maestro,
bibliotecario, scultore, ecc., e 4 sacerdoti (tra cui don Magnasco Salvatore).
La sede sociale fu trovata nell’oratorio di NS del Rosario nella chiesa di
s.Antonio Abate di via Pré e poi in via della Maddalena, 12. Lo statuto
prevedeva aiuto ai lavoratori iscritti, alle vedove, orfani, infortunati;
stendardo, corsi scolastici, circolo ricreativo, banda musicale. Questo
solidalizio assunse il nome di ‘Soc.Op.Catt. NS del Soccorso e
s.GiovanniBattista’ ed assunse subito importanza per l’adesione di grosse
personalità e nobili. Nel suo seno nacque nel 1881 una ‘speciale commissione
per l’unione delle varie società parallele’).
I primi tempi furono assai floridi, e si arrivò a creare
perfino una banda musicale.
Ma ben tosto iniziarono numerose difficoltà di
intemperanze e dissidi ideologici, cosicché nel 1882 il fondatore dovette
procedere ad una prima scissione, trasferendo la sede in via sant’Antonio presso la proprietà Stagno; ma in contemporanea - ricuciti
i dissidi dal Dufour - si riuscì ad allargare i principi pratici dell’operato,
costituendo in seno alla società la prima Conferenza di san Vincenzo de Paoli (il cui primo presidente fu Gaetano Lagorara, che nel 1888 battezzò la
prima bandiera sociale).
Ma pochi anni dopo, nel
1893 la Federazione dovette intervenire nella gestione della società, nominando
un quadrunvirato che durò in carica un solo anno dopo il quale, nonostante
tutto, si dovette sciogliere l’Associazione con nomina di un delegato che operò
la dispersione dei beni (la cassa, gli arredi e la bandiera) e purtroppo anche la bruciatura dei documenti e dei libri contabili,
che avrebbero potuto arricchirci di testimonianze su queste vicende iniziali; infatti alcuni soci si adoperarono per iniziare un’altra società,
chiamata “nostra Signora della Vittoria” -genericamente detta “della
Vittoria”-; ma anche questa dovette soccombere sul nascere, confluendo nella
“società generale Universale” in più floride condizioni, perdendo però così la
definizione di cattolica (e costringendo don Daste al ricupero delle immagini
ed arredi sacri acquistati); altri come il neo presidente Gaetano Lagorara, tutti
fedeli amici di Maurizio Dufour (ad ogni rinnovamento, lui rimase
irriducibile promotore della sua idea originale) preferirono
rifondare nello stesso 1894 un’altra società di mutuo soccorso, con statuto,
intestata a “Maria SS.Immacolata e san Maurizio” - in omaggio al nome del
Dufour stesso, e con matrice sempre prettamente cattolica, in contraltare delle
numerose altre società di mutuo soccorso tra operai, spesso inserite in
ambienti o politicizzati o fortemente anticlericali.
Ristabilita una certa solidità dirigenziale, quest’ultima
società finalmente riuscì a decollare, aumentare il numero dei soci e maturare
in quella che è attualmente: trovarono sede in via della Cella, presso casa
Samengo (gestita da don Daste), ove si
espressero sviluppando una intensa attività di mutuo soccorso: gratuitamente si
prestavano anche il medico dott. Dodero ed un farmacista non conosciuto (considerato che allora ancora non
esistevano le mutue assistenziali); venivano elargiti sussidi per
malattia e si possedeva una cassa di soccorso -detta di quiescenza- per aiuti a
chiunque abbisognasse.
Nel 1907 fu riveduto lo statuto ufficiale.
Quando nel 1911 una cooperativa costruì in via G.B.Monti
il palazzo detto ‘Palau’ (dal nome del proprietario dei
terreni), la società (guidata dal presidente Giacomo Pittaluga - capo officina
dell’Ansaldo Meccanico, poi titolato cavaliere - affiancato da Ulisse Repetto e
Pietro Boccardi) aderì ai
lavori ed il 30 mar.1913 trovò definitiva ospitalità nel fondo di esso,
inaugurando – con l’intervento del card. V. De Amicis - la nuova bandiera ed i
locali con uso del giardino (nel quale è leggibile una lapide con i nomi degli iscritti alla
società, caduti nella grande guerra: Alfredo Carpaneto, Domenico Cosmelli,
Romildo Spotti, Ettore e Gualco Giacomo). Nell’occasione fu sorteggiato – e vinto da un operaio - un
servizio d’argento di cucchiaini, dono del Papa.
I verbali di assemblea denunciano una interruzione di
attività tra il 1920 e 1927.
Nel 1939 la cooperativa
che conduceva l’edificio fu obbligata a sciogliersi : per poter mantenere
l’uso dei locali e la loro non occupazione da parte delle organizzazioni
fasciste, fu necessario stilare un lascito di tutti i beni intestandolo alla
parrocchia della Cella (precisando
che si riservava l’uso dei locali per continuare l’attività, anche se mutata in
alcune caratteristiche sociali quali la mutualità e la cassa quiescenza non più
in atto dal 1941 perché mutate le leggi in merito).
Durante il conflitto,
la sede fu usata anche come rifugio antiaereo per chi non riusciva a
raggiungere la sottostante galleria; una bomba d’aereo asportò un poggiolo del
palazzo ma fortunosamente non creò danni ai ricoverati: questo fatto è
ricordato da un marmo che ringrazia per lo scampato pericolo la protezione di
NS della Guardia; uno dei soci venne coinvolto nelle faide politiche del fine
guerra senza apparente motivo ed ucciso a Campomorone; dopo la resa, ospitò
alcuni dei soldati e richiamati sbandati che poi andarono a formare i gruppi
partigiani.
Nel salone principale un altro marmo ricorda le riunioni
ivi effettuate dal Comitato Cospirativo per la Liberazione, delle quali
l’ultima fu il 25 apr.1945.
Dopo il 1945, nell’ambito della san Maurizio tuttora
operante, si ricostituì la “conferenza di san Vincenzo de Paoli” ed il
“Circolo ACLI” intitolato a Paolo Reti (la cui attività permise la
formazione di una squadra di calcio e di bocce, ambedue vincitrici di ambiziosi
tornei).
Nel 1954 fu battezzata la nuova bandiera sociale
Nel 1966 si aprì il tesseramento anche alle donne, che
oggi rappresentano il 20% circa degli iscritti (poco meno di 400, di età media
di 62 anni) continuando ad intervenire per aiutare gli emarginati, i soli ed i
sofferenti offrendo a prezzi stralciati una degnissima sede e tanto calore
umano.
===civv
24-26: un unico edificio, con
caratteristiche decorazioni sulla facciata di stile liberty; già di proprietà
Mignone, fu progettato da A Petrozzani nel 1910 “nell’angolo prolungamento via
GB. Monti”.
===civv
28-30: anch’esso in unico stabile,
leggiadramente decorato, appare posteriore al precedente, risalendo al 1936
circa.
A
livello del civ. 30:
a)
la numerazione continua non seguendo la strada, evidentemente costruita dopo,
ma salendo le scalette: infatti il 32-34 è sopra il muraglione, e da lì la numerazione
prosegue verso levante.
b)
inizia la scalinata “Scalinata G.B.Monti”
(vedi) che ha l’onore di una targa sua - ripristinata
nel 2009 dopo anni di assenza della quale si intravedevano i supporti tra le
pietre del muro.
c)
sotto la scalinata l’ingresso di una galleria
che in profondità si unisce a quella che inizia in via dei Landi, e finiscono
cieche; fu usata come rifugio dai bombardamenti durante l’ultimo conflitto
mondiale e poi chiusa, lasciando utilizzabile solo pochi metri per uso privato
(in concessione?).
d)
nello stesso punto, la strada compie una curva a tornante, affiancando opere di
sostegno della muraglia soprastante, tra le cui arcate hanno fatto ripostigli
e magazzini, presumo privati.
e)
a questo livello, il 24 apr.1979 fu “gambizzato” dalle Brigate Rosse il
direttore dell’Ansaldo, ing. Giuseppe Bonzani (persona molto schiva e riservata, onesta e altruista, che abitava in
via Marabotto ed usava il tragitto per andare e tornare al lavoro all’Ansaldo
ove era dirigente; accettò questa ‘punizione operaia’ col sorriso sulle labbra
neanche dovesse essere lusingato da tanto interesse per lui e sopportando tutto
con rassegnata e religiosa determinazione tanto che agli atti dello Stato non
appare nessuna denuncia e quindi neanche il suo nome tra le vittime degli ‘anni
di piombo’). I colpi alle gambe, lo ridussero in fin di vita per emorragia,
avendo leso l’arteria femorale e fu salvato miracolosamente al Pr.Soccorso).
VERSO LEVANTE===civ.
25: è chiamato “palazzo degli Stura”,
anche se di essi ormai più nessuno vi abita. Alla sua erezione, fu occupato
interamente dalla famiglia “Stura G. & figli” imprenditori e costruttori
edili - nel 1933, con questa titolazione
e con indirizzo in corso D.Alighieri = corso Martinetti, 4/3 (i figli erano tre ingegneri - nessuno edile:
Peppino, ing. civile Sandro ing.idraulico e Secondino ing.trasporti che poi nel 1961 abitarono questa casa
rispettivamente agli interni 4,4,10; ed uno medico: Luigi.
Il
Pagano/61 riporta due altri Stura, ing. pure loro: Virgilio – che nel 1933
abitava in corso D.Alighieri 4/6 e poi - come Pietro che compare nel 1967, a
Genova). Questi costruttori (che nel 1967 avevano uffici in via Cantore 8E.1 e
deposito in via Carpaneto 15r), erano vicini alla Chiesa (e forse alla
D.C. politica); molto operarono nella San Pier d’Arena da ricuperare dopo la
guerra (la chiesa di don Bosco, che io sappia, e altri:vedi civ.27).
Nella zona, c’era un edificio
che ospitava una stamperia ed un oleificio (la “Sirov”: soc. ind.le raffineria
olii vegetali, la cui sede rimase nell’edificio ancora negli anni ‘60 ).
===civ.
27: è degli anni 1957-8, eretto dall’impresa Stura sugli orti delle suore
soprastanti l’istituto di don Daste. Tra lo spiazzo sottostante per le auto (limitato da una ringhiera) e la proprietà delle suore, compare
un corridoio sottolivellato (anch’esso limitato da una ringhiera, lungo come il
posteggio e raggiungibile da scaletta, che era accessibile solo da una porta in
salita Belvedere che però è stata murata; rimane il marmo di base del gradino
di un cancello, che dava adito allo spazio; tutto questo spazio – sino oltre la
soprastante via Tosa, inizialmente era della villa delle suore, poi degli
Strura che l’adoperaroro come giardini propri e sui quali poi costruirono il
civ. 27).
===
subito dopo il 27, proseguendo a levante, la strada taglia l’antica crosa di
salita Belvedere; la continuazione a monte della salita - causa il taglio, e
dovendo ricuperare la pendenza - fu sostituita da una scalinata di poche rampe.
Seguono,
sul marciapiede a mare tre distinti cancelli delle “suore Pietrine”: per
l’istituto, per l’orto e giardini e per servizi. Bello è il gruppo di alberi di
canfora (un altro è nel
cortile della Croce d’Oro, unici in città),
che mandano i loro rami sulla strada.


le Pietrine angolo
via Tosa
===civ.
48 dopo via Tosa, il lungo edificio
chiamato “dei ferrovieri”, perché inizialmente costruito per questi lavoratori.
Durante l’ultimo conflitto mondiale, fu raggiunto da due bombe che causarono
tre morti.
Immediatamente
dopo, è il ponte che - essendo anonimo, fa parte di questa strada - (è detto anche “ponte di Quota 40” perché già inserito in diversi
piani regolatori per far continuare questa circonvallazione sino al Campasso); solo nel marzo1976 si arrivò ad iniziare i lavori
che furono conclusi nel maggio 1977: passando sopra corso L.Martinetti, fa
concludere la strada -fino ad allora monca-, in corso Magellano. Lungo circa
64m, largo circa 15 con una carreggiata di 13m, fu costruito in cemento armato.
VERSO PONENTE
===civ. 40: non esiste, avendo progettato - ma mai eretto - un
altro palazzo. Viene riferito che il 42, eretto dalla coop. La Vittoria,
era stato progettato e quindi doveva nascere con due portoni distinti. Ma
circostanze non conosciute hanno fatto cambiare e saltare i programmi.
===
civ. 38: detto “dei Mutilati e dei Combattenti”; alcuni stemmi e
cartigli sulla facciata ne caratterizzano il nome e lo scopo per cui fu eretto
dalla soc. coop. Generale Cantore (vedi foto sotto).
===civ. 36 e 36a: il
primo fu costruito dall’impresa Bagnasco, Florio Pietro (proprietario del
terreno) & Balestrero nel 1931.
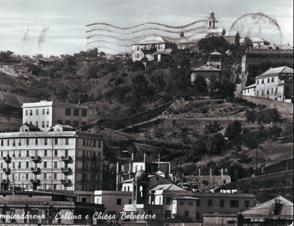

la casa Bottero è visibile a sinistra, colorato
rosso, il civ. 38
sopra l’edificio civ. 48 di via GB Monti.
Nel
civ. 36 Negli anni 30 all’interno 19 abitava Bottaro Caterina, direttrice di
una rivista “Lavori Femminili” editita dal 1914 al 1975; arricchita di
‘disegni per tutti i lavori donneschi e letture amene’. Assieme all’Eco di
donBosco erano gli unici periodici editi nella nostra città.
Del civ. 36a, due appartamenti
sovrapposti (uniti da scala a chiocciola)
furono comperati da Bottaro Caterina (o Bottero, nata a Carcare e deceduta dopo frattura
del femore per scivolamento a terra) per iniziarvi aiutata da suore
laiche un rifugio assistenza per orfanelle.


Bottaro
Caterina, fondatrice
della
casa famiglia s.Cuore
Nel 1936 avendo acquistato il
palazzotto retrostante la strada, allora numerato 36A-cancello (oggi
localizzabile in via Battaglini), dopo
averlo munito di cappella privata, riscaldamento, dormitorio ed adeguati
servizi vi si trasferì: nel 1950 risulta chiamarsi “casa
famiglia del Sacro Cuore, per Orfane povere
ed abbandonate”.
L’istituzione fu poi regalata
alla Fondazione di religione ‘Cenacolo Domenicano’ (ente morale, con sede a SestriPonente in via Vado, del quale era stato direttore
il sac. Viola Giuseppe milanese del 1807); questa congregazione a sua
volta cedette l’immobile nel 1966-7 alla soc. san Tomaso d’Acquino di Sestri
che rimase proprietaria per uno o due anni finché lo rivendette all’impresa
Salus, che costruì via Battaglini.
Sulla via GBMonti, tra il civ. 36
e 38 esiste ancora il cancello d’ingresso -seguito da una scalinata privata
che portava alla “casa famiglia del Sacro Cuore”- orfanatrofio femminile ; ove
si stampava pure un periodico intitolato “Lavori
Femminili”(nel 1950 aveva direttrice Rina Bottaro; aveva pagine con dei
ricalchi da –col ferro da stiro- riportare su tela e ricamarli).
Questa proprietà confinava a
nord con quella Boccalatte – che arrivava sino alla salita Belvedere a fianco
della palazzina omonima, e ad est con
quella di Antonio Bagnasco.
All’incrocio
con via Battaglini, la strada trapassa in via dei Landi. La palazzina posta
sopra il muraglione e di pertinenza di via Mignone, però in precedenza delle
nuove strade, era il civico 30a di via GB Monti.
DEDICATA
al
pittore sampierdarenese, nato il 20 dic. 1797 (anno della proclamazione della Repubblica Ligure;
Sborgi scrive nato 1794) nel ‘palazzo
Queirolo’ (in via San Pier
d’Arena, subito a ponente della casetta della Delegazione di Porto – in piazza
della Sanità, di fronte alla crosa dei Buoi-. Queirolo, assieme a Calvi,
lavoravano nell’industria dell’olio e furono tra i firmatari per l’erezione del
Modena), da papà Angelo -sarto- e da
AngelaMaria Tasso.
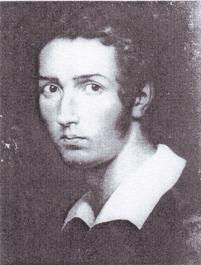
Ebbe numerosi fratelli, dei quali si
sa solo di uno divenuto sarto; uno capitano marittimo, e due ricamatrici.
A 17 anni entrò all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, nella sezione
disegno, e subito si distinse quale migliore allievo del corso; però essendo di
spirito indomito e di carattere irrequieto ed eccitabile, forse sentendosi
frenato dalla locale prevalente ed indiscussa cultura classica, o incompreso,
preferì trasferirsi a Bologna (del cui soggiorno mancano totalmente tracce e documenti); da qui a Roma, attratto da un’idea di maggiore
libertà espressiva e dal gusto preromantico di Camuccini, e dalla compagnia di
amici (tra cui i
pittori Francesco Baratta e Giovanni Fontana, l’architetto Nicolò Laverneda e
lo scultore Giuseppe Gaggini, tutti inviati colà dall’Accademia genovese: alla caduta dell’impero francese ,
la Ligustica nel 1815 stanziò una somma -promossa dal nobile Marcello Luigi
Durazzo- utile per inviare il migliore alunno per ogni specialità, a studiare e
perfezionarsi a Firenze o Roma); iniziò
a produrre qualche opera, andata oggi dispersa (un “Sansone”); vinse il primo premio per l’anatomia nel 1818;
finché nel 1820 in venti giorni eseguì un “san Gerolamo in atto di
penitenza”, per partecipare ad un concorso di pittura
-indetto dall’Accademia romana di san Luca-: la cronaca ricorda che il
direttore, addirittura Antonio Canova, gli cinse solennemente il capo con una
corona d’alloro (come
era allora in uso per testimoniare il massimo dell’onore), decretando così un trionfo per il giovane e per
l’opera (posta nella
chiesa di san Luca, viene considerata un capolavoro: rappresenta il santo, in
grandezza naturale, in atto di umile penitenza; l’Alizeri ricorda che Vincenzo
Camuccini -valente pittore che già faceva scuola ed da cui il Monti aveva
iniziato a fare il discepolo - lo declamò affettuosamente ma sinceramente “mio
maestro”. In effetti il tratto pittorico appare potente e sicuro, quale fosse
stata opera di un esperto e già declamato pittore).
Intensa divenne la richiesta della sua opera, specie come ritrattista,
divenendo valentissimo, uno dei più significativi del suo tempo, sapendo
cogliere i maggiori risultati di freschezza dell’immagine, rispetto i
cosiddetti tradizionalisti (dipendenti da una cultura accademica più rigida e rallentata in un
periodo in cui il linguaggio pittorico era evidente movimento innovativo). La sua opera si colloca in posizione di spicco del
primo romanticismo genovese.
Non specificatamente attivo nel ramo, però produsse anche affreschi, di cui è
tipico un autoritratto conservato nel Museo dell’Accademia Ligustica e nel
quale viene colto un “progressivo superamento della nettezza disegnativa
accademica, in nome di un uso più nettamente costruttivo del colore”. Sborgi
precisa “personalità più significativa – e tenderemmo a dire unica –
nell’ambito dell’adesione al romanticismo emozionale… formatosi all’Accademia e
morto giovanissimo a Roma dove sembra che seguisse anch’egli gli insegnamenti
del Camuccini”.
Morì appena ventiseienne, il 12 dic.1823 a Roma, dopo giorni di atroci spasmi
e dolori cerebrali (la
morte prematura, e la fama raggiunta rapida a livelli così eclatanti, indussero
a pensare ad un avvelenamento -anche per gelosia professionale; ancora usava
allora, con pochi scrupoli, anche se la diceria proseguiva dicendo che
l’avvelenatore sarebbe morto a sua volta il giorno dopo, precipitando in un
burrone-; la maldicenza mai fu provata, e non appare probabile: rimane quindi
la malattia infettiva -come una otite o meningite- il movente più logico a
giustificare il luttuoso episodio).
Lasciò non molte opere; qualcuna anche negli USA; in Italia persistono solo
alcune tele nelle case private e nelle chiese romane. Alla Ligustica abbiamo quattro
dipinti: due di essi, un “ritratto della sorella Anna” (olio su tela di 46,5x56,2); ed un “autoritratto con colletto
bianco”( olio su tela di
47,5x31, ambedue donati dalla sorella Giulia il 4 lug.1877, anteriori alla sua
partenza) “rappresentano una
significativa, ma non particolarmente emergente, interpretazione in chiave
latamente romantica della ritrattistica tardo-neoclassica”. Gli altri due, la
“testa di vecchio barbuto” (olio su tela, di cm 47x35), ed un “autoritratto” (olio su
parte tela e parte cartone, ambedue del periodo romano ed ambedue provenienti all’Accademia da un legato del 1857, del marchese
mons. Stefano Rossi) “mostrano una
modernità di concezione che è indubbiamente difficile a riscontrarsi in quegli
anni non solo nella cultura romantica genovese, ma anche in quella italiana,
tanto da porre, paradossalmente, alcuni dubbi sulla paternità del dipinto”
E’ opportuno distinguere il Nostro, spesso confuso con un
omonimo pittore genovese nato nel 1610 e morto di peste nel 1657. Quest’ultimo,
lodato da G.Reni; citato dall’Alizeri, in enciclopedie e nel “dizionario
biografico dei genovesi”; fu allievo di Luciano Borzone e condiscepolo del
coetaneo Mainero; incisore in rame sul libro (1644) ‘L’Ateone’ di GB DiNegro.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Notizie dei Professori di disegno in Li –vol.I- pag. 130
-Alizeri
F.-Guida artistica per la città di Genova.-Sembolino.1875-
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 2949
-A.
non conosciuto-Manoscritto chiesa san Gaetano-don Bosco-pag.512
-A.
non conosciuto-dattiloscritto relazione storica della soc.s.Maurizio
-AA.VV.-Mutualismo
e solidarietà-Reg.Liguria.2001-pag.155
-AA.VV.-il
Museo dell’A. Ligustica di B.Arti-CARIGE-1983-.65.262
-AA.VV.-Annuario-guida
archidioicesi-ed.1994.422--ed.2002-pag369.459
-AA.VV.-annuario
generale d’Italia-Pozzo.1953-pag.1124
-AA.VV.-La
pittura a Genova ed in Liguria-Sagep.1987-pag.418-9.421autor
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1976-pag. 84
-Beringheli
G-Dizionario degli artisti liguri-DeFerrari 2001-pag. 35
-Biavati.Marasco.Rizzo-Il
segno in trappola-Marietti-pag.148
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.49
-Dellepiane
A.-Enciclopedia dei liguri illustri-ERGA-vol.2-
-Dellepiane
A.-I maestri della pittura ligure-Tolozzi.1971-patg.201
-Doria
G.-Investim e sviluppo econom. a Ge.-vol.II-Giuffré.1973.pag.768
-D
’Oria S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.53
-Durante
A.-don Nicolò Daste-DonDaste.1964-pag.84.86
-Enciclopedia
Sonzogno
-FaldiEF.-Spirito
eletto sotto ruvida corteccia-DonDaste.1975-
-Galotti
F.-Pittura e scultura oggi-Artisti Riuniti.1970-pag.80
-Gazzettino
Sampierdarenese : 1/73.9 + 8/73.5 + 4/76.7 + 5/77.3 + 6/77.2.7 +
7/77.4 + 1/81.11 + 9/82.16 + 10/02.12 + 04/04.6 +
-Genova
-Rivista municipale : 1/39.28autoritratto e 2 quadri +
4/39.1 + 5/67.48
-Gente
di Li.Almanacco.103
-Il
Cittadino, quotidiano. 07.10.1997-pag.9
-Il
Secolo XIX. : 9 lug.1998 + 5.2.02 + .4.04 +
-Lamponi
M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag.189
-Maira
Niri M.-La tipografia a Genova...-Olschki.1998-pag.280.XXX.
-Medulla
M.-Sampierdarena-DeFerrari 2007-pag. 22
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.141
-Miscio
A-La seconda Valdocco- Elledici.2002- pag. 378 vol.II
-Morabito
L.-Il mutuo soccorso- ist.Mazziniano.1999- pag. 432
-Novella
P.-Le strade di Genova-Manoscritto B.Berio.1900-30-pag. 17
-Operaio
Ligure- FOCL- marzo 1959. settembre 1959. luglio 1962.
-Pagano/33-pag.
598.856.1179--/40-pag.347--/50- pag.202.234--/61-pag.247
-Pastorino
P.-Viaggio sentimentale nella GGenova-Tolozzi2007-pag.83
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1250autor
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995.tav. 22.34
-Sborgi
F.-1770-1860 pittura neoclass. romantica in Li-mostra.1975-p.108
-Sborgi
F.-in “Studi di storia delle arti”-Sagep.2003-pag.183
-Sborgi
F.-pittura e cultura artistica nell’Acc.Lig-Quaderni Ist.St.Arte-n°7
-Società
S.Maurizio - relazione storica.1977-
-Stradario
del Comune di Genova- edizione 1953-pag. 119
-Tuvo
T.-SPd’A come eravamo-Mondani.1983-pag.34
-Tuvo&Campagnoli-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.109fot.203
-
non
citato su Enciclop. Motta + Novella non lo include tra i “figli” +
da
cercare:
ed.1991-II-pag. 925=Beccaro
R.-GBMonti- in La pittura in Italia, l’800- a cura di ECastelnuovo
MONTI scalinata G.B.Monti
 Esiste
tuttora la scaletta in cemento che - attaccata al muraglione di contenimento a
livello del primo tornante di strada - permette di accorciare per salire ai
palazzi sovrastanti, con i quali si continua la numerazione civica dal 30 di
sotto, al 32 di sopra (anticamente era incluso anche il 30b, ora in via
Mignone).
Esiste
tuttora la scaletta in cemento che - attaccata al muraglione di contenimento a
livello del primo tornante di strada - permette di accorciare per salire ai
palazzi sovrastanti, con i quali si continua la numerazione civica dal 30 di
sotto, al 32 di sopra (anticamente era incluso anche il 30b, ora in via
Mignone).
In
origine esisteva una evidente ripida fascia scoscesa, cosicché questo tratto
di terreno verso ponente, è stato un po' l’ultimo ad essere edificato ed in
alto aperto come prosecuzione della strada di quota 40.
Mentre
ancora nel 1953, la scalinata aveva una classificazione autonoma, con nome
(scalinata G.B.Monti), targa (di cui residuano le zanche infisse tra le
pietre), n° di immatricolazione:2810; nel tempo successivo le fu tolto
d’ufficio questa dignità, declassandola a banale congiunzione tra due tratti di
strada.
Nel
1992 un giovane, caduto e morto per precipitazione dall’origine della
scalinata, mise in discussione struttura, manutenzione e funzionalità del
manufatto, che all’ispezione però apparve regolare.
Singole
iniziative mirate a ridare autonomia topografica, sono finite nel silenzio
della non risposta da parte dell’incaricato del Comune.
Nel
2009, per interessamento diretto e insistente di un abitante della zona (sig.
Bertaglia Giorgio), presentando documentazione e reclamo, la Municipalità ha
riconosciuto il titolo autonomo ripristinando la targa.
BIBLIOGRAFIA
-Gazzettino
Sampierdarenese: 1/93.13 in
cui si fa confusione tra via GBMonti e via dei Landi
-Stradario
del Comune di Genova- edito 1953-pag.119
non c’è sul Pagano e nello stradario dei VVUU del 1968 +
MONTICELLI
vico Monticelli
Un vico così chiamato, era posto
a levante di via della Cella superiore; oggi essa è una rientranza, chiusa in
fondo, facente parte della stessa via della
Cella.
Era posta a mare della villa
Serra-Monticelli e dagli ultimi proprietari di essa aveva preso il nome, dato
senza ufficialità ma sempre -come in uso sino alla fine dell’800- in funzione
di definire una zona in base all’elemento ivi esistente di maggiore conoscenza
pubblica.
Nel dic.1900 fu ufficialmente proposto ed assegnato il
nome di “vico Nicolò Bruno”; e così appare ancora nell’elenco stradale del
1910.
Nel Pagano/25 compare ancora,
come ‘via N.Bruno’, con presenza dei calderai in rame e costruzioni meccaniche,
al civ. 5-7r, Palandri A. & C.
Negli anni prebellici la
titolazione all’ingegnere fu trasferita altrove (vedi), lasciando anonima
questa piccola traversa.
Nel cartolario dell’abbazia di
Promontorio, c’è un “censimento delle anime” scritto dal parroco don Brizzolara
nel 1907. Vi compare - come se fosse una strada o una zona - il nome
“Monticelli” e sono registrati in essa i seguenti abitanti
1-Corti Giacone fu Costante, Nozzoleni Sofia fu
Carlo-Figli: Ioanna 14-Ferruccio 8- Carlo 4- / (ogni / è una riga saltata)
2-Ponte Giuseppe fu Stefano – Traverso Assunta fu
Giuseppe- Figli: Maria 18-Eugenio 15- Pasquale 12 /// (Prosegue con:)
3- Burattini, moglie, figli; ////4- Rebora,
(con figlio, nuora e nipoti); / 5- casa Rebora-Cardinale Emmanuele
ecc;/// 6-Conte ecc.; /// 7-casa colonica-Bruzzo ecc. più
Ligalupi ecc.; / 8 Cappa e Cardinale , ecc.; / 9- Monera ecc.;
// 10 Facco //
11-
casa canonica –d. Giovanni Novara rettore- Maria Traverso
domestica-/ rev.cappellano- d.Righetti MarioLuigi più Cesarina Gotuzzo ved.
Righetti avola; //
12- Bruzzone ecc.; // 13 Spazzarini ecc.; // 14
casa Parodi ecc.; // 15 Musacchi ecc.; più Balducelli ecc.; // 16-
Campanella ecc.; 17 Morando ecc.; // 18 Mander ecc.; // 19
Bruzzone ecc.; -Semino ecc.; Parodi ecc.; /// e prosegue fino a 39
Potremmo farla risalire a salita
Belvedere-corso dei Colli, unica spiegazione è che il pastificio fosse
indicativo di tutto il percorso per arrivare a Belvedere; ma:
--la casa canonica con i due
sacerdoti, la riporta più verso via Aporti
--non può riferirsi alla traversa
di via della Cella;
--sono continuazione di essa, ma iniziavano
da dopo l’attuale via NDaste;
--la parte bassa della salita
doveva necessariamente essere sotto la parrocchia della Cella, quindi
evidentemente la territorialità parrocchiale di Promontorio scattava da più
alto.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio parrocchiale di san
Bartolomeo della Costa di Promontorio
-Archivio Storico Comunale
-Pagano/1925 pag. 1822
MORO
strada Aldo Moro
TARGA :
San Pier d’Arena - strada –
Aldo Moro – uomo politico – 1916-1978
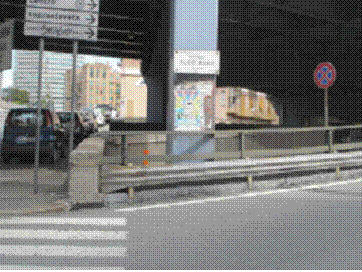

QUARTIERE ANTICO:
Coscia
N° INFORMATICO:
41390
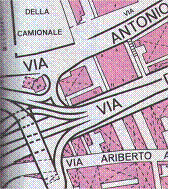 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
UNITÀ URBANISTICA: -28
- il solo tratto iniziale
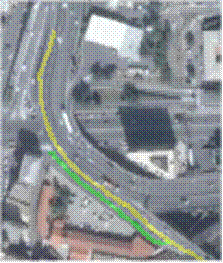
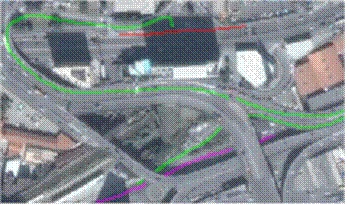
da Google Earth, 2007. Verso Genova idem, da Genova
CAP: non esiste, non
possedendo civici per assegnare oggetti postali
STRUTTURA:
È
il nome dato alla “sopraelevata”, che -iniziando da ovest- da via A.Cantore da
dietro al civ. 8, e da via di Francia collegata all’elicoidale per
l’autostrada arriva alla Foce. Ufficialmente la strada appartiene alla Foce,
percorrendo solo un breve tratto in territorio nostrano.
Iniziando
invece da Genova, vicino alla fine del tragitto si biforca facendo scendere un
ramo in via di Francia, ed uno che mira all’autostrada; ma appena passato
sopra via A.Cantore, a destra si biforca per inserirsi in via ACantore davanti
al Novotel
E’
proibita al transito degli automezzi pesanti e dei ciclomotori di piccola
cilindrata, ed ha un limite di velocità lievemente superiore a quello
cittadino: l’uso di telecamere per multare gli indisciplinati, non ha
funzionato nel tempo neanche come deterrente. L’autovelox è saltuariamente
applicato dai VVUU nascosti, solo come acchiappasoldi e non preventivo.
Nel
percorso, erano previste stazioni di richiamo SOS, non esistendo piazzole di
sosta. Ma già nel 2000 non funzionavano più.
STORIA
L’adozione
delle “corsie riservate” negli anni 1963-4, risolse solo in parte i problemi
dell’intasamento del traffico nel centro cittadino: si dovette studiare un
nuovo sistema “decongestionante”, creando una nuova superficie stradale che
assorbisse almeno quella parte di traffico diretta agli estremi cittadini.
La
sopraelevata –già inserita nel PRG del 1959- fu costruita (quando in città
erano immatricolate solo 120-130mila macchine), obbligando la demolizione di
vecchi fabbricati per 300mila m³ (tra cui nel luglio 1964 del Ponte Reale, appendice al palazzo Balbi - poi Durazzo e poi reale, costruita agli
inizi del XIX secolo dall’arch. Tagliafichi Domenico per collegare la casa
reale con l’arsenale).
Progettata
dall’ing. Luigi Miranda, fu eretta - rinunciando alla scelta di farla in
cemento - con oltre 14 mila tonn. di acciaio della CMF (Costruzioni metalliche
Finsider; ovvi dei supporti di calcestruzzo).
I
lavori, iniziati il 12 feb.1964 furono portati avanti abbastanza rapidamente:
lunga 4600 m (il Secolo
scrive 4507m escludendo gli svincoli);
larga 16,1 m per due corsie per direzione; con spartitraffico centrale e due
marciapiedi di poco meno di un metro ciascuno; sorretta da 205 piloni (il Secolo dice 210); fu collaudata da una colonna di autocarri a pieno
carico del peso di 660t..
Fu
inaugurata il 6 sett.1965 (Pastorino&VBigliero
dicono il 5 sett.; il Secolo scrive il 25 agosto); capace di far scorrere 1800 mezzi all’ora (oggi supera di molto i
2000).
Fu
dedicata allo statista dal Consiglio comunale con delibera del 1 marzo 1979.
Il
costo, sostenuto dal Comune, sommò a 1752 miliardi abbondanti.
Risulta
essere strada a scorrimento veloce, senza corsia di sosta né emergenza,
limitata al traffico leggero.
Soggetta
a corrosione, un primo intervento consistente si ebbe nel 1985 e si concluse
tre anni dopo con il cambio del colore dal grigio al bruno bronzeo. Per 700
milioni, nell’anno 2001 furono fatte riparazioni lavorando di notte: un intero
‘maquillage’ prevedrebbe rinnovi di parti divenute ‘non più a norma’, come i
guard-rail e le colonnine SOS, rapidamente obsolete (che non funzionano più sostituite
dai telefonini privati).
Grossi
interventi sono stati fatti in zona piazza Cavour (eliminando una rampa di
accesso) e nel 2006-8 alla Foce, nel rifacimento della copertura del Bisagno.
Di
essa, solo il primo tratto, con tutti i tre accessi e due svincoli, è nella
zona di nostra competenza. A lungo si auspicò la continuazione sino almeno a
Sestri, opportuna sia per alleggerire il traffico sampierdarenese che per il
collegamento con l’aeroporto. Nel 1998, ripetuto nel 2002, si lanciò anche un
referendum se conservarla o aprirsi a nuove iniziative stradali (un ponte od un
tunnel); ma la sopraelevata raccolse innumerevoli voti di benemerenza... almeno
finché gli altri non saranno realizzati.
Purtroppo
non mancano gli incidenti, anche mortali. In tale conseguenza, nel 2007 è stata
preclusa alle moto nelle ore notturne.
Ancora
nel mirino nel 2011: sia per la qualità del guard rail imputato di essere
tagliente insicuro, ma la cui sostituzione risulterebbe troppo gravosa; e sia
per l’installazione di un ‘Tutor’ (apparecchio elettronico che controllando il
tempo di percorrenza - dall’entrata di un veicolo all’ uscita – valuta che la
velocità, non superi i 60 km/ora)

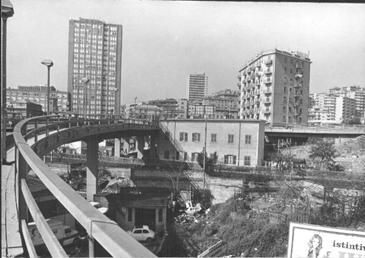
foto anni
1980 – Gazzettino Sampierdarenese
Alcuni
sommi architetti la vogliono demolita perché antiestetica rispetto il centro
storico che attraversa ed a cui preclude la vista mare; altri la vogliono sia
per la comodità e sia perché è anche una bella passerella per i turisti. Vincono
i secondi perché non ci sono soldi per scelte alternative.
DEDICATA
allo
statista politico leccese, nato a Maglie (LE) il 23 settembre 1916.
Cresciuto
nelle fila dei giovani cattolici della FUCI, si laureò in legge (divenendo professore di diretto
penale all’università di Bari) e si
dedicò alla politica attiva reggendo vari dicasteri. Divenne poi segretario di
partito (1959-65), poi deputato democristiano (la DC, popolarmente chiamata ‘scudo crociato’, allora
-negli anni 1945-60, era il maggiore partito politico in Italia).
Abile
oratore, iniziatore di quei bizantinismi nei discorsi capaci di essere letti in
più modi affermando il tutto ed il contrario di tutto, propugnatore del ‘ni’
(che non era né no, né si) e delle ‘divergenze parallele’.
Nel
1963, dimostrandosi esperto nell’arte politica del tessere accordi utili, favorì
la formazione del primo governo di centro-sinistra alleandosi con il PSI (il
‘centrosinistra’). Divenne presidente del consiglio (1963-68; 1974-76)
Dal
1969 al 1974, ministro degli affari esteri, risolse il problema della regione
altoatesina e partecipò attivamente a tutte le iniziative miranti a creare
l’Europa.
Protagonista
quindi, perché capo di un partito che da oltre un ventennio aveva dominato la
vita pubblica fin dalle prime elezioni, quando i comunisti, protagonosti
sull’altro fronte e sullo slancio dei partigiani, rimasero fortemente delusi in
quanto si erano sentiti sicuri di vincere.
Nel
PCI, a fianco della massa, inserita ed adattata nel sistema (anche se con
successive riedizioni e sempre nuove generalità), della potente, efficente e
zelante macchina da guerra dei suoi iscritti -vogliosi di rivoluzione e
capovolgimento del potere- schizzarono fuori le schegge estremiste, la stella a
cinque punte delle brigate rosse, le B.R.. Per loro la politica in atto era un
allontanarsi dall’ideologia comunista, quindi un produrre criminoso che
giustificava la criminalità poltica, attuata con soluzioni gordiane: per
distruggere la DC occorreva prima intimorire ma poi soprattutto distruggere i
notabili di quel partito. Per il Fronte popolare comunista, inneggiante a Lenin
e successore, libertà e progresso era essere loro al potere, e non la DC che
rappreentava la bieca reazione.
Il
16 mar 1978, fu rapito a Roma in via Fani da un commando delle B.R.. Questi - uccisi
nell’agguato i cinque uomini di scorta (due ancora seduti al loro posto sulla
vettura del ministro – non blindata - e tre sulla alfetta al seguito) -
trattennero per 56 giorni il deputato: lo “processarono” prima di farlo trovare
cadavere, abbandonato nel bagagliaio di un’auto il 9 mag.1978.
Enorme
lo sdegno internazionale; gravi e pesanti i giudizi e gli intrecci di quei
terribili giorni con ovvie ripercussioni politiche; bisticci tra la linea dura
e quella delle concessioni (la quale –secondo i primi- pur di salvare lo statista, dimenticò quei
cinque servitori dello Stato che non avrebbero dovuto esserci come trucidati,
per intavolare trattative).
Tutto,
ancor oggi non completamente chiarito. Perché fu rapito nel momento in cui
stava andando a Montecitorio per varare un nuovo governo Andreotti, il quarto,
nel quale anche il PCI entrava nella maggioranza. Lo stesso Moro, alcuni giorni
prima aveva dichiarato che la DC aveva bloccato il PCI, ma il PCI a sua volta
bloccava la DC, e quindi occorreva una intesa mirata a sbloccare l’impasse per
riuscire a governare il paese.
Ma
forse la macchina organizzativa degli estremisti era già in moto da molto prima;
o forse un potere parziale non soddisfaceva l’esigenza del totalitarismo.
Con
la lentezza necessaria, la macchina della giustizia ha poi fatto luce sui
colpevoli: confessioni e spiegazioni hanno chiarito la dinamica di tanta
ferocia, anche quella ideologica.
BIBLIOGRAFIA
-ArchivioSC
Toponomastica, scheda 2975/a
-A.non
conosciuto-Storia del trasporto pubblico a Ge.-Sagep.1980-p.285
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi-ed.1994. (è
citata, ma è di nessuno)
-CMF-Ge., viabilità e
infrastrutture- WTC.1989-
-Enciclopedia Zanichelli
-Gazzettino Sampierdarenese
: 9/86.1 + 5/87.6
-Il Secolo XIX : 2.10.98 +
28.12.00 + 18.01.04
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.1258
-PetrucciVE articolo
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.36
MORO passo
Moro
carta
del Vinzoni 1757. In blu, le chiese
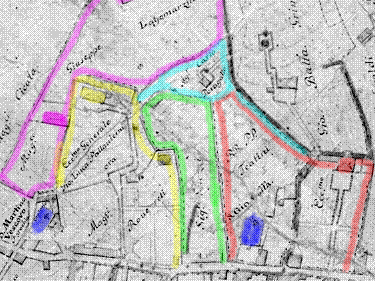 Vinzoni 1757
Vinzoni 1757
Fucsia=proprietà
mag.co Giuseppe Lagomarzino
Oggi corrisponderebbe a via Caveri 11= Moro?
Giallo=
ecc.mo generale GioLuca Pallavicini→mag.ci Rovereti
→DurazzoPallavicini→Currò→ScuolaCivica →SuoreFiglieSAnna
Verde=
sig. Ghezzi
→DeMarchi→march Pareto Domenico→SocMetall.Produzione
Rosso=
ecc.mo GB Grimaldi
→TeresaDurazzo Pallavicini→Salesiani
Celeste=
sig. Carlo Peragallo
→Montano Negrotto → Moro?→vedova Moro?
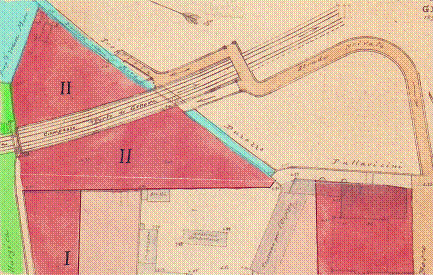 1906
1906
in
rosso, la proprietà salesiana con a destra la villa Durazzo Pallavicini
in
celeste, la proprietà “vedova Moro” con la strada “a proprietà vedova Moro”. In
verde la soc. metallurgica. A destra via Giovanni Bosco
Per il vico in oggetto, si
offrono due possibilità, senza la capacità attuale di dare una risposta:
A)=Per la cartina del 1906, villa
Moro con relativa strada (altrove descritto
Fosso Moro, e nella carta del Vinzoni si vede che corrisponde ad un rivo
torrenziale) è ben leggibile nell’appezzamento di terreno color celeste,
già appartenente ai MontanoNegrotto.
B)=A voce, da anziani, la villa
di via Caveri, in fucsia, era una villa Moro.
Se fosse vero A), dal Vinzoni si
rileva che i terreni di Peragallo non possedevano alcuna villa ma solo una
casa. Ma una villa potrebbe essere stata costruita dopo dai MontanoNegrotto (una carta del 1890, nello stesso angolo azzurro mette
“proprietà Montano” e la strada è “passo MontanoNegrotto”). A questi sarebbero
seguiti i Landi e -dopo loro- i Moro (già c’era nel 1904) e, nel 1906 dalla
vedova Moro. E nella seconda immagine sta proprio scritto la strada che dalla
attuale via P.Cristofoli (a sua volta collegata
da un lato con nuova strada comunale che verrà chiamata Giovanni Bosco) dall’altro
lato (poco a nord della antica villa Bianca, poi
dei Salesiani) deviava attraversando la ferrovia (per arrivare al Parco del Campasso) con un cavalcavia
progettato in ferro e portandosi verso nord
Con l’erezione dei palazzi di via Cristofoli e via Ardoino, il sentiero fu
cancellato: infatti in quest’ultima carta si legge nel tratto attuale via
Cristofoli-via s.G.Bosco: ‘passaggio in sostituzione di quello a nord a
sopprimersi a servizio dei proprietari a monte’.
Se fosse vero B), -vedi via A.Caveri civ.11 - la villa era quella di
Lagomarsino, e poi divenuta Moro; oggi distrutta e sostituita da un grosso
caseggiato ad uso abitazioni. Il viale privato, che sbucava in vico Cicala fu
affidato allo studio progettuale dell’ing. Bonistalli per realizzarvi delle
case tramite la ‘soc. coop. edilizia La Moderna’
e corrisponde all’attuale via A.Caveri Pertanto
non avrebbe nessuna attinenza con il vicolo vhe stiamo trattando.
DEDICATA - sappiamo che ad aprire l’oleificio (vedi in via Pittaluga), fu
Tomaso Moro. Allo scopo acquistò – assistito dai figli - le due ville
Negrotto e Pallavicino, con relativo terreno a monte delle ville stesse (vedi, nell’attuale via L.Dottesio) sul quale edificò lo
stabilimento; e che oggi è invece occupato dal grattaciuelo di via A.Cantore.
Alla morte di Tomaso (1904 circa), evidentemente la casa,
divenne proprietà della moglie, vedova Moro (vedere le foto).
A
fine secolo 1800, comprarono pure la “villa Boet”(non conosco dove fosse; ma Favretto che ne da notizia, la colloca in
Corso dei Colli. I Moro utilizzarono i terreni per dare il via ad una
speculazione edilizia lottizzando l’intero parco).
BIBLIOGRAFIA
-AA.VV.-Il donBosco nella storia
urbana-DonBosco.’97-pg31.39.52.57.61
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.108
-Bosio&Pastor&Rinaldini-Il
d.Bosco nella storia urbana-DonBosco1997
-Genova rivista municipale :
6/34.536 + 5/35.398
-Favretto G.-Sampierdarena
1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.175
MOSTO piazza Antonio Mosto
Attualmente la titolazione è
in Albaro e non più a San Pier d’Arena .
Agli inizi del secolo 1900, lo spiazzo appare esistere
con il nome generico di “piazza Promontorio” (e con l’indicazione
dell’esistenza di casa Frixione).
Appare vincolato dalla Soprintendenza un cancello e
portale di una ex villa Doria poi Moro; forse di questa casa.
Fu quindi dedicata al
patriota: il suo nome appare citato a penna in una aggiunta posteriore alla
stampa dell’elenco delle strade cittadine del 1910: “dal corso dei
Colli” (poi corso Dante Alighieri, oggi corso L.Martinetti) ”alla via Porta Angeli, con civici sino al 6
e 7”.
In quell’epoca vi erano delle
trattorie, chiamate ‘Caegà’ e ‘Baggetto’
Nel 1926, riscontrando
esistere una omonima via in Centro, dal Comune genovese fu deciso il cambio
della titolazione che avvenne ufficialmente dal 19 agosto 1935 quando
fu dedicata a Francesco Gandolfi (il cui nome già è accennato dal Novella). Con questo nome ha persistito sino alla completa
personale cancellazione avvenuta nel 1998-9 anche come piazza a sé, per essere
considerata ultimo tratto di corso L.Martinetti.
Al civ. 1r –ancora segnata nella piazza A.Mosto- nel 1940 c’era l’
“Osteria - di - Barabino Attilio / cucina casalinga – vini fini del Piemonte (per vino £.1,6; pane e coperto £.2; pastasciutta £.5;
carne alla milanese £.6; rosto con contorno £.5; frutta £.2; tot £. 21,80)
Sulla facciata del civ. 5,
furono apposte :
---una lapide-edicola
con in un tondo l’effige della Madonna e sotto la scritta “tota pulcra est
Maria”; un altro piccolo marmo sottostante ricorda la data “5 settembre MCMXX”
---una lapide
ricordo “Promontorio e Belvedere – ai loro – gloriosi caduti”. Ricordo caduti
in guerra - (a destra) cap. Molaschi Giuseppe – serg. Mora Fancesco – cap.m.
Bevegni Andrea – Bruzzo Agostino – Campodonico R*** - serg. Carlo Scorta*** -
(a sinistra) Bruzzo Enrico – Cappanera Antonio – Mascardi GB – Molinari Enrico
– Podestà GB – Solenni Mario “ ( ***da ricontrollare i nomi)
Una lapide,
ricorda i caduti in guerra del quartiere Promontorio
Dalla piazzetta, inizia la strada che porta “alla
vetusta chiesa di san Bartolomeo della Costa, che sorge a capo di un ridente
poggio, che domina la sottoposta vallata”
DEDICATA al genovese, nato il 12
lug.1824, distintosi per le sue scelte fondamentali di vita, tutte mirate
all’unificazione d’Italia.
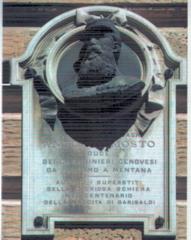
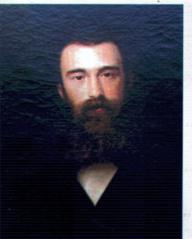
lapide
a Mosto in via Vallechiara a Genova ritratto
Optò fin da giovanissimo
schierandosi a fianco delle idee mazziniane e dell’azione garibaldina, sanando
in quanto amico di entrambi, gli eventuali dissidi di “primattori”; Mazzini
scherzando, di lui diceva “vi presento l’amico Mosto. Egli non gioca, non beve,
non bestemmia, non fuma. Ha solo un vizio: quello... di non averne nessuno”.
Abitava una casa a Genova, in via
Vallechiara, ove è posta una lapide con busto bronzeo: “abitò questa casa /
Antoniuo Mosto / duce / dei carabinieri genovesi / da Palemo a Mentana”.
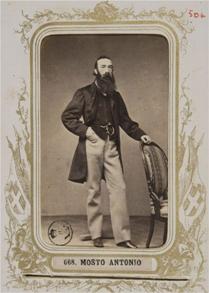
Nel 1854 è già presente
nel sociale, quale socio della genovese “Società Filantropica
Alimentaria”, mirata a combattere il carovita
usando il sistema dell’acquisto di merci all’ingrosso e rivendita al minuto a
prezzo praticamente di costo.La società visse per un anno e mezzo e costituisce
l’abbozzo delle prossime a venire cooperative.
Il 29 giu.1857 partecipò
ai moti genovesi con conseguente condanna a morte, che evitò fuggendo
all’estero. Seguì amnistia.
Assieme a Bartolomeo Francesco
Savi (che morì suicida nel 1865), fondò i
Carabinieri Genovesi, specialisti nel
tiro con l’arma che si rivelò assai spesso decisiva nel “colpire nel mucchio”
falcidiando le truppe nemiche ancora ancorate alla formazione di compatto
quadrato, che poi guidò nelle varie spedizioni garibaldine.
Furono
volutamente dimenticati dalla storiografia ufficiale, perché partiti come
mazziniani-repubblicani. Il reparto partecipò a tutte le operazioni dal 1850 al
1870; nacquero infatti agli inizi del 1851
quando fu ufficialmente fondata la “società di tiro a segno”, che promsse l’uso
della carabina - con gare ed esercitazioni domencali, fatte a proprie spese
compreso l’arma, tra le quali fu preferita –divenendo poi d’ordinanza - la
carabina a canna rigata e di piccolo calibro fabbricate in Belgio ed allora in
dotazione dei tiratori scelti svizzeri – i quali si chiamavano scharfschützen
o carabinieri). Considerate le spese personali da sostenere, i frequentatori
erano piccoli borghesi commercianti o professionisti; pochi i popolani, rari i
ricchi (come Mosto, appartenente a famiglia di negozianti). Aciuto è il loro
ruolo nella rivolta genovese del 29 giugno 1857
che fallì dopo aver conquistato forte Diamante: il centinaio di arrestati (tra
i quali A.Mosto –fuggito- e FB Savi) furono rinchiusi in sant’Andrea e
condannati a pesanti pene detentive che scontarono in parte, fino al 28 aprile
1859 quando con la guerra all’Austria furono amnistiati per poter partecipare
alla campagna militare dapprima distribuiti nelle varie compagnie di Cacciatori
delle Alpi e solo dopo formando un corpo
separato con divisa grigio-azzurra e che fu completato (causa morti e promossi)
da volontari lombardi. Combatterono a Malnate (26 maggio 1859) in 28 contro oltre 400 tedeschi. Nel 1860 erano una quarantina a partire il maggio da
Quarto, e divenne loro comandante Antonio Mosto (ma non potè essere presente
perché condannato a morte – in contumacia- per la parteciazione ai moti del
1857); combatterono a Marsala e Calatafimi, messi in prima fila subendo gravi
perdite (15, tra morti e feriti) ma producendone di peggio; fino a Palermo
venendo via via rinforzati con altri elementi provenienti da Genova con
Pianciani: nel passaggio in Calabria erano un battaglione di 180 con 4
ufficiali. A settembre 1860, Mosto fu reintegrato al comando fino al Volturno
ed a novembre quando il corpo fu sciolto perché diventavano leggendari ma
sospetti di essere presenti non per obbedienza quanto per propagandare le idee
repubblicane. Nel frattempo, le società di Tiro a segno si erano moltiplicate.
Ripresa nel 1866 la guerra all’Austria: non
furono molto graditi, e quindi inseriti assieme ai bersaglieri volontari, denominati
anonimamente ‘corpo di volontari’, insieme a ginnasti delle soc. Ginnastica genovese;
il tutto durò un mesetto (dall’1 al 24 luglio)e si concluse con Custoza col
rimpatrio e scioglòimento. Nel 1867 Garibaldi
iniziò (con 100 carabinieri inseriti in un battaglione di bersaglieri ecomandati
dal maggiore Mosto, raggiunti da altri 300 provenienti da genova) una campagna
nel Lazio che durò soli pochi giorni e durante la quale Mosto fu gravemente
ferito alla coscia dx. lascando il comando a Luigi Stallo. Il 3 novembre
combatterono a Mentana ed il 5 novembre 1867 Garibaldi li sciolse.
Nell’autunno
1870 i volontari con Garibaldi accorsero a
Digione in Francia entrando nell’armata dei Vosgi: qui dovettero cambiare le
vecchie carabine divenute obsolete e, quando a febbraio del 71 finirono le ostilità, furono sciolti con la
consapevolezza che non sarebbero più stati richiamati essendo stato adottato il
servizio militare obbligatorio nazionale. Solo a livello locale rimase in vita
la società dei Carabinieri Genovesi, almeno sino alla fine del 1800.

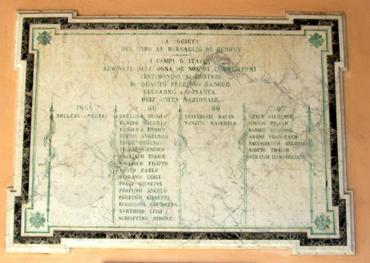
lapide murata a Tursi del “Tiro al bersaglio”
Fece pressoché tutte le campagne militari
garibaldine, dal 1849 al 1860 in Sicilia (ove a Milazzo fu
decorato con medaglia d’oro al V.M. per il comportamento in battaglia quando pur perdendo metà dei suoi carabinieri
genovesi, seppe dare l’esempio reggendo valorosamente la sua posizione. Garibaldi donò a lui ed ai suoi soldati una bandiera
italiana ricamata dalle donne napoletane; essa pervenne a Genova nel 1861 ed è gelosamemnte
conservata al Museo del Risorgimento, usata per particolari cerimonie –come il
funerale a Mazzini- (dei “mille”,
quarantatre (59 scrive Badinelli) soldati portavano quel nome ‘carabiniere’ derivato
dall’arma in dotazione di produzione svizzera; dapprima invidiati per le belle
carabine federali portate da casa (come pure la divisa) ed usate per le gare di
tiro a segno, poi per il nome glorioso che si fecero combattendo: marciavano
sempre in testa alla colonna formata dalle otto compagnie dei Cacciatori delle
Alpi.
Già allora mostrava più anni di
quelli che aveva, causa la barba piena e lunga, sguardo acuto gettato sempre in
avanti attraverso gli occhiali con montatura dorata: sembrava “tra un asceta e
un archeologo che da quelle parti andasse cercando ove fu Segesta. Quel che
valesse per fegato e cuore, chi non lo sapeva, lo indovinava” o lo veniva a
sapere dal racconto delle sue gesta: dal suo fare durante i moti, al 1866
quando fu nominato comandante di un battaglione di volontari genovesi (vedi ad
Armirotti); al 1867 quando fu ferito a Monterotondo nell’ Agro Romano.
Divenuto uomo politico,
partecipò in modo decisivo quale intermediario tra Mazzini e Vittorio Emanuele
II (in vista di un accordo tra governo monarchico e partito d’azione
repubblicano). Fu attivo nel 1863-4 per la liberazione del Veneto; fu
incaricato di presiedere a numerosi comitati.
Nel 1851, a Genova aveva
partecipato, divenendo consigliere a fianco di Stefano Canzio ed altri, alla
fondazione della “ società del tiro nazionale per la Provincia di Genova”,
avente lo scopo di fornire i mezzi all’esercizio del tiro al bersaglio,
preparando provetti tiratori; la società divenne fucina, dalla quale emersero
tutti i giovani che formarono il corpo garibaldini dei Carabinieri, e seppero
distinguersi nelle varie battaglie, guidati appunto dal Mosto col grado di
colonnello, poi di generale.
Nel 1870 si ritirò dalla vita
pubblica , dedicandosi al commercio, pur sempre partecipando attivamente -anche
economicamente- alla causa dell’indipendenza, e impegnandosi nell’ambito del
movimento democratico soprattutto contribuendo allo sviluppo dell’
associazionismo operaio. Il 23 marzo di quell’anno, risulta presente ad una
riunione tra cospiratori del Comitato rivoluzionario, assieme a S.Canzio, ad
una riunione con Mazzini venuto a Genova da Lugano: lo scopo era fare il punto
insurrezionale, con la agognata méta di una Italia anche repubblicana, ma -più
impellente- di Roma capitale, anche se purtroppo monarchica.
A Marsala arrivò come capitano
(avendo FB Savi come tenente, S.Canzio sergente, D.Uziel caporale)
Con questo spirito continuò la
lotta politico-sociale, sino alla fine avvenuta in Genova il 30 giu.1890.
Una lapide con ritratto fu
posta a memoria in largo della Zecca (via Vallechiara); ed il busto a villetta
DiNegro.
Esistono un Mosto Carlo, genovesefratello di Antonio che nella
sèpedizione dei Mille morì a Palermo sulle alture del Parco: inseguito dai borbonici,
stremato, attese il loro arrivo rassegnato e così fu finito a colpi di
baionetta. Ricordato in una lapide nell’atrio di Tursi, che fu semplice milite
– incluso nei ‘Carabinieri genovesi’ – sbarcati a Marsala con Garibaldi; quando
il nostro Antonio era di essi il capitano (e Stefano Canzio sergente, Uziel
Davide caporale). E risulta che fu -sempre quale Carabiniere genovese - poi
incorporati nei Cacciatori delle Alpi.
Ed
un Giovanni Battista Mosto, popolano genovese non imparentato con i
precedenti. Analfabeta, si imbarcò sul Lombardo e fece tutta la campana di
Sicilia; l’8 novembre 1860 si arruolò nella Regia Marina da guerra e fu lontano
dal teatro di guerra così non poté dimostrarne la presenza se non molto dopo,
su testimonianza di A.Mosto e S.Canzio e non poté riceverne neanche la
pensione.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 2981
-AAVV.Pozzi E.-A G.Mazzini,
inaugurandosi…-Sordomuti.1882-pag.105
-Badinelli D.-Provincia “garibaldina”-DeFerrari 2007-pag.30
-Bettinotti M.-glorie gastronomiche della…-La
casana.II.1965-pag.20
-Cappi G.-Genova e le due riviere-Rechiedei.1892-pag.363ritratto +
-DeLandolina GC – Sampierdarena
-Rinascenza.1922-pag. 49
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Genova rivista municipale : 12/34.1024ritratto
-GiacomonePiana P.-Viva la carabina! ...-Microstorie.2010. IV-pag.29.49
-Morabito.Costa-Universo della
solidarietà-Priamar.’95-p.163-4ritratto.168
-Museo s.Agostino- archivio toponomastica
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto-
bibl.Berio-1900-pag. 15-6.18
-Pagano/1933-pag.70.247---/1950 pag.
35.38
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di
Ge-Tolozzi.1985-pag.1261
-Salucci A.-Amori
mazziniani-Vallecchi.1928- pag. 14
-Tringali S.-Sampierdarena 1864-1914
mutualismo e...-Agis.2005-pag.26
MUSSOLINI via Arnaldo Mussolini
Nome che volevasi dare ad un
tratto di via di Francia, durante il ventennio fascista, probabilmente dopo la
sua morte. Ma nel 1933 ancora non appare nell’elenco cittadino.
Dopo l’8 sett.1943, alla
strada fu imposto dai fascisti di Salò il nome “via Dieci Giugno” (vedi), data
dell’entrata in guerra.
Alla Toponomastica non esiste
una scheda con la sua titolazione.
STORIA San Pier d’Arena
pensò negli anni del fascio (dal 1929 circa) dedicare a suo nome una società
ciclistica, facente parte dei ‘Gruppi Rionali’(organizzazione
capillare dello sport, con sede nella casa Littorio di via G.Mameli).
Nel Pagano 1940 non c’è alcuna
dedica, in nessuna parte della G.Genova; ed a nessuno con questo cognome.
DEDICATA al fratello del duce Benito; nato a Dovia
di Predappio nel
 olio di Adelina Zandrino
olio di Adelina Zandrino
1885; fu profugo dal Friuli ma partecipò lo stesso alla
guerra del 1915-8 divenendo sottotenente; e poi insegnante di agraria in varie
scuole. Oltre l’insegnamento, si dedicò al giornalismo, divenendo il 1
nov.1922 condirettore, col fratello, del quotidiano “Il Popolo d’Italia”,
giornale fascista fondato a Milano il 15 nov.1914; dimostrandosi negli scritti,
fedele seguace nonché moderatamente obbediente al fratello.
Genericamente di indole mite e
riservata, lasciò molti saggi di agraria e di politica. I suoi camerati lo
inneggiarono adducendogli provvidenze per le classi lavoratrici, leggi sindacali,
carta del lavoro, ed opere assistenziali importanti come le colonie estive per
bambini.
Morì all’improvviso nel dicembre 1931 a 46 anni, mentre
percorreva una via di Milano. Il fascismo ne onorò la memoria in maniera
osannante; Genova gli dedicò anche il parco che oggi si chiama Peralto.
San Pier d’Arena gli dedicò la casa del fascio di via
Mameli (via Carzino).
Viene ricordato l’umoristico
episodio dell’antifascista, che molto rischiando, sulla targa sotto il titolo
“via Arnaldo Mussolini” aveva scritto “via anche il fratello”.
BIBLIOGRAFIA
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-‘Genova’ Rivista municipale:
1/32.49ritratto + 2/32.136idem + 11/33.941
-Lamponi M.-Genova in
bicicletta-Valenti.1977-pag.138
-Pastorino.Viglidero.Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.736
-Stradario del Comune di Genova
edito 1953-pag.121
non
citato dal Secolo XIX


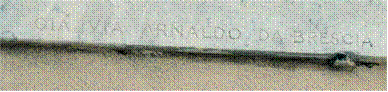

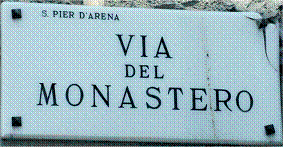

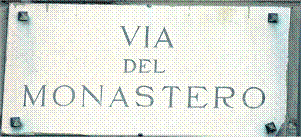
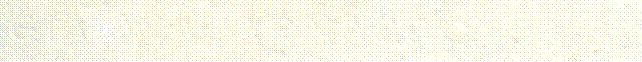
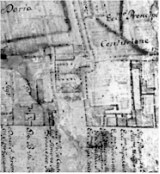 da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero
da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero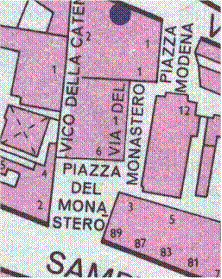 dal Pagano 1967-8
dal Pagano 1967-8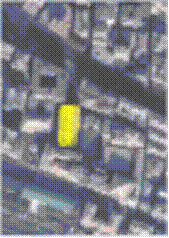 da google Earth, 2007. In giallo il
teatro Modena
da google Earth, 2007. In giallo il
teatro Modena






 da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;
celeste, crosa dei Buoi.
da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;
celeste, crosa dei Buoi.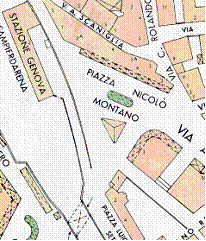 da Pagano 1961
da Pagano 1961 da Google Earth 2007. In celeste,
via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione
ferroviaria.
da Google Earth 2007. In celeste,
via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione
ferroviaria.








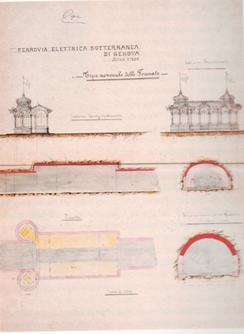
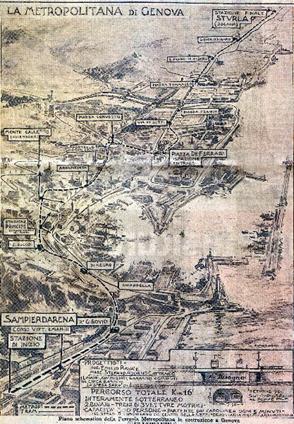

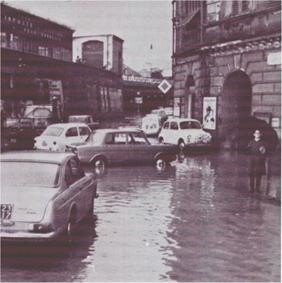










 con
ombrelloni gialli, la trattoria.
con
ombrelloni gialli, la trattoria. 


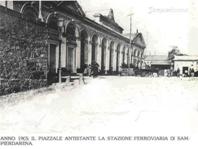



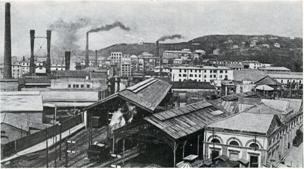






 28.4.44
28.4.44

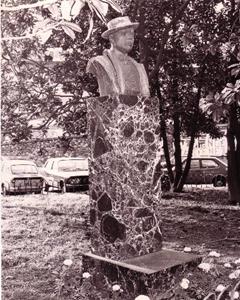
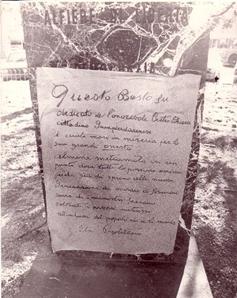
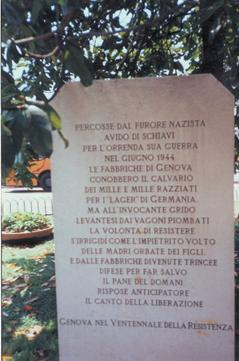




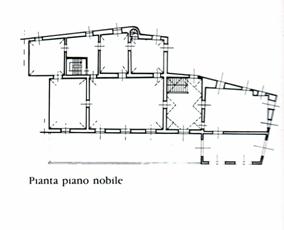































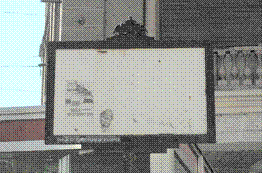















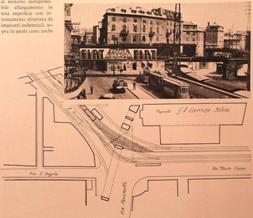
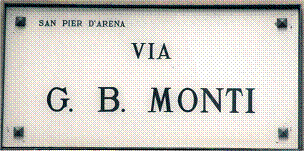





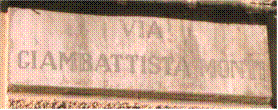




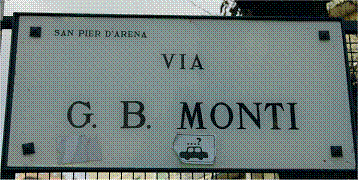
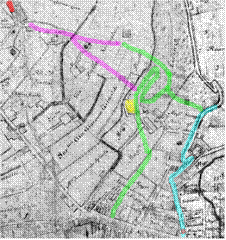
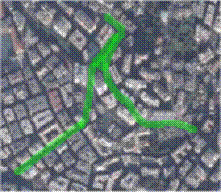
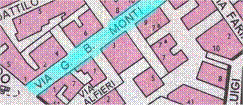
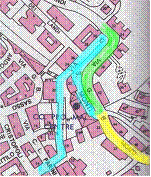
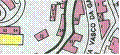

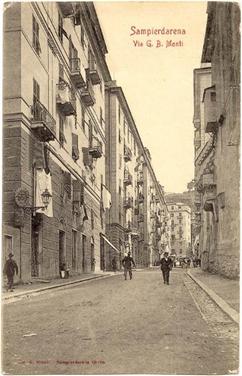
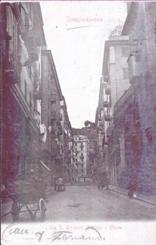












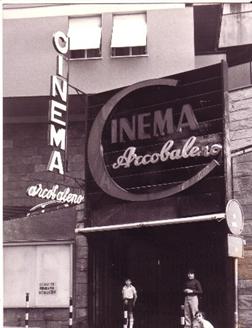


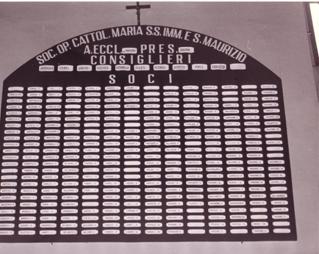

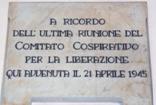
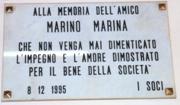



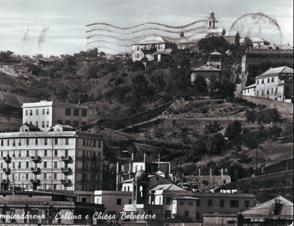



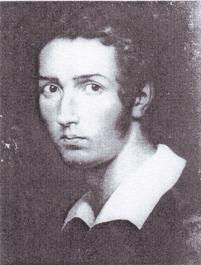

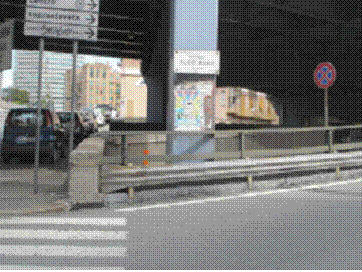

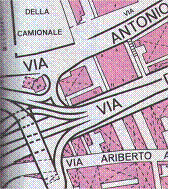
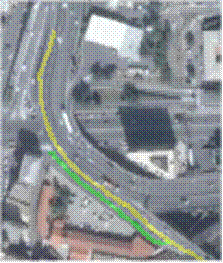
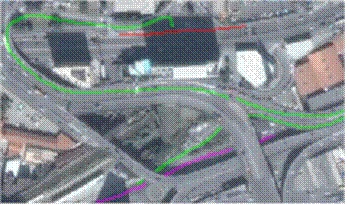

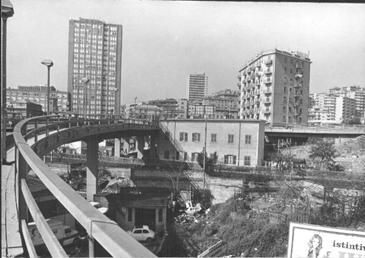
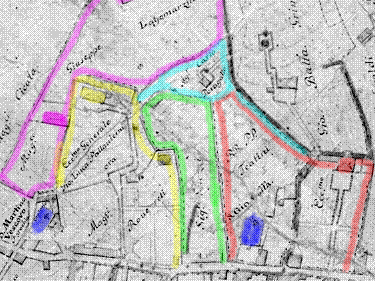 Vinzoni 1757
Vinzoni 1757