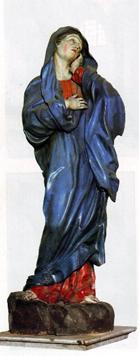PITTALUGA
via Gerolamo Pittaluga
TARGHE:
-via -
Gerolamo Pittaluga – scultore – sec.XVIII
-2 – 2829 –
via – Gerolamo Pittaluga – scultore – sec. XVIII

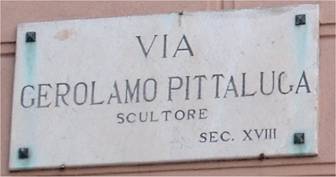
angolo con via A.Cantore-ovest


angolo con via G.Balbi Piovera

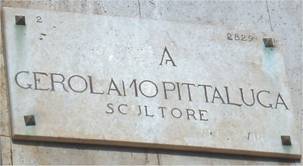
angolo via A.Cantore est su questa targa
non si legge più la scritta “Già via E.Mazzucco”
QUARTIERE ANTICO:
Canto
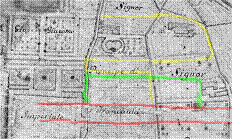 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
Ipotetici
tracciati: in verde, della via;
giallo, via
BPiovera; e rosso via ACantore.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2829 CATEGORIA: 3
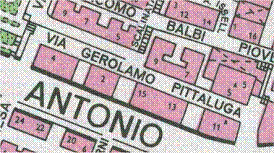 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 48940
UNITÀ URBANISTICA:
27 – BELVEDERE
28 – s.BARTOLOMEO
 da
Google Earth 2007
da
Google Earth 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: NS
delle Grazie
STRUTTURA:
senso unico veicolare verso ponente; dagli inizi di via
A.Cantore ritorna in via A.Cantore - scorrendo parallela ad essa, a monte -
prima dei giardini di villa Scassi. Tagliata a metà e incrociata, dall’inizio
di via G.Balbi Piovera.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

la strada
vista da ponente a levante
CIVICI: vanno in crescendo da levante a ponente. I numeri neri,
quelli dispari -posti a monte della strada- sono tutti nella mezza strada a
levante.
I pari -posti a mare della strada- ambedue solo nella metà a
ponente
2007= UU27 = solo il 47r
=UU28= neri = da 1→ 9 (mancano
3, 5; aggiungere 5A),
da 2→ 4
rossi = da
1r→ 45r
(manca 31r)
da 2r→ 20r (manca
16r)
===civv. 1 e 3 divennero tali nel 1954 quando in quell’anno fu
cambiato l’assetto della strada: prima erano l’ 11A e l’ 11B di via A.Cantore.
Furono ambedue demoliti nel 1957 e sul loro sedime l’anno dopo fu costruito un
unico palazzo a cui fu assegnato il civ.1, posto a metà della scalinata che a
levante la unisce a via B.Piovera (cosicché il civ. 3 non esiste più).
Il Pagano ancora nel 1961 scrive che al tempo i numeri neri
erano dal 2 al 4-dall’1 al 9.
===civ.2: preesisteva a tutte le variazioni legate alla costruenda nuova
strada, perché eretto nel 1908 (come scritto sul frontale del portone). Il
portone è, dei due a mare della strada, quello più a levante, in senso giusto
per la viabilità odierna, ma in senso opposto per quella all’origine
(giustificata però dal fatto che allora era l’unico).
===civ. 2r il Pagano/61 pone la ditta Alemagna panettoni
===civ. 4: posto sul lato a mare, è il più a ponente di tutti i
caseggiati. Il portone ha la caratteristica di occupare –nella facciata - il
più a ovest di due riquadri (ciascuno incorniciato da una mezza colonna ai due
lati) ambedue uniti con un unico capitello frontale alla sommità (nel riquadro
a levante, c’è una finestra). Questa scelta architettonica, di per sé inutile,
lascia pensare che in origine –prima di ammodernamenti- ci fossero due porte, e
forse per due scale
===civ.5: fu eretto nel 1955. È posto sulla scalinata, di fronte all’1. Al 5r,
nel 1961 c’era una officina meccanica di Medica I.
===civv. 7 e 9 ebbero questa assegnazione nel 54; prima erano
l’ 1 e 3 della via.
===civ. eretto nel 1936 (XIV)
===civ.13r nel 1961- L’autorimessa Sampierdarena
===civ 37r nel 1961- L’autotr. ParodiP
Alcuni insediamenti artigianali hanno sede solo nella
metà strada a levante come alcune officine meccaniche per auto, un salone
d’auto, la civ ===5Ar la soc. Multilastic; ed una palestra di insegnamento
professionale della danza, appunto chiamato “Spazio-Danza”
(è una associazione
sportivo culturale nata nel 1991, e maturata in scuola ufficialmente
riconosciuta dal Ministero della pubblica
istruzione. E’ divenuta
negli anni un centro didattico territoriale di primaria importanza
nell’insegnamento della danza in tutte le sue qualità, dalla classica al
flamenco e liscio, dalla ‘danza del ventre’ al jazz, al ‘tiptap’, a quella
‘afro’, al ‘funky’, alla ‘latinoamericana’, ed a qualsiasi espressione in
merito che l’uomo abbia inventato. Nel marzo 2004 l’aumento degli allievi ha
indotto aprire una 2a.sede in via AdBozzolo 1, in angolo con via E.Degola,
utilizzando uno stabile da tempo rinnovato esternamente ma abbandonato nella
funzione commerciale).
STORIA: La parte a levante è distinta in due diverse
componenti: una, la ripida scala diritta verso il monte; la strada carrozzabile
vera e propria, con senso viario parallelo a via A.Cantore.
La prima (e piccola parte della seconda), in origine erano
parte del parco della sottostante villa Spinola.
Rimane traccia del giardino, in una nicchia a
ninfeo visibile non appena salita la prima rampa di scale che unisce
la nostra strada a quella che scorre superiore, via G.Balbi Piovera.

Questo piccolo ninfeo, che ha più di cinquecento anni, è
stato assurdamente coperto anteponendogli, nel mezzo, una colonna in cemento
che sorregge la cancellata
delimitante la proprietà del piano terra del civ. 1 Appare
un orribile compromesso salomonico: sottintende che l’architetto che ha
costruito l’edificio non potendolo distruggere perché difeso presumo dalle
Belle Arti e non potendolo neanche inglobare nel giardino privato, piuttosto
che lasciarlo fuori di esso al piacere visuale e storico dei passanti, ha con
dubbia intelligenza inventato questa mostruosità architettonica: che i beni
privati abbiano priorità sui beni comuni e di rilevanza storica, mi appare
strano).
La scalinata, prima di essere inclusa nella strada in
oggetto, faceva parte di un erto viottolo o scalinata a sua volta, che saliva a
Promontorio, e che popolarmente veniva chiamata ‘via Montegalletto’
(vedi).
La seconda, ha -a metà percorso- un micro rilievo a dosso da
superare; probabile naturale asperità del terreno, non affrontato spianandolo,
nei tempi in cui si lavorava senza ruspe meccaniche.


la metà a levante, vista dall’incrocio con v.BPiovera
verso ponente con i civv. 2 e 4
La parte a ponente, ha anch’essa due caratteristiche ma diverse dalla prima,
anche se con sembianze speculari.
Una infatti, speculare alla scalinata della parte a levante,
posta nella parte finale della strada, corrisponde ad un trattino di quella
strada che nel 1800 era tutto un sentiero diritto, che dall’attuale
via NDaste saliva sino a Promontorio (si chiamava vico Imperiale (vedi) ed era un tutt’uno delle
attuali via Damiano Chiesa-via
GB Botteri-(non via MFanti) via Carrea; costeggiava a levante i muri di cinta
della villa Scassi –già della famiglia Imperiale-. Con l’edificazione di tutta
la collina e l’apertura di via Cantore e dell’ospedale, l’erta salita venne
frantumata in tanti pezzetti e con titolazioni diverse).
L’altra è la strada vera e propria che nel tratto di nostro
interesse cambiò
ripetutamente nome a seconda delle ideologie politiche della giunta municipale:
dopo vico Imperiale divenne via Jaurès; poi via Egidio Mazzucco (così era nel 1933; poi questa
titolazione fu trasferita con delibera del podestà del 19 ago.1935 nella attuale
v.C.Rolando); infine -e finalmente per fortuna senza faziosità- via G.Pittaluga.
Quando sul colle (1915) fu eretto il nuovo ospedale, per chi voleva
raggiungerlo dal basso, la salita Imperiale era la via di elezione: bisognava
passare per l’attuale tratto a ponente della strada, e continuare salendo
fiancheggiando sempre la villa Scassi. Solo dopo la cessione al municipio del
terreno di proprietà Piccardo, che permise si aprisse la strada, divenne
agibile alle carrozze seguendo i tornanti dell’attuale via G.Balbi Piovera.
Il palazzo ha i due portoni, aperti su questa facciata,
appunto perché antecedenti all’apertura di via Cantore. Anche la attuale
farmacia Cantore, si apriva su via Pittaluga (quindi nel retro rispetto ora; ma
questo ingresso, dopo essere divenuto secondario, fu eliminato negli anni 70-80
circa).
Incastonato dentro il muro che sostiene la via BPiovera in
ascesa, c’è uno dei vespasiani ancora in
funzione e relativamente decente.

DEDICATA allo scultore del legno più famoso del nostro borgo,
essendo nato a San Pier d’Arena il 21 magg. 1689 (altri scrivono 1691
circa). Di genitori di condizione economica modesta, essendo
istintivamente portato al disegno e poi a modellare il legno, fu indicato a
Pietro Ciurlo (allievo di A.M.Maragliano e che pure lui viveva nel borgo-vedi);
ne divenne allievo e per innata bravura riuscì poi a divenire superiore al
maestro. Infatti, staccandosi dalla bottega del maestro, ne aprì una propria ed
iniziò ad assumere direttamente commissioni da privati e da congregazioni
religiose.
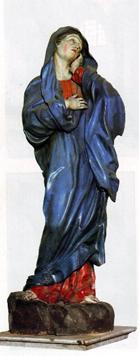
Ci ha lasciato a testimonianza della sua bravura un
“Crocifisso” (nella chiesa della Cella), ed un gruppo “crocifisso con Madonna
e san Giovanni Evangelista” eseguita per la chiesa di santa Sabina (antichissima del IV secolo, fu
rifatta due volte: dopo l’incursione araba del 936 e nel 1547 rinnovata architettonicamente
e negli arredi; affrescata nel 1846, fu poi sconsacrata nel 1931, demolita nel
1939, al suo posto eretto un cinema. Però
per fortuna ricostruita ex novo in via Donghi, ove si conservano tutt’ora
queste opere d’arte),
ambedue unici della sua produzione conosciuta scolpiti in grandezza naturale.
Ed altrettanto unico esistente in patria, è un
bassorilievo in legno lavorato con avorio (nel tabernacolo sull’altare maggiore
della chiesa cappuccina della SS.Concezione: decorò le formelle in legno,
scolpendo con tecnica finissima ed a bassorilievo la resurrezione di Gesù).
Conosciamo finiti all’estero: un altro bassorilievo (tratto
da un disegno di Luca Cambiaso, già di proprietà di Stefano Passano: alla sua
morte, fu venduto a collezionisti inglesi); un tabernacolo per la chiesa dei
cappuccini di Lisbona (trattasi di un bassorilievo con episodi dei sacri Libri,
tratto da disegno dell’abate Lorenzo De Ferrari); una statuina di sant’Antonio
(in origine per l’omonima chiesa di San Pier d’Arena); ed altri bassorilievi.
Purtroppo l’artigianato
dell’intagliatore del legno ha lasciato traccia storica labilissima, né
attendibile né documentata, limitandosi la storiografia –solo il Soprani in
pratica, e poi il Ratti- ad intagliatori per le chiese (il coro o pulpito), ma
assai imprecisa nei riguardi del lavoro per statuine del presepio. In questo
campo, pare che il Pittaluga iniziò ed acquisì fama scolpendo statuine tendenzialmente
grandi ed in particolare quelle degli animali al punto che per definizione,
viene riconosciuto come l’animalista del presepio genovese.
Seguendo la moda che faceva divenire tradizione il presepio
nelle case dei nobili, poi predilesse eseguire prevalentemente i “lavori in
piccolo”, che lui vivente, gli diedero maggior guadagno ma che più facilmente
si sono disperse. Di sua produzione vengono citate quelle conservate al museo
civico di Villetta Di Negro, ed in poche chiese di Genova. Caratteristica divenuta
innovativa a quei tempi, era di modellare e rendere mobili le parti del corpo
scoperte, lasciando invece fisso e da rivestire di abiti il manichino centrale:
questo permetteva di far assumere alle statuine i gesti e l’atteggiamento più
consoni alla posizione fatta assumere nello scenario e nello stesso tempo
concedere alle signorine nobili, usando ritagli di stoffe per i loro vestiti,
esercitarsi nell’arte del cucito modellando gli abiti per i personaggi,
gareggiando in maestria e fantasia.
A quarant’anni di età, fu colto da una grave malattia degli
occhi, che offuscandogli la vista, compromise seriamente la sua attività. Di
carattere mite e religioso, sopportò con rassegnazione per tre lunghi anni
questo martirio, finché le intense cure di un valente oculista, gli permisero
di tornare alla sua arte. Marito esemplare, rimase uomo pio e mite: pensando
di essere ignorante in tutto, appariva sottomettersi a tutti cercando di non
contraddire i sentimenti altrui; fu ottimo padre per i suoi sette figli (il
Soprani dice che non ne ebbe alcuno) che allevò seguendo i principi di
rettitudine e religiosità che ispirarono la sua vita.
Si spense nel nostro borgo, il 14 mag.1741 (altri come il
Soprani scrivono: “per violenta malattia, nel 1743, al cinquantesimosecondo del
viver suo”) a poco meno di 53 anni.
Già da molti secoli prima,
dai tempi delle Crociate, essendo la spiaggia di San Pier d’Arena rinomato
cantiere di navi di tutte le stazze, ed essendo in uso abbellire gli scafi con
sempre più pregiati intagli e sculture, la scuola locale di questi artisti del
legno fu sempre all’avanguardia ed assai ricercata: il Novella ricorda altri
due valenti artisti intagliatori: Giuseppe Forlano e Filippo Santacroce (quest’ultimo
fu incaricato di abbellire la poppa della galea capitana della Repubblica,
scolpendovi l’arrivo a Genova delle ceneri di san Giovanni Battista).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica, scheda 3546
-AA.VV.-Annuario guida Archidiocesi- ed./94-pag.431;
ed./02-pag.467
-AA.VV.-Scultura a Genova e in Liguria-Carige-vol.II-pag.287
-Gazzettino Sampierdarenese: 6/88.9
-Galassi MC.-Venite adoremus- Tormena.1993. pag. 39.57
-Genova, Rivista municipale: aprile/37.33
-Grosso&Bonzi&Marcenaro-Le casacce e la scultura lignea-Goffi.’39-p.25
-Il Secolo XIX del 31.1.04 +
-Lamponi M.- Sampierdarena – Libro Più.2002 – pag.199
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio
1930circa-(pag.7.11)
-Soprani&Ratti-Vite de’ pittori, scultori e…-Tolozzi.1965-vol.II-pag.289
-Pagano/1933-pag.247; /1961-pag.338
-Pastorino&Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi
1985-pag.1484
-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35
-Rosselli B&E-Santa Sabina restituita alla città-LaCasana
1/1985-pag 39
-Stradario del Comune di Genova ediz.1953-pag.141
-non citato su Enciclopedia Motta e Sonzogno + Paolo
Novella +

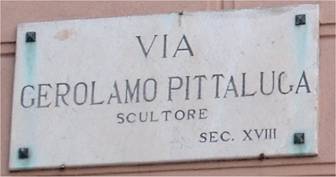



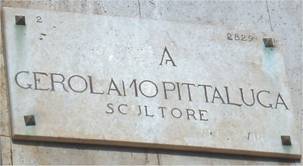
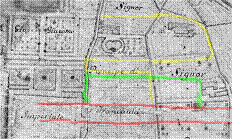 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757. 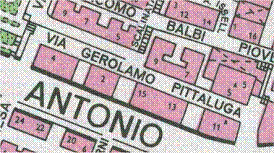 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8 da
Google Earth 2007
da
Google Earth 2007