RONCO via Nino Ronco
TARGA:
San Pier d’Arena - via – Nino Ronco – ingegnere-senatore – 1863-1949

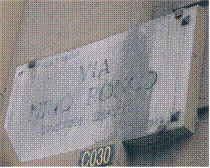
all’angolo con via A.Cantore
QUARTIERE MEDEDIEVALE: Mercato
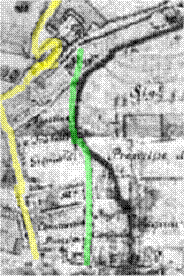 da MVinzoni, 1757. In giallo salita
Belvedere (corso LAMartinetti).
da MVinzoni, 1757. In giallo salita
Belvedere (corso LAMartinetti).
N° IMMATRICOLAZIONE: posteriore al 1950
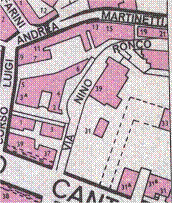 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA n° : 54460
UNITÀ URBANISTICA: 27 - BELVEDERE
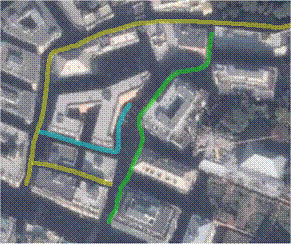 da Google Earth. 2997. In giallo, corso LMartinetti;
celeste, via ACairoli. A destra del riquadro, villa Ronco.
da Google Earth. 2997. In giallo, corso LMartinetti;
celeste, via ACairoli. A destra del riquadro, villa Ronco.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STRUTTURA: Come si vede nella carta del Vinzoni, oggi sotto terra scorre coperto il torrente Belvedere che scende a levante della villa Grimaldi; all’altezza della villa Cardinale, deviava e discendeva ancora più a levante (a est del civ.31 di via A.Cantore).
Da via A.Cantore, procede in leggera salita verso il monte per tre-quattrocento metri; chiusa alla fine da un muro che deve essere assai antico (probabile già delimitazione della villa Ronco) e che la separa -nel retro del lungo palazzo di corso LA.Martinetti- dal corso stesso. Per i residenti, i problemi per non aprire in alto la viabilità abbattendo il muretto, sono due: i posteggi auto (temuta invasione da chi abita in corso Martinetti) e lo scorrimento, con aumento della traffico e pericolosità.
Doppio senso viario.
E’ servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
STORIA: nella carta del Vinzoni, fa testo il corso del torrente proveniente da sopra ove è la salita Belvedere e la ex proprietà dei Gesuiti con la chiesa di s.Pietro in Vincoli. Esso in alto scorre a levante della proprietà dei fratelli Grimaldi (oggi dei Carabinieri); ed in basso tra quella a ponente di “Angr! (non ben comprensibile questa prima sigla; potrebbe essere una abbreviazione di Ang(elo?) Cardinale” il viale, che da via sant’Antonio (via N.Daste) portava alla villa, viene descritto come fiancheggiato da magnifici e giganteschi alberi, bordato di fiori; e sbucava nel giardino antistante la villa ove erano due grandi alberi: una palma ed una magnolia; e quella a levante del “Prencipe di Acquaviva” (un De Mari che, nella carta, sarebbe possessore di due ville: quella oggi chiamata Ronco (vedi) e quella Doria-Masnata)
Ed occorre posizionare via Cantore che ha snaturato le proprietà (i Cardinale avevano la villa nella parte alta del rispettivo terreno, e gli orti e giardino che scendevano fino alla sottostante strada Centrale (poi via sAntonio, oggi v.NDaste; via Cantore portò la villa (poi abbattuta) direttamente al suo livello, tagliando gli orti.
La strada fu aperta quando l’impresa Gadolla iniziò a costruire la scuola e, dopo essa, il primo palazzo in fondo alla strada (seguito dagli altri a scendere, sino al civ. 39 per ultimo), “rubando” una fetta stretta e lunga sul confine ovest di quello che era un giardino (quando proprietario era –dopo il ‘prencipe’ DeMari-, e –forse i Salvago- proprio il senatore N.Ronco).
È una delle strade più recenti, denominata dal Consiglio comunale il 30 settembre 1963. Appena aperta, divenne una appendice di via A.Cantore per cui nel 1964 divennero civici locali il 31 (poi demolito nel 1967),39,63.79.
Sotto la pavimentazione corre un torrente, opportunamente incanalato e rinchiuso in un acquedotto sotterraneo.
CIVICI sono continuativi, tutti neri; dal basso, salendo sino in cima.
2007 = dispari, da 1 a 73 (manca 23; compresi 29AB). Sono posti a levante della strada, quindi praticamente sarebbero tutti compresi nel territorio che -ai tempi del Vinzoni- era del Principe di Acquaviva
(i pari sono descritti dopo i dispari)
===civ. 1 è posto nell’angolo con via Cantore; la facciata finisce col 9 e i civv. rossi proseguono sulla facciata posteriore sino al 15 dove una sbarra chiude uno spiazzo adibito a posteggio auto accessibile anche dal cancello civ. 33 di via A Cantore. Nella parte più a levante di questo posteggio, una scala porta ad altro posteggio superiore raggiungibile a fianco della scuola. Infatti, a monte di questo spiazzo c’è una strada che conduce a dei box sotterranei, e –sopra essa- una terza che è a mare dell’Istituto e porta al retro di esso ove sono altri posteggi auto.
===civ. 29: il palazzo costruito nuovo nel 1967, ospitava la scuola che era stata fondata nel 1911 (era in via Pastrengo 6, con dirett. Babbini e Azzolini, si definiva ‘Moderna’, ed era Classico-Tecnico-Lingue-PraticaCommerciale, Stenodattilografia); nel 1922 divenne - “Istituto Palazzi tecnico commerciale e per geometri, e legalmente riconosciuta” (aveva tel. 459.405; aveva orari diurni e serali. Una succursale era anche in via A.Castelli, al civ. 6). Ormai chiusa da molti anni come tale, fu affidata ad un Commissario liquidatore (Vittorio Bazzani) della Compagnia Italiana di Assicurazioni spa. Nel 1998 il Comune avviò le trattative per acquistarne le aule e trasferirvi la scuola media “N.Barabino” lasciando libero il palazzo Doria-Masnata per le attività dell’Università della terza età. Ma le cose non sono andate tutte così; seppur negli anni ha ospitato lo stesso la succursale della scuola media.
Nel 2007 e 2011, è irrimediabilmente chiusa e abbandonata.
Al limite monte della facciata principale dell’ex scuola, c’è la targhetta di un civ.31 senza alcuna apertura di locale.
(Proseguendo via NRonco) come già detto, lo stacco tra il palazzo col portone 29 ed il palazzo successivo è costituito da due strade parallele separate da un muretto: nella strada più bassa, (per quella sopra, vedi al civ. 33) che costeggia la facciatga a monte della scuola, è lunga una ottantina di metri ed chiusa: all’inizio da una sbarra, e nel fondo da tre entrate: due, ai box di Gadolla sottostanti villa Ronco (che portano il civico 29A e 29B) e la terza, ancora nel 2007, è vasto un buco nel muro stesso chiuso da un cancello provvisorio, il:
===civ. 31 fu assegnato nel 1967 sottraendolo a via A.Cantore. É collocato in fondo ad una appendice della strada proietta ta verso levante. Un cancello chiude un’altra stradina in salita (dietro al palazzo successivo col portone 39) parzialmente asfaltata, che dopo pochi metri entra come in galleria sotto costruzione in cemento per salire alla villa, ma ancora solo a piedi. Infatti il materiale per ristrutturare la villa è sollevato con una alta gru, da dopo il cancello in su.
Villa DeMari-Salvago-Ronco= poco si sa dell’origine di questa possente villa: non la data di costruzione, né la proprietà e storia iniziale.
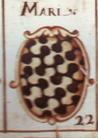
 la villa, da via A.Cantore
la villa, da via A.Cantore
La famiglia: antica famiglia risalente ai tempi di Pipino il Breve –anno 795- il quale fu da loro aiutato a sconfiggere i Longobardi, ricevendone il titolo di conte. Furono poi Consoli della Repubblica, ambasciatori, ammiragli (uomini d’arme e di mare=vedi lo stemma). Un ramo andò nel viceregno di Napoli prima del 1500 inserendosi quali banchieri, nel settore finanziario, e quali commercianti (grano, orzo, olio) acquisendo prestigio, titoli e crediti.
Viene poi citata nel X secolo quale facente parte del ramo Carmandino (o di Cremeno) , tra le Viscontili (o nobili per stirpe) traendo origine da navigatori divenuti potenti e riconosciuti mercanti, governatori, diplomatici.
Nel secolo XII divenne ghibellina ed acquisì uno stemma “d’oro a tre bande ondate nebulose di nero”. Ansaldo, il primo conosciuto, fu il maggior esponente politico-militare della famiglia; Andreolo suo figlio ed Arrigo nel XIII sec capitani (come Simone alla fine del 1300; Fabio, della galea ‘La Capitana’ alla battaglia di Lepanto). Seguiranno ammiragli (Ansaldo che ebbe la signoria della Corsica; Stefano al servizio spagnolo); 4 dogi (DomenicoMaria, 1797; Gerolamo, 1699; Lorenzo, 1744; Stefano, 1663 –anni della grande peste-); nonché religiosi, acculturati, patrioti.
*Tra i tanti, appare Stefano patrizio genovese, il più illustre del casato nel suo secolo, nato ca1530 da GB q.Giuliano –aggregato agli Usodimare- e da Mariettina Serra q.Paolo, morto l’11 gen.1592. Iniziò come capitano-proprietario di galee alla lotta contro i saraceni (due sue galee furono inviate a Lepanto), divenne politico locale essendo il più ricco della già ampia famiglia, avversario del Doria contro la politica filospagnola, mirando al dogato che non ottenne. Nel suo testamento, erede universale sua figlia Diana; destinò -1592- alla moglie Veronica Grimaldi «l’usufrutto delle residenze di Sampierdarena» perché poi divenissero di Diana ma, se non si sposava passassero a Ippolito, primogenito del nipote Francesco, che visse la rivolta antiaustriaca del 1747. Nessuno dei due, Diana e Ippolito, furono del ramo del principato di Acquaviva; quindi non interessati a questa villa.
Solo si sa per certo che la famiglia DeMari abitante a Genova, e che occupò stabilmente posizioni di vertice nel governo della Repubblica nel periodo compreso tra il XVII e XVIII secolo (dogi, governatori, ambasciatori) possedeva a Sampierdarena una villa, legata ad un fidecommesso.
La villa Attribuzione non sicura, proviene da un documento ritrovato all’ASG datato agosto 1633 e firmato dal notaio Gio Andrea Celesia; si leggono accordi di grossa fornitura tra il famoso architetto Bartolomeo Bianco ed il maestro ‘clavonero’ (specializzato in chiavi e serrature) Stefano Baiardo, per lavori da svolgere per conto di Agostino De Mari in San Pier d’Arena (considerato la grossa cifra di 737 lire ed 8 soldi, da spendere per 380 cerniere, 362 ganci, 211 serrature, 135 chiavistelli e 31 pezzi vari, se ne deduce che la grossa quantità fosse utile solo per l’arredamento di una villa da costruire).
Agostino De Mari, 1586-1645, nacque a Genova da Francesco q.Agostino e da Lelia Pallavicino. Nato in famiglia già di primo piano, socio–bancario-economico, nella nobiltà locale. Ascritto al patriziato nel 1608 (assieme al fratello Stefano, che diverrà doge), fu esponente di spicco, filospagnolo, della città, incaricato di mansioni ambasciatoriali (come la trattativa per Zuccarello con il duca di Savoia; e proposto in Spagna per Finale e per essere trattati da reali avendo eletto una Regina a capo dello stato), di magistratura e di Inquisitore di Stato. Sposato con la cugina Marzia DeMari, ebbe otto figli.
Appare improbabile abbia lasciato la villa ad un nipote (a Carlo, figlio del fratello e unico Principe della famiglia) e quindi è possibile che la sua residenza sampierdarenese sia un’altra. Considerato altresì che altra villa DeMari, fu acquistata dalla famiglia anche se già eretta ed arredata dai Doria (oggi Istituto don Daste) se ne conclude con riserva che l’accordo di cui sopra potrebbe riguardare questa ultima). Infatti le conoiscenze passano automaticamente all’anno.
1757 La carta del Vinzoni cita che la proprietà è del “Prencipe di Acquaviva” e fa comprendere ambedue le ville, questa e quella sottostante dei Doria, forse i primi proprietari).
Principe di Acquaviva fu Carlo I De Mari: figlio di GB, fratello di Agostino.
nato a Genova il 17 ott.1624 da Giambattista e da Paola Pallavicino. Continuò ad essere uno dei più rappresentativi del patriziato genovese nel settore mercantile-finanziario specie nel napoletano; prosecutore del padre nella giurisdizione feudale di due città in provincia di Otranto (feudi di marchesato, di Assigliano e Torrepiana; ma anche proprietario di terre in Molise, Abruzzo, Campania, Puglie; incaricato di pubbliche funzioni dalla Repubblica e da altre famiglie che avevano interessi nel meridione); ascritto alla nobiltà genovese si inserì pienamente nel ceto dirigente-finanziario gradatamente spostando le proprie attenzioni ed interessi verso Napoli. Infatti, nel 1664 risultando creditore di 35mila ducati dall’università di Acquaviva (Bari), quando fallì anche il collega finanziere principe genovese Paride Pinelli (ex amministratore della città) acquistò per 256mila ducati le terre pugliesi di Gioia ed Acquaviva messe in vendita dai creditori ricevendo così da Marianna d’Austria l’investitura di principe di quelle terre il 18 dicembre 1665. Il Dizionario dei Liguri cita solo lui dei DeMari con il titolo di principe: evidentemente i suoi eredi, seppur anche loro titolati, hanno avuto molto minor peso. Nel 1666 andò a stabilirsi ad Acquaviva ove morì quarantasettenne il 10 dic.1671. Aveva sposato Geronima Doria; ebbe unico figlio maschio GB Francesco (il quale avrà tre figli; tra i quali, Carlo II; quest’ultimo sarà designato dal nonno a ereditare i feudi –e quindi molto probabilmente anche le terre sampierdarenesi- essendo nel frattempo premorto suo padre GB. Ed è lui che verrà ascritto nella nobiltà napoletana appartenendo il nonno alla fase di transizione dal ceto finanziario a quello nobiliare).
Quindi, la generica titolazione del Vinzoni, fatta un secolo dopo la morte di CarloI va interpretata come proprietà di un erede, risiedente però nel suo principato a Napoli e quindi per lui non definibile personalmente. Ovvio che a un certo punto se ne siano disfatti (magari, dopo aver ceduto prima il terreno di sotto ai Doria; e poi questo con villa, ai Salvago).
18xx Dai DeMari, divenne proprietà dei Salvago, e da essi alla famiglia Ronco (vedi) non sappiamo quando.
1900 - inizi del, la villa si apriva in via s.Antonio civ. 28, subito a ponente del terreno antistante il primo ospedale, e la stessa villa Doria-Masnata. Era custodita da un fattore; tra essi viene ricordato il padre (venuto da Paveto a San Pier d’Arena per questo impiego) di Luigi Cambiaso (questi fu uno dei più forti polisportivi locali dell’epoca prebellica (dal nuoto al canottaggio, al pugilato, al tamburello ma soprattutto al calcio) ed instancabile dirigente organizzatore di società sportive nel dopoguerra.
1934 viene vincolata e tutelata dalla Soprintendenza.
Dal 1942, da loro è passata ad una società di un Gadolla (fratello di Gianfranco che negli anni 2003 è consigliere comunale del partito AN), che pur di disfarsene già aveva offerto l’uso gratuito dello stabile al Comune per usi scolastico-sociali (divenuti obbligo e vincolo da dopo la costruzione dei 300 box sottostanti).
Durante l’ultimo evento bellico, la casa fu danneggiata nella parte a nord-est e tale rimase a lungo in condizioni sempre più deteriorate finché non crollò parte del soffitto. Era immaginabile e temibile una passiva attesa di autodemolizione, visto l’abbandono, la improduttività e l’inutilizzazione pratica a qualsiasi interesse sociale o privato: già nel 1986, un sopralluogo degli assessori competenti concluse che ‘l’alto tasso di degrado della Villa, la rendeva inagibile a qualsiasi utilizzazione’; si parlò anche di usarla per uffici della Pretura. La situazione costrinse i proprietari, il Comune e la Circoscrizione (contrario solo il Consiglio di Circoscrizione nel nov.1988) ad accordarsi con l’impresario Gadolla (titolare della ‘Fortune spa’, e –non si sa da quando- nuovo ed ultimo proprietario dell’immobile) ed ottenere il rifacimento del tetto. La convenzione prevedeva il riparo dello stabile (per cederlo poi al Comune essendo destinato a ‘servizi’ (nell’antico piano regolatore era destinato ad ‘istruzione’). Un progetto richiesto all’arch. Spalla, destinava lo stabile ad asilo nido o scuola materna; ma la difficoltà di accesso ne rese disinteressante la realizzazione) in contemporanea concessione di costruzione nel vasto terreno dei giardini a sud della villa, di box -in un auto-silos- a tre piani (ne erano previsti 280, di cui 96 nel piano terra con uscita in via Cantore; 92 ciascuno negli altri due, con uscita in via Nino Ronco; il Secolo scrive siano 297; di essi 34 dovrebbero essere a disposizione della villa e raggiungibili da essa con scale ed ascensori).


Per la villa, nel 1991 si parlava di uso scolastico internazionale; o di casa di riposo per anziani. Il grosso e profondo scavo (iniziato nel 1992 e lievemente ridimensionato rispetto l’originale) obbligò l’eliminazione di grossi e vecchi alberi tipo cedri del Libano (alcuni di essi sono conservati ancora nella parte di giardino non demolita). Al loro posto, sul tetto dei box (un’area di 3000 mq circa), il CdC e C.Comunale avevano voluto fosse fatto un giardino pensile all’italiana. Progettato da Giovanni Spalla (autore del restauro del Ducale), il terrazzo fu riempito con 1 metro di terra per ospitare in 12 grandi aiuole fiori, cespugli e piante, e che dovrebbero essere curati dagli acquirenti dei box stessi; ed il tutto raggiungibile con un ascensore che si sappia mai entrato in funzione se non per pochi giorni iniziali (ipoteticamente per permettere l’ingresso a disabili, carrozzine, anziani): nel maggio 1998 -già in ritardo di due anni- si annunciava l’apertura al pubblico (solo per il giardino rifatto; la parte intatta, rimane di appartenenza alla villa) essendo prossimo l’accordo Comune-Gadolla sull’atto di asservimento (i proprietari dei box quale parte privata hanno da provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del parco e quant’altro necessario per la funzionalità compreso aprire e chiudere i cancelli).


Da allora e per un bel pò aleggiò il mistero della apertura in perenne rinvio -sicuramente problemi di sicurezza ed economia gestionale- finché annunciata ‘a giorni’, il 26 sett.1998 fu inaugurata ufficialmente dall’assessore comunale all’ambiente Chiara Malagoli. Ma l’apertura durò poco. A fine anno 1999 se ne interessarono anche i Lions Club di San Pier d’Arena, alla ricerca di una sede dopo aver dovuto abbandonare villa Pallavicino di via san Pier d’Arena, ma l’idea fu subito abbandonata non solo per il costo legato all’affitto o l’acquisto (si parla di sei miliardi e mezzo più tasse, nel 1993), ma per le spese necessarie per rendere abitabile l’edificio (vincoli CEE, norme di sicurezza, agibilità, collaudi, rifacimenti murari ecc.: e questo se è valso per loro, lo varrà per tutti i futuri interessati). Toccava ai proprietari una mossa intelligente; ma lontani come sono, presumibilmente non hanno attenzione a questo bene, che rappresenta un enorme spreco edilizio ed urbanistico ma un valore storico da salvaguardare.
. Nel dic.2001 nuova vampata di interesse, rimorta sul nascere. L’incuria, il degrado, il vandalismo ma soprattutto un esposto-denuncia degli abitanti interessarono il Consiglio di C (sig. Minniti Domenico) ed il questore (dr.Oscar Fioriolli), con conclusiva solita soluzione: chiudere.
Così nulla per il giardino, e nulla per la villa. Le varie amministrazioni coinvolte (proprietari, Gadolla, Comune, forse la Soprintendenza o più su i ministri), ciascuno nega personali responsabilità, tipo terra di nessuno, una patata bollente. Sergio Gadolla rende disponibile la cessione a titolo simbolico (considerato lo stato fatiscente, e l’obbligo all’uso per fini sociali) al Comune che però (ass. Claudio Basso) non può assumersi l’onere di un immobile da restaurare perché manca di qualsiasi elemento a norma di legge CEE e quindi costosissimo per le casse comunali (anche se poi il Comune spende per affitti di spazi per scuole, generose somme). E tutto -per noi- vola alto. Intanto, da lontano, notiamo che le persiane stanno cadendo a pezzi e qualche finestra è aperta ai piccioni ed a chiunque voglia entrare.
Nel 2002 la Regione (dietro un bando nazionale sul recupero noprofit delle strutture esistenti da utilizzare per nuove iniziative) aveva stanziato 13milioni di €. per le associazioni Liguri di volontariato, da distribuirsi a sorteggio tra le domande accolte (94; troppe: la cifra diverrebbe insoddisfacente per ciascuna) e gli aventi diritto (dapprima 16, poi 10, poi 6). Di questi soldi, 1milione fu dapprima destinato ad un Centro di Solidarietà da installare nella villa (asilo, scuola, centro assistenza ed aggregazione anziani; progettato dall’arch. Vittorio Grattarola, prevedeva 125mila e. per l’ acquisto, il resto più un mutuo per la ristrutturazione e gli arredi. Questo contatto rimarrà in stallo fino all’affidamento dei laviri, due anni dopo) ma alcuni consiglieri opposero contestazione, per presupposti errori illegittimi (non è chiaro se solo per onestà o contro il consigliere avversario o contro il Centro), tanto è che l’iniziativa non è rientrata nelle sei previste e quindi la villa restò disabitata, vuota ed inutilizzata.
Nel settembre 2004, riprendono i lavori di ricupero (preventivando 2.400.mila euro, di cui 70% dalla Regione e 3% da mutui e sponsor come la UE, Comune di Ge., Compagnia di s.Paolo, varie Fondazioni (Carige, Vodafone, s.Stefano, Unidea), assoc.Enel Cuore onlus) dopo che Gadolla è riuscito a vendere l’edificio per 120mila euro –non senza lo scoppiare un ‘caso politico’, essendo Gadolla esponente del partito A.N.-, alla Associazione “Centro di solidarietà” (onlus), della “Compagnia delle Opere”, abbreviato CdO e con sito www.cdoliguria.org braccio operativo di “Comunione e Liberazione”, detti pure ciellini o ‘papisti’ messi alla pari con gli integralisti cattolici (e quindi con avversari sociali, i laici e l’indirizzo repubblicano in genere), fondato nel 1986 da giovani che gratuitamente iniziarono ad affrontare i bisogni della vita (dal problema scuola –con ovvia preferenza a quella confessionale- a come trovare lavoro, fare amicizia, aiutarsi, organizzare il tempo libero, specializzandosi nell’accompagnamento-orientamento-formazione-educazione-inserimento dei giovani al lavoro). Grande impresa non profit gestita da politici di alto livello, specie della regione Lombardia il governatore Formigoni) e impresa del settore “no-profit”, che usa fondi europei (dell’obbiettivo2) erogati dalla Regione (l’onlus in Liguria ha 350 imprese associate che arrivano a 30mila nella Nazione), per creare un centro multifunzionale: assistenza a famiglia (compreso un centro adozioni ed affidi), giovani (compreso sostegno scolastico ed orientamento al lavoro (tipo ufficio collocamento in virtù di nuove leggi)), anziani e bisognosi. Si propongono un asilo nido (25 posti), un auditorium, giardino pubblico, banco alimenti, gli uffici dell’Avsi (Assoc.Volontari Servizi Internazionali, per cooperazione verso il Terzo Mondo) e del centro culturale Charles Peguy. Allo scopo lo spazio verrà ampliato con un salone nuovo di 180mq sul retro della villa.
Sbloccata la situazione burocratica, ripresero i lavori nel 2005 circa e nell’ago 2007 proseguirono i lavori. Un tabellone comunica: «Inserimento di Centro polifunzionale di assistenza alla famiglia». Lavori appaltati dall’ass. Beni culturali, «Centro di Solidarietà, della Compagnia delle Opere, della Liguria» della quale è presidente generale è Bernhard Scholtz, e locale Marco Castagnola; presidente del Centro dS. È Srgio Martinoia
I lavori sono eseguiti su progetto di ing.arch. Vittorio Grattarola &C, arch. Bandini Paolo; eseguiti dall’Impresa Saporito. Investiti 2.584.800 €, dei quali 1.809.360 della Regione Liguria. A fine 2007, rifatto il tetto ed intonacato le facciate, dall’esterno sembrerebbe ‘in ordine’. Infatti, i lavori di ristrutturazione sono stati completati nel 2008.
Il 31 maggio alla presenza del cardinale arcivescovo (il quale ha richiamato tre punti: generosità della città; risposta concreta alle necessità della famiglia; ricaduta sociale e delle più alte autorità istituzionali (C.Burlando, presidente della regione; A.Repetto presidente della Provincia; M.Vincenzi sindaco di Genova; P.Odone presidente della CdCommercio; D.Minniti presidente del municipio locale, ecc), è stato inaugurato. Il 6 giugno successivo viene definitivamente in funzione il centro polifunzionale di servizi alla famiglia chiamato “Villa Ronco” prevede: un asilo nido-+- un centro di aggregazione giovanile, specie per quelli a rischio di disagio, con proposta di un percorso educativo e di introduzione al lavoro-+- una ‘filiera’ integrata di servizi per l’azienda e la persona: disoccupoati, giovani, donne, stranieriu, disabili, deboli-+- un centro diurno per anziani-+- un centro famiglia, specie quelle adottive o affidatarie-+- uffici per i servizi alle imprese, ai soggetti non profit e alle persone). Con lo scopo –tratto da uno scritto di don Luigi Giussani”- di “una casa più abitabile per l’uomo” che renda visibile e possibile per tutti una novità di vita, di convivenza, di costruzione del bene comune; messa a disposizione per il quartiere di Sampierdarena. Pubblica una rivista trimestrale, titolata “Corriere delle Opere” con tema principale ‘lavoro e formazione’.
A fine maggio 2009 il CdO della Compagnia ligure, ha rieletto presidente Marco Castagnola. Egli ha presentato due prossime iniziative: una ‘scuola di imprese’ e la riedizione 2009 de ‘Matching’ ovvero studio del business che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 2000 imprese italiane ed estere.
L’edificio è a tre piani; uno a terra di 392 mq (più delle cantine sul retro), uno nobile, di 504 mq., con soffitti decorati da Tavarone; un sottotetto di 293 mq con soffitta di 31 mq.. Di volume rettangolare allungato, fu costruita nello stile tipico locale mescolando sapientemente ed utilmente lo stile prealessiano genovese con quello alessiano. L’ingresso principale era rivolto a ponente verso i giardini ( ricchi di nobili piante come i nespoli del Giappone, palme, alloro e grossi pini), sia dal piano terra, che dal piano nobile a livello del giardino più alto; il prospetto principale era invece quello rivolto a sud con le finestre tipicamente disposte: ravvicinate le tre centrali e lateralizzate le estreme, su una facciata che una volta era affrescata.
Gli spazi esterni coprono in totale 6mila mq. .
La proprietà si sviluppava a ponente di salita Salvator Rosa e confinava a nord con la proprietà Grimaldi (la villa dei Carabinieri) e ad ovest con la proprietà Cardinale. L’accesso partiva da via sant’Antonio al civ.24 (attuale via N.Daste), e con un lungo viale costeggiante il lato ponente della proprietà, arrivava alla villa posta anch’essa all’estremo ponente del terreno di sua proprietà; la parte a levante era invece tutta a fasce, con giardino, orti e frutteto. Attualmente una stretta e lunga parte di giardino è stata corrosa all’estremo est per la serie di abitazioni che si aprono su via Nino Ronco; la ex biblioteca Gallino ha ‘tappato’ il viale d’accesso; in salita inferiore S.Rosa altri palazzi hanno occupato parte dei terreni; così oggi si può accedere alla villa solo tramite via N.Ronco ed una porticina secondaria in salita S.Rosa, che deprezza la costruzione, impedita di ingresso adeguato alla sua importanza (perché Gadolla ha concesso questo scempio? a tutto prima, appare proprio il classico disgraziato, insensibile alla storia, all’estetica ed alla funzionalità).
A monte del muro che separa il civ. 29 dal seguente, c’è un tratto di strada più corto, che si infila (ha il civ. 33 e la scritta “Garage”) nella facciata a mare del palazzo successivo che inizia con -sulla facciata principale- il civ. 35 a cui segue nel centro quello del portone, col civ. 39 (due scale).
Il terzo palazzo della strada ha il portone civ. 63. Lo stacco tra il 39 e quest’ultimo, è diviso in tre stradine parallele che portano a box e garages dei residenti; così come anche lo stacco tra il 63 e l’ultimo palazzo (col portone n° 73 e che fu costruito per primo) che conduce a dei box.
La facciata a monte dell’ultimo è separata dalla appendice di corso Martinetti da un alto muro il quale però procede verso est (evidente confine della villa padronale sottostante oggi distrutta) ed arriva fino a salita Inf.S.Rosa affiancato da una grossolana scalinata fatta all’antica, con alti gradini in pietra, genericamente abbandonata.
____________________________________________________________
2007= civici pari, da 8 a 30 ( mancano 4 e 6; da 10 a 18). Sono posti a ponente della strada, nei terreni -in alto- del principe di Acquaviva ed -in basso all’inizio- del nobile Cardinale)
All’angolo con via ACantore è il civ. 2; il palazzo è separato dal seguente da un cancello che porta il civ. 8, preceduto da un residuo di muro antico che limitava la piccola proprietà sottostante del mag.co Cardinale (vedi via Cantore). Segue lo sbocco di via Adelaide Cairoli (vedi. É divisa in due parti, da un muretto e si prolunga nel retro del grooso palazzo che si apre in corso Martinetti, il quale nel retro –e quindi sulla nostra strada- inizia e finisvce con due bastioni a torre, estetivamente carini ma di non facile interpretazione architettonica). Via Cairoli è sempre stata separata da via NRonco da un muretto con sovrapposta una struttura mattonata; nel 2006 è stato ‘forato’, e sebbene sbarrato da un’asta, permette collegare le due strade per le auto (da via VCairoli uscire in via Ronco) e non ha civico.
 uno strano torrione ottagonale
uno strano torrione ottagonale
Lo stacco tra la nostra strada e questo palazzo prosegue verso l’alto, sempre delimitato dal muro che fa vedere - al di là - dei cortili privati dei residenti a piano terra di quel condominio.
Segue il palazzo –ex fabbrica di latta che si apriva in corso Martinetti- che è stato completamente ristrutturato a condominio al quale sono stati dati vari civici, 26 al portone e -per i box- da 20 a 30.
DEDICATA all’ingegnere, professore docente di idraulica alla scuola Superiore Navale di Genova, grande ufficiale, presidente del porto di Genova dal 1 apr.1909 al 14 ago.1922.
Nacque a Genova il 27 nov.1863 (da un patriota garibaldino laureato in legge, morto 22enne a Bezzecca prima della sua nascita); la madre lo educò all’ideale della patria, sentimento che lo animò per tutta la sua integerrima vita.
Laureato a Torino in ingegneria (Lamponi dice matematica); si scrive fu pure insegnante.


