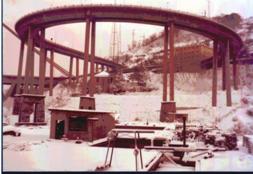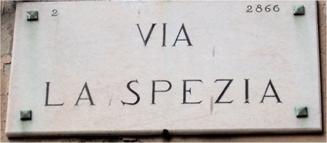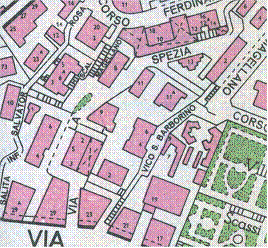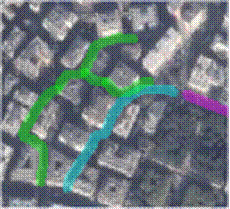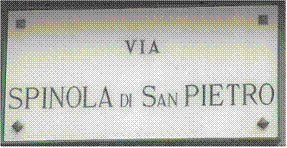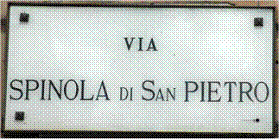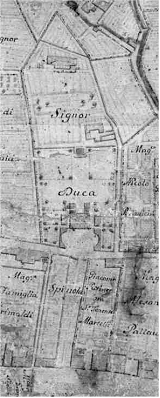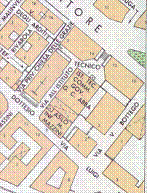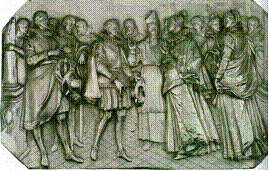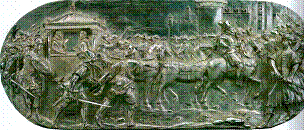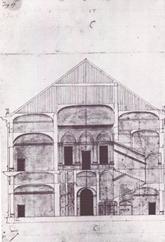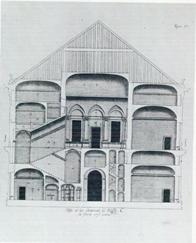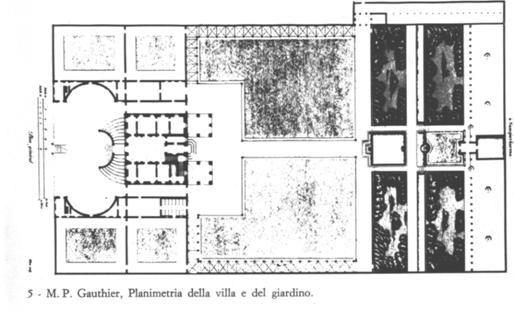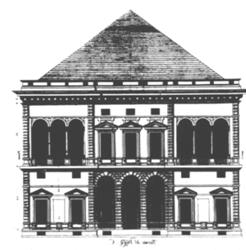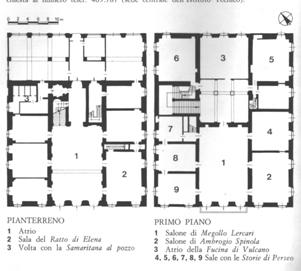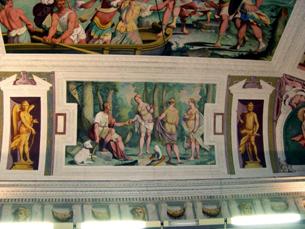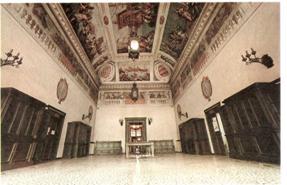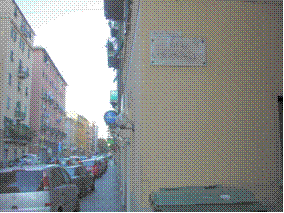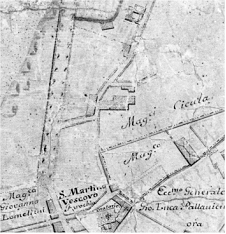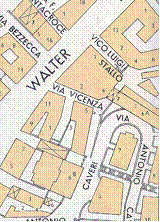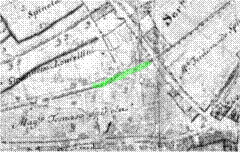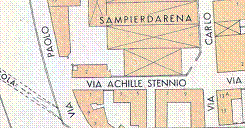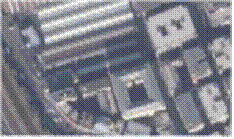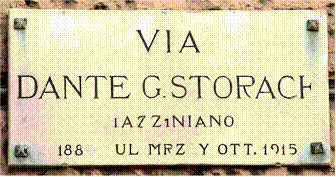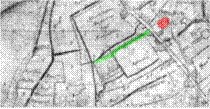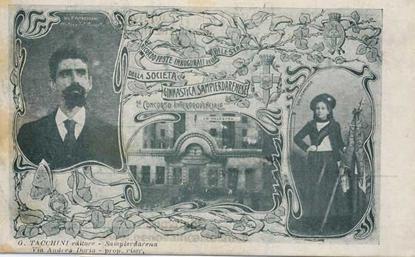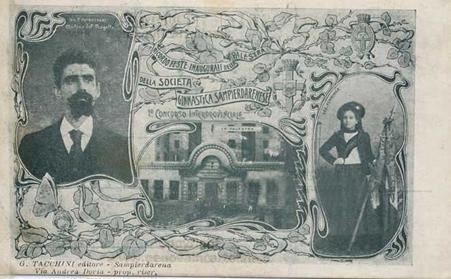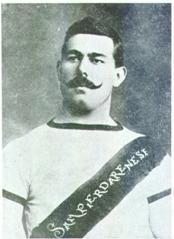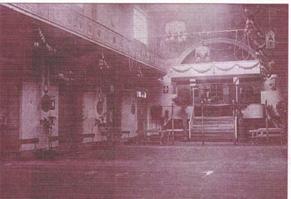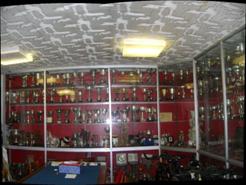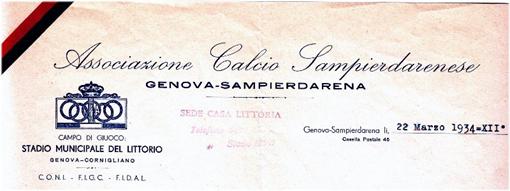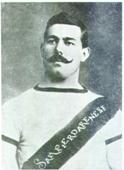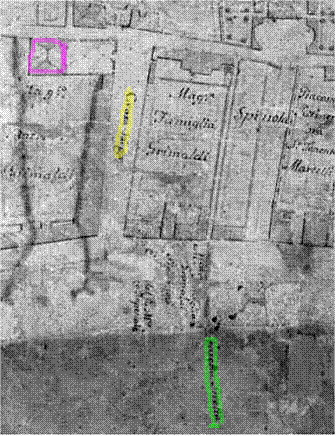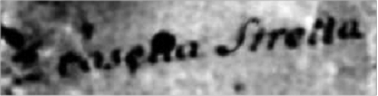SANTACROCE via Filippo Santacroce
 Dal Pagano 1961
Dal Pagano 1961
Procedendo verso Rivarolo, era la
traversa verso ponente, subito dopo via Bezzecca, dall’attuale via W.Fillak; chiusa. Adesso è un breve tratto
stradale di una decina di metri, che incrocia la laterale di via Bezzecca.
Prima però, ed ancora nel 1933
era ancora “via san Fermo” ed aveva alle spalle la fonderia.
Fu denominata ‘via Filippo
Santacroce’ con delibera del podestà del 19 agosto 1935.
Rimane inclusa nel Pagano/40 “da via
delle Corporazioni”; con un civ. nero 1, e uno rosso al 2r
s.a.eserc.fond.liguri Costruz.
Ancora nello stradario del Comune
dell’anno 1953 è riportata via Santacroce, col n° di immatricolazione 2845 ;
di 3.a categoria; “da via W.Fillak (chiusa)”.
La titolazione è stata soppressa
dal Consiglio comunale nell’aprile del 1960, in concomitanza dell’erezione dei
palazzi che ora in gran parte appartengono a via Bezzecca; ed incorporata nel
nome unico del partigiano Fillak; infatti l’unico portone esistente, nel
passaggio è divenuto civ.16A di tale via.
DEDICATA
allo scultore in legno, nato ad Urbino nel XVI secolo e di cui abbiamo notizie
solo da dopo il 1569 quando per interessamento del conte genovese Filippo
Doria, ancor giovane, fu inviato a Roma a scuola di cesello.
Divenuto abilissimo, lo steso
nobile lo accolse poi a Genova e lo occupò ad intagliare in minuto coralli,
gioie, avorio, diaspri, cornioli e legni duri; e per creare piccolissime
figure (famosi sono i volti dei dodici Cesari ed
una passione di Cristo, incisi su noccioli di susina).
È ricordato pure per intagli di
grande formato - detti “di giusta grandezza”, come statue e statuine da
presepio (rivestite poi con abiti cuciti
dalle figlie dei signori con i ritagli dei loro preziosi abiti); parti
di navi (fanali, scritte, polene; in
particolare sulla ”Capitana” di Giovanni Andrea Doria che partecipò alla
battaglia di Lepanto nel 1571); e casse processionarie delle quali è ricordata quella dell’oratorio di
sant’Ambrogio di Voltri Un atto (notaio Pellegro Pogliasca) del 1594 per
l’oratorio di Voltri, ritrovato dall’Alizeri, sottoscrive il patto da parte
dell’artista di “fabricare una cassa con santo Ambrosio a cavallo, di allessa
di parmi cinque e mezo, con il chierico di altessa di parmi tre e mezo e angeli
quattro (scomparsi)…”. In effetti – in una scelta ricca di personaggi in
atteggiamento di battaglia, rappresenta s.Ambrogio a cavallo che sconfigge con
una frusta gli eretic; anche il cavallo partecipa schiacciandone uno e
mordendone un altro che urla dal dolore. Dietro, due chierici apparentemente
estranei, aspettano invece l’esito sicuro dello scontro). Non si conosce il
coloritore. Ma si sa che nello stesso anno il pittore Agostino Piaggio colorì
un’altra cassa del Santacroce, scolpita per la stessa casaccia, rappresentante
il martirio di s.Bartolomeo, ma andata distrutta
Chiamato familiarmente ‘Maestro Pippo’,
i suoi cinque figli - chiamati Pippi, si dedicarono anch’essi con discreto
successo alla stessa arte: forse è loro il soffitto della sala del Maggiore
Consiglio in palazzo Ducale.
Di tutti più famoso fu G.B.,
nipote in quanto figlio di Matteo.
Morì a Genova nel 1607.
Artisticamente rientra nel
complesso panorama della scultura lignea cinque-secentesca, caratterizzato da
un elevato numero di artigiani-artisti, noti più attraverso le carte,
documenti, contratti, che per le poche opere superstiti.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-.Toponomastica, scheda 4035
-AA.VV.-Scultura a Genova e in
Liguria-Carige-vol.I-pag.389.391-3
-Enciclopedia Motta (dice morto
nel 1609)
-Genova rivista municipale :
8/37.34
-GrossoO-Le Casacce e la scultura
lignea..,-Goffi.1939-pag.31
-Montaresi M.-Genova, dal borgo
alla città-Erga.1990-pag.159
-Pagano ediz./1933-pag.230--/40-pag.401;
1961-pag. 379.446.quadro 72
-Stradario del Comune di
Genova-ediz.1953-pag.159
non citato da Novella+Vigliero+
ESonzogno
SANTO CRISTO
crosa Santo Cristo
Una crosa con questo nome viene
citata nel regio Decreto del 1857, quando si volle definire quella parte della
“strada superiore” o interna (il lungo
serpentone costituito da via De Marini (oggi, compreso via L.Dottesio), via sant’Antonio e via Mercato (oggi via NDaste)) nel momento in cui essa andava a
proseguire verso il ponte sul torrente Polcevera.
Il decreto, come limite alle
singole parti della strada, pone dei nomi di proprietari delle case che – a
quei tempi - dovevano essere conosciuti dai più: così ‘via Mercato’ andava da casa Monticelli, angolo con via della Cella fino alla casa
Ferrando e fratelli Morasso, poste alla biforcazione con l’inizio sia
della ‘crosa santo Cristo’ che quella di ‘san Martino’.
Infatti, di queste, la prima casa
(Serra-Monticelli-Baselica) è la villa
posta nell’angolo tra via N.Daste e via della Cella; la seconda (Ferrando) era all’altezza di via A.Scaniglia, quindi l’ultima di via
Mercato; i terzi (fratelli Morasso) avevano
casa vicino all’Oratorio dei Morti quindi nei pressi di via Alfieri.
Ma secondo la mia interpretazione
non è mai esistita una simile crosa; e corrisponde alla cattiva lettura della
“crosa san Cristoforo” (attuale via A.Scaniglia), per la quale l’estensore della legge erroneamente
abbreviò il nome (un lapsus di scrittura)
che favorì l’errore di interpretazione.
BIBLIOGRAFIA
Archivio Storico
(NB. il decreto, riportato sul Secolo XIX senza nessuna
ulteriore spiegazione né firma del ricercatore, è irreperibile come originale
sia all’Archivio di Genova che a quello di Torino; ed a me pervenuto come ritaglio
denza data di uscita del giornale)
SAPONIERA piazza della Saponiera
LA STRADA.
Citata solo dal Gazzettino S., riferita ad un avvenimento occorso l’11.03.1817.
Il giornale racconta infatti che gli abitanti del borgo vennero avvertiti dalla
municipalità francesizzante di una distribuzione di pane alle ore tre dopo il
mezzogiorno nella piazza su citata, e con la raccomandazione di presentarsi in
tempo poiché dopo quell’ora le porte della piazza sarebbero state chiuse e non
ci sarebbe stato più ingresso.
Nessun altro libro cita questo
nome e nessun altro l’avvenimento. Per una localizzazione, si potrebbe
allacciare alla crosa dei Buoi: per fare il sapone occorre il grasso o l’olio:
essi potevano arrivare via nave, ma potevano anche essere raccolti in una zona
locale di macellazione che però nessun testo riporta.
Concesso che quest’ultimo sia
vero, è accettabile che il nome della
piazza fosse popolare e tale da
essere conosciuto dai più; di conseguenza -molto presumibilmente- lo doveva in
merito ad una delle numerose fabbriche di sapone, forse più grossa e
rappresentativa delle altre.
All’erezione della ferrovia, e
con l’espansione dell’Ansaldo, una conosciuta fabbrica di sapone era in
attività alla Fiumara; ma non sarebbe stato logico riferirsi ad essa per il
nome del titolo in trattazione, perché in zona decentrata per una distribuzione
di pane alla popolazione.
Evidentemente fa parte dei
nominativi non ufficiali (ché - a quei tempi - non esistevano ancora targhe
comunali, e solo le strade più importanti avevano un nome - decretato dall’uso -
e non dalla ufficialità), e legato ad una denominazione di comune conoscenza,
di qualcosa (nel nostro caso uno stabilimento fabbrica di sapone) ritenuto
punto di riferimento generale.
DEDICATA
Saponifici sono citati dal 1700 in quantità fino a 25-30 per tutto il borgo,
con un totale di 50-60 operai. In quel secolo, l’industria del sapone era
monopolio dei liguri.
Si descrive che il nome sapone
derivi dal dialettale toponimo Savona.
Ma, come spesso accade, l’avidità
del guadagno e la non capacità imprenditoriale genovese fecero precipitare
questa tradizionale produzione: sopratutto, inventare variazioni lì per lì
economicamente vantaggiose, quali l’aggiunta di talco, steatite, barite, ecc.
Della fine del 1500 sono editti
mirati - con pene pecuniarie pesanti - a frenare le frodi, che coinvolgevano
anche le altre produzioni – in primis la seta che per legge non doveva essere
“insaponata con la feggia” altrimenti “si dava cattivo odore al panno e non
poco pregiudizio alla tinta“; la punizione era pecuniaria (£.200, restituzione della somma percepita ed una
inabilitazione all’esercizio per un periodo di tempo stabilito dai
prestantissimi Magistrati”); ed il tintore che avesse egualmente usato tale
sapone adulterato, sarebe incorso nelle stesse pene.
Il sapone doveva essere “della
bontà dovuta” e non con le seguenti misture “olio, bratta, soda mischia con
calcina” (la soda e la calce costituivano
lisciva la quale veniva mescolata con la bratta a formare il sapone adulterato).
I francesi di Marsiglia e gli
inglesi, ebbero alcune sagaci e vincenti capacità: modernizzare gli impianti
(con ovvio minor costo alla base); inizialmente non modificare la purezza del
prodotto; imporre dazi alti all’importazione – escluso il mercato dell’olio a
dazio zero di importazione - e trovarne - bassi per i saponi e alti per l’olio
- alla nostra frontiera. Con queste caratteristiche, soppiantarono il mercato
ed il nome internazionale. Una volta acquisito il ‘business’, anche loro
adottarono le alterazioni qualitative (soprattutto
il talco) spaccialdole per miglioramento commerciale salvaguardando il
nome ‘di Marsiglia’.
Inizialmente i nostri
produttori trovarono sfogo esportando nell’America (USA
e Perù, sopratutti); e tutto funzionò con guadagno, finché anche loro
non sbarrarono l’importanzione alzando i dazi.
La lavorazione del sapone si
allaccia all’importazione ed alla lavorazione di olio d’oliva (e tutti i derivati estratti dalle grane oleose),
soda (quella caustica, necessaria per la
produzionbe di certi saponi, era più conveniente importarla dall’Inghilterra
che produrla a casa nostra) e legname necessario per i fuochi; ed alla
produzione delle candele steariche (anche di
queste la nostra città era fiorente, ma vessate da leggi che ne impedirono la
prosperità).
Continue dovevano essere le
difficoltà operative perché -in genere- piccole industrie, monofamiliari,
carenti di operai e quindi di mercato, essendo il nostro interno invaso dai
prodotti inglesi malgrado fossero meno puri (usavano olio di palma e di cocco,
resine grasse).
Eppure, dalla relazione
dell’ing. Oneto del 1876, l’industria locale del sapone è citata al terzo posto
(dopo la meccanica e gli zuccheri); e la città quantificata ‘il punto più
importante d’Italia’.
Cronologicamente, nella storia
industriale-artigianale locale, si inizia a parlare di saponifici
nei primi anni del 1800; in particolare, il 1838 segna inizio di significativa
ascesa produttiva generale:
1830 (vedi in San Pier d’Arena)
1840-70 (idem);
1841 esistono sul territorio ben
30 fabbriche e 50 addetti;
1847 esistevano nel borgo ben 25
fabbriche di sapone, che davano lavoro a 57
operai; erano numericamente oltre la metà dei saponifici liguri;
1850 (vedi in via Daste e San
Pier d’Arena); 1869 (idem);
1863 sempre 30 fabbriche ma 100
operai;
1868 24 fabbriche con 65 operai;
1876 dalla relazione dell’ing.
Oneto, l’industria locale del sapone è citata al terzo posto (dopo la meccanica
e gli zuccheri); e la città quantificata ‘il
punto più importante d’Italia’. Vengono citate come ‘primeggianti’ fra tutte
(perché capaci di produrre tutte le qualità e tutte le quantità) la ditta
Oneto Agostino & C.; ditta Giacomo Canale; ditta Smith; ditta J.Meyer (posta –nel 1890- in via Garibaldi, 14° - di fianco
alla Oneto, dove oggi è ENEL); ditta
L.Traverso
1880 inizio di ripresa
Dei produttori, vengono citati
in particolare:
=Oneto
Agostino 1889-1902 (una
delle due è scorretta=sarebbe vissuto13 anni; G23 25) Titolare –se non esistono omonimi-. Forse preceduto
da -Francesco 1868 e seguito da -Luigi 1901 (SA30).
L’azienda, ‘ditta Agostino Oneto &C’ posta in via
Garibaldi 14 (via
A.Pacinotti; dove è l’Enel) smerciava
sapone comune (uso industriale e domestico per toeletta) in America ed in
Europa conquistando mercato (per il sapone palmitico-resinoso) una volta
esclusivo dell’Inghilterra.
Nel
1875 prevedendo ultimare un locale a
tramontana del fabbricato principale prospiciente via Garibaldi presentò in
quest’anno al sindaco il progetto (ripresentato nel 1890) degli ing. Salvatore
Bruno e Luigi Macciò prevedendo un nuovo impianto ferroviario con scalo merci,
allacciamento al porto e raccordo con la linea di Torino al fine di
decongestionare il traffico su rotaie divenuto caotico e convulso a livello di
s.Benigno. Nel 1876 occupava 60-70 operai,
produceva mille q./mese, viene citata come ‘primeggiante’ fra tutte le
industrie locali perché capace di produrre tulle le qualità di merce, ed in
tutte le quantità. Lo stesso Agostino, ingegnere, diverrà consigliere
comunale nel 1882; e la sua carta da lettere
–ai due lati del nome- riportava un disegno di un veliero da una parte e di un
pezzo di sapone dall’altro.
In
quegli anni in via Gioberti al civ. 13 compare una non meglio specificata ‘opera
Pia Oneto’ che nel 1902 ritroviamo proprietaria del civ.13 di via Gioberti.
Nel
1902 l’azienda compare aver uno dei primi
telefoni, col n. 815.
Nel
1925 l’opificio venne scalzato dall’OEG che
progressivamente allargò gli spazi,
sacrificando il saponificio Oneto e buona parte delle scuderie di Carpaneto.
Oneto Luigi ( -1923)
Molto probabilmente è lui che, impegnato nel sapone ed amante della vela, aprì
sulla spiaggia un piccolo cantiere per barche a vela destinate soprattutto
all’hobby delle regate (che allora stava
nascendo anche in Italia: in Inghilterra ed USA era da 50 anni che esistevano
le regate, quasi tutte per scommesse); ed
è a lui che il com. DeAlbertis si rivolse nel 1876
circa per costruire una prima goletta,’ Violante’, 12 metri circa, varata non
ad uso mercantile come erano tutte sino ad allora, ma per crociera o diletto (stiva adeguata allo scopo, con maggiori comodità e
raccolta di frutti di raccolta di ricerca scientifica: minerali, fotografie,
scoperte, costumi, maschere, vasi, ecc.).
E
sempre a lui, per progettare nel 1893 uno
yawl di 25,5 m, costriuito poi a SestriP, chiamato Corsaro, partito da Genova il 3 giugno 1893- dopo sosta a
Cadice- il 22 iniziò la traversata dell’Atlantico impiegando, 27gg e 22h x
3850miglia, per arrivare a san Salvador e poi trasferirsi a NYork
Alla
fine del 1800, con l’introduzione dei
motori, poco a poco furono smantellate tutte le barche a vela (dei Leverato,
Fossati, Bertorello); fu allora che Luigi ebbe l’intuito di ricuperare le
imbarcazioni a vela per farne regate. Pioniere, fece di SPdA il fulcro iniziale
di tanti appassionati (e poi valenti campioni in maestose regate al largo della
nostra città), dello Yachting Club nazionale e del Club Nautico Sampierdarenese
(nato nel 1901) dei quali l’Oneto fu il
fondatore. Così unì al mestiere di industriale la passione nautica che lo portò
ad essere il disegnatore e forse anche armatore di yacht da gara, più noto e
famoso anche all’estero. I velisti sampierdarenesi, sia come conduttori che costruttori (assieme a Luigi Oneto, si
ricordano Gilberto Pestalozza e Nicolò Russo) oggi sono sfumati nel nulla, ma
in quegli anni di primo secolo, erano fonte di gloria e di orgoglio cittadino,
vissuto con la stessa intensità di una vittoria oggi della squadra di calcio
del cuore, specie nell’edizione annuale della “coppa Città di Sampierdarena”. Tra le 19 imbarcazioni più famose da lui ideate
troviamo il ‘Violante’ ed il ‘Corsaro’ che portarono in tutti i mari del mondo
il cap. Enrico D’Albertis. Morì ottantenne il 13 agosto 1923 nella sua ‘villa Remondina’ a Serravalle ---
Il
“Giornale di Genova” del 29 ago 1935
conferma che Oneto Luigi era proprietario di un grande e floridissimo
saponificio (non sappiamo se parente –fratello- di Agostino) e che per riposare
veleggiava davanti alla spiaggia.
=Oneto Francesco nel
1868 al civico 3 di via CColombo, che aveva inventato e fabbricava “un
nuovo sapone giallo ad uso inglese”; nella strada aprì una rivendita.
=Canale
Giacomo citato 1876-
grosso esportatore in Sardegna malgrado la
concorrenza di Marsiglia. Nel 1889 risultano
‘fratelli Canale’.
Ed altri, in ordine
alfabetico:
Barabino
Gerolamo (via Colombo); Beerle A&C nel 1900 (via Colombo);
Casanova Salvatore (via Colombo); Castello Vitt. 1889; Castello Matteo fu GB;
Casanova Salvatore; DeMarchi Gerolamo (A74); Galleano Tomaso; Galliano Pietro; Leverato
Stefano (via Gioberti); Lombardo Giov.1889 poi Lombardo f.lli 1900 (via Daste);
Meyer Isidoro 1889; Morgavi AE 1925 (via
T.Grossi); Montano Nicolò 1908 (via Colombo- p.zza Montano);
Morasso Luigi (via Bombrini - PA5); Moro flli (via Colombo); Paita 1889; Pavese
(via Garibaldi); Premuselli frat. 1889; Queiroli-Calvi; Romairone
Giuseppe (via SPdA) ed un Romairone frat.di Agostino; Sasso (vedi sotto); Smith;
Traverso Luigi; Tubino Salvatore (via
Bombrini PA154)
BIBLIOGRAFIA
-Gazzettino Sampierdarenese:
2/94.7
-Lunario del signor
Regina-Pagano.1899-pag.541
-Oneto A.–industrie in
Sampierdarena-Rivista Marittima-febbr.1876-p.334
-Pagano (da ricercare nelle varie
annate)
-TuvoCampagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore1975-pag.190
SASSO via privata Sasso
Corrisponde all’attuale via Gioberti, prima che le dessero
ufficialmente questo titolo, e quando invece popolarmente veniva indicata per
lo stabilimento (oleificio?) omonimo che si apriva nella strada.
Rientra, e quindi già presente ed
indicativa, nelle strade riconosciute dal regio decreto del 1857, che per la
prima volta nella storia cittadine fornisce una prevista nomenclatura delle
strade principali.
Il fatto che fosse “privata”,
sottolinea l’uso limitato allo stabilimento; seguendo l’usanza di allora di
indicare le strade neoformantesi in rapporto all’oggetto popolarmente più
facile a conoscersi, e significativo per indicare la zona.
È probabile quindi che la
titolazione, rimossa da questa strada centrale, l’abbiano solo spostata in zona
Fornace.
DEDICATA , presumo, al titolare
dell’oleificio (o saponificio) Sasso (vedi via GB Sasso).
Omonimi,
ma l’azienda si chiamava”fratelli Sasso’, gli imprenditori che avevano aperto
nel 1889 nel quartiere san Martino una fabbrica di pallini e di tubi di piombo,
ed ancora erano attivi nel 1930. Considerato il numero della manodopera
occupata nell’oleificio, e la concomitante presenza nella strada dello
stabilimento oliario, è più probabile sia per quello descritto in testata.
SASSO via
G.B.Sasso
TARGA:
S. Pier
d’Arena – 2846 – via - G.B. Sasso – industriale sampierdarenese – 1840-1914
Via – G.B.
Sasso – industriale sampierdarenese – 1840-1914


angolo con
via P. Cristofoli


angolo con
via N.Ardoino
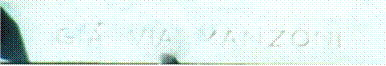
QUARTIERE
MEDIEVALE: san Martino
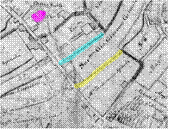 da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni
Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.
da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni
Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2846 CATEGORIA: 3


da
Pagano/1961 da Google
Earth 2007. In giallo, via Arduino.
CODICE
DELLA STRADA - N° INFORMATICO 56500
UNITÀ
URBANISTICA: 25 - SAN GAETANO
CAP: 16151
PARROCCHIA:
s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: senso
unico viario da via P.Cristofoli (Google=fucsia) a monte dell’incrocio via C.Rota
(Google=celeste), a via N.Ardoino (Google=giallo).
Da
accesso alla salita di “scalinata dei Landi” (Google=rosso).
E’
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
Ne
Il Secolo XIX/ 03 e 04 si legge che è stata inclusa nell’elenco delle ‘vie
private di interesse pubblico’ e quindi programmata a divenire municipale con
passaggio gratuito, per usufruire di manutenzione e dei servizi generici quali
fognature, spazzatura, illuminazione, asfaltatura ecc.
STORIA: sino al
1900, il terreno era proprietà Durazzo Pallavicini, curato a prato e orti.
In
una carta del 1890 si dimostra che -stante una ‘fame’ di alloggi popolari assai
pressante- .tutta la zona fu lottizzata ed ogni imprenditore, nel suo terreno,
poteva costruire con ottimi profitti.
Nel
1905 via Cristofoli era appena tracciata; e anche la nostra strada, allora
aveva in erezione i palazzi che poi la hanno delimitata: durante la loro
erezione era quindi ancora solo un anonimo camminamento privato, usato dai
muratori.
Al
suo compimento fu intitolata via Alessandro Manzoni (e tale era ancora nel 1933, di 5.a categoria, con
civici sino all’ 1 e 10, e che collegava via P.Cristofoli con via
C.Cattaneo =N.Ardoino).
Con
delibera del podestà, il 19 agosto 1935 fu denominata ‘via G.B.Sasso’.
CIVICI
2007-NERI
= 1 e da 2
a 10
ROSSI= da 1r a 13r (compresi 7F e 9AB) e da 2r a 20r.
===Nel
Pagano/40 esiste “da via P.Critofoli a via C.Cattaneo” ed ha solo civv. rossi 1 fruttiv.; 3 latteria; 5 vini; 8
ottoniere; 11 lavor. latta Fossati Giaconmo; 11 fabbr.cornici Bocci Ernesto
===Nel
Pagano/1950 è citata
solo al 5r=una osteria, di Ivaldi Maria; non bar
né trattorie. Il quello /1961 i numeri
rossi vedono: 1r=fruttivendolo; 3r=latteria; 4r=calzolaio;
5r=osteria; 8r=ottoniere;
11r =lattografia Fossati&C; 12r=carrozziere; 14r=ORLEM
officine elettromagnetiche; 16=panificio
===civ.10 (Nella curva) abitava la famiglia in cui è cresciuto
Natalino Codognotto, più noto come Natalino Otto,
cantante sposatosi 1955
con Flo’s Sandos (Mammola Sandon); e con lei ebbe una figlia, Silvia. Era nato
a Cogoleto nel 1912 penultimo di cinque; e trasferito qui all’età di tre anni
col padre ansaldino. Da bimbo fu affetto da polio, che guarì lasciandogli un
lieve handicap nel camminare. Andato tredicenne a lavorare in una officina, già
era bravo a percuotere una batteria e ritmare i tempi delle canzoni in voga.
Meno pesante fu il secondo lavoro di sarto; ma il balzo fu l’offerta -1935- di
suonare –e poi anche cantare- sul Conte Biancamano, durata due anni. Durante il
conflitto continuò a cantare in compagnie di varietà e con Gorni Kramer che lo
lanciò in alcune incisioni che permisero di farlo conoscere in campo nazionale
e cantare nelle migliori orchestre (Semprini, Mojoli, Kramer ecc.). Il suo
stile era lo slow, il ritmo lento, al limite quello moderato. Morì precocemente
per cardiopatia nel 1969
===civ.11r c’era
negli anni 1950-60 lo stabilimento di lavorazione della latta (recipienti,
scatole, ecc) e della relativa litografia di Fossati
Giacomo e f.lli, con sede anche in via U.Rela. Nel 2008 c’è un
gommista.
Il
piccolo edificio è – nel retro – strettamente collegato alla linea ferroviaria
che dal porto va al Campasso. Negli anni dell’ultima guerra, era di transito
durante gli allarmi per scappare in galleria.
È
punto di interesse qualora la linea potesse diventare metropolitana
di ponente, quale punto di fermata intermedia.
===civ.13r dagli anni
2000 esiste una moschea, luogo di culto musulmano.
DEDICATA ad un
industriale, presumibilmente concittadino, ma di incerta definizione sociale.
Nel
1889 compare Consigliere nella giunta comunale locale guidata dal sindaco
Dall’Orso Pietro
Il giornale politico-amministrativo ‘La Ragione’
pubblicato a San Pier d’Arena nell’ anno 1890 nel numero di luglio sostiene la
candidatura di un Sasso GB industriale per le elezioni amministrative del
giorno 20 (assieme a Giovanni Bombrini, Carlo Orgero pittore, Natale cav
Romairone (direttore della Cassa generale) e
Lazzaro dr Canessa).
A) forse è lo stesso che
impiantò in via Gioberti, a ponente dalla neonata strada, uno stabilimento per
la lavorazione dell’olio di oliva e/o saponificio.
Appare il
più probabile perché combacerebbe tutto, escluso -ma fondamentale- il periodo
di vita delimitato dalle due date sulla targa. Alcune carte della ferrovia del
1847-50 (quando il titolare avrebbe avuto 7-10 anni) citano un Sasso Emanuele
fu GB quale proprietario del terreno a levante della crosa sant’Antonio (poi divenuto vico stretto sant’Antonio), esteso dalla “strada comunale interna” (via N.Daste) alla “strada Reale”
(via Sampierdarena - sulla quale si apriva la casa di proprietà) e coltivato ad
orto. Quindi è probabile che il Nostro sia un omonimo, ma nipote del vecchio
GB, e figlio di Emanuele: allora usava dare ai nipoti il nome di un nonno,
specie il paterno. Non si sa chi dei tre aprì lo stabilimento, ma probabilmente
il Nostro fu quello più famoso e che allargò con fortuna le sorti
dell’opificio.
Il primo GB, doveva già
essere un possidente, essendo subentrato proprietario del vasto appezzamento
di terreno -nel quartiere sampierdarenese detto Boraghero, subito a levante
della Cella-, quando la strada neanche esisteva; e prima che il tutto fosse
interessato al taglio -a metà- operato dalle ferrovie e dalla neonata strada
Reale -attuale via G.Buranello- nel 1847; in quella data , come già detto,
la proprietà era di Sasso Emanuele fu GB .
Cronologicamente quindi:
1°GBàEmanueleà2°GB).
B)
molto meno probabile, uno dei fratelli (non se ne conosce il nome) che lavoravano il piombo. Essi risultano presenti in città (allora
facente parte del 1° circondario di Genova) nel 1889, tra i “fabbricanti di
pallini e tubi di piombo” (vedi in via P.Reti).
Alla
data 1889 – a mie mani- nessun altro Sasso svolgeva attività industriale
neanche collegata al commercio. Negli ultimi anni del 1800 nessun Sasso abitava
in via Gioberti né in via C.Colombo allo sbocco con questa strada, ove doveva
esserci la villa del 1° Sasso GB.
Nel
1933 nel Pagano, unici Sasso in attività a Genova sono solo sempre quelli dei
pallini .
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica , scheda 4064
-AA-.VV.-Annuario
guida archidiocesi-ed.1994-pag.444; ed.2002-pag.480
-AA.VV.-Il
don Bosco nella storia urbana-DonBosco.1997-pag.61cartine
-Beccaria
R.-I periodici genovesi dal 1473 al 1899-Ge.1994-pag.490
-Bosio&Pastor&Rinaldini-il
Don Bosco-Algraphy1997-pag57
-Il
Secolo XIX del 23.08.04
-Lamponi
M:- Sampierdarena- Libro Più.2002- pag. 160
-Lunario
genovese del signor Regina-anno 1889-pag.541
-Pagano
–ed.1933-pag.247; /40-pag.404; ed.1961-pag.383
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio 1995- tav.22
Non
è citato in DoriaG.-investimenti e sviluppo…Giuffrè 1973
“
“ “ “ Oneto A.-industrie in Sampierdarena-1876-.
SAVOIA
piazza Savoia
Nell’anno 1900 - regnante da
questo stesso anno Vittorio Emanuele III dopo l’uccisione di re Umberto I - venne
proposta alla Giunta comunale di ufficializzare la titolazione alla piazzetta
facente parte a mare della via Cristoforo Colombo, e che popolarmente veniva
chiamata “piazzetta d’ingresso ai bagni Savoia”; dedicandola in omaggio al
nuovo reggente la casa regnante.
I bagni Savoia erano, di tutta la
spiaggia, decisamente tra i migliori e più curati, frequentati solo dall’élite
dei benestanti che potevano godere di un alto reddito e quindi di una migliore
gestione.
Nel 1910 piazza Savoia è inclusa nell’elenco stampato dal
Comune delle sue strade e piazze, localizzata ‘da via C.Colombo al mare’, con
solo il civ.1.
Nel 1927 la piazza è presente nell’elenco delle strade
presenti nella neonata Grande Genova, ed è classificata di 5.a categoria.
Nel 1933 la piazza era ancora
tale, e con un civico, il n.1.
Con delibera del Podestà, il 19
agosto 1935, venne cambiata la titolazione in “piazzetta
dei Minolli “ (vedi).
DEDICATA
L’origine della casa
Savoia si perde nell’oscurità del X secolo; ma già dall’XI secolo era tra i
potenti del mondo di allora con il conte Umberto I Biancamano (970-1048
circa), considerato il capostipite, e seguito -per 43 generazioni- da principi,
sempre regnanti o comunque dominanti, anche con diverse denominazioni: conti di
Moriana, di Savoia e di Aosta, duchi d’Italia, principi di Piemonte, re di
Sardegna, re d’ Italia.
La casa regnante in Italia
discende dai Savoia principi di Carignano. A Vittorio Emanuele I (1802), successero Carlo Felice (1821), Carlo Alberto (1831), Vittorio Emanuele II (primo
re d’Italia dal 1849), Umberto I (dal
1878), Vittorio Emanuele III (dal 1900),
Umberto II (nel 1946). Preferiamo tacere
sulle due generazioni successive, ancora viventi nel 2008, soggette a molto
discutibili e tendenzialmente squallide notizie di cronaca moralmente vicina al
nero.
La Savoia come regione, insieme a
Nizza, fu ceduta nel 1860 alla Francia in seguito agli aiuti forniti dai
trasalpini nella lotta antiaustriaca.
L’atavica bramosia di espandersi
e dominare i vicini, la Liguria in particolare con il conseguente ‘sbocco al
mare’, inficia gli ampi meriti acquisiti dai Savoia lottando sempre per l’
unificazione d’Italia, da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele III (Trento e Trieste tornarono alla madre patria sotto il
suo regno). Ma opportunamente alla storia fu bendato gli occhi stendendo
per anni una opportuna cortina di silenzio mirata a mascherare il metodo tirannico
usato per tenere unita la penisola e poi le colonie: la mano pesante verso
Genova si somma con quella sicula (il brigantaggio) e si sposa felicemente con
la violenza fascista.
La figlia di VE III (Mafalda 1902-1944) morta in un campo di
concentramento a Buchenwald, non controbilancia l’accumulo fatto dal re di tutta
una serie di tragiche scelte (accettazione del fascismo e del colonialismo,
della guerra, delle leggi razziali, della fuga all’estero) che offuscarono
pesantemente la sua immagine governativa.
La Repubblica - nata dopo il
referendum istituzionale del 2 giugno 1946 - nella sua Costituzione ha sempre
negato ai componenti maschi della famiglia la possibilità di rientrare in
Italia dall’esilio. Per anni si parlò di concedere agli eredi maschi della
famiglia reale la libertà di movimento (e con esso, anche del rientro in
possesso dei beni terrieri, e di quant’ altro, che era di famiglia nel
territorio e nelle banche). La legislazione in merito iniziò nell’anno 2002 ad
essere votata; e divenne effettiva alla fine dell’anno 2003- metà 2004.
Ma nei pochi anni a seguire,
sopratutti Umberto III si è macchiato di tali imbecillità delinquenziali, da
sclassificare completamente il suo titolo ed il suo casato.
Per una valutazione dei rapporti
di Genova con i re del Piemonte e della Sardegna, vanno distinti i periodi
separati:
---Prima
del 1815 La storia risale al 1390, quando il Conte Rosso faceva palesi pressioni verso il
litorale ligure.
Ricapitò nel marzo 1625
quando il duca Carlo Emanuele I°,
altrettanto ambizioso ed audace, alleatosi con i francesi
(seppur classificati ugonotti e propagatori di eresie) si mise in marcia
da Asti per arrivare a Genova (28mila uomini di
cui 650 a cavallo, con 24 cannoni,15 colubrine e pezzi da campagna trainati da
600 buoi) passando per Savignone: le sue forze si scontrarono con i
genovesi comandati da Battino Maragliano il 10 maggio sul monte Pertuso (ove poi fu costruito il santuario di N.Signora della
Vittoria), e furono sconfitte.
Ma i pruriti non furono sedati:
il Senato dovette ricorrere alla costruzione delle mura (1632) le
cui imponenti difese furono erette proprio contro le velleità di conquista dei
Savoia (è di quei tempi una poesia satirica intitolata “gabbada che fa il
gobbo di Rialto al gobbo di Savoia” in cui si pone in ridicolo il desiderio di
conquistare Genova).
=Vacchero Giulio Cesare, ricco
mercante fu allettato da promesse della corte dei Savoia e programmò una
rivoluzione contro la Repubblica; scoperto, fu giustiziato nel 1628 ,
ed i suoi beni immobiliari in via del Campo a Genova, rasi al suolo.
=facciata ovest palazzo ducale ***
===alleanza con austroungarici
nel Balilla***
Non si descrivono i mille e mille
microepisodi in riviera e lungo i confini, a testimonianza di un non minuto
malanimo ed acrimonia.
Peggio fu quando (1814)
con la Restaurazione la città perdette la sua libertà repubblicana: scomparsi i
francesi ed instaurato un Governo provvisorio, si esultò all’idea di un ritorno
all’indipendenza. Ma la realtà si presentò frustrante: il Piemonte lavorando
sotto sotto diplomaticamente aveva ottenuto che l’Europa gli concedesse la
Liguria (l’Inghilterra... tanto amica, l’aveva già promessa dal 1805); il 12
novembre 1814 a Vienna le otto potenze che ridisegnarono l’Europa aggiudicarono
Genova al Piemonte malgrado la chiara volontà di non accettare l’annessione.
---Dopo
il 1815
È Legge internazionale che uno
Stato per annettersi un territorio, è indispensabile proponga un plebiscito; e
così fu per i vari ducati (Modena, Parma,
Toscana) e regni (Borboni e Papato);
escluso per la Liguria, perché mai nessuno firmò né votò la accettazione di
quanto stabilito dal Trattato di Vienna.
Il 7 gennaio 1815,
regnando Vittorio Emanuele I (Torino, 24.7.1759-Moncalieri 10.1.1824
secondogenito di VittorioAmedeoIII. Personaggio tendenzialmente pavido e
contrario ai principi della Rivoluzione francese, apparve senza aspirazione a
governare, titubante nell’affrontare la patata bollente delle popolazioni in
sommossa (a partire con i moti del 1821)).
Al congresso di Vienna, ebbe con Thaon DeRavel la presa di possesso del
territorio ligure, instaurando un soffocante regime assolutistico (abrogò i codici napoleonici, ripristinò la
legislatura prerivoluzionaria, riaffdò l’istruzione ai sacerdoti, discriminò
ebrei e valdesi).
Genova, allora abitata da 80mila
persone, fu per il re proveniente dalla Sardegna, una debacle di prestigio e
cocente umiliazione con una fredda accoglienza, ‘senza entusiasmo e con non
poco broncio’ da parte delle autorità e della popolazione. Un famoso quadro di
Felice Guascone ne fissa l’immagine dolente ed indifferente, quando venne a
Genova insediando una guarnigione di settemila soldati (un decimo della popolazione) chiaramente finalizzata alla
repressione.
Il 12 marzo 1821 il re di
Sardegna abdicò in favore del fratello Carlo
Felice ultimogenito (di quattro figli di
Vittorio Amedeo III. In un periodo (1815-1845) in cui tutti i servizi si
erano azzerati, la situazione economica era divenuta drammatica, il porto
praticamente inattivo, l’analfabetismo al di sopra del 50%, all’improvviso, si
aggiunsero iniziative e traffici bloccati da una politica piemontese
protezionista delle proprie finanze ed una pressione fiscale nuova ed
esasperata; nonché l’asservimento ad un Palazzo lontano, diffidente,
inizialmente disinteressato ed altezzoso.
Sposo di MariaCristina Borbone.
Fu definito “re triste”, snobbato dai sudditi diretti perché taciturno e con
forti aspirazioni religiose; ma caparbio lo fu da subito quando rientrato a
Torino da Modena ove era al momento della nomina, in pochi giorni disfece la
“fuga in avanti” portata dal reggente CarloAlberto che aveva concesso la
costituzione ed una giunta di governo. Affrontò con fermezza la ribellione di
Santorre di Santarosa, si oppose ad ogni apertura, favorì solo l’aspetto
finanziario, la lotta ai pirati e la giustizia. Così mal sopportato ed
impopolare anche a Torino, divenne forse un po’ coccolato dai genovesi per i
quali nutrì una particolare sensibilità (patrocinò il teatro, inaugurato il
7.4.1828 con un’opera di Bellini) non ricambiata perché alla cerimonia, la
nobiltà preferì eclissarsi anticipando la villeggiatura.
Un decimo della popolazione era
divenuta e classificabile ‘povera o addirittura mendicante’; la mortalità infantile
arrivò al 40% e quella generale ai vertici del sopportabile (nelle epidemie del
1854-5 morì il 70% dei ricoverati: 3504 su 5032).
A peggiorare i rapporti col
Piemonte, ci fu Lamarmora (1849) quando soffocò, per ordine del
neonominato re di Sardegna Vittorio Emanuele II
(Torino 14.3 1820-Roma 9.1.1879), i moti
popolari genovesi, nel modo più crudele, suffragato dallo spregio dello stesso
re che chiamò i genovesi ‘vil razza dannata’; e quando per sua rabbia si
dovette subire l’onta dell’abbassamento della coda dei grifoni a mortificazione
del titolo di Superba.
Antisavoia irriducibili quindi,
avversione radicata, aperta e palpabilmente sentita a Torino dove l’espressione
di cui sopra significava che eravamo considerati contrari al governo, di infimo
livello e quindi da reprimere con direttive severe e punitive. Anche per
Cavour, che normalmente parlando e scrivendo in francese curava le finanze,
eravamo tali da non doversi fidare. Finché poi, costretto ad accreditare
Ansaldo, Bombrini, Rubattino e Penco, di conseguenza dovette -non solo
ricredersi- ma addirittura ribaltare le aspettative economiche basandole su
essi quali migliori imprenditori del regno.
Intercorse quindi un periodo di
appiccicosa sudditanza di una parte della cittadinanza (specie quella dei
pubblici uffici o che riceveva benefici, medaglie e titoli dal governo) e di
astiosa sopportazione da parte del popolo minuto. Ne sono esempio alcuni
eventi: per i primi, nel 1823 il tappezziere
Cambiaso si lagna perché non è stato ancora soddisfatto dal Comune delle “spese
sostenute per l’ammobigliamento di un Palazzo per ricevere Sua Maestà il Re, in
San Pier d’Arena” (poveretto quel Cambiaso, vittima della piaggeria dei primi
su citati, per un re che non ha mai soggiornato nel borgo, quando poco distante
–in via Balbi- aveva un ‘palazzo reale’); e gli scritti di delibere comunali
tipo “Sua Maesta Reale, il Sindaco e i Consiglieri del Comune di San Pier
d’Arena, umilmente penetrati nanti del vostro Regio Trono, espongono...”; e stante la minaccia che -1832- Lorenzo Dufour chiuda lo zuccherificio
–osteggiato dalle regole daziali a vantaggio degli stranieri-, il Comune
intercede presso il re che riveda tali ostacoli, finendo la lettera con un
“salvo sempre che non osti positiva ed inderogabile legge Sovrana”; oppure una
circolare ai Sindaci del 1838: “ venne in pensiero al Re Nostro Signore, cui
nulla sfugge di quanto può tornare a vantaggio degli amati suoi sudditi,
d’istituire in ogni Capoluogo...una Giunta speciale per un lavoro generale di
statistica...” roba che in democrazia è ovvia, ma a quei tempi era
autorizzazione di schedature da parte della polizia.
Per i secondi, su tutti quello dell’ago 1840 quando fu tirato un
sasso alla carrozza dell’Arciduca d’Austria, e –con la più feroce ed inusuale
omertà- all’indagine seguente, non fu trovato il colpevole.
L’Amministrazione
sampierdarenese, finché restò autonoma –sino al 1926 quindi- fu
genericamente laica repubblicana e di sinistra, con momenti di prevalenze
anarchiche e massoni (vedi le titolazioni stradali di allora, da Ferrer al
Degola): comunque in genere assai poco incline ad osannare i Savoia.
Si può quindi presumere che –come
si rileva dagli scritti comunali- inizialmente il nome alla piazza -più che una
glorificazione della famiglia regnante- fosse legato alla struttura lignea
delle cabine dello stabilimento balneare che si apriva con quel nome nella
piazzetta; e la scelta rimase come era uso per indicare alcune località col
nome di quello che di maggior conoscenza vi fosse collocato (alla fine del
secolo 1800 -essendo poche le strade nominate con nome proprio- e la città in
evoluzione ultrarapida). Non credo però ci fosse ambigua malignità negli
amministratori di San Pier d’Arena. E questo indipendentemente dalla scia di
Genova perché anch’essa mai stata sposa felice nelle braccia dei Savoia (anche
se qualche concessione fu da loro donata, come il teatro dedicato al re e la
statua equestre di piazza Corvetto).
Per soprusi, da secoli sempre da
noi subiti e mai generati, per Genova i Savoia+bersaglieri, è divenuto nel
tempo un binomio di insofferente rancore, che solo il tempo ha trasformato in
freddo disinteresse fino a far prevalere la ragione con la quale si è voluto
‘perdonare’ e dedicare all’arma, una strada.
Cova come la brace quindi quel
sentimento che si tramanda tacitamente in chi ha un poco di cultura storica e
di amor proprio, fino ai giorni d’oggi.
BIBLIOGRAFIA.
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica
scheda 4078
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.54
-Dellepiane R.-mura e
fortificazioni di Ge.-NEG.1984-pag. 113.164
-Enciclopedia Sonzogno
-Il Secolo XIX: (recensione di Montale B.-Mito e realtà di Ge.nel
Risorgim) del 13.90 3
-Internet: www.bampifranco@.it
-Novella P.-Guida di Genova-manoscritto
1930 circa-pag. 19
-Pagano /33-pag. 248
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1668
SAVONAROLA
via Girolamo Savonarola
STORIA: Agli inizi dell’anno 1900
fu proposto alla Giunta comunale cambiare nome alla antica via san Cristoforo
(che corrispondeva alle attuali via A.Scaniglia, via E.Degola, via R.Pieragostini
) dandole il nome del frate “Girolamo Savonarola”. La proposta non fu
accettata, e per questa strada le modifiche furono diverse.
Ancora nell’elenco stampato dal
consiglio comunale il 1910, questa titolazione non appare ufficialmente
riconosciuta; ma vi compare inserita a posteriori, a penna, con la titolazione:
“via fra Gerolamo Savonarola; 1ª traversa a sinistra di via G.Bruno’; senza
civici”).
Nel 1914 non era stato
ancora deciso nulla, finché nel settembre di quello stesso anno venne
definitivamente accettato di donare il nome di “via Gerolamo Savonarola” a
quella che attualmente, per delibera del Podestà genovese in data 19 agosto
1935, è via Sofonisba Anguissola, anche
allora traversa chiusa di via G.Bruno (via del Campasso).
In Comune è catalogata alla G di Gerolamo: così è scritta
nel 1927 - di 5ª categoria - nell’elenco delle vie comunali all’atto della
unificazione delle delegazioni nella Grande Genova, assieme all’omonima del
Centro che nella scelta definitiva, ovviamente, conservò la titolazione.
Negli anni 1925-30 al civ.
5 c’era la conceria pelli, fabbrica
cinture-cinghie e lacciuoli in cuoio-estratti tannici, di Pinato Giulio;
10-4 lavorava il formaggiaio Rastelli Giovanni;
Barbieri Nicola frutta secca ed agrumi.
Il Pagano del 1933 include
un negozio di formaggi al civ. 10-4 di Rastelli Giovanni; e di frutta e verdura
di Barbieri Nicola
Nel 1935 la delibera di
cambio della titolazione, come descritto sopra.
DEDICATA al famoso frate
domenicano, nato a Ferrara il 21 sett.1452,
e morto a Firenze il 23.5.1498. Entrato in
convento a 22 anni a Bologna, otto anni dopo divenne Priore al convento di san
Marco di Firenze. Eccelso di mente, spaziò in cultura come allora si educava,
a tutto campo dall’astronomia alla legislazione, dalla letteratura soprattutto
alla filosofia. Studioso, insegnante, abile oratore e predicatore, iniziò a sostenere
la tesi che la Chiesa doveva rinnovarsi e riformarsi, ma prima moralizzarsi e
castigarsi.
Nel 1490
venne a Genova in san Lorenzo, per predicare la quaresima; tale fu la delusione
della situazione spirituale della nostra città divisa in fazioni e lontana
dallo spirito ecclesiale che lui auspicava, che –si racconta- andandosene via
attraverso la porta di san Tomaso (a Principe), scosse rudemente i propri
calzari esclamando “neanche la polvere, dei genovesi!”.
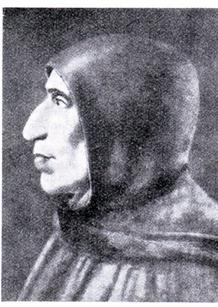
In contemporanea, il contesto
politico era – come sempre - ingarbugliato. Nell’anno 1492 (scoperta dell’America),
l’epoca dei Medici iniziava il declino; a determinarlo furono sia la morte di
Lorenzo nei primi mesi dell’anno (e cadrà
definitivamente nel 1494 con l’invasione –auspicata dal frate- del re di
Francia Carlo VIII); e sia, a Roma, la nomina a papa – in agosto - di
Alessandro VI nemico
dei Medici (Rodrigo Borgia: per tre anni successivi fu favorevole
al frate, limitandosi a richiamarlo; finché le sue denunce non sconfinarono da
Firenze per coinvolgere la corruzione romana dei Borgia: ne conseguì scomunica due
anni dopo, e l’impiccagione l’anno dopo ancora). Con i Medici, tramontava assieme l’istituzione repubblicana e l’epoca
del Rinascimento rappresentato da una società amante dell’arte e del bello, sconfinante
nel lusso, scivolante nella simonia e libertinismo (e perfino della sodomia: si scrive fosse molto
diffusa, allora nella Firenze ‘bene’ e religiosa)). Ne conseguì una riduzione commeciale che mise in ginocchio la
città.
In questa fase di impantanamento
politico, a Firenze, il frate si fece coinvolgere iniziando a prendere parte
alla politica attiva -schierandosi con Carlo VIII che però poi non lo protesse-.
Stese un programma ricco di ideali ugualitari ispirati dalla carità cristiana e
zelantemente a favore di una riforma contro la corruzione e la vanità (allora tipico comportamento dei nobili e del clero).
Secondo lui, tutti troppo allontanati dai principi cristiani, ed
espressione di una moda di rinascimento paganeggiante.
Inizialmente ottenne un certo potere
cittadino, durante il quale promosse sagge riforme, riportò la pace tra le
fazioni locali e proseguì nella missione di ricondurre la società ad una più
austera e rigida morale. Eccedette quando i suoi seguaci da lui ispirati,
conosciuti col nome di “piagnoni”, irrigidirono le pretese ed arrivarono a
bruciare (i “roghi della vanità”) libri,
quadri, oggetti, tutto ciò che poteva essere catalogato frivolo e moralmente
non ascetico, generando perplessità e ribellione tra i nobili, i quali
-ripristinata la signoria e conosciuti col nome di “arrabbiati”-, si sentirono
disturbati da regole sì schiette ma troppo severe: si adoperarono per
allontanarlo o denunciarlo di sospetta eresia per farlo mandar via. Papa
Alessandro VI dopo averlo benevolmente richiamato lo invitò a Roma, lo propose
cardinale, infine però non ottenendo risposta gli proibì la predica con una
bolla, essendo stato anche lui accusato dal frate di essere indegno della sua
carica.
I ripetuti attacchi contro
l’operato del papa, lo portarono successivamente alla scomunica (12 mag.1497) ed all’accusa di eresia; cosicché nel 1498 fu arrestato, processato, e seppur animato
da nobili e democratici principi, la disobbedienza gli costò la condanna (22 maggio, assieme ad altri due frati, Silvestro
Manuffi da Firenze e Domenico da Pescia) ‘ad essere impiccati, il corpo
arso sulla piazza della Signoria (un tondo in
bronzo incastrato nel pavimento, ricorda il punto del rogo), e le ceneri
disperse in Arno’.
Il convento fiorentino rimase
chiuso per alcuni mesi, spopolato dei frati, dispersi in tante sedi; anche la
campana maggiore fu rimossa ed allontanata dalla città sopra un carro, mentre
un boia la frustava.
Scrisse numerose opere, tra cui
:“Trattato circa il reggimento e il governo di Firenze”;“Prediche”; “Poesie”.
Contrastante, singolare e di non
facile comprensione quindi la sua posizione nella storia di allora (anche essa, di per sé e come già detto, assai confusa
e compromessa tra interessi e potere –a sua volta religioso, temporale, laico,
agnostico): in parte moralista (e quindi
martire e quasi santo: così lo vedono i protestanti, i repubblicani, i filosofi
ed alcuni ecclesiastici famosi come san Filippo Neri, san Francesco da Paola,
papa Benedetto XIV); in parte ribelle (offensivo
e soprattutto recidivantemente non obbediente ai superiori -come dovuto essendo
frate- e quindi scomunicabile ed esecrabile; e, nell’ottica di allora, da
pagare con la vita)
Papa Voitila ha poi chiesto
perdono, per questo tipo di violenza della Chiesa.
Quindi una figura -oggi
classificabile moralmente nobile e normale, ma- inserita in un mondo
impreparato ad ospitarlo.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale.
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica, scheda 4083
-BrunoGuerri G.-Questo
Savonarola-Il Giornale quotidiano del 2.3.08
-DeLandolina GC-Sampierdarena
-Rinascenza .1922 – pag. 54
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Il Giornale,
quotidiano-02.03.2008-p.11
-Novella P.-manoscritto guida di
Genova. 1930 – pag. 17
-Pagano / 1933 -pag.248
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1670
-Terrile F-Le vie e piazze del
borgo Pila-Mascarello 1936-pag.52
-non
citato da Pescio-I nomi delle strade di Genova
SCALO
vico dello Scalo
fu proposto questo nome nell’anno
1900, per una strada in zona Crociera, trasversale di via san Cristoforo (tratto via Pieragostini),
che vicino alla raffineria zuccheri portava allo Scalo ferroviario P.V.
(piccola velocità) il il quale costeggia il torrente e – ancor oggi - si
immette nel parco del Campasso. Non aveva numeri civici.
Venne annullata negli anni subito
dopo il 1910 quando, compare nell’elenco ufficiale, che avesse il civ.1.
Non corrisponderebbe a via
Spataro perché allora già candidata ad altro nome; e neanche all’attuale via T.Grossi, lontana dallo scalo. Quindi ad
altra strada più vicina al ponte, scomparsa con la demolizione dello
stabilimento dell’Eridania.
Come detto, il vicolo portava
allo “scalo ferroviario P.V.” (piccola velocità), il quale era parallelo e
vicino al torrente, quasi all’inizio del ponte sul lato a monte di esso,
ovviamente nei pressi del gabbiotto della dogana.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale.
SCANIGLIA via Angelo
Scaniglia
TARGHE:
via - Angelo
Scaniglia – architetto sampierdarenese – sec.XVIII-XIX
San Pier
d’Arena – via – Angelo Scaniglia – architetto sampierdarenese – sec. XVIII




QUARTIERE
MEDIEVALE: Mercato
 da MVinzoni, 1757. In rosso la zona Mercato con via NDaste;
giallo via CRolando.
da MVinzoni, 1757. In rosso la zona Mercato con via NDaste;
giallo via CRolando.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2847 CATEGORIA: 2
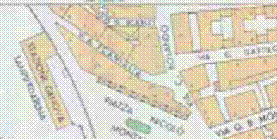 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 56940
UNITÀ
URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO
26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: la numerazione aumenta da via C.Rolando a via
P.Reti.
La targa presso via P.Reti,
che nel 2007 è in plastica, prima era di marmo e portava in basso-sinistra la
scritta “già via C.Battisti”.
La strada è l’esempio
pratico – come alcuni tratti di via N.Daste - di come era la strada, in epoca
antecedente all’allargamento delle altre vie sulla direttiva verso il ponte: è
stretta quanto una carrettabile; oggi consente una fila di auto in sosta ed una
contenuta carreggiata, quaasi senza marciapiedi.
Senso unico viario, con due
marciapiedi dei quali, quello a mare, assai stretto ed incompleto.
È servita dall’acquedotto
DeFerrari Galliera.
CIVICI
2007=UU25- NERI = da 1 a
11
ROSSI=
da 1r a 45r (compreso
21ABCr)
UU26=NERI = da 2
a 4
ROSSI= da 2r a 12r
(compresi 2Ar, 4Ar, 10ABCDEr)
===Nel
Pagano/40 “da via Martiri Fasc. a v. E.Mazzucco”.
Civv. neri= 2 abit avv. carpaneto M.; 9
levatrice. Rossi= 3 parrucch.; 4 carbone; 5 tintoria- lavanderia
genovese; 8 ripar. calzat.; 10 tipografia Montaldo; 13 Dispensario
neuropsichiatrico; 17 salum.; 27 panif.; 33b osteria; 37 fruttiv; 45 parrucch.
===Nel tratto iniziale,
subito dopo la guerra del 1945, vengono ricordati quasi di fronte uno
all’altro, a lato mare un carbonaio (vendita anche di ghiaccio e selz); lato
mont
===Nel Pagano/1950
sono citati: 31-33r=l’osteria di
Ivaldi Iolanda; nessun bar né trattoria.
===Nel Pagano/61: 11nero/interno1=albergo Stazione; 4r=carbonaio;
5r=fruttivendolo; 8-10r=tipografia; 11r=«Bruna» olio; 17r=residuati minerari;
21r=merceria; 22-27r=panificio; 31-33r=osteria;37r=fruttivendolo;
43r=calzolaio; 45r=parrucchiere.
===civ.1 portone stretto, che dà immediatamente adito ad una
ripida e stretta scala; solo in cima ad essa si entra nell’androne, con vuoto
interno, scale e pianerottoli con ringhiera.
===civ. 2r il retro detta trattoria Torre del Mangia di piazza
Montano.
===civ.
4 Il palazzo ha il
portone su questa via, ma è più ‘noto’ per la facciata di retro che fa
palizzata su piazza N.Montano (sulla quale non ha entrata), interposta tra il
civico 2 di quella piazza (in angolo a ponente) e 4 (la villa Carpaneto).
Vincenzo Crovo racconta Durante l’ultimo conflitto mondiale,
con l’incoscienza e con quel po di perversione tipica dell’eta’, dopo ogni
incursione nemica noi ragazzini, raggruppati a frotte (o a bande), accorrevamo
a vedere i disastri (o le macerie come taluni le definivano).
Se poi si aveva notizia che fra le macerie c’era addirittura
un ordigno inesploso, il nostro senso di avventura e di coraggio (da raccontare
ai coetanei) valeva almeno il doppio. Peraltro c’e’ anche da rimarcare che,
ogni ordigno inesploso disinnescato (ma senza eccessiva premura), talvolta
rimaneva in sito anche per parecchio tempo perche, nel clima di propaganda
dell’epoca, doveva essere la dimostrazione pratica delle lacunose tecnologie
nemiche. In tale contesto, quando a scuola lunedi’ 10 febbraio 1941, ossia il
giorno dopo del tragico bombardamento navale di Genova, si sparse la notizia
che un proiettile di grosso calibro inesploso era visibile proprio a
Sanpierdarena, ci organizzammo ed al termine delle lezioni andammo di corsa
ed eccitati a vedere quell’ordigno calibro 381 che aveva forato da parte a
parte il “caseggiato di fronte alla Stazione Ferroviaria” e,
fuoriuscito sulla via retrostante, era poi rotolato sulla strada fino quasi
all’angolo dell’attuale via Rolando. Il caseggiato fu ovviamente ripristinato,
tuttavia ancora oggi a distanza di tanti anni, chi osserva con attenzione il
prospetto, lato Stazione Ferroviaria, puo’ distinguere con chiarezza una
differenza di “bugnatura” nell’intonaco, in una porzione quasi circolare (come
peraltro era il foro) fra la seconda e la terza finestra all’altezza del
penultimo piano.
 .Successivamente, ormai adulto, seppi
anche che (forse) quell'ordigno per artiglerie navali era stato
costruito dalle Officine Ansaldo di Sestri Ponente e venduto dal Governo
Italiano, nel 1.939, nel contesto di una importante partita di
materiale bellico del valore complessivo di cinque miliardi di lire
(sic !!!) Vincenzo Crovo
.Successivamente, ormai adulto, seppi
anche che (forse) quell'ordigno per artiglerie navali era stato
costruito dalle Officine Ansaldo di Sestri Ponente e venduto dal Governo
Italiano, nel 1.939, nel contesto di una importante partita di
materiale bellico del valore complessivo di cinque miliardi di lire
(sic !!!) Vincenzo Crovo
===civ. 5 ha, sotto il
cornicione, vaghi segni di colore che fanno presumere una antica decorazione
ormai svanita.
===civ. 7 è più basso degli altri (tre piani) ed ha una fila
verticale di finte finestre-persiane


civ.5 civ.7


===civ. 9 di sei piani (ultimo sopraelevato)
===civ. 21r = nel 2009 sede della libreria “il Libraccio” già presente anche in via CRota
===civ. 11 conserva sulla facciata, sottostante il cornicione e
lungo la facciata, dei vaghi segni policromi, intervallati da rettangoli
rossastri.

foto da
collezione di Gaggino Edilio
__________________________________________________________
Commercialmente, nel 2003
vi si aprono a mare una pizzeria; box privati con saracinesche chiuse e maltenute,
come inutilizzate; alcuni vani del negozio ex-tessuti plastici aperto in via
P.Reti fino al 2010 (dal 2008 una parte del negozio che fa angolo con via
P.Reti, vende motocicli). A monte un frutta e verdura; numerosi box privati
esteriormente mal tenuti.
===civ. 11 nel 1950 si apriva l’Albergo Stazione, in realtà
locanda con alloggio, allora di Traverso Maria ved. Parodi
===6r nel 1950 c’era una distilleria di Campodonico &
Ceccarini F.R.A.S.
STORIA: A
giudicare dalla irregolarità della facciata posteriore della villa
Centurione-Carpaneto, che segna l’inizio della strada, non potendo essere stata
la strada a condizionare l’architetto, né le volontà del commissionario che
aveva a disposizione terreno enorme per erigere una casa, l’ipotesi più
corretta è che essa sia stata eretta sulle fondamenta di una precedente
costruzione tre-quattrocentesca, che sorgeva nell’angolo stradale fatto dalla
crosa dei Buoi e la via al Ponte.
Come si vede nella carta del Vinzoni del 1757,
dall’inizio della nascita del borgo sino a quella data, questo tracciato è
rimasto invariato. Millenaria quindi questa prosecuzione -allora anonima, verso
il ponente- della via principale del borgo che allora attraversava nel centro
il villaggio; in particolare posta al confine del quartiere detto “Mercato“,
quale ramo della biforcazione che finiva al ponte di Cornigliano.
Non sappiamo quando, ma si presume per scelta popolare e
forse a fine 1800, ebbe il primo nome ufficiale di strada San
Cristoforo (vedi) simbolico
forse, visto che portava al torrente e che -per quella via- si intraprendevano
anche i viaggi fuori dell’abitato.
Nel 1850 fu tranciata dal viadotto ferroviario e
dalla conseguente via PReti; pur conservando sino al torrente e sino a dopo il 1916
il nome ad intero di – via s.Cristoforo -. In quest’ultima data morì
Cesare Battisti, suscitando scalpore ed indignazione, infiammando gli animi e
determinando una scelta della Giunta locale con il cambiare nome alla strada,
dandole quella del martire trentino (vedi).
Nel frattempo, il nome dell’architetto era già stato usato
dalla Giunta locale: quando nel 1927 il Comune di Genova - neoformatosi
con l’unificazione delle contrade limitrofe nella Grande Genova - pubblicò
l’elenco delle strade facenti parte della città, lasciò questa titolazione
–perché non doppione- ad un ‘vico’, di 5ª categoria, posizionato trasversale a
via della Cella nella sua porzione superiore, ed era un assai breve tratto di
strada, oggi anonimo.
Solo quando il Podestà, con delibera del 19 agosto 1935
firmò la eliminazione in San Pier d’Arena della titolazione via Cesare
Battisti perché doppione con quella di Albaro, fu deciso il trasferimento del
nome dell’architetto, dal vicolo a questa via –decisamente più importante e
consona- che porta al Ponte di Cornigliano. In contemporanea lo stesso decideva
il frazionamento delle titolazioni. Quindi, a questa data, la limitazione al
solo primo tratto della lunga ed antichissima strada che portava al ponte: dai
dati comunali, iniziava da via E.Mazzucco (via C.Rolando) ed arrivava a via Milite
Ignoto (via P.Reti). Proseguiva verso il torrente chiamandosi via E.Degola
(fino alla Crociera) e via Monte Corno (via R.Pieragostini) fino al
Ponte.
DEDICATA
all’architetto sampierdarenese, il cui nome completo è Angelo Maria.
La Famiglia = Cresciuto in una famiglia di architetti e costruttori (il
padre forse era residente ove ora è piazza Modena).
Il nome è originario di Rapallo, e risale negli archivi al
1200. Poco dopo il 1528 lo troviamo nel Libro d’Oro dei nobili.
Si ricordano :
=un primo Paolo Francesco, che nel 1550-80 risulta
costruttore di opere pubbliche e di fortificazione in Gavi
=Un altro nobile Paolo Francesco che lavorò alla
parrocchiale e campanile di Sestri P..
=Tra loro fratelli Giacomo e Michele, che
furono nel 1631 tra gli appaltatori delle nuove mura di difesa di Genova, nel
tratto tra Granarolo e Peralto.
=Stefano -che nel 1655 progettò in città l’imponente
edificio dell’ Albergo dei Poveri; dipendente dei Padri del Comune, e del
Magistrato di guerra della Repubblica, fu spesso incaricato di studiare e
perfezionare i progetti delle mura e del porto (anche di quello di Vado nel
1627) , anche quelli ideati da altri architetti, migliorando ed eliminando gli
errori in rapporto alle continue modifiche delle armi di offesa. È citato
dall’Alizeri nel vol. 1 delle “Notizie dei professori del disegno... -
pag.35”
=secondo l’Alizeri, c’è a questo livello un altro Paolo
Francesco, che l’autore definisce “parrebbe discendenza di quello Stefano a
cui dobbiamo le tracce del vasto Albergo dei poveri”. E, per lo stesso Alizeri
è questo il ‘disegnatore di strade da Ovada a Voltri ed Arenzano), con
dettagliata descrizione di tutte le terre e castelli da esse attracersate; e
che ‘ebbe mano nei lavori del Portomaurizio’ che però, trascurò per motivi non
descriti, non facendo bella figura per lavori che poi, nel 1674 dovettero
essere rifatti o ripresi, e quindi con biasimo dei Reggitori al punto che
dovettero affiancargli un altro architetto, col quale però i rapprti furono ‘litigiosi’
per un buon lustro finché ambedue scompaiono dalle ricerche dello storico
=un Franco e Giuseppe (rispettivamente nonno e padre di
Angelo, nativi di Cornigliano in zona detta Colombara, appaltatori di opere
pubbliche e capi mastro).
Il
Nostro. Nacque il 23 nov.1791 da Giuseppe e Caterina Marchese. Ammesso
il 6 mag.1811 alla scuola di disegno dell’Accademia Ligustica di Belle Arti,
nel 1813 si sposò con Marianna Luisa Rivara, dalla quale ebbe due figli,
Stefano (che morì giovanissimo) e Caterina (poi vedova Tubino, ricca insigne
benefattrice locale e soprattutto dell’ospizio omonimo. Unico neo fu che non
curò l’ampia collezione di disegni e progetti del padre, cosicché alla sua
morte gli eredi -ancor peggio sensibili- la lasciarono disperdere totalmente).
Allievo di Carlo Barabino, appena diplomato in materia, ebbe incarichi diversi
nel borgo favorito dall’intenso rinnovamento edilizio dell’epoca: la chiesa ottagonale di Nostra Signora della Sapienza, nella villa ex-Doria delle suore
Franzoniane, nel 1820-2; nel 1831 lavorò per aprire il
camposanto ed erigere il nuovo teatro di
Sestri Ponente; il Teatro Nuovo poi Ristori in via San Pier d’Arena (1833) che fu poi costruito dall’impresario Lorenzo Scaniglia; l’ampliamento e
l’abside nel 1846 dell’ Oratorio
della Morte ed Orazione di via A.Cantore: era stato
costruito in forma rotonda e stile corinzio nel 1772 da suo padre; sarà poi
demolito nel 1937; nel 1849 disegna la chiesa di N.S.delle Grazie, antecedente alla attuale; il riadattamento del palazzo
del Comune nel
1852: nato su un fortilizio medievale e già soggetto a
diverse opere di ristrutturazione ai fini di edificio pubblico; il prolungamento della navata centrale ed il progetto -assieme a Nicolò
Bruno-della facciata della chiesa di
S.Maria della Cella di
via Giovanetti.
Nel
1821 fu acclamato Accademico di merito della Ligustica; e nel 1835
la sua bravura, lo portò ad essere candidato a sostituire il
maestro alla sua morte, nell’incarico di reggere la cattedra di architettura
civile dell’Università genovese (incarico che poi fu affidato a Resasco).
Eletto
consigliere comunale di San Pier d’Arena nel 1824, dedicò molta parte della sua
attività alla carica politica.
Il
30 gen.1880, morì in città. Anche se ormai era aperto il cimitero alla Castagna,
seguendo le antiche consuetudini di seppellire in chiesa, fu tumulato in san
Gaetano (allora in via san Martino (via C.Rolando): gli fu eretto un piccolo monumento, che andò
distrutto con il bombardamento del 1943.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Notizie dei professori di disegno...-vol.I-Forni anastat.-pag.35
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4096
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.445—ed./02-pag.481
-Bottaro.Paternostro-
Storia del teatro a ge,-Esagraph.1982-pag.164
-Comune
di Genova- stradario del 1953-pag.163
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.55
-Dellepiane
R.-Mura e fortificazioni di Ge.-NEG.1984-pag.164
-Gazzettino
Sampierdarenese 3/80.4
-Genova
rivista comunale n° 3/38.25
-Lamponi
M.- Sampierdarena- Libro Più.2002- pag. 160
-Medulla
M.-Sampierdarena- DeFerrari 2007- pag.23
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.16
-Pagano/1933
–pagg. 248; /40-pag.405
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1671
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova.Marsilio.1995-tav.33.34
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.80.95.192
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.114
-non
citato su EM + ES +
SCANIGLIA vico
Angelo Scaniglia
Nell’anno 1900 l’Amministrazione
pubblica propose la titolazione
“vico Angelo Scaniglia ” ad un
segmento posto a levante di via della Cella, e popolarmente chiamato “via
Copello” .
Nel 1910 il vico esisteva
ufficialmente riconosciuto, ovviamente compreso ‘da via Cella verso Levante’,
con il solo civico 1. Ed è questo che l’amministrazione sampierdarenese passò
alla toponomastica del nuovo Comune della Grande Genova nel 1926 all’atto
della unificazione.
Nel 1933 risulta esistere ancora,
collegante via della Cella con vico Pacinotti; ed essere di 5.a categoria con
nessun civico.
Risale al 1934 una fattura di
“Molinari Luigi / lavorazione ardesie / Genova-Sampierdarena – vico
A.Scaniglia, 3r (da Via della Cella)”, con ‘deposito eternit, cemento, calce,
gesso, laterizi‘.
La titolazione fu qui eliminata,
su delibera del podestà firmata il 19 agosto 1935, in cui si dettava spostare
il nome dell’artista alla strada che passa dietro il palazzo Carpaneto (via C.Battisti, già via san Cristoforo) e che
volge verso il ponte di Cornigliano; lasciando il vicoletto della Cella
anonimamente inglobato nelle strada principale.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio parrocchiale sBartolomeo della Costa di
Promontorio
-Archivio Storico Comunale
-DeLandolina GC- Sampierdarena -Rinascenza .1922 – pag. 55
SCANZI vico Giovanni
Scanzi
TARGHE:
vico - Giovanni Scanzi –
scultore – 1840-1915 – già vico G. Giusti.


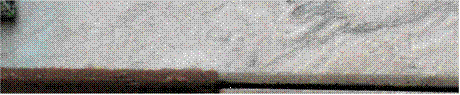
angolo con via C.Rolando


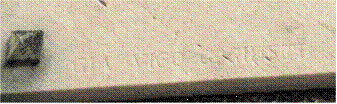
angolo con
via A.Stennio
QUARTIERE
MEDIEVALE: san Martino
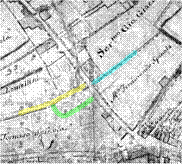 da MVinzoni, 1757. In giallo il tracciato di via AStennio;
celeste di via CRota; verde ipotetico di vico GScanzi nel terreno del mag.co
Tomaso Spinola.
da MVinzoni, 1757. In giallo il tracciato di via AStennio;
celeste di via CRota; verde ipotetico di vico GScanzi nel terreno del mag.co
Tomaso Spinola.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2848, CATEGORIA
3 (dice: via)
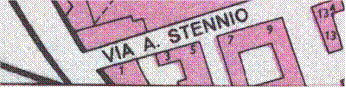


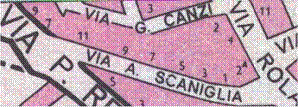 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 56960
UNITÀ URBANISTICA: 25
- SAN GAETANO
26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007
da Google Earth 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA:
s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: Collega
via C. Rolando con via A. Stennio.
Nessun
cartello proibisce il transito veicolare che però può essere effettuato solo da
motocicli causa la strettezza e l’angolo retto che compie e che non è descritto
nella cartina del Pagano (vedi
poco sopra).
È
strada privata, ancora pavimentata a grossi tasselli di pietra.
Nel
nov.03 compare nell’elenco delle ‘vie private di interesse pubblico’ e quindi
programmate a divenire municipali con passaggio gratuito per avere in cambio
manutenzione e sevizi vari quali spazzatura, asfaltatura, illuminazione,
fognature, ecc.
STORIA: Negli anni
subito dopo il 1910 appare già intestato “vico Giuseppe Giusti“ (e presumibilmente tale era già agli inizi del 1900; ed ancora così
restava nel 1933 quando collegava via A.Saffi con via Montebello, ed era di 5 ª
categoria e con civici sino a 2 e 3).
Finì per essere intitolato nel 1935 allo scultore, deciso con delibera del
Podestà il 19 agosto di quell’anno (da via E.Mazzucco (via C.Rolando)
a via A.Stennio).
CIVICI
2007-UU25=NERI
= da 1 a 3 e 2
ROSSI= da 3r a 17r (mancano 1r, 9r) da 2r a 12r
UU26=NERI = nessuno
ROSSI= 6r e 8r
Nel
Pagano/40 la via è “da via E.Mazzucco a via A.Stennio. Nei nn. neri privati (levatrice e pianoforti) e nei rossi: 3r off.mecc.; 5r carbone; 6r ottoniere; 13r «Pia»
s.a.prod.idrofili.
Nel
1960 si rilevano: 3r=manifattura ceramiche
Genovesi; 4r=lav.metalli; 5r=tipografo.
DEDICATA allo
scultore genovese nato il 30 feb.1840 da Antonio (modesto carovana del porto) e
da Caterina Gherardi.
Iniziato
al lavoro come “garzonetto” nello studio di Santo Varni (1852), questi lo
giudicò di possibile talento e lo indirizzò all’Accademia Ligustica dove lui
stesso insegnava l’arte della scultura. Qui il ragazzo riuscì ad esprimere le
sue ottime qualità, tanto da vincere (1863, assieme al Monteverde) il premio
“pensione Marcello Durazzo” consistente in un soggiorno-scuola di perfezionamento a Roma, per
quattro anni .
Effettivamente
nella capitale affinò il suo bagaglio tecnico, producendo due opere inviate a
Genova per far giudicare il grado di apprendimento -ora disperse-, di un “satiro che scherza con una
capra” ed il “rapimento di Elena” giudicate di alta qualità e che furono
esposte alla Promotrice genovese nel 1866.
Rientrato (1868) a Genova, aprì lo studio nel palazzo Fieschi in Santa Maria
in Via Lata, dove diede inizio ad una intensa attività artistica con
committenza sia locale che straniera (specie in sud America ed in Germania), realizzando innumerevoli opere.
Partecipò negli anni 1870-80 a quel periodo artistico che
viene chiamato “realismo-verismo borghese” esprimendosi (antesignani della
fotografia) in una forma puntigliosa del particolare (merletti, trine,
gioielli, lacrime, mani callose o lisce, ghette, bombette e cappelli
accartocciati dalla tensione; nonché simboli come caducei, fucili,
onorificenze, ancore, e tutto quello che corrispondeva all’educazione del tempo
legata soprattutto ai drammi -sia teatrali che musicali-). Sempre più
richieste, soprattutto per i cimiteri (ove si voleva esprimere il simbolo della
conquistata opulenza e dove la crescente nuova borghesia voleva lasciare una
traccia visibile della acquisita posizione sociale) le pose atte a far
comprendere le emozioni ed i sentimenti (addii strazianti, mani nelle mani ) e
la ricerca della somiglianza fisica riproponendo l’espressione come si era da
vivi (per i cimiteri, era da ricercare con l’indagine e la descrizione orale
dei congiunti).
Nell’evoluzione artistica, questa moda fece da giunto di
passaggio alla forma simbolista, che poi aprì la porta la gusto Liberty
(1900-1920).
Tra
le produzioni funerarie (oltre 50 a Staglieno), vengono ricordate in
particolare la tomba Casella (1877: fu la prima; vi raffigurò il volo dell’angelo della
resurrezione); poi, la tomba Carrena Ada, 1880-Staglieno,
ove -si descrive- sia riuscito
nella piccola, deliziosa e commovente scultura della giovane a divinizzare il
dolore; la tomba commissionata per Piaggio Erasmo,
1885-Staglieno, opera grandiosa, dove l’arte si è elevata alla più alta dignità
monumentale; la figura femminile della tomba Raggio,1885-Staglieno
supera ogni possibilità di lode e meraviglia per l’espressione attonita ed
impietrita dal dolore; Carpaneto,
1886-Staglieno, ove
l’angelo ammaina le vele ad un vascello, simbolo della vita giunta
all’approdo; e la tomba T.Ghiglino
(1890), ove seppe esprimere una fondamentale verità cristiana che è l’ascesa
dell’anima al Paradiso: figure femminili con vesti mosse dall’aria e librate in
alto contornate da angeli favorirono composizioni di sicuro effetto.
Altre
opere le ritroviamo nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Assarotti: sulla facciata (un
san Giorgio; l’opera fu replicata per essere collocata a Staglieno sulla tomba
di famiglia dello scultore), sull’altare destro (un san Giuseppe, ed un Davide
con Abramo), sulla cupola (la Vergine)
. All’ Acquasola il
busto di Martin Piaggio;
nella chiesa del sacro Cuore in Carignano ( un sant’Antonio –nell’ ’interno
della chiesa- ed un Redentore -grande statua in bronzo dorato che sovrasta
sulla facciata la porta centrale-); nel
palazzo dell’Università, il ritratto in bronzo di Andrea Podestà del 1908, ed un busto di Nino Bixio; alla Berio, la patetica figurina dell’orfanella; a Tursi la statua in bronzo di Giuseppina Tollot, munifica concittadina; all’Albergo
dei Poveri il
ritratto di G.Polleri, facoltoso e benefico concittadino; nell’ex-ospedale Pammatone, la statua del gesuita B.Centurione; in villetta Di Negro il busto di G.C.Abba , lo storico
dei Mille; al ex-circolo Filologico il ritratto di G.Leopardi; al ponte dei Mille lda dove salparono i due piroscafi del Rubattino che
favorirono l’impresa garibaldina: è una colonna rostrata con all’apice la
stella della libertà, eretta nel 1910 a ricordo del 50enario, quando l’artista
aveva 70 anni; nella galleria d’arte
Moderna di Nervi,
una scultura di fanciulla.
Fu
nominato cavaliere ufficiale della Corona; professore emerito dell’Accademia di
san Luca in Roma; insegnante di scultura nell’ Accademia Ligustica di Belle
Arti (1879-92) dove
coltivò importanti discepoli come Brizzolara Luigi, Orengo Luigi, Merello
Rubaldo; accademico di merito e
promotore (consigliere di amministrazione) dell’Accademia genovese; consigliere
comunale. Questi titoli dimostrano che lo scultore era divenuto protagonista
dell’evoluzione artistica alla fine del XIX secolo.
Morì
a Genova il 21 apr.1915, legando con testamento olografo datato 25 dicembre
1914 il suo cospicuo patrimonio (nonché moltissimi modelli delle sue opere) all’Accademia stessa, perché con parte della
rendita premiasse per pubblico concorso i più promettenti scultori, per opere
da collocarsi in edifici pubblici (in caso di concorso nullo, la somma sarà devoluta
all’Albergo dei Poveri). Gli allievi lo
ricordarono con una targa opera di Orengo Luigi, posta nell’Accademia, adorna
di sculture degli allievi
E’
sepolto a Staglieno, nel porticato inferiore a ponente.
Nel
maggio 2005 il Museo dell’Accademia Ligustica ha esposto sei terracotte
ritrovate nei depositi del museo ed attribuite all’artista (sono quattro visi
femminili -destinati a monumenti funerari- ed un busto in gesso
dell’avvocato-benefattore Giacomo Borgonovo; nonché un bronzo della Madonna col
Bambino benedicente -detta delle Vigne- (ne esistono altre ‘copie’ dell’originale prodotta dagli
Orsolino –Tomaso e Giovanni- nel 1616; un’altra in argento rappresentò il dono
dei fedeli alla Chiesa per l’insediamento di papa Benedetto XV nel 1914).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale di palazzo Ducale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda n° 4097
-AA.VV.-Annuario
guida archidiocesi-ed.1994-pag.445; ed.2002-pag.481
-AA.VV.-Scultura
a Genova e in Liguria-Carige-vol.II-pag.521 foto
-Grasso-Pellicci
: Staglieno-Sagep-pag 31.54foto.59foto97foto.144foto.146foto
-Genova
rivista municipale dell’ott/37.41 + ott/40.25
-Il
Secolo XIX del 25.11.03 + 23.08.04 + 21.5.05 + 30.10.05 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena- Libro Più.2002- pag.161
-Museo
S.Agostino-archivio uff. toponomastica
-Pagano
–ed./1933-pag.246; /40-pag.405; ed./61-pag.384
-Pastorino
Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag.1672
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.33
--non
citato su EnciclopediaMotta e Sonzgno e su Novella.
SCAPPINI
via
Remo Scappini
TARGA:-
San Pier d’Arena – via -
Remo Scappini – antifascista
– 1-2-1908 – 15-6-1994


angolo con via De Marini


angolo con via Scarsellini
QUARTIERE
MEDIEVALE: Coscia
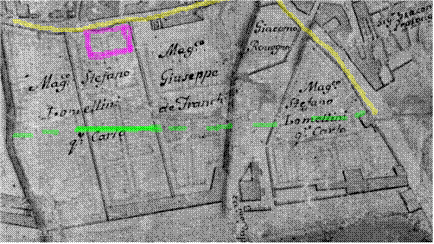 da MVinzoni, 1757. In giallo via De Marini; fucsia ipotetica
posizione del WTC; in verde la via Chiusa.
da MVinzoni, 1757. In giallo via De Marini; fucsia ipotetica
posizione del WTC; in verde la via Chiusa.
N°
IMMATRICOLAZIONE: posteriore
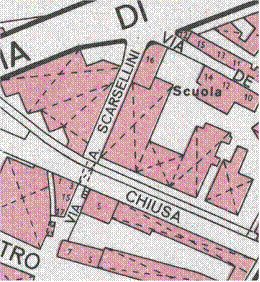 da Pagano 1967-8. La nostra, sovrapponibile a via Chiusa
da Pagano 1967-8. La nostra, sovrapponibile a via Chiusa
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 56970
UNITÀ
URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 da google Earth 2007. In giallo via Demarini; fucsia via AScarsellini
da google Earth 2007. In giallo via Demarini; fucsia via AScarsellini
PARROCCHIA: Si presume s.M delle Grazie
CAP: 16149
STRUTTURA: da via A.Scarsellini a via De Marini. Scorre parallela
al mare, con a sinistra un silos auto che sale ad elicoidale, seguito da un più
basso edificio ove è civ.4 con l’impresa Liberti &
Parodi e dal lato mare del grattacielo Shipping; sbuca verso oriente in
via DeMarini avendo di fronte il muro della strada in salita che porta
all’autostrada. A destra c’è una costruzione chiamata ‘torri basse’ perché di
altezza di un normale palazzo.
Si sovrappone per delibera
della Giunta comunale del 18 gennaio 1996 al tracciato di via Chiusa dalla quale ereditò il civ. 4. Nello stesso anno
acquisì i numeri fino all’11 assegnati ad una nuova costruzione di 13 piani.
Allo sbocco in via DeMarini,
costeggia il fianco della Torre Shipping.
CIVICI
2007= UU26= da 3 a 39
(mancano 1, 5→9)
da 4
a 8 (“ 2)
DEDICATA
Per tutto il periodo bellico fu segretario direttore
responsabile della federazione comunista genovese, ovvero di tutto il lavoro
politico e militare del PCI in Liguria lottando col nome di battaglia Giovanni
(che cambiò in Rossi Mario quando, scoperto, fu
fortemente ricercato).
Nativo
di Empoli nell’anno 1908, per due anni operaio
in giovane età quale allievo vetraio, entrò a 15 anni nei gruppi della gioventù
comunista diventando funzionario locale
esercitando questo incarico giovanile con
fermezza e rigidità morale, volutamente in contrapposto al lassismo fascista.
Nel 1930, ventiduenne, individuato come
sovversivo (in effetti era rivoluzionario d’istinto, fin da giovane applicando
attività cospirativa antiregime) fu ricercato e catturato nel 1934 e condannato dal Tribunale Speciale a 22 anni di
reclusione. Amnistiato in occasione del ventennale fascista, riuscì ad
espatriare prima a Parigi e poi a Mosca (dove per tre anni fu educato alla scuola marxista-leninista,
che prevedeva anche scuola di guerriglia. Una delle prime cose imparate, fu la
fedeltà ed obbedienza senza riserve né domande, alle direttive del partito). Così, caduto il fascismo, fu incaricato di
rientrare ed organizzare in Liguria la lotta partigiana clandestina, risiedendo
di fatto a Torino dove creò nell’interno del partito -e quindi diresse (lasciando a Bosi il segretariato
della Federazione)- un “triunvirato
insurrezionale”, mirato a dirigere l’incarico politico-militare ricevuto dal
partito.
L’8
settembre 1943, il PCI era già in possesso di una rete organizzata, e tramite
il triunvirato, ampliò e perfezionò il coordinamento e gli aiuti per le
formazioni sia cittadine che di montagna. Assieme agli esponenti degli altri
partiti politici (partito
d’azione, democrazia cristiana, socialisti, repubblicani, liberali) diede vita alla costituzione del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale; formato presso l’hotel
Bristol).
Lo Scappini fu designato quale presidente a capo del CNL locale, divenendo detentore di tutti i poteri
amministrativi e di governo della Liguria (viveri, rifornimenti, ordine pubblico, organizzazione della
resistenza armata di popolo e militare contro l’occupazione tedesca). Iniziò
favorendo con scritti, volantini, scioperi e sabotaggi, dapprima solo il
disarmo, poi scontri aperti contro i militari; creazione di istruttori
militari; squadre di difesa operaie (preludio delle SAP: squadre d’azione patriottica, specie dopo l’improvvisa
deportazione di 1488 operai prelevati bruscamente dalle fabbriche genovesi e
trasportati a Mauthausen per alimentare quelle hitleriane).
Il ruolo di responsabile coordinatore era estremamente
difficile per la mancanza totale di comunicazione diretta; la precipitazione
improvvisa di situazioni imprevedibili; le mille interferenze più o meno aperte
con gli altri partiti, tutti miranti a non farsi sopravanzare dal compagno. Ci
voleva una buona dose di fortuna; e Scappini la ebbe al suo fianco sino alla
fine.
Il
20 nov 1943 ritornò a Genova, inviato dai
dirigenti milanesi (Paietta,
Longo, Secchia) a rilevare l’incarico
fino ad allora gestito da Pieragostini, ed assumere così il controllo
dell’organizzazione ligure; qui trovò pressoché inesistente la cultura
cospirativa e militare, e l’organizzazione del comunismo genovese nel caos sia
in alto che in basso. Iniziò quindi a dirigere la componente comunista nel
C.L.N. regionale cospirativo, ed assumendo il ruolo di stimolante -contro
l’<attendismo> interno e degli altri partiti- privilegiò la reazione
armata da attuarsi con tutti i mezzi a disposizione, iniziando con gli scioperi
ed il terrorismo urbano dei Gap (a
dicembre Buranello era già stato individuato e costretto a riparare sui monti;
il 13 genn due gappisti uccisero un ufficiale tedesco ferendone gravemente un
altro (otto antifascisti, tra cui il pf Bellucci, prelevati da Marassi, furono
fucilati l’indomani mattina; altri 42 furono inoltrati verso i campi di
concentramento). Il 6 aprile scattò l’operazione di rastrellamento alla
Benedica, con 150 morti e 350 deportati. Il 15 maggio avvenne la bomba nel
cinema Odeon , con la rappresaglia del Turchino. Il 16 giugno, 1500 operai furono
prelevati, insaccati in quaranta treni merci e deportati. In Germania), senza tralasciare l’organizzazione sui monti affidata al com. Miro (lo slavoVictor Ukmar, fanatico comunista, esperto militare
rivoluzionario, inquadrato nella militanza internazionalista soggetta agli
ordini di Mosca, descritto di non integerrima moralità) che prese contatti con Bisagno della
divisione Cichero che bene resse al grande rastrellamento del 24 agosto.
Nel
giu 1944 lasciò l’incarico di segretario della
Federazione genovese (sostituito
da Ilio Bosi), divenendo responsabile
del Triunvirato insurrezionale ligure.
Divenne
ricercatissimo quando, abitando in corso Firenze 38/13, fu individuato dalla
polizia del dr.Veneziani e dalle SS quale dirigente della Federazione comunista
genovese (nell’ispezionare
un carteggio rinvenuto in un appartamento di via P.Salvago 14/6, ricco di materiale: appostandosi quindi nei pressi, poterono
arrestare vari frequentatori dell’abitazione alcuni dei quali che collaborarono
con la promessa dell’impunità. Tra gli arrestati ci fu la moglie Chiarini Rina
chiamata “Clara” (essa fu arrestata -seppur fosse
sotto il falso nome di Antonietta Bianchi di Lorenzo nata a Livorno ma della
quale fu subito riconosciuto la falsità del documento. Ciò malgrado non volle
mai dire le esatte generalità, ostinando a tacere anche della propria
abitazione; il che le permise di non essere conosciuta quale moglie di
‘Gi’=Giovanni alias Rossi, in quel momento latitante ma supposto dirigente)-
minacciata e torturata, per lungo tempo con ‘fare scaltro e reticente’ non
fornì alcuna identificazione utile né di se stessa né dell’organizzazione;
finché non segnalò l’indirizzo di casa, corso Firenze 38/13, quando però gli
abitanti (il marito soprattutto) erano ormai in fuga; fu condannata alla
deportazione; ma riuscì a fuggire e tornare. Fu decorata con medaglia
d’argento al V.M.). Lui, fortunosamente
riuscì sempre a sfuggire salvandosi dalle rappresaglie che giornalmente
decapitavano i vertici della resistenza (fra tanti, ricordiamo Riccardo Masnata e R.Pieragostini).
Nel
suo ruolo dirigenziale, si rendeva conto nel giungo 1944 che la popolazione
genovese era sfiduciata e quindi non ancora pronta ad una insurrezione di
massa, malgrado lo sciopero generale del marzo e che da poco (il 16 giugno) le
forze tedesche avessero deportato migliaia di operai.
In
quel mese si vennero a formare le SAP (squadre di azione partigiana; esse, moltiplicatesi
rapidamente già nell’autunno ’44 poterono essere raggruppate in 36 Brigate (24
chiamate Garibaldi, organizzate e dirette dal PCI; 2 Matteotti dal PSIUP; 2
Mazzini dal PRI; 1 Patria dalla DC; 4 GL dal Partito d’Azione; 2 Libertarie da
anarchici; 1 Autonoma dal PLI)) ciascuna
formata di 3-4 distaccamenti composti da più squadre di 5 uomini.
Partecipò
alla programmazione dell’insurrezione e liberazione finale di Genova, cercando
sia di prevedere le mosse del nemico e prevenirle per attutire i danni alla
città, superando diplomaticamente tutte le divergenze tra i vari partiti ed i
settarismi personali, sia di salvaguardare il prestigio del partito nei
difficilissimi equilibri di forza, potere, comando (ovvero il controllo sia militare che
politico del movimento partigiano, con quadri di comando affidati a comunisti
di fiducia) .
Nella
notte del 23 aprile 1945 il CLN, presieduto
dallo Scappini si riunì in seduta permanente nel collegio San Nicola (per la DC c’erano Taviani, Loi,
DeBernardis; per il PCI Scappini e Pessi; per il Pd’Azione Cassani Ingoni,
Lavoretti, Zino; per il PLI, Manzitti e Martino; per il PRI Acquarone e
Gabanizza; per il PSI Toni, Cirenei e Bianchi. Gli invitati furono adunati
usando una immaginetta religiosa, il santino di san Nicola, a significato del
luogo d’incontro). Presero
il loro preventivato posto direttivo quale prefetto (avv. Martino Errico); questore capo della polizia (avv. Bianchi Costante); presidente del CAP Canepa Carlo; in Regione (Manzitti) e Provincia (avv. Raimondo Enrico); e poi anche il futuro sindaco
nominato in Faralli
Vannuccio del PSI
appena liberato dal carcere di Marassi ed ancora convalescente di una grave
lesione ad un occhio conseguente le sevizie subite alla casa dello studente; e
i vari amministratori) e decise
l’insurrezione seguendo in parallelo le trattative che i professori medici
Giampalmo e Romanzi conducevano con il generale Günther Meinhold (il maggior-generale, assegnato da Hitler al comando
della ‘fortezza Genova’ dalla seconda metà del 1944 dopo la ritirata dal fronte
russo, aveva avuto l’ordine specifico di minare e distruggere città e porto in
caso di arrivo degli Alleati onde offrire loro ‘terra bruciata’. L’ufficiale,
vivendo in città si rese conto dell’assurdità del comando e consapevole che per
potersi ritirare doveva trattare; e così divenne pronto a disobbedire rendendosi
conto della sconfitta e dell’inutilità di versare altro sangue. L’incarico di
distruggere il porto fu trasferito alla Marina, al cap. Max Berninghaus della
Kriegsmarine (che nel frattempo aveva sconfessato Meinhold condannandolo a
morte per tradimento). Fu monsignor Siri inviato dal cardinale Boetto che
perorò la causa. Intanto Meinhold, con la mediazione sempre del cardinale,
seppur forte di oltre 15mila soldati (tra tedeschi e repubblichini), offrì
dapprima la ritirata, poi la resa, con ovvio personale ed impegnativo sforzo
mentale, complessato da ovvi enormi sentimenti contrastanti).
Così
il 24 mattino alle ore 10 il popolo iniziò ad occupare con lotta cruenta e
prima che sopraggiungessero gli anglo-americani, il palazzo comunale, i
telefoni, la questura, le carceri, il porto, lottando sino al 26 mattino (i fascisti si erano già defilati,
rimanevano i tedeschi decisi ad oltranza, attestati e ben armati in palazzo
Raggio, a Coronata, monte Moro, Nervi, Albaro, val Polcevera). Un giovane partigiano, cautamente penetrato nella
‘casa del Fascio’ di via II Fascio d’Italia, ne uscì esterrefatto dicendo ‘Non
c’è più nessuno!’.
Il
25 alle ore 17 a villa Migone nel quartiere di san Fruttuoso, si incontrarono
il medico C.Romanzi, il gen. Meinhold, R.Scappini, assieme a Martini Errico (rappresentante del partito liberale), Aloni Mauro (maggiore, comandante militare) il console von Etzdorf, G.Lavoretti (dei liberali), non presenti fisicamente ma rettori della trama,
l’arcivescovo Pietro Boetto ed il suo ausiliare Giuseppe Siri la scusante era : non siamo politici
e la Chiesa non interferisce con le lotte profane. Alle 19,30 dopo qualche indugio, il tedesco firmò la
resa e la comunicò via telefono ai suoi subordinati (riconosceva con franchezza la
sconfitta ed inutile ulteriore spargimento di sangue e distruzioni; precisando
che era generale tedesco e non nazista; che la sua decisione non sarebbe stata
condivisa da Berlino e da gran parte delle truppe (dai 6 a 8mila soldati tra
‘di terra –soprattutti artiglieri-‘ e di marina: Genova era sede delle forze
navali tedesche leggere) per i quali cercava garanzie di trattamento; la pace sarebbe entrata in vigore
dalle ore 09,00 del 26. Non tutti i tedeschi furono d’accordo e decisero
unilateralmente di non cedere ai partigiani e di resistere sino all’arrivo
degli alleati ai quali solo cercavano di arrendersi per dignità militare e per
maggiori garanzie): fu quel giorno la
vittoria della diplomazia su quella delle armi. Alle ore 13 gli americani erano
arrivati a Sestri Levante, ma lì fermati dalle batterie tedesche alla ricerca di tempo, sperando
ancora di poter evacuare Genova: il capitano americano M.Steinman, arrivatovi
per primo, morì a Lavagna colpito dal preciso fuoco tedesco, assieme a molti
suoi soldati
Il giorno 26 vide il tripudio della folla; l’assegnazione
delle previste funzioni direttive cittadine ed avvio alla lotta agli altri
incarichi di potere; per le strade molti cittadini -collusi con i fascisti-
furono irregolarmente giustiziati ed altri incarcerati.
A Mulinetti la reazione americana, forte di cannoni su
mezzi cingolati sopraggiunti nella notte, schiacciò queste sacche di
resistenza, ma intanto la marcia degli alleati era stata rallentata di un
giorno.
Il mattino del 27 arrivarono in città i primi alleati,
guidati dal generale Almond; in particolare si trattò di una avanguardia di
jeeps, guidata dal tenente Egget con i plotoni I ed R; il grosso arrivò nel
pomeriggio del giorno dopo. Migliaia di tedeschi prigionieri sfilarono poi
risalendo via XX Settembre, con sguardo di rassegnata depressione dei soldati,
ma ancora di tracotante disprezzo delle SS.
Come
ai tempi del Balilla, Genova –unica città in Italia- si era liberata da sola,
con la volontà del suo popolo, dando ulteriore prova della propria fierezza e
salvando l’onore del soldato italiano
Lo
Scappini divenne poi segretario della Federazione del PCI di Pisa, ed
onorevole. Genova lo riconobbe ‘cittadino onorario’.
Scrisse
con costanza anche nei momenti di impegni travagliati, una aggiornata relazione
della situazione periferica, onde poter tenere informati i centri coordinatori
nazionali: questo fu di molto aiuto nella ricostruzione storica degli
avvenimenti, spesso ingarbugliati, dalle vicende belliche e dalle tesi
interessate dei singoli. Nel 1981 le memorie furono pubblicate dall’editore
milanese LaPietra, col titolo ‘Da Empoli a Genova’.
Morì
ad Empoli, ove risiedeva, il 15.6.1994.
BIBLIOGRAFIA
-Antonini
S.-La Liguria di Salò-DeFerrari.2001-pag.494
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4097°
-AA.VV.-Contributo
di Sampierdarena alla Resistenza-PCGG.1997-p.68
-Calegari
M.-Comunisti e partigiani-Selene.01-
-Faraggiana
A.-Garofani rossi-1977-pag.141
-Gazzettino
Sampierdarenese 6/94.15
-Genova-rivista
del Comune- 1/49.17 (oppure 1/47.17nota5?)
-Gimelli
G.-Cronache militari...-Carige.’85-p.52.70.194.226.243.477.947
-Il
Giornale -quotidiano- 20.01.2010
-Lamponi
M.- Sampierdarena- LibroPiù.2002. –pag.29
-Ronco
A.-Genova in guerra-Il Secolo XIX-Carige-pag.182
non c’è ancora in Pagano e 101/94
SCARSELLINI via Angelo Scarsellini
TARGHE:-
San Pier d’Arena – via -
Angelo Scarsellini – martire di Belfiore

sul WTC
angolo con via De Marini


angolo con
via Scappini


QUARTIERE
MEDIEVALE: Coscia
 da MVinzoni, 1757. In giallo via Demarini; fucsia ipotetica
posizione del WTC; verde ipotetico tracciato della strada.
da MVinzoni, 1757. In giallo via Demarini; fucsia ipotetica
posizione del WTC; verde ipotetico tracciato della strada.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2849
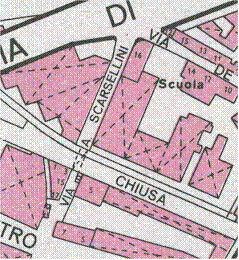 Pagano 1967-8 – L’area dove scritto ‘scuola’ era
l’oleificio.
Pagano 1967-8 – L’area dove scritto ‘scuola’ era
l’oleificio.
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 57020
UNITÀ
URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007
da Google Earth 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie
STRUTTURA: la strada appare nella carta del 1961 in
zona oggi completamente sconvolta nella struttura.
Allora, sempre era orientata
sud-nord ed iniziava da via P.Chiesa (alla stessa altezza di dove, a mare, inizia il raccordo
autostradale); dopo due brevi isolati, da
metà strada - a levante - con una scalinata si
saliva sulla soprastante via Chiusa che la intersecava; con l’altra metà - a
ponente - passava carrozzabile sotto la suddetta via Chiusa e proseguiva – fiancheggiando
l’oleificio - per sbucare in via di Francia pochi metri a ponente di via
DeMarini.

Oggi, da via P.Chiesa arriva
sempre in via di Francia (e via De Marini), ma con a levante un corpo edilizio
rettangolare di 13 piani (detto ‘torri basse’); seguito dalla rotonda di un
silos-garages ed infine dal fianco del WTC. A ponente c’è prima un basso
edificio -alto come una casa normale-; seguito dalla facciata del secondo
gemello grattacielo, dalla rampa carrabile che porta alla piastra di
collegamento delle due torri gemelle; ed infine da una più bassa costruzione
conosciuta come AZ dal negozio che vi è stato ospitato.
È servita dall’acquedotto
DeFerrari Galliera.
STORIA: Viene
descritta scorrere in terreno di proprietà del CAP.
L’11
ottobre 1940 il podestà deliberò così la titolazione di questa strada che
precedentemente corrispondeva ad un tratto di via G.Alessi (che scendeva da via DeMarini-via
Dieci Giugno, a via
P.Chiesa).
Doveva fungere da passaggio
di scarico verso il lungomare, del traffico proveniente dalla sopraelevata e da
via di Francia, snellendo via Buranello. Ma ancora nel 2002 una gru -utilizzata
per costruire le torri- occupava trequarti della strada strozzando ogni
iniziativa in quel senso. In questa data secondo i progetti iniziali del Centro
san Benigno, doveva aprirsi sulla strada la seconda torre de “i gemelli”, poiché di esse ne era stata eretta una
sola, quella a ponente. Questo secondo grattacielo è stato pressoché ultimato
solo nel 2004, realizzato dalla soc. Edige. Da una rampa carrabile, si accede
ad un vasto parcheggio per auto. Nel 2006, liberata questa strada, il traffico
non ha trovato sfogo a mare impedito da quello che -provenendo da piazza Barabino-
taglia la deviazione facendo preferire andare diritti in via Buranello.
CIVICI
2007= DISPARI: da 1 a
183 (mancano
9→13, 25,27,33,37,41,79,93,95,111,113,143,177)
PARI da 2 a 62 ( mancano 26,28,46→56,60)
aggiungi 6CD e 32B
===civ. 1 esistente nel 1961 : ci abitava una ostetrica
===civv. pari 2→ 8 (secondari al civ. 1 di via De Marini) e dal
4 →al 24 assegnati nel 1988 a nuova costruzione .
===civv. 15, 17 demoliti
nel 1995 e rassegnati, con tutti i dispari, sino al 139 a nuova
costruzione, nello stesso anno
===civ. 37r nel 1961 c’era un rigattiere
===civv dal 145 al 181 assegnati a nuova costruzione nel 1996 .
DEDICATA Al patriota
italiano, nativo di Legnago nel 1823 (Lamponi scrive 1782), martire di Belfiore
nel 1852, di professione macellaio.
Cittadino
di carattere ottimista e pratico, pagò di persona lo slancio e l’entusiasmo di
partecipare alle lotte per l’irredenzione della sua terra natia anche se
condotte quasi sempre in pochi o comunque senza mezzi ed organizzazione
coordinata. Iniziò partecipando ai moti del 1848, sperando nella liberazione
del Lombardoveneto; la sconfitta del Piemonte lo costrinse all’esilio in
Francia e poi in Piemonte.
Rientrato
nel Veneto ancora soggetto all’ austriaco, partecipò alle cospirazioni dirette
dal sacerdote Enrico Tazzoli (diffusione di opuscoli rivoluzionari, riunioni sediziose,
organizzazione di focolai di animosi, alcune anche ingenue tipo progettare
traffici d’armi o rapire l’imperatore);
di loro, da poco aveva perduto la vita Luigi Dottesio, che -dopo cattura e
processo- fu la prima vittima dell’ampia rete del comitato insurrezionale
creatasi nel territorio occupato dallo straniero.
La
polizia austriaca, forte di due inquisitori particolarmente tenaci, attraverso
vari arresti riuscì a concatenare i fatti ed i nomi di vari collaboratori -per
lei traditori-; riuscendo così a fare una retata di ben 110 cospiratori . Essi
furono processati in vari gruppi, e 10 condannati a morte, altri al carcere
duro della Mainolda.
Scarsellini,
arrestato a Venezia, fu tra i condannati a morte il 4 dic.1852 , e condotto al
patibolo dell’impiccagione il giorno 7, assieme al Tazzoli ed altri tre; in
altri giorni morirono anche Tito Speri e gli altri: secondo l’accusa, tutti rei
di alto tradimento. L’esecuzione avvenne in un vallo del forte, posto a difesa
della piazza di Mantova.
Alla
liberazione, la località divenne altare per la libertà d’Italia.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4100
-Autore
non conosciuto-Guida del porto di Ge-Pagano.1954-pag.732
-AAVV-Annuario
guida archidiocesi anno/94-pag.445; anno/02.-pag.481
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Genova&Genova, n°6 del
maggio/01
-Lamponi M.-Sampierdarena-
LibroPiù.2002-pag.29
-Pagano 1961-pag.385
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1672
-Poleggi E&C-Atlante di
Genova-Marsilio 1995- tav.51
SCASSI corso Onofrio Scassi
TARGHE:
San Pier
d’Arena – corso - Onofrio Scassi – medico-scienziato-politico – 1768-1836
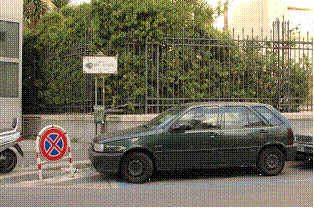

in angolo con corso Magellano, casetta dell’AMT


in angolo
con scalinata C.Beccaria
QUARTIERE
MEDIEVALE: Mercato
 da MVinzoni, 1757. In rosso salita sBarborino; giallo vico Imperiale; fucsia, via GB Botteri; verde, ipotetico tracciato del
corso, sotto la vasca del lago infer.
da MVinzoni, 1757. In rosso salita sBarborino; giallo vico Imperiale; fucsia, via GB Botteri; verde, ipotetico tracciato del
corso, sotto la vasca del lago infer.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2850 CATEGORIA: 2
 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n° : 57040
UNITÀ
URBANISTICA: 27 – BELVEDERE
28 – s.BARTOLOMEO
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: Cristo
Re
STRUTTURA: doppio
senso viario, da via G.B.Balbi Piovera a corso F.Magellano.
Due
scalinate si aprono a mare sulla strada: una col nome di scalinata Beccaria;
altra anonima che la collega a via GBBotteri.
La
proposta formulata del marzo 2004 di munire la strada di posteggi a pagamento
sul lato a mare, fu bocciata dal CdC: il problema coinvolge quello del traffico
(ospedale, scuola, residenti), che ostacola il flusso delle ambulanze
Prima
dell’applicazione delle targhe in plastica, nell’angolo a sinistra della
vecchia targa c’era inciso “già corso Roma”.
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

foto anni 1960
CIVICI:
2007
=possiede solo neri, 1 e 3 =UU27 e 2→10=UU28.
Nel
Pagano/40 la strada va “da via G. Balbi Piovera al monte” ed ha solo ilo civ.
1 degli “Ospedali civili Sampierdarena”
STORIA: dalla mappa
del Vinzoni si vede che la strada faceva parte del giardino di villa Imperiale,
separando il tratto di giardino (col viale centrale, il quale, lievemente in salita e detto
‘delle statue’, ancor oggi è esistente al limite alto del parco) dal largo lago –detto ‘inferiore’- della villa
stessa.
Non è chiaro quando il Comune, a vantaggio dell’ospedale,
trovò modo di allargarsi a levante rispetto la cinta degli Imperiali; si riscontra infatti una non
corrispondenza tra la carta del Vinzoni (ovvero della antica villa) e la
situazione ad oggi: in quella, il vico Imperiale scorreva diritto al lato
orientale della proprietà racchiusa da un alto muro. Tutto corrisponde, dall’inizio
in basso sino a ponente della torre dell’ospedale – ancor oggi eretta - della
ex villa del principe Francavici. A quel livello, il muro di cinta della villa
Imperiale fu distrutto per aprire via GBBotteri, ma dovrebbe riprendere diritto
a monte del corso Scassi - per salire a Promontorio -. Invece oggi la proprietà
dell’ospedale si estende per ulteriori 100m a levante – al limite con via
MFanti-. Qui, nel tratto iniziale, c’è un muro di cinta, ma non è in linea con
quello di via Botteri. Quindi, o questo di via Fanti è della proprietà vicina,
i principe di Francavici, ma da nessuna parte è scritto che l’ospedale acquistò
terreno espandendosi a levante; o c’è un errore nella carta (assai difficile)
nella parte medio-alta della proprietà.
La
strada, nacque con i lavori di erezione dell’ospeale; e nel 1915 - in
concomitanza dell’inaugurazione ed apertura funzionale dell’ospedale - fu
battezzata corso Roma. Ancora in quel
tempo, non aveva sbocco ai due estremi ma si collegava col centro cittadino
tramite la ripida via G.B.Botteri. La difficoltà a transitarla con i mezzi di
allora (su carretti trainati a mano o da animali), furono poi superati con la
donazione dei terreni utilizzati per aprire via Balbi Piovera.
Ma
prima di quest’ultima, sappiamo che in un primo progetto, la strada
inizialmente andava dall’entrata dell’Ospedale verso levante, per farla
scendere a tornanti lungo il fianco destro della valletta di san Bartolomeo
fino all’antica abbazia.

Mentre,
dal lato a ponente, la strada fu interrotta al limite del giardino della villa
Imperiale-Scassi, e tale rimase per altri cinquant’anni circa. Del muro di
cinta che limitava a ponente detta proprietà, rimane - proprio sul marciapiede
a mare della strada - un arco-porta, che
molto probabilmente collegava l’interno della villa con l’accesso alla basilica
di san Giovanni Borbonoso.
Sul
montante a mare dell’arco, in occasione dell’apertura della strada fu apposta
una lapide del 1915 che scrive:
«A testimonianza del giardino
cinquecentesco / onde / Galeazzo Alessi per Vincenzo Imperiale / il colle
aprico / da valle a monte / imparadisava / il Comune / quest’arco intatto volle
rimanesse simbolo dell’arte / travolta dalle esigenze nuove //--// Il Popolo
Sampierdarenese / chiamato nel 1° maggio 1915 / al battesimo del corso Roma /
ne consacrava il ricordo»



Come
scritto, inizialmente il progetto non era come oggi: infatti già approvato l’anno 1925, già finanziato e
reso esecutivo (così nella relazione dell’amministrazione cittadina del 1926 al
momento dell’ultimo anno di autonomia prima dell’assorbimento nella Grande
Genova, ed in alcune mappe del 1931) era previsto un allacciamento con via san
Bartolomeo, tramite una strada che doveva scorrere a tornanti lungo il fianco
della collina -larga 15m, lunga 4 km, passante per Promontorio; ed a ponente
arrivare al Campasso ed oltre fino al confine con Rivarolo in via A.Ristori. Evidentemente
l’assorbimento con Genova, fermò e cambiò tutto.
Così
poi invece, dalla Abbazia di s.B.d.Fossato
la strada fu continuata ma sul versante opposto, quello a levante verso le mura.
Il 19 agosto 1935, con delibera del podestà, fu
cambiato la titolazione della capitale con l’attuale, per evitare l’omonimia
con Genova.
Mentre
a ponente, l’allacciamento con corso
Magellano avvenne assai tardi, oltre gli anni 1950.
Nell’angolo
la gabina dell’ascensore che collega il corso
con via A.Cantore, descritto in questa ultima strada.
Tutta la zona sovrastante che dall’antico era parte integrante della villa
Imperiale-Scassi (sottostante e descritta in via N.Daste) quando dal Comune fu
comprato tutto, fu dapprima deciso tagliare i giardini a livello del laghetto
inferiore, dedicando la soprastante - cosiddetta zona boschiva - all’ospedale.
Alla fine, compreso il taglio di via A.Cantore, tutta la proprietà si trovò
separata in tre porzioni, come aree autonome ed avulse una dall’altra che han
costretto me a descriverle separate con grande rimpianto nel cuore (la villa in via N.Daste; i giardini
in via A.Cantore; il boschetto in corso O.Scassi), perché così han fatto perdere a san Pier d’Arena la più alta
magnificenza che aveva.
Tornando alla zona boschetto, la possiamo interpretare solo dagli acquarelli
prodotti da Dante Conte e da rare fotografie. Li premettiamo alla descrizione
del nosocomio (leggere
anche “giardini villa Scassi in via A.Cantore).


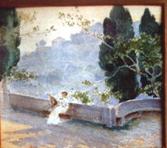

la torre delle Franzoniane - nei
pressi del terzo ninfeo arco esistente in c.so Scassi
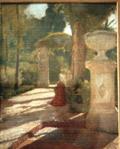




come foto
2 il
terzo ninfeo idem


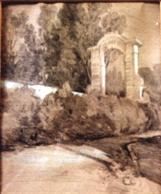
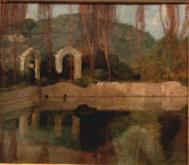

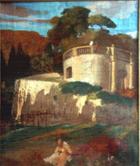

terzo ninfeo
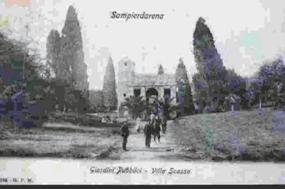

il terzo ninfeo un
lago


parte della quadreria presente nella Direzione dell’Ospedale
===civ
1 l’OSPEDALE civile, già “Azienda”.
Dal 2009 semplice “Ospedale
civile villa Scassi”, tornato a far parte delle ASL 3 regionale (Anticamente gli ospedali erano alla
diretta dipendenza dallo Stato; la loro gestione passò alla USL Regionale, che
nel territorio è la numero ‘3 genovese’. Oggi, quelli minori non sono aziendalizzati
e dipendono dal complesso sanitario gestito direttamente dalla Regione; invece,
quando un ospedale è aziendalizzato gode di autonomia economica pur sempre
dipendente gestionalmente dalla Regione).
1)==Alle origini
locali, leggiamo che il primo ospedale cittadino, non inteso con la mentalità
odierna ovviamente, ma come ‘ospizio per viandanti e marinai’, fu quello in
salita san Barborino dall’anno 1200 circa, detto ‘spedale’ o ‘ospizio di
san Giovanni’. Praticamente nulle, le notizie
relative a questa iniziativa, al punto che storicamente ne è accertata l’esistenza
ma di cui nessuno descrive la funzione e lo sviluppo negli anni. Fu chiuso con
bolla pontificia di Sisto IV il 26 novembre 1471 assieme a tutti gli altri
uguali genovesi, a beneficio dell’accentramento in unica sede, a Pammatone.
2)== Dopo questo, nulla fu fatto nel borgo, finché il
Comune con delibera del 2 lug.1871 decise l’acquisto a condizioni di assoluto
favore della villa Masnata (oggi essa si
affaccia su via A.Cantore, ma allora si apriva nell’attuale via N.Daste.

Necessaria
la descrizione dell’ambiente sociale in cui maturò la decisione: dal 1865 il
borgo era divenuto città e l’unica assistenza ospedaliera era solo a Pammatone.
Le grosse industrie avevano richiamato innumerevoli immigrati, operai - e
famiglia annessa - alla ricerca di occupazione fissa. Come conseguenza, un
aumento di malattie ed incidenti. Divenne costoso, disagevole ed a volte drammaticamente
difficile l’utilizzo di Pammatone posto al di là del colle di s.Benigno in
tempi in cui le barelle erano
sospinte a
mano su strade in terra battuta).
Nacque come Opera Pia, ed il 26 gennaio 1873 fu riconosciuto Ente
Morale; fu inaugurato il 15 marzo 1874 con 60 posti letto.
Dopo solo vent’anni d’uso, apparve evidente che la
villa non era più sufficiente alle esigenze della tumultuosamente crescente
popolazione, e che non era opportuno ci si dovesse sempre appoggiare a
Pammatone.
3)== Così il 30 mag.1903, sotto
l’amministrazione di N.Ronco, fu elaborato un progetto per qualcosa di più
consono alle necessità: per 1.402mila lire, si prevedeva un edificio da far
sorgere a quota 60, nel luogo della villa Scassi chiamato ‘boschetto’, dove
allora c’erano il lago artificiale ed “il bosco ed un centro di tiro al
piccione” nonché accesso da via dei Colli
(approvato dalla prefettura
il 14/5/04). Fu proprio la strada, di
difficile realizzazione, che fece fermare l’inizio lavori. Si arrivò così al 1907
quando il prosindaco Gino Murialdi (nominato commissario prefettizio alle dimissioni di N.Ronco) fece proporre la collocazione dei primi padiglioni
a quota 40 dove era la grande vasca e facendo studiare una via di accesso
differente.
Così, nel 1911, l’impresa Carena Giovanni, (sindaco Peone Gandolfo), iniziò i lavori di accesso verso quota 40 usando la
strada oggi chiamata via GB Botteri, (solo in seguito, fu aperta a levante una più larga e comoda
strada chiamata via E.DeAmicis che corrispondeva
all’insieme delle attuali via Malinverni, via Pittaluga, via B.Piovera) che da quota m.5,5
sale a quota 40 (-ancor
oggi assai stretta- sul terreno concesso gratuitamente dal sig. Benedetto
Piccardo (la cui proprietà, posta ove ora sorga il grattacielo, tramite
cancello si apriva in via De Marini (via L.Dottesio)).
Nella ex-proprietà Scassi, fu per prima distrutta la grande vasca dentro la quale gli Imperiale, gli
Scassi e poi turisti vari, andavano in barca; per aprire la strada e poter innalzare il padiglione centrale
principale, sul cui fianco una entrata con un
unico maestoso ed imponente festone floreale e, molto più recenti una palazzina all’estremo levante della strada, adibita
dapprima ad archivio ed ora a CUP; l’entrata carrabile da corso Magellano; ed
il contestato – ma vinto dall’ospedale – accesso alla camera
mortuaria posta al piano terra del pad. 9 – dopo la sbarra dei vari
civici di corso Magellano 1.
Sulla
facciata Antonio Quinzio disegnò sulla facciata
esterna un affresco oggi scomparso, sotto una nicchia culminante con la torre
di città sovrastante lo stemma col sole nascente ed un cartiglio con scritto
“ospedale civile”.






anno
2007
Forse,
suoi anche gli affreschi nell’interno dell’atrio
(nessuno spiega il
significato: in basso tre uomini nudi sorreggono altrettante bandiere, di cui
quella centrale crociata e quella a sinistra è alla base di una serie di figure
che si sublimano verso l’alto, forse a simbolo della tendenza ad elevarsi al
cielo; -al centro ed in alto- una figura femminile ammantata di rosso vista dal
basso, tende minacciosa un pugnale contro una nube nerastra, probabile simbolo
delle malattie),
 Atrio con lapide
Atrio con lapide
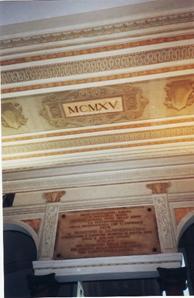


Atrio = soffitto laterale parete
soffitto centrale



Atrio = soffitto centrale Scale
= parete laterale
nel
quale è in evidenza una lapide dettata dal sindaco, l’on. Mario
Bettinotti che tramanda (foto sopra) «resti scolpita nel marmo / con
indelebile segno / siccome eterna vivrà nelle anime / la testimonianza / della
riconoscenza che l’ospedale / deve / al Municipio di Sampierdarena /
costruttore e donatore munifico di questa sede / dove il dolore umano / si
placa / nel magistero della scienza / nel palpito della fraterna carità / nel
sorriso della natura».
Su progetto dell’ing. Adriano Cuneo, nel 1913 fu eretto un secondo
lotto, a padiglioni separati (così era necessario allora, in
assenza di antibiotici, per contenere eventuali epidemie e contagi): due per medicina, due per chirurgia, uno per
maternità, uno per servizi - cucine, lavanderia, camera mortuaria -. Allo scopo venne sacrificata la
parte alta dell’ampio territorio appartenente agli Scassi: dalla quota 40 in
su, furono distrutti il lago artificiale superiore, l’ampia voliera (lasciando
la colombaia), l’ultimo ninfeo fatto a grandioso anfiteatro a due piani,
risalibili con rampe laterali; ed il rigoglioso bosco di macchia mediterranea.



lavanderia radiologia
suore ‘cappellone’-foto 1960


in costruzione pad. 3 e 4


pad.
6 pad.
7


pad. 8 con il sottostante lago superiore asciugato
idem pad. 8
Lo
sgombero dal sottostante nosocomio, avvenne in due tempi: il 15 sett.1915
-per necessità belliche
e la richiesta della villa sottostante da parte delle autorità militari per
loro uso; numerosi del personale sia medico che infermieristico erano partiti
per il fronte, frenando ovviamente il naturale progetto di ampliamento- si aprì di fretta per primo il pad.3 di chirurgia uomini (quando ancora non erano terminati
molti servizi generali come l’impianto ascensori e di riscaldamento
-quest’ultimo entrò in funzione solo nel 1923-). Particolare che riguarda
questo evento è l’evidente –ma da nessuno descritto- allargamento verso levante
di un centinaio di metri della proprietà ospedaliera, proprio a monte di corso Roma (poi O.Scassi). Quando il Comune acquistò villa e terreno degli
Imperiale-Scassi, quest’ultimo a levante era delimitato –come descritto nella
carta del Vinzoni- da una crosa chiamata vico
Imperiale la quale
procedeva diritta dal basso all’alto con piccola sbavatura che però diventa
enorme (un cento metri) appena sopra la torre dell’Ospedale ex-villa dei
Francavici. Evidentemente l’ente ospedaliero acquistò questi metri a est (e,
trattandosi di ‘eredità’ Francavici, forse il generoso P__che aveva regalato il
terreno per far salire via B.Piovera, non è esente dal pensiero che abbia
donato anche questa ‘fetta’ di proprietà) che determinarono: A) troncamento di via Imperiale (poi
via GB.Derchi) con
ovvia necessità di farla finire con una scaletta sbucando nella stradina
interna che poi diverrà via Carrea; B) solo così avere possibilità di far
entrare nella proprietà in possesso, due padiglioni affiancati.
Subito
dopo la prima riunione del Consiglio di amministrazione avvenuta il 14 mar.1916
e diretta dal presidente prof. Gallino, avvenne il secondo e definitivo
trasloco nel maggio successivo: il trasporto degli ammalati fu realizzato
tramite un carretto trainato da un asino – ambedue di proprietà dell’ospedale, finché poi non fu
comperato anche un cavallo ed un carretto speciale, utili anche per i
trasferimenti interni e per la cucina; solo nel nov. 1926 fu acquistato un
camion che sostituì il cavallo, non l’asinello che rimase col nuovo
carretto. La retta era stata fissata in rapporto alle possibilità personali:
gratuita per i poveri residenti in SPdA, e retta giornaliera per i più
possidenti. Limiti ai malati infettivi, esclusi gli affetti da TBC ma da
collocare separatamente.

Elenco donatori dell’ospedale
==anno 1916
cav.
Nasturzo Silvestro; comm Romairone (lascito); Derchi Luigina ved.; Lagorara
f.lli; Cassa R Ge.; Feltrinelli f.lli
==anno 1917
Nasturzo; DeAndreis
Menotti; Vassallo avv. Guglielmo; Carige
==anno 1918
Pittaluga
Luigi; Pittaluga Luigi (pro cappella erigenda); Paleari Angioletta; Nasturzo;
F.lli e s.lle del fu Macciò Natale cav.; Soc.Carbonifera Industriale It.; Michelini
Caterina ved. Bertorello; Rapallo fam.; Gatti Agostino; Balbi f.lli e s.lle;
soc. an. Calderai in rame di Cornigliano; Feltrinelli; Bertorello Salvatore; Liberti
Placido Enrico
Nel
1917, in una relazione pubblica, fu presentato su opuscolo il prospetto
completo del progetto, di come e dove l’Amministrazione prevedeva espandersi; i
tempi hanno fatto modificare molti di queste ipotesi, come si può constatare
nella foto sotto, compreso i giardinio della villa e l’attuale corso Magellano:
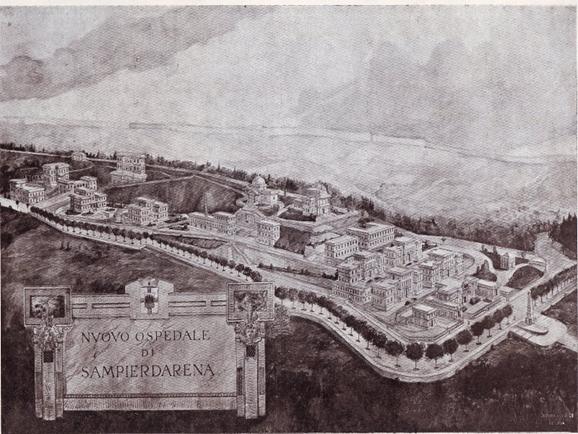
Nel 1919, aveva già 500 letti; si previde un sostanziale concorso spese
a carico del Comune di San Pier d’Arena (in più, alla sopravvivenza contribuivano altri Comuni vicini
per i loro ricoverati, l’usufrutto delle rendite patrimoniali, rette pagate dai
privati più abbienti, lasciti e beneficenze (come il cav. Nasturzio Silvestro, fornitore in forma
gratuita di ghiaccio), rimborso
spese della degenza di soggetti di altri comuni del regno, enti, iniziative e
promozioni varie).
In questo dopoguerra, - e sino al 1932 - le difficoltà economiche subentrate,
determinarono un rallentamento del previsto ampliamento, apportando però
miglioramenti sostanziali (gli
amministratori da 6 a 7; i medici da 12 a 17; gli infermieri -chiamati
sussidiari, comprese le 11 suore- da 45 a 120, operanti in tre turni
giornalieri ininterrotti).
Venne iniziato (apr.1924) il pad.8
-già chiamato
“padiglione per la tubercolosi”, progettato secondo le norme più recenti della
terapia, con 110 letti elevabili a 140, bagni “modernissimi e latrine distinte
per gli ammalati e personale”, cucina ad ogni piano, ascensore e
montacarichi-; fu completato nel 1926 assieme al pad. 7 della
maternità, iniziato prima, ma non ancora ultimato; venne avviato l’impianto a vapore centralizzato del
riscaldamento (fornito da impianto basale munito di ciminiera
ottagonale, alta 40 m.; fu abbattuta negli anni 1980 per la molestia recata ai
grossi edifici popolari costruiti nei dintorni dell’ospedale; tutte le tubature
– comprese quelle elettriche – scorrono sottoterra lungo un cunicolo che inizia
a ponente del pad. 8, è largo circa 2 metri ed alto altrettanto o poco più – ma
in alcuni punti assai di più - che serviva nell’antica villa da scarico
dell’acqua dal lago superiore a quello inferiore).
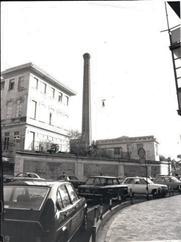



dove inizia presso il pad. 8 un tratto del cunicolo sotto
pad.1 e corso Scassi


sotto il pad. 7 con sbocco all’esterno
Il Comune donò all’Ente ospedaliero, il 25 sett.1926, tutti i sei
edifici eretti (5, pari
a 250 letti +1 centrale amministrativo) +
2 in fase di ultimazione (maternità
e tbc); da allora l’Amministrazione divenne autonoma (e si impegnò a ridurre la retta dei poveri del 25%; a “destinare
tutto ad uso esclusivo di Ospedale”, ovvero “mai essere adibiti a destinazione
diversa, né tantomeno alienati...”; al massino, se espropriati o cambio di
destinazione, il ricavo va investito in buoni fruttiferi e devolvere il reddito
a scopi benefici a favore dei sampierdarenesi per nascita e domicilio.
L’ultimo sindaco, il cav. Manlio Diana ebbe valorizzato
l’insieme pari a 6milioni; notaio Giuseppe Martinoia, rogito 25 sett.1926; con
vincolo di essere sempre a scopo assistenziale; con sussidio annuale portato da
840mila lire ad 1milione)
Solo i vecchi e cronici, dopo l’iniziale trasloco, nel 1919 ritornarono al Masnata;
nel 1929 vennero tutti trasferiti a Coronata, ma ben presto dovettero
essere riospitati a villa Scassi, alloggiandoli in provvisorie baracche di legno, dette allora “sezione cronici, oppure sanatorio” fatto erigere nella parte alta della proprietà per ospitarvi i
prigionieri austriaci, che se lo costruirono in legno preferendolo ad una
prigione in muratura.
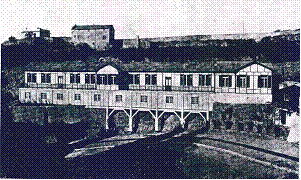

foto epoca 1930


anno
1997 anno 2002 –
eliminato l’amianto
Nel 1930
(anno VIII dell’EF) fu ristrutturato usando l’eternit ed è scritto su ‘Genova’
che fu adibito quale nuovo padiglione ad uso sanatorio per i tubercolotici,
essendo “in ottima posizione, con ambienti spaziosi, pieni d’aria e di luce, dalle
cui finestre si gode di un’ottima vista delle colline circostanti e del mare”.
Fu demolito nel 1998, ma in suo scheletro rimase fino al
2002; fu ricostruito nel 2006 completamente nuovo.
Dove è la sua base, fatta come piloni di ponte
fiancheggianti la salita mattonata, si intravedono residui di grottesche
(false stalattiti ) relative al contorno del lago anticamente esistente nella
zona.
Nel
1930 il comune di Genova, successore nel possesso dei beni sanitari,
decise
non pagare le spese con un saldo annuale a forfait, ma rimborsando all’ospedale
per i singoli malati, la singola retta giornaliera da far pagare, riferita alle
giornate di degenza effettivamente consumate (di base, in corsia o camera comune lire 14,50/die) stabilendo le differenze per
gli Enti, per gli altri Comuni, per la Casa di Salute, arrivando a diarie da 20
a 45 lire).
l
20 lug.1933 l’amministrazione degli Ospedali cedette al Comune di
Genova villa Masnata e l’area antistante necessaria per aprire via Cantore
Nel
1934 entrarono in funzione tutti gli ascensori interni (quello del pad.7 dovette aspettare
l’anno dopo); nel 1936 venne
iniziata sopraelevazione dei padd. 3 e 4, a
cui seguirono tutti gli altri.
Nel 1938, per un progetto di espansione, fu proposto l’esproprio di un terreno confinante a ponente - di
44mila mq e proprietà della marchesa Durazzo Pallavicini; ne verranno invece
poi acquistati solo 16mila mq (nei restanti mq molto più tardi verrà costruita la chiesa) posti a ponente delle cucine,

e
allora di proprietà della sua erede marchesa Negrotto Cambiaso (La DurazzoPallavicini probabilmente
fu Teresa, che ebbe figlio GiacomoFilippoV (1848-1921) sposo con Matilde
Giustiniani; morto questi senza eredi, la vedova sposò Pierino NegrottoCambiaso
in seconde nozze). Il numero dei
ricoverati era salito a 650 (di cui 200 affetti da tubercolosi).
La guerra del 40-45 impoverì gli organici e
la cassa; nel ‘40 fece scomparire la cancellata per il ricupero del ferro;
fece riaprire nella zona alta del parco, nel ’41, il “Giardino” per una grave epidemia di tifo;


il Giardino – ove ora
sorge il pad. 10 – l’arco dell’antico giardino aiuta a localizzare la zona.



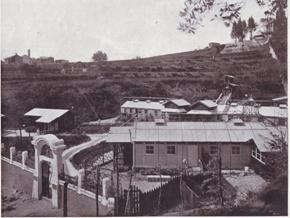
in basso a destra, la
cinta del lago superiore
Sempre
nel 1941, in zona bassa si costruì una galleria per evacuazione, cercando
di arginare il fuggi-fuggi disordinato di gente terrorizzata, specie di malati
e feriti, ma che risulterà pur sempre inefficace; nel ‘44 i bombardamenti
distrussero il pad. 7 e - parzialmente il 5 e 6 e la chiesetta del Giardino.
Dopo il 25 aprile, sotto i muri di cinta nell’altura, si descrive dei
‘partigiani’ nella frenesia della vendetta, fucilarono senza processo dei
collaboratori - o presunti tali - dei tedeschi.
Nel
1950 aveva presidente il geom. Manzini Oreste e
primari Albanese Andrea
(ortopedico); Bianchi Giovanni (radiologo); Canestro Corrado (ORL); Fulle GB
(chir); Dallera Nicolò (o.ginec); Polleri Pio (medic); Rossi Giovanni
(patologo); Rebaudi Ulisse (dermo); frola Enrico (medic); Vialetto Ernesto
(neurol); Fazio Giuseppe (medic.legale); Cisi camillo (ped); Magliano Eugenio
(medic); Marchesini Ettore (oftalm); Costa Luigi (medic).
Nel nov.1955 si deliberò la costruzione del pad.
10, salvando dei muri dell’antica villa, un arco di uscita dalla
proprietà cintata per immettersi nel boschetto superiore. Inizialmente vi fu
aperto un reparto di medicina, affidato all’ill.mo clinico prof. A.Marmont
(attualmente è adibito a servizio di medicina nucleare).


il pad. 10 negli anni 1960 una
nicchia votiva ricavata da grotta artificiale che arredava il lago
Sottostante
ad esso, e confinante col retro del pad.8 esiste tutt’ora una piccola
costruzione in muratura ora in abbandono, con torretta rettangolare munita di
tetto a pagoda, non segnalata nel rilievo del giardino fatto da Reinhard. era
una antica colombaia (nel cartello del restauro, è
chiamata ‘voliera’ ma –a mio avviso - erroneamente perché non è mai stata tale
(che però esisteva, ma vicino, e già da tempo abbattuta) quanto piuttosto colombaia:
sia perché essi – a partire dal campanile – erano usati quali postini di quei
tempi, sia perché da lassù i signori andavano a sparare al passo dei colombi selvatici) che è vincolata e tutelata dalla Soprintendenza, a
fianco della quale sono ancora 2 grossi gessi di animali che una volta ornavano
il sentiero. Nel 2006 è pressoché completato il restauro esterno ed, a buon
punto, quello interno. A monte di essa, sono stati costruiti due piani+tetto ad
uso box per auto.



ante restauro laterale
interno



soffitto, ante restauri i due
leoni, ante sistemazione
Il
26 novembre dello stesso anno, s.e. il card. G.Siri consacrò la chiesa (L’ospedale, nato in un clima decisamente laicizzato,
nell’anno 1908 aveva licenziato il cappellano, generando da parte dei cattolici
scritti di protesta, nonché un apposito comitato e raccolta di offerte per
riammetterlo a spese pubbliche. Da allora, mai eretto l’alloggio per il
sacerdote, e le suore ospitate in precarità (le ‘figlie della Carità’ o
cappellone, di san Vincenzo dè Paoli).



progetto sistemazione della Chiesa – attuale collocazione
(foto 1960)
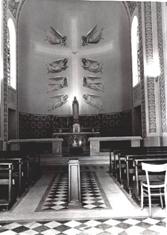
Circa l’edificio, l’amministrazione aveva previsto una
costruzione allo scopo, ma furono sempre ritardati i tempi finché una chiesuola
fu adattata in una baracca di legno, nel settore Giardino, poi coperta con il
famigerato eternit. Un più sostanziale discorso sulla chiesa iniziò
nell’ott.1933 quando fu cappellano il famoso don Giordano, con precisazione da
parte dell’Amministrazione di non voler spendere nulla di proprio. Seppur
raccolta una discreta cifra, ed approvato il progetto dell’ing. Ferrari, la
guerra fece rinviare di nuovo tutti i programmi. Solo nel 1954 padre Rinaldi
dei padri Camillani o Ministri degli Infermi (i Camilliani furono fondati da san Camillo de Lellis
nel 1582 e sono dediti ai malati indossando un abito talare con grossa croce
rossa sul petto),
costituì un comitato pro chiesa: ridotta all’estremo la spesa, spostando la
sede nell’area all’estremo levante anziché sopra il pad.7, promovendo lotterie
e beneficenza, nel 1955 fu eretto il sobrio edificio ad unica navata,con un
altare maggiore su cui domina la statua di una Madonna ‘Regina Mundi’, donata
dalla squadra di calcio U.S.Sampdoria, con retro affrescati degli angeli).
Il 13 dic.1959, con festosità interna, l’ospedale venne riconosciuto ed
elevato “di prima categoria”; si aprì la scuola convitto per infermieri professionali.
Nell’ott.1961 fu inaugurato il pad.9
a grattacielo, dedicato al dott. Peone Gandolfo, giù medico-sindaco di San Pier
d’Arena.
Nel 1982 si aprì con semplice cerimonia un attrezzato e moderno ‘centro ustioni’, poi ribattezzato‘grandi ustionati’,
con camere sterili e le più sofisticate attrezzature atte a combattere le
deturpanti e dolorosissime lesioni. La ‘sponsorizzazione’ avvenne per la
generosa donazione (con
la clausola dell’anonimato di Italo Scorza – alla sua morte-
della sua consorte Angioletta Mela-; 1894-1982, titolare della società in
n.c. Gerolamo Scorza posta in calata Gadda, grossa produttrice di legname
nazionale, importatrice di quello estero, segheria e deposito anche di
compensato, alberature e per riparazioni navali. Si assunse l’intero onere
economico dalla progettazione alla realizzazione della più moderna struttura;
dalla somma messa a disposizione, si ottennero anche due ambulanze e
l’attrezzatura per il centro ortottico)
Nel 1996, l’ospedale divenne Azienda,
ed assume il nome di azienda Villa Scassi. L’anno dopo fu inaugurato un
funzionale Pronto Soccorso, la cui struttura
muraria ben presto fu demolita (con trasferimento momentaneo al retrostante pad. IV) per far posto al modernissimo centro nominato DEA,
aperto nel 2001.



foto 1997 anni
1980


1990 con un solo fornice
Nel
1998 venne definitivamente sventrato la palizzata lignea del Giardino,
col contemporaneo inizio del programma di aprire ancora più in alto un eliporto.


foto 1 area a monte del pad. 10 con in alto zona posteggi e
verso il basso la rampa per arrivare all’eliporto; sulla sommità dei prati –
fuori area di proprietà ospedaliera – le case di Promontorio
foto 2 l’eliporto e – a destra – il muro cghe separa l’area
a salita superiore S.Rosa
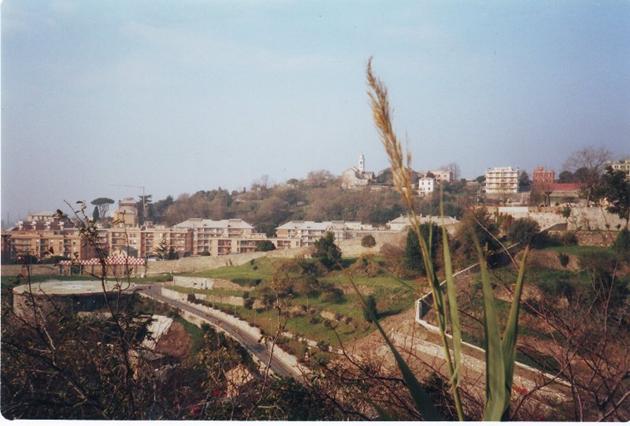
Non viene specificato da quando, ma l’intero complesso è vincolato e tutelato
dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Liguria.
Vengono rammentati saggi amministratori nelle figure dei presidenti Cavallaro,
Fraguglia, Saitta, Ferrando. Nel giu. 2001 venne ristrutturato il
P.Soccorso (ma, i
codici a colore fanno far aspettare anche delle ore, una volta con intervento
dei carabinieri).
Nel 2002 compare tra le strutture, la ‘clinica privata o casa di salute’, al piano terra del pad.5, gestita
dai medici stessi dei vari reparti ma anche aperta a tutti i professionisti
anche di altri ospedali, per medicina e chirurgia (aria condizionata, telefono,
frigobar, parcheggio riservato, non orari di visita). Questo trattamento ha favorito la scelta da parte di molti pazienti
paganti o assicurati, con ovvio beneficio dell’intero ospedale in cui vengono
usate le cifre guadagnate. Queste iniziative concorrono ad aumentare la
disponibilità, la scelta e la fiducia nei medici ed infermieri.
Così anche, stipulando contratti di appalto con
società esterne a livello internazionale, riguardanti la pulizia, il calore e climatizzazione, le fonti
di energia come la corrente elettrica ed il gas, lavanderia e ristorazione,
vigilanza e , ecc. notevole è risultato il risparmio e la funzionalità.
Da
questi anni, ampi e frequenti riconoscimenti di funzionalità, entrando nei 18
ospedali nazionali più innovativi e secondo per il costo giornaliero di
ricovero (--sotto la
guida del direttore Lionello Ferrando, dal 2003 tutto il sistema
informativo è ‘on-line’ ovvero computerizzato: eliminate in pratica le
lastre ed i referti, sostituiti da cd-rom --Nel 2003 l’ospedale è stato
soggetto ad un clamoroso furto di 14 seggiole antiche (‘600 e ‘700-;
probabili provenienti da villa Doria Masnata) -fotografate e catalogate- che
la Soprintendenza aveva valutato 40mila euro. -- Sempre dal lug. 2003 è partito
il progetto di un nuovo padiglione a monoblocco, da affiancare al 9:
ospiterà le più moderne attrezzature tecnologiche con la casa di salute
privata, e permetterà una completa e finale ristrutturazione funzionale di
tutto il nosocomio. Nel 2006 è in fase avanzata di costruzione).
===civ.20
assegnato a nuova costruzione nel gennaio 1955, divenne il civ.20 di corso
Magellano nell’ottobre dello stesso anno.
===civ.
2 fu distrutto, demolendolo nel 1957.
Nel nov.1953 e nel lug 1954 la Commissione Edilizia
comunale approva il progetto di costruzione di un caseggiato nella strada, non
viene precisato quali; nel 1963 la numerazione rossa e nera fu unificata
IL PARCO sopra corso
O.Scassi
La targa posta nel 1915 sull’arco di ponente (quello di levante fu demolito) esistente nel
corso stradale, è un tuttodire a riconoscimento: «a
testimonianza del giardino cinquecentesco - onde - Galeazzo Alessi per Vincenzo
Imperiale - il colle aprico - da valle a monte – imparadisava - …».
In effetti, in origine, tutto il giardino dalla
villa arrivava sino a Promontorio: era il più vasto possedimento terriero nel
nostro borgo, ed essendo rimasto tutto in possesso del Comune –anche se poi
frazionato in tre parti per necessità urbana ed edilizia- è l’unica cosa che ci
concilia con le scelte fatte nell’ottocento e novecento quando furono date –in
piccola parte complici i bombardamenti- maggiori concessioni a distruggere che
a costruire.
Furttenbach nel 1627 scrive il suo «Newes itinerarium
Italiae…» ed a proposito : “in cima, su un monte assai alto, vi sono due
bacini…c’è una graziosa passeggiata con la quale il cuore si può rallegrare”.
Le carte del Vinzoni (1757 e 1773), quella del Porro
(1830) e le vedute di Gauthier (1832) permettono captare i confini, la vastità
e varie localizzazioni di questa parte del parco.
Nell’origine, questa parte di parco (fa fede l’arco, che è stato conservato troneggiante
da solo in corso Scassi e che permette di confrontare con la pianta del
Gauthier) in basso inizia a livello del bordo inferiore del ‘Lago
inferiore’, ed arriva sino all’apice di Promontorio ove pare, perché informazione non sicura, che in questa zona, circa
subito sotto la chiesa di Promontorio, c’era una fontana dalla quale
iniziava l’utilizzo dell’acqua del torrente e che, -come la fonte Ippocrene-
iniziava il regno di Apollo e delle Muse: una fantastica Arcadia, una nuova
Elicona.
Nel poema, l’autore finge
essere accompagnato dalla musa del canto, Euterpe, a visitare un fantastico
paesaggio, con casa e giardino, dove la bellezza.
Il giardino nasce parallelo
al poema. L’acqua che scende, è l’asse ai cui lati si allarga la Natura.
Quest’ultima, emergente da una poliedrica situazione: la poesia del
proprietario indirizzato a quella Natura, quale via i fuga dagli affanni
quotidiani; la mitica fantasia in auge in quei tempi –da vedere anche nella
grotta Pavese-; gli architetti Donzello che –seppur prevalentemente rudi
costruttori- anche se liberi di agire debbono interpretare i non facili voleri
del committente «…sagace giardinier…/compor sapendo e accordare insieme/ e
beltà di natura e beltà d’Arte/ seppe imitar di bella donna il viso…»; la vera
natura del luogo che doveva essere interpretata ed artificiosamente plasmata ed
arricchita con piante possenti (querce, aceri, olmi, noci, platani, faggi) od odorose
(allori, pini -cedri, cipressi, abeti, tassi e bossi) o fruttiferi (meli, e
fichi, olivi, melograni, lentischi e mirti fioriti) o preziose piante di sapori
(come timo, rosmarino, salvia, ecc.) e, a terra, fiori come rose, narcisi,
gelsomini, garofani e violette.
Oggi, le varie mutilazioni
e tagli, hanno compromesso maleficamente l’interpretazione di questo incanto
Iniziando dal basso:
===LAGO INFERIORE dopo il viale centrale in salita (ancora esistente nel parco, descritto in via
A.Cantore), si arriva al lago artificiale, grande vasca
rettangolare (circa 30x40), posizionata in corrispondenza dell’attuale strada
e DEA (pronto soccorso. L’ingresso principale
dell’ospedale, o padiglione 1, fu eretto a levante della vasca).
Anche il Derchi, che acquarellò e dipinse lo specchio
d’acqua (Nocchiero così commentò «…la tavola del
Lago villereccio, con arconi, di Villa Scassi, ci offre tra acque chete e
riflessi iridati, l’ambito perduto, anzi perdutissimo, della tranquillità e
della pace, tutelata dai serrati filari di alberi dal fogliame verzicante e
dorato…»), evidenzia l’arco decorativo lungo il muro di cinta, e che fa
da riferimento a tutta la ricostruzione.
Nella visione del Gauthier -1832- il lago inferiore aveva
a monte un viale alberato (nel disegno,
affusolati ma probabilmente dei bagolari opportunamente potati), e si
arrivava ad un ultimo e terzo ninfeo, alto forse più dei due inferiori, a
grotta con pilastri, con superficie del tetto rettangolare (lato lungo in verticale), balconata ovale –e,
come disegnato da GB Derchi, con accesso a rampa bilaterale arrotondata- alla
cui base erano due leoni accucciati. Ospitava due grosse statue marmoree, di
Flora (dea dei fiori) e di Pomona (frutti. A significato che, sopra esse, iniziava
quella parte di proprietà non più destinata a giardino ma alla parte produttiva
e generativamente spontanea della Natura). Da questo ultimo ninfeo
partiva un muro delimitante, che arrivava sino al muro esterno di levante. E
per il Gauthier, il prospetto dei possedimenti della villa finivano qui, senza
la parte superiore.
=Nei primi anni del 1900, Fravega ricorda che nel lago si
andava in barca, mèta di innamorati, di chi desiderava andare ‘all’aperto,
come i pittori Derchi e Conte, e di chi desiderava andare a ‘ribotta’ verso la
trattoria-osteria posta più in alto, dove salita Sup.S.Rosa compie curva a
sifone e dove, come dimostrato dalla carta del Porro e testimoniato da altri
più recenti (sig.Bertaglia) che ricordano ancora in epoca postbellica, c’era
una grossa vasca sopra via dei Landi.
===LAGO SUPERIORE
=Nelle intenzioni dell’Imperiale, doveva essere sia
riserva di acqua per il lago sottostante e per la villa, e sia peschiera dove
allevare fresco d’acqua dolce. Ne ‘Lo Stato rustico’, il GioVincenzo Imperiale
descrive (1611; vedi a ‘salita Imperiale’)
un giardino fantasioso ed ideale, ma senz’altro che fece coincidere col suo
pensiero dai due costruttori del parco. Pertanto
Dalla prima rappresentazione vinzoniana tratta dal libro
dei domini della Serenissima, si trae la conformazione quasi quadrata con ampio
semicerchio a monte (con raggio di circa 15m.) in area raggiungibile dall’estremo
viale del parco tramite lunga creuza diritta (dalla villa, tre volte il tratto
per arrivare al primo lago), circondata in tondo da alberi, con a ponente una
scalinata che arrivava in alto ad una casa tutt’ora esistente lungo salita
Sup.S.Rosa, e che da monte raccoglieva le acque in discesa da san Bartolomeo
della Costa.
Alla base del lago, forse anche come contrafforte alla
pesante spinta dell’acqua, fu eretta - ed esiste ancora, ristrutturata negli
anni 2006-7 - un edificio detto ‘Piccionaia’. Da lassù, i signori
Imperiale potevano andare a caccia quando era tempo del ‘passo’ dei colombi
provenienti da sud, e sia conservare i piccioni ad uso postale.

Invece a nord della vasca, c’era un gruppo marmoreo
raffigurante Nettuno – con tridente - circondato da Teti ed Anfrite. Nel suo libro, l’Imperiale poneva Petaso che con lo
zoccolo smuoveva i sassi dove terminava il monte e sgorgava un fiume
l’Ippocrene, la cui acqua vivifica tutto il modo sottostante, comprese le
statue marmoree delle dee, delle ninfe, dei putti e di tutti gli animali veri o
fantastici.
=Nella ristrutturazione dello Scassi, sembra che nulla fu
modificato in questo settore del giardino.
=Divenuto proprietà comunale, questi trovò ovvio e
necessario sacrificare l’area a monte, per erigervi il nuovo ospedale, mandando
perduto buona parte del terzo dell’intero possedimento dedicato al verde.
E, a mio avviso è con questo passaggio di proprietà che
nella parte alta, sopra il lago, fu concesso l’utilizzo a campo scuola di tiro a segno per i gli iscritti alle società
sportive, in particolare i tiratori di carabina da prepararsi alle guerre con
quel nuovo tipo di fucile (che poi si distinsero
con Mosto e Garibaldi). Finite le guerre risorgimentali, questa società
divenne -fino alle prime decadi del 1900- poligono per il tiro al piattello e
forse anche al piccione (con il sindaco Diana presidente). Infatti in una
cartina preparatoria dell’inizio lavori dell’Ospedale, compare ancora la
scritta “tiro a segno”.
Nel 1910, in particolare per iniziare i lavori, furono
eliminati e vi vengono descritti
===una vasta cisterna d’acqua, di circa 30x50
metri (vedi Nocchiero. GBDerchi pag.47),
che formava un laghetto contornato di canne, alberi d’alto fusto e spontanei
‘limoni di muro’ i cui frutti erano usati fritti in impasto con farina, uova e
zucchero; in esso, dopo essere divenuto proprietà comunale, pur essendo
proibito pescare o nuotare, era permesso farci un giro in barchetta, divenendo
meta di innamorati o di chi marinava scuola;
===vicino, come già detto sopra, in una rustica
‘villetta’, era stata attrezzata una trattoria, ove potersi ristorare
nelle ‘gite’ domenicali, alla pari di quelle rimaste più famose a Promontorio.
Negli anni dopo il 1990, nella parte apicale,
sopra il padiglione 10, un ampio appezzamento più o meno a dirupo ed ancora a
macchia mediterranea selvaggia, sino ad ora abbandonato salvo un piccolo campetto
da pallone per i dipendenti, è divenuto zona di atterraggio degli elicotteri
che nella previsione dirigenziale serve al trasporto rapido di certi malati ed
a parco posteggio d’auto.
DEDICATA
Della
famiglia Scassi poco si sa, essendo andate disperse le carte relative.
Appare originaria di Arenzano (testata con documenti catastali e diritti
patronali datati 1600).
Capostipite fu il primo Onofrio (medico, che ebbe tre figli : Emilio, Nicolò
(divenuto vicario nella chiesa di san Pietro in Banchi) ed Agostino.
Quest’ultimo pure lui divenne medico a Cogoleto: coniugato
con Francesca Agnese, fu padre del nostro Onofrio, di Gerolamo (1777-1842,
morto vedovo senza discendenza) tre sorelle (Battistina
Maria (15.O1.1771), Battistina Giovanna Maria (10.02.1773) e Giovanna
Maria (10.02.1775), e
di Raffaele (1785 che nacque a Rapallo quando
il padre vi portò la famiglia (1775.6) avendo vinto la condotta medica; a 28
anni già aveva carica di consigliere imperiale di Russia e divenne armatore,
imprenditore ed anche governatore di una zona sul Mar Nero per conto del
governo russo. Morì in Russia. celibe nel 1840circa).
Il
Nostro Onofrio. Celeberrimo medico e politico ligure a cui furono imposti i
nomi di Onofrio, Emilio, Maria.
Nacque
in Cogoleto, il 2 sett.1768 primogenito da Agostino e da Francesca
Agnese di Ambrogio, di
antica e facoltosa famiglia di Cogoleto.
Il giovane fu cresciuto all’amore ed onore della
cultura, intesa come arte da acquisire indipendente dalla professionale: nei
suoi ascendenti materni e paterni, tutti erano laureati in legge, medicina o
altre facoltà coltivate per pura passione e non per necessità economica o
sociale.
Già a 12 anni (1780) fu iscritto al seminario arcivescovile genovese; ed
a 16, seguendo un corso di filosofia e matematica, fu capace di sostenere in
pubblica disputa, tesi
filosofiche (in quei tempi illuministi, la
filosofia era alla base ed a coronamento di tutto lo scibile) e scientifiche che ebbero l’onore della pubblicazione, dimostrazione di
una già vasta cultura in un candidato di quell’età.
Il 4 agosto 1784 sostenne all’Università ed in pubblica disputa ben 136
tesi di metafisica, morale, scienze fisiche e naturali (nessuna in medicina),
pubblicate e dedicate a Giacomo Filippo Durazzo.
Terminati gli studi con la laurea a Genova in scienze mediche e filosofiche
dibattendo temi di filosofia e di matematica(5 luglio1788). Come
premio, andò a perfezionarsi a Pavia (alla scuola del famoso igienista G.Pietro Franch e del
chirurgo A.Scarpa, allora i più illuminati maestri nell’ambito medico, inteso
come disciplina applicata e suddivisa in modo diverso dall’ attuale:
fondamentali erano l’anatomia; l’igiene che intuendo, ma ancora non conoscendo
i germi, era generica e sui generis e non condivisa come causalità delle
malattie infettive; la chirurgia che non possedeva ancora gli anestetici e che
abbandonava al loro destino i feriti di guerra salvo drastiche amputazioni; la chimica farmaceutica con i suoi principi derivati solo dalle erbe
naturali).
Poi ancora si mise a girare in contemporanea l’ Europa -come d’uso nella sua
famiglia- per ampliare gli orizzonti culturali al di sopra della notevole
grettezza e pigrizia dell’aristocrazia genovese (specie in Inghilterra, dove nel 1792, da due anni
faceva parte del club studentesco parauniversitario Royal Medical Society senza
esserne formalmente iscritto. Ad Edimburgo, nel gennaio di quell’anno vinse il
tema proposto dal club e poté quindi dissertarlo in pubblico (aveva stilato
un lavoro scientifico “de foetu humano” (scritto in latino, oggi valutabile
errato, sotto il profilo dottrinario, avendo seguito teorie allora prevalenti
ma scorrette); così a novembre divenne membro onorario del club stesso.
Sicuramente non poté non aver sentito parlare di Edward
Jenner, medico britannico, che in quegli anni pubblicizzava le sue esperienze e
che negli anni attorno al 1796 aveva messo a punto e capito il metodo di
immunizzazione contro il vaiolo (inoculando il virus proveniente dalle vacche -da
cui vaccinazione-; ed ancora ben lontani da Pasteur –che solo dopo gli anni
1860 iniziò a descrivere l’origine batterica delle malattie infettive; e
vent’anni ancora dopo, necessari a porre le basi definitive della
vaccinazione-).
A 24 anni (1792) venne a Genova per iscriversi al Collegio di Medicina (allora non ancora facoltà a sé ma
inclusa nella antica corporazione di filosofia , che dava l’abilitazione ad
esercitare la professione); e due anni
dopo gli toccò l’onore di pronunciare il discorso inaugurale per l’insediamento
dei nuovi serenissimi senatori di fronte al doge Giuseppe Maria Doria, in un
momento in cui il consesso deliberante era politicamente diviso tra i
conservatori e gli innovatori fu molto abile a elogiare i nuovi tempi pervasi
di idee egualitarie ed evolutive post rivoluzionarie, ed in contemporanea far
basamento sulle tradizioni e sulla conservazione dei principi più saldi, senza
mutamenti profondi (a
Genova: una parte dei nobili e popolazione -capeggiata dal farmacista-droghiere
di via Luccoli Felice Morando e dal medico Antonio Mongiardini- erano
filofrancesi, quindi riformatori delle istituzioni; la Francia stessa spingeva
con minacce più o meno velate per favorire l’ allargando delle basi
dirigenziali ai borghesi, e che tutti i cittadini potessero accedere al governo
tra essi, soprattutto i giacobini; mentre Massena occupava Oneglia.
Altra parte dei nobili, preti e popolo, era invece
conservatrice, mirata a rimanere legata alle consuetudini e norme immutate dal
1576, quali la neutralità ed autonomia della Repubblica senza aperte alleanze:
sfilavano per i paesi e strade al grido di “viva Maria” oppure “morte ai
giacobini”.
In Europa, l’Inghilterra favoriva gli equivoci che potessero
mettere la neutralità della Repubblica in situazioni di grave disagio: tipico
l’incidente della fregata francese ‘Modesta’, predata e con l’uccisione di
alcuni marinai il 6 ott. 1793 da due navi inglesi mentre era ancorata in porto:
arrivò il 9 sett. 1796 al Senato l’ingiunzione di pagare alla Francia una
ammenda di 4milioni (Merega dice 14) di indennizzo perché il fattaccio era
avvenuto in acque territoriali nostre (in più si ingiungeva la sospensione di
tutti i processi intentati a sostenitori della causa francese, l’interdizione
perpetua a pubblici uffici per gli avversi, l’interdizione di tutti i porti
alle navi inglesi e la cessione per utilizzo dei porti di Vado e Spezia).
Mentre il Senato valutava le pesantissime richieste, a peggiorare la situazione
una incursione inglese fu effettuata l’11 sett.1796 sul lido sampierdarenese e
pochi giorni dopo fu accidentalmente ucciso un soldato francese in rissa con
marinaio inglese. Il destino metteva il cappio attorno al collo della
Repubblica Intanto, anche i Piemontesi per sé e l’Austria per la Lombardia,
erano alla continua ricerca dello sbocco in mare).
Dopo un addomesticato plebiscito, il 6 giugno 1805 Napoleone
da Milano decise per tutti: decretò l’annessione di tutti i territori della
Repubblica Ligure all’Impero francese, con abolizione della Costituzione Ligure.
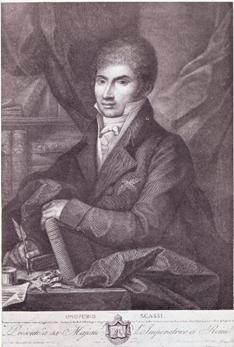 Forte delle
conoscenze raccolte all’estero, ricevette pressoché subito dopo (1795)
una missione nel ponente ligure, per una strana epidemia di ‘febbri
putrido-biliose’, diffusasi nella popolazione e nelle truppe francesi dimostrate dipendere dalle inesistenti
precauzioni igieniche in località sovraffollate come carceri, ospedali, truppe; Massena, al comando di un corpo di spedizione non perfettamente
organizzato promosso contro il Piemonte e l’Austria invasori della riviera di
ponente, aveva occupato Oneglia creando una situazione pericolosa non solo
politica per la mossa militare precorritrice di guerra più vasta, ma anche
sotto il profilo sanitario). Si mise in
luce per le sue straordinarie qualità e capacità nell’assolvere il caso, seppur
con gli scarsi mezzi offertigli . Così che, da questa prima esperienza che gli
fruttò il posto (1796) di coadiutore di medicina teorica a Pammatone e
di professore di fisiologia e filosofia nell’Università l’anno dopo, giunse
gradatamente a cariche sempre più responsabili
Forte delle
conoscenze raccolte all’estero, ricevette pressoché subito dopo (1795)
una missione nel ponente ligure, per una strana epidemia di ‘febbri
putrido-biliose’, diffusasi nella popolazione e nelle truppe francesi dimostrate dipendere dalle inesistenti
precauzioni igieniche in località sovraffollate come carceri, ospedali, truppe; Massena, al comando di un corpo di spedizione non perfettamente
organizzato promosso contro il Piemonte e l’Austria invasori della riviera di
ponente, aveva occupato Oneglia creando una situazione pericolosa non solo
politica per la mossa militare precorritrice di guerra più vasta, ma anche
sotto il profilo sanitario). Si mise in
luce per le sue straordinarie qualità e capacità nell’assolvere il caso, seppur
con gli scarsi mezzi offertigli . Così che, da questa prima esperienza che gli
fruttò il posto (1796) di coadiutore di medicina teorica a Pammatone e
di professore di fisiologia e filosofia nell’Università l’anno dopo, giunse
gradatamente a cariche sempre più responsabili
La sua capacità di districarsi da impegni settoriali (seppur ‘fiutando’ l’inarrestabilità
delle idee progressiste) e di tessere
una trama con le autorità politiche (le quali, per le difficoltà di comunicazione, godevano di
elevate autonomie decisionali), lo portarono
a gestire eletti incarichi pur mantenendo un contegno molto riservato,
dignitoso e tempestivamente indipendente, senza farsi trascinare dallo
scegliere correnti politiche particolari (proprio mentre le idee innovative sconvolgevano la
mentalità tradizionale dei colleghi più anziani creando un ambiente di forti
tensioni, disordine organizzativo negli ospedali, indisciplina gratuita e
discordie; ma non solo in campo sanitario: da Parigi provenivano e dilagavano
moda del vestire e delle acconciature, gestione di feste fino al colore delle
carrozze, stile dei mobili e moralità. Si stava –con non discreta violenza e
terrore- antiteticamente- imponendo la libertà); così si dimostrò subito dopo, uscendo dal Collegio dei medici; e così
altrettanto lo portarono a sottrarsi alla donazione di una decorazione offerta
da Napoleone stesso ai propri fautori.
Nel 1798 divenne professore alla cattedra di medicina teoretica,
presidente del Collegio dei medici e socio dell’Istituto Nazionale (un solidalizio culturale politico,
che ebbe breve esistenza, ma che lo elevò a cariche sempre più preminenti). Per incarico del ministro degli interni della
Repubblica Ligure democratica presentò un piano di ristrutturazione degli studi
medici, che senza rompere l’antica tradizione, prevedeva nei particolari
l’esercizio di tutti i componenti, dai professori agli infermieri, in un
innovativo metodo di riforma ed organizzazione che, per la fretta di essere
applicato si rivelò un guazzabuglio ricco di errori ma pur sempre ‘il male
minore’ rispetto al caos esistente .
Nel 1799 e fino al 1803, nel periodo estremo dell’assedio a
Massena, divenne a 31 anni presidente della commissione sanità: fu incaricato
nel momento più grave dell’assedio e dell’epidemia conseguente, della lotta
contro “febbri d’ogni indole più maligna (le petecchiali, probabilmente da ipovitaminosi C, particolarmente
infierivano così nell’umile casolare del povero come nei marmorei palazzi dei
ricchi”; il tifo, la peste ed il colera che dilagavano tra le truppe –
francesi, austrianche e marinai
inglesi
- e la popolazione, favorite dalla ovvia carestia, dall’assenza di igiene, dai
numerosi feriti e morti da seppellire: in solo tre mesi erano decedute oltre
4500 persone su una popolazione di poco inferiore alle 100mila più i soldati;
al ritmo di oltre cinquanta al giorno).
Dopo la battaglia di Marengo (14 giugno 1800) il rientro in città dell’esercito
cisalpino ci portò il parmense Giovanni Rasori, ingegnoso chirurgo che aveva
assunto anche incarichi governativi e qui fu inviato per coordinare le
operazioni sanitarie già intraprese dallo Scassi, mirate a debellare le varie
carenze alimentari e sanitarie. Le imposte severe regole igieniche e di
prevenzione, e la battaglia contro operatori indisciplinati ed incapaci tra cui
alcuni sanitari che si rifiutavano di andare a curare i malati nel lazzaretto,
ridussero rapidamente e drasticamente la mortalità, fino a domare le epidemie.
Lui stesso presentò lavori sui calcoli biliari e sulla scrofola; con questo
incarico approfittò anche per favorire -primo in Liguria e contemporaneo ad
altri illuminati, in Italia- l’introduzione del vaccino di Jenner contro il
vaiolo, e pubblicando nel 1801 le “ riflessioni sulla vaccinia ” (dopo aver letto il trattato dello
Jenner portatogli a Genova dall’amico medico inglese Batt, ed aver ricevuto dal
prof. Odier del materiale necessario per l’innesto. Aveva iniziato nel 1799 le
prime inoculazioni in un bimbo di 32 mesi figlio del negoziante Tollot, e
successivamente in un altro bimbo di tre anni figlio di un certo Marrè; ma la
tecnica fu adottata ufficialmente nell’anno 1800: dall’aprile 1800 ottenuto da
Parigi il pus vaccinico, si iniziò nell’ospedale Pammatone una regolare pratica
preventiva ed una campagna di informazione contro tutte le forme di supponenza
ed arretratezza, basate solamente su eventuali errori o imperfezione dei mezzi
usati o imperizia dei medici praticanti. Fiorato gli riconosce –tra i tanti-
anche il merito di essere stato uno dei primi a superare le barriere nazionali
delle scoperte scientifiche, vantaggiose per tutti.
Il poeta genovese Gioacchino Ponta, ne tessé la lode
asserendo “…tu primo, o Scassi, alle materne arene - dalla Senna recasti il
dono e il lume – del Vaccin tesor…”; nel 1811 a Maria Luigia imperatrice e
regina, fu donata una incisione con i ritratti di Jenner inventore, di
LaRochefaucaud Liancourt il primo ad introdurre la vaccinazione in Francia, e
del sig. dott. Scassi, già Senatore di Genova, cavaliere dell’ordine reale
delle due Sicilie, professore e decano della facoltà di medicina all’Accademia
Imperiale di Genova, il primo che praticò la vaccinazione in Italia) .
E’ sempre del 1801 la partecipazione alle ‘Memorie’,
quadrimestrale della Società Medica di Emulazione di Genova
Così la scalata sociale si avverò raggiungendo sempre più alti incarichi
direttivi amministrativi (in
genere sempre sanitari ed accademici) tipo
venire a far parte (1803) del Consiglio generale del Dipartimento
dell’Entella, (durante
il periodo storico dell’annessione della Liguria alla Francia e della
cessazione dell’indipendenza della Repubblica di Genova, la Repubblica era
stata divisa in sei giurisdizioni presiedute da un provveditore; il Nostro
accettò l’incarico ma in realtà non lo svolse non riuscendo a muoversi da
Genova); e presidente del Collegio e
Società medica di emulazione (ovvero basata sullo stimolo ai 24 membri a produrre studi clinici da
relazionare ogni quindici giorni, divenendo antesignano dei moderni simposi e
congressi).
Fece
redigere un nuovo ed aggiornato testo di farmacopea; partecipò alla
costituzione della Università ed alla fondazione della “Società medica d’emulazione”,
nonché alla commissione per la riforma universitaria (inizialmente trasferendo l’insegnamento dall’ospedale Pammatone a san Martino, mise
le basi al moderno corso universitario di abilitazione, formato da tre anni di
medicina teorica seguiti da altri tre di medicina pratica, con esami per aver
diritto al diploma di libero esercizio. Dopo vari tentativi poi, nel 1803
stabilì che i professori docenti fossero definitivamente ed unicamente
assegnati all’ Università, inquadrando così in forma definita il corso nuovo
della vita universitaria) .
Divenne senatore nel 1804, al culmine dell’ ascesa
politica; vivendo gli ultimi spasimi della Repubblica: fu parte della
commissione inviata a Milano per offrire a Napoleone l’annessione alla Francia,
e quando l’imperatore scese a Genova (1805), a lui toccò il discorso ufficiale
di ricevimento.
Nel 1806 lo leggiamo nelle ‘Memorie’ stampate dall’ ‘Instituto Ligure’ celebre istituzione fondata nel 1797
composta dalle più eminenti personaggi della cultura locale e che poi diverrà
Accademia imperiale delle scienze e belle arti.
All’inizio del 1815 -secondo le norme istituite dal Congresso di Vienna- Genova
fu definitivamente privata della propria autonomia, venne inglobata nel nuovo regime
sabaudo, e socialmente divisa in due classi sociali (nobili e borghesia); nel riordinamento vennero soppressi l’Istituto
nazionale (era nato nel
1798, divenne ‘Accademia Ligure’, e di esso era presidente) e la Società medica d’emulazione. Ma già assai
prima di questa data, il governo piemontese forte della promessa di poter
occupare la Liguria, già si interessava alla qualità politica delle persone di
prestigio: lo Scassi da una relazione di un funzionario della polizia sabauda
già inserito a Genova prima (1814) dell’annessione viene descritto “è reputato
un buon Medico, fu uno dei Capi della Rivoluzione di Genova. Nel Governo
Democratico ha sostenuto più cariche e nel 1803 da Napoleone fu nominato
Senatore. È nel numero degl’ Indipendenti”. Quanto abbastanza per dire che era
stato coinvolto nel governo francese; il giudizio era quindi che era opportuno
scartarlo.
Invece, la descritta e conservata sua equidistanza politica (non altrettanto fortunata fu
l’identica ideologia della Repubblica, perché fu punita da interessi politici
superiori) gli consentì di mantenere
tutti i precedenti incarichi anche dopo l’annessione al Piemonte; la polizia
piemontese qualche anno dopo ebbe modo di classificarlo ‘pessimo
napoleonista, democratico, libero muratore’. Anzi, a 47 anni come Decano della
facoltà (nel desiderio
da parte del re di accattivarsi i favori delle migliori personalità della
borghesia genovese più colta e professionista), fu introdotto alla corte sabauda col titolo di medico onorario, e
gli fu affidato l’incarico di riorganizzare il comparto sanitario del regno,
producendo successive riforme, migliorative della prima effettuata nel 1803.
Da grande dignitoso personaggio, in questo periodo rimase volutamente piuttosto
emarginato nel grosso avvicendarsi a corte; così astenendosi da particolari
impegni politici, rivolse la sua attenzione alla pratica locale: restaurò il
Collegio di Medicina dell’Università (continuandovi lo Scassi l’insegnamento in anatomia e
fisiologia; il nuovo regolamento stabiliva l’obbligo dell’insegnamento usando
unicamente la lingua latina), e la
Commissione di Sanità di
cui il Nostro divenne parte fondamentale e in cui nel 1819 promosse la nascita
di una giunta superiore per la vaccinazione; tutte le proposte in questo
settore a lui caro, lo portano ad essere
riconosciuto quale il
precursore dell’odierna igiene pubblica.
Nell’aula magna del
DIMI una targa ricorda : “preceduta da lunga e onorata serie di Lettori di
medicina teorica e pratica, di cui restano memorie sicure fin dall’anno 1635,
veniva -con decreto degli ecc.mi sigg. dodici Protettori dell’Ospedale Grande-
istituita nel 1789 la CLINICA MEDICA, che da allora continuò sotto la direzione
dei clinici prof. Nicolò Olivari (1790-1819)- Onofrio E Scassi
(1819-1824)-Antonio Mongiardino (1824-1836)…” .
L’Università non si fece coinvolgere nei moti
studenteschi del 1821; il padre di Giuseppe Mazzini, Giacomo, lo sostituì
nell’insegnamento alla cattedra di anatomia, e lo Scassi lasciata anche la
Clinica Medica, divenne componente principale della Deputazione degli studi,
organo cui spettava l’onerosa sorveglianza disciplinare e didattica
dell’Università, interessandosi in genere benevolmente dei giovani che venivano
vessati dalla polizia di Stato, come Giuseppe Mazzini ed i fratelli Ruffini. Si
veniva preparando una nuova generazione, con diverse aspirazioni confusamente
rivoluzionarie, e orientata verso altri ideali: toccò al Mazzini dare ad essa
un indirizzo unitario più preciso, che mise politicamente da parte persone di
qualità come lo Scassi, il quale però da buon moderato rimase soddisfatto
della propria opera e del proprio valore professionale . Negli anni che
portarono ai moti del 1821, la situazione in città -specie tra gli studenti-
non era idilliaca ma aveva in lui un dirigente di larghe vedute e non certo un
autoritario aguzzino, permettendo così la crescita di quei fermenti come i
fratelli Ruffini, Federico Campanella, F.Rosazza, GB.Castagnino .
Finché anche l’Università fu chiusa nel 1831 per motivi
politici rimandando per quattro anni gli studi esclusivamente nell’ ospedale
cittadino .
Il 26 gennaio 1812 aveva sposato Angela Saccomanno, dalla quale il 27
maggio 1815 ebbe il figlio Agostino (è probabile a sua memoria che sul ninfeo della villa, oltre
alle lettere sovrapposte OS –per Onofrio Scassi- ci sono anche –anch’esse
sovrapposte- le lettere AS. (E non SA come io pensavo
inizialmente, riferendole a sant’Angelo, in quanto dovrebbero aver avuto anche
la I di Imperiale). Per ovvia conseguenza al centro c’è
uno stemma che per logica è della famiglia
(anche se non compare
in nessuna pubblicazione da me letta).
Il 19 apr 1816 (11.647
e Parma dicono nel 1801. Prima, all’inizio della sua carriera era stato
residente al Carmine; poi –censimento del 1808- abitante in via Garibaldi
(allora ‘via Nuovissima’ al civ.260 già f.lli Cambiaso; poi –1818- sempre in
‘via Nuova’ civ.871 nel palazzo Cattaneo (oggi civ.8) ove morì: Parma scrive
che detto palazzo fu comprato dal conte Scassi nel 1825-50), già essendo proprietario di vaste terre presso
Voghera, divenne proprietario (notaio Sigimbosco) della villa “la Bellezza” (allora del principe Giulio
Imperiale di sant’Angelo, ed in gravissimo stato di abbandono dopo i fatti
bellici austro-francesi del 1799-1800).
La restaurò affrontando ingenti spese, affidando l’incarico architettonico a
Carlo Barabino (1768-1835), quello ornamentale a M.Canzio e per le plastiche a
G.Centenaro (F.Baratta ?); fece incidere sulla porta “ Onophrius Scassi dirutum
rifecit”; ed andò a viverla quando era rifiorita in tutta la sua bellezza,
in un paesaggio ancora idilliaco e paesano del borgo, prima che la ferrovia-le
industrie-la sovrapopolazione-le strade e le case attorno ne sconvolgessero
il contesto; da allora è più comunemente conosciuta come “villa Scassi”.
Dagli eredi la villa fu venduta nel 1886; e dal 1926 è proprietà del Comune
Intanto, nel 1819 diventa il secondo direttore della Clinica Medica
universitaria genovese (succeduto al prof Nicolò Olivari, docente nel periodo
1790-1819), restò in carica sino al 1824 (quando fu succeduto dal terzo,
Antonio Mongiardino); poi, divenuto medico Ispettore degli Ospedali (nomina
sostenuta dall’amico Antonio Brignole Sale) venne pure chiamato a far parte del
direttivo della città, dapprima come decurione (nomina vitalizia),
poi come procuratore, infine (1830-3) per tre anni come sindaco di seconda
classe (ovvero proveniente dalla borghesia, ma appoggiato a Francesco Lamba
Doria per la nobiltà; in
un momento di gravi tensioni politiche interne e di tesissimi rapporti con
Torino e soprattutto di scarse risorse economiche. Con questi incarichi
promosse nel 1825 un importante rinnovamento edilizio su disegno di Carlo
Barabino (tra cui il
grande teatro lirico intitolato a Carlo Felice: fu lui a ricevere i sovrani il
giorno dell’inaugurazione);
un solido ponte sul Bisagno in sostituzione di quello travolto nel 1822;
strade carrozzabili con le riviere; ampliamento del porto; sistemazione di
piazza Fontane Marose; l’inizio lavori del cimitero di Staglieno (portato a termine dopo una grave
epidemia di colera che nel 1836 falcidiò la città); e l’apertura di un ospedale per i malati di mente
collocato vicino all’antica porta degli Archi ).
Il 2 luglio 1830, in aggiunta di tutti i
riconoscimenti ottenuti, re Carlo Felice lo nominò conte, di San Giorgio, dal nome delle sue
principali proprietà nel comune di Santa Giulietta, oggi in Lombardia, nella
provincia di Pavia e re Carlo Alberto
appena eletto al trono personalmente gli conferì la ‘croce di cavaliere o commenda,
dei santi Maurizio e Lazzaro’ (durante una visita alla città: allo scopo gli fu preparato in
Sampierdarena un arco di trionfo; dopo la sua costruzione arrivò la missiva che
il re non voleva si spendessero soldi pubblici di celebrazione: si dovette invocare
il permesso di non abbatterlo poiché l’opera era ormai compiuta e la spesa
fatta. Fuori la porta della lanterna, furono consegnate le chiavi della città). Era insignito pure del titolo di cavaliere
dell’ordine di s.Anna di Russia.
Nel
1831, per migliorare la situazione sanitaria della città, partecipò a
costituire una associazione assistenziale, chiamata ‘N.S. della Provvidenza’
per la cura a domicilio degli infermi poveri. Pagava una o più quote annuali di
lire 20
Morì in città nella notte del 9 ago.1836, lasciando i suoi beni al
figlio (Vitali scrive
che Marcello Durazzo comunicò la morte alla regia Deputazione nella seduta del
22 sett. 1836, dopo che da vari mesi risultava assente alle riunioni).
La ‘Gazzetta di Genova’ ne annunciò la scomparsa,
dedicando un ampio necrologio
Numerose
le tracce scientifiche: scritti e memorie scientifiche, provvedimenti decisivi
e di svolta nell’educazione, nella cultura e nell’organizzazione sanitaria; in
un’epoca di gravi, travagliati e travolgenti eventi politici .
Pochi giorni dopo la sua morte, l’unico figlio - Agostino,
il ‘giovane conte Scassi’ dalla sospettosa polizia fu sospettato essere autore
di scritti anonimi a sfondo repubblicano e liberaleggiante. Dal 1831 faceva
parte della Associazione della Provvidenza (vedi sopra) per la quale pagava la
quota annuale di lire venti. Sposatosi il 13 agosto 1834 a San Pier d’Arena con
Rosa figlia del marchese Stefano Rivarola (vedi
alla via omonima). Nella villa sampierdarenese gli nacque il 13 agosto
1836 un figlio, a cui fu dato il nome del nonno (alla coppia nacque poi anche
una figlia la quale a sua volta,
sposata con un Sauli, ebbe due figli Ambrogio ed Onofrio: ad essi, con regio
decreto, fu data l’autorizzazione di chiamarsi Sauli-Scassi).
Il nipote
Onofrio Scassi (jr), crebbe nelle belle proprietà del nonno paterno,
compresa la villa di San Pier d’Arena, smanioso d’affermazione e di seguire
forse a proprio modo un modello napoleonico. Il padre suo, vedendolo pieno
d’ingegno e inclinato a entrare nelle armi, lo pose nella militare accademia: si
arruolò nei cavalleggeri, raggiungendo dapprima il grado di sottotenente nel
Reggimento Novara e poi luogotenente e aiutante di campo del generale
Alessandro Avogadro di Casanova nel Reggimento Aosta. Uscito dall’Accademia, allo
scoppio della Seconda Guerra d’Indipendenza, chiese ed ottenne di poter tornare
ai reparti; rientrò quindi il 5 maggio 1859 con lo stesso grado, nel reggimento
leggero a cavallo di Novara, al comando del colonnello Federico Morozzo della
Rocca.
Nel
combattimento di Montebello il 20’ di maggio 1859, preludio dell’epopea della
indipendenza e unità d’Italia, cadde insieme con gli altri due ufficiali De
Blonay savoiardo e Govone di Alba appartenenti ad altri squadroni.
Un annalista riporta “Il
combattimento si era svolto con estrema violenza e con gravi perdite da ambo le
parti; … accanto al capitano Piola Caselli comandante del 3° squadrone, cadde
ferito il sottotenente conte Onofrio Scassi; cinque o sei ussari, visto
l’ufficiale in difficoltà, gli si fecero addosso e lo finirono: era il primo
ufficiale del ‘Novara’ caduto sul campo; avrà la medaglia d’argento alla
memoria”; ed oltre riporta correttamente la motivazione della concessione della
Medaglia d’Argento al Valor Militare:
“Scassi Onofrio
(luogotenente) - Montebello, 20 maggio 1859 - Tra i
cavalleggeri di Novara cadde estinto Onofrio Scassi conte di Santa Giulietta, e
cadde appunto nelle sue terre, essendo a pochissima lontananza il paese di
Santa Giulietta, ov’è seppellito nella cappella gentilizia di sua casa …” e
dove si vede la medaglia che
si meritò nel di’ della battaglia.
Ma con lui così, si
estinse la discendenza
Quasi inaspettatamente
anche Giuseppe Cesare Abba, trattando della successiva Spedizione dei Mille in Da Quarto al Volturno,attraversando in treno la campagna
di Montebello: “4 maggio, in viaggio.”
“Non so per che guasti il treno s’è
fermato. Siamo vicini a Montebello. Che gaie colline e che esultanza di ville
sui dossi verdi! Ho cercato coll’occhio per tutta la campagna. E’ appena
passato un anno, e non un segno di quel che avvenne qui. Il sole tramonta
laggiù. In fondo ai solchi lunghi un contadino parla ai suoi bovi. Essi
aggiogati all’aratro tirano avanti con lui Forse egli vide e sa dove fu il
forte della battaglia ? Ho negli occhi la visione di cavalli, di cavalieri, di
lance, di sciabole cavate fuori da trecento guaine, a uno squillo di tromba;
tutto come narrava quel povero caporale dei cavalleggieri di Novara tornato dal
campo due giorni dopo il fatto. Affollato da tutta la caserma, colla sciabola
sul braccio, col mantello arrotolato a tracolla, coi panni che gli erano
sciupati addosso, lo veggo ancora piantato là in mezzo a noi, fiero, ma niente
spavaldo!
-Dunque, e Novara ?
-Novara la bella non c’è più! Siamo
rimasti mezzi per quei campi E narrò di Morelli di Popolo, colonnello dai
cavalleggieri di Monferrato morto, di Scassi morto, di Covone morto, e di
tanti altri, lungo e mesto racconto.
-E i francesi ?
- Coraggiosi| - rispondeva egli : ma
bisognava sentirli come i loro ufficiali parlavano di noi!
Io lo avrei baciato, tanto diceva
con garbo”.
BIBLIOGRAFIA
--non citato su ES + 61a +
-A
Compagna- almanacco dei soci -1971 -pag.157
-Alizeri
F-Guida illustrativa per la città di Ge.-Sambolino1875-p.647.651
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4101
-AA.VV.-Annuario
guida archidiocesi-ed/94-pag.445: ed/02-pag.481
-AA.VV.-Catalogo
delle ville genovesi-Bertelli1976-pag. 163
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti1984-pag. 43
-AA.VV.-SPdA.nella
sua amministrazione fascista-Reale26-pag.23.44
-Beccaria
R. I periodici genovesi dal 1473 al 1899-Ge.1994-pag. 383
-Berveglieri.Remedi-i
laghi scomparsi di Villa Imperiale-2006-
-Cappi
G.-Genova e le due riviere-Rechiedei 1892-pag.351
-Cavallaro
G.-Ospedale civile di SPdA-Pagano-196?- foto
-Comune
di Genova-annuario statistico 1977 –pag. 149
-Enciclopedia
Motta
-Fiorato
S.-Genova Medica-bollettino OdM- n° 9/2008-pag.27
-Gazzettino
Sampierdarenese : 5/80.1 + 4/93.8 + 6/93.4
-Genova
rivista municipale-comunale : 7/30.605 + 10/30.839foto.841 + 4/31.257*** + 5/37.39ritratto +
10/38.841 + 10/40.31 + 11/53.38 + 7/54.34
-Il
Secolo XIX : 29.11.1998 + 11.07.01 + 19.01.03 + 23.02.03 + 06.03.03 + 13 e 31.08.03 + 04 e 29.11.03 + 07.01.04 + 14.03.04 +
-Lamponi
M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag.207
-Merega
M.-Il servizio militare nella Repub...-SocLiStPatria.1983.p.324
-Miscio
A.-La seconda Valdocco-Elledici.2002-vol.II- pag.137
-Mosci
L.-su: Liguria medica -XII- 1/1987.19
-Novella
P.-Storia di Genova-manoscritto bibl.Berio.1930-pag. 13.18
-“Ospedali
Civili*** di SPd ’A- opuscolo –1920
-Pagano/1950–pag.195;
/61-pag.385
-Parma
E.-La pittura in Liguria,il Cinquecento-CARIGE.1999-pag.340
-PastorinoVigliero-Dizionario
delle strade di Ge-Tolozzi’85-p.1672ritratt
-Poleggi
E.&C-Atlante di Genova- Marsilio 1995-tav.35
-Remedi
A.-studi e ricerche su Agostino Scassi.2011
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.250
-Vitale
V.-Informazioni di polizia sull’amb...-SLSPatria-v.61-1933-pag.452
-Vitale
V.-Onofrio Scassi- Atti SLSPatria-vol.59.1922-tutto-.
SCUOLE TECNICHE
piazza Scuole Tecniche
Era il nome generico e non
ufficiale, dato alla piazzetta che poi, nel 1906, divenne legalmente “ piazza
Giacomo Bove” (oggi, dal 1935, è “via
V.Alfieri”).
Il nome proviene dalle scuole,
ospitate nel palazzo omonimo, usato seguendo l’uso di nominare una località in
rapporto al punto di riferimento più importante e conosciuto dai più.

Foto
1910 - il portone a sinistra corniciato di bianco è l’attuale civico 46 di via
ACantore. In alto dopo gli alberi, nel centro della foto, i tetti dei quali
rimane il segno in via Alfieri; alla loro destra il campanile dell’Oratorio
Mrte e Orazione; a destra del quale il palazzo Boccardo.
Nel 1870 esisteva una
‘istruzione primaria’ composta dai primi asili infantili, seguiti dalle scuole
elementari (pubbliche e private; serali e domenicali). Seguiva una ‘istruzione
secondaria’ con divisione tra istruzione classica e quella tecnica. Mirata
questa ultima a soddisfare le pratiche esigenze dell’industria, del commercio,
della navigazione, dei sempre più frequenti contatti con l’estero, fu
largamente adottata nella provincia genovese anche se troppo spesso lasciata sprovvista
di quanto necessario per insegnare praticamente (ad esempio il gabinetto di
fisica o di chimica) tanto che si chiedevano se non fosse meglio inserirsi
direttamente nel lavoro lasciando che – chi più sveglio - imparasse di più
inserito nell’ambiente che preparato nel teorico senza sussistenza pratica. In
SanPierd’Arena in quell’anno era aperta una Scuola Tecnica comunale
comunitativa (a Genova erano tre e tutte regie
governative; una a Voltri comunale ma pareggiata; a Sestri e la nostra a carico
del municipio locale). Nel 1870 era direttore il sacerdote teologo
Bistolfi Giuseppe; 2 erano i professori di lingua italiana-storia-geografia;
uno di lingua francese, di matematica, di calligrafia, di aritmetica e
computisteria, di scienze fisiche e naturali.
Ancora nel 1899, le scuole
civiche erano divise in “elementari (o
preparatorie”con cultura generale e francese, ricamo, canto e piano, ballo,
ginnastica);seguite dal “corso superiore” di 4 anni (con morale, aritmetica e contabilità, igiene e scienze,
storia, lettere italiane, geografia, francese, inglese, disegno, ornato);
oppure dalle “industriali” (con disegno,
cucito, ricamo, calligrafia, filigrana, ecc oltre a lingua italiana,
aritmetica, francese , calligrafia, storia e commercio); oppure dalle “tecniche”(diurne, serali e domenicali; con lettere, francese o
inglese, computisteria, aritmetica, scienze, disegno, calligrafia, matematica)
.
A levante, la PIAZZETTA era
delimitata dall’Oratorio della Morte ed Orazione (vedi via A.Cantore); mentre a
ponente aveva la casa Scaniglia (poi Barabino), la proprietà Parodi (ambedue
oggi scomparse abbattuta e diversamente utilizzata) ed il palazzo Boccardo ,
sede della scuola .
Il PALAZZO
BOCCARDO (vedi a via A.Cantore e,
parziale foto in via GB Monti), posto
allora in via del Mercato al civ.11 (oggi
corrisponde come sede all’ultimo civico di via A.Cantore, il n°
51*** ). già a metà secolo del 1800 era di proprietà municipale. Nel
1856 ospitò la società di MS Unione Umanitaria -primo
vagito dell’attuale Ass.Operaia Universale di M.Soccorso, che ebbe nel palazzo
la sua prima sede-, che vi aprì scuole serali elementari, di disegno
meccanico ed ornamentale, nonché una palestra (per
ginnastica, scherma, scuola di tiro a segno e carabina ) ed una
biblioteca circolante. Nel 1868 trovarono sede anche la “società di MS dei
volontari italiani” riunente i combattenti volontari che - coordinati da Luigi
Stallo - si organizzano in società avente presidenti onorari Garibaldi e
Mazzini (che ringraziarono con lettera) .
Nel 1891, ed eguale nel 1896,
un elenco di immobili di proprietà comunale, cita: “Palazzo Scuole Tecniche,
locali carcere ed abitazioni annesse (valore) L. 100000”.
Nel 1908 non esiste più questa
proprietà, e le Scuole Tecniche sono nel ‘Palazzo Galeazzo Alessi’, ovvero in
villa Scassi allora ritenuta disegnata da questo architetto.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Falcone
G.-Annuario della Prov. di Ge.-Ferrando.1870-pag-. 618
-Lunario
genovese del signor Regina 1889-pag.278
-Morabito.Costa.Universo
della solidarietà-Priamar.1995-pag.333
SECONDO FASCIO D’ITALIA - via -
è descritta alla F
SETTEMBRINI piazza Luigi Settembrini
TARGA:
piazza - Luigi Settembrini –
letterato e patriota napoletano - 1813-1876


QUARTIERE
MEDIEVALE: Mercato
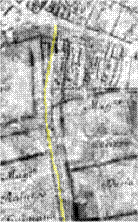 da MVinzoni 1757. Ipotetica
posizione della piazza, a levante della crosa dei Buoi, nei terreni del mag.co
Giuseppe Doria
da MVinzoni 1757. Ipotetica
posizione della piazza, a levante della crosa dei Buoi, nei terreni del mag.co
Giuseppe Doria
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2851 CATEGORIA: 1
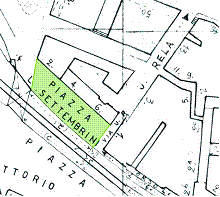
anno 1960
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 58380
UNITÀ
URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STRUTTURA: attraversata solo da pedoni, si estenda da piazza
N.Montano a via U.Rela. Sono circa 1000 mq di area pedonale
E’ servita dall’acquedotto
DeFerrari Galliera
STORIA: Ebbe più
nomi: per primo, quello popolare di “piazza della Posta”, per indicare la presenza degli uffici,
nell’affiancato palazzo affacciato su via N.Bixio, ed utilizzato
dalle regie Poste italiane provenienti dalla sede di via A.Castelli: più vicini
alla stazione ferroviaria e di arrivo dei primi mezzi intercittadini come gli
Omnibus.
In seguito divenne ufficialmente “piazza Felice Cavallotti”, e così è citata dal Novella negli anni 1900-1930,
aperta su via Milite Ignoto e su via U.Rela.
Il 19 agosto 1935 il podestà firmò la delibera di titolazione a “piazza
Sabaudia” (città laziale nell’agro pontino)
Titolo che le rimase fino al 23 marzo 1944, quando il Commissario prefettizio
deliberò per l’ intestazione col nome attuale.
Il terreno nel 1757 faceva parte della vasta proprietà di Giuseppe
Doria, apparentemente senza una villa propria e quindi prato, destinato al
mantenimento di animali (cavalli forse, visto vicino la ‘zona delle stalle’). Nelle
successive carte dell’ottocento appare già strutturata a più ampio giardino con
il segno di una vasca centrale; infatti, nel 1850 circa, con la
costruzione della linea ferroviaria, tutto il lungo spiazzo-giardino, fu
ridimensionato, tagliato e ridotto: a nord della palizzata fu lasciato un più
vasto terreno che volgarmente veniva chiamato “o prou” ove esisteva anche un
gioco delle bocce (le
strade vicino di contorno, ora via Orsolino ed U.Rela, furono di conseguenza
dapprima chiamate via Prato).


anni
1990
Ancora
nel 1908, il terreno non appare incluso nei terreni di proprietà
comunale e quindi soggetto - come tutto attorno- alla selvaggia erezione di
palazzi degli anni tra il 1870 e 1920: esistono documenti depositati
all’Archivio S.Comunale di richiesta di vendita del terreno; quindi malgrado lo
spazio allettasse più d’un costruttore, fu infine deciso dal Comune di
ricuperarlo a piazza pubblica, quale ora, divenendo per la sua centralità “il salotto
buono” di San Pier d’Arena.
Fu restaurato e ripulito nel 1975, ma subì da quel tempo la presenza
-per anni- di un attivo centro di spaccio di stupefacenti, che fecero della
zona un punto da evitare; ‘perseguitati’ dalle forze dell’ordine, traslocarono
altrove lasciando spazio a riunione di extracomunitari – forse albanesi - che
trovarono nella piazzetta luogo di incontro tra loro.



1997 – asfaltata 1980
1980 senza palma



anni ’80 con palma
Nel complesso -ed in pratica-, è stata generalmente, gravemente ed a lungo
trascurata dall’amministrazione pubblica. Nel nov.1999 si annunciò
trionfalisticamente che il CdC aveva approvato il progetto in base al quale oltre
al rifacimento dell’illuminazione, giochi d’acqua nella fontana ripulita, ecc.,
la piazza “ritornerà agli antichi splendori con al posto dell’asfalto un
‘accoltellato’ di mattoni di colore rosso cupo, com’è nella tradizione
genovese” (dalla terra
battuta, in cartoline dell’inizio 1900 appare pavimentata a lastroni di pietra
che, per praticità nel dopoguerra furono coperti da asfalto, si è passati a
mattoni rossi come in piazza Modena, forse sempre meglio di nulla anche se non
mi pare vero che esista simile tradizione! Forse l’acquisto –come le palme- di
grossi quantitativi di mattoni, oltre al risparmio favorisce la creazione di
una ‘nuova tradizione’). Le lungaggini
burocratiche (legate a
competenze operative nell’ambito delle varie sezioni comunali con necessità di
una delibera della giunta che assegnasse la responsabilità dei lavori ad una di
esse) ritardarono l’iniziativa di due
anni. A fine 2001 infatti -con una spesa prevista di 300milioni circa e
finita a 450milioni - iniziarono i lavori su progetto dell’arch. Cassini,
terminati 18 mesi dopo, inaugurati il 27.7.02: tolto l’asfalto, la
messa in atto della pavimentazione a mattoni rossi, poggiati in costa su sabbia
drenante; sotto gli alberi è stato formato un corridoio in ciottolato che
separa la zona centrale dai marciapiedi laterali.



foto 2002
È
stata rifatta l’illuminazione che era a lampade appese con fili, ora con
lanterne in ghisa su mensola; sostituiti alcuni alberi, che ora sono 19 più due
palme; ripulita ed aggiustata la vasca (vedi sotto).
Numerosi
sono i progetti futuri; da mostra all’aperto di pittori, ripristino del
banchetto di frutta e verdura. Ed altrettanto numerose si sono succedute sedi
di commercianti, artigiani (macelleria, pasticceria, ristorante, osteria, parrucchiere,
mobilificio, tessuti, focacceria, erboristeria) ciascuna famosa e ricordabili solo per la generazione che le ha
vissute.


antica targa di reclame, posta nell’angolo con il tunnel ferroviario
per piazza VVeneto.
Al centro una bella fontana la cui storia è emersa in due versioni solo
in tempi molto recenti, all’atto dell’ultimo restauro.
L’origine
e lo scultore della vasca sono stati a lungo sconosciuti. Si pensò anche ad un
trasferimento dalla vicina villa Centurione-Carpaneto quando fu ridimensionato
il vasto giardino.


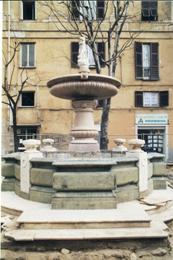
1999 2002
La
prima descrizione è di Remedi, il quale cita un verbale della riunione
della giunta comunale datato 28 maggio 1906, ove si legge della possibilità di
costruire una fontana in piazza Giovanni Bovio (attuale
piazza N.Barabino) su progetto (arch. Egisto Bellini) e realizzazione della Società Unione Scalpellini e
Selciatori Genovesi, detti dell’Ansaldo; i quali -non senza tornaconto (visto le numerose commesse a loro
affidate)- volevano dimostrare la loro
bravura e devozione alla città di san Pier d’Arena. Ancora Remedi scrive che
tutto il progetto fu approvato ed intanto presentato alla fiera Universale di
Milano dello stesso anno. Ma le cose non filarono lisce: i pezzi furono invece
montati in piazza Felice Cavallotti (oggi Settembrini); nel 1908 la cooperativa entrò in crisi; la giunta
cambiò colore ma accordò un anticipo di lire cento a fronte di richiesta di
sovvenzione, che divennero 5625,92 nell’aprile 1909 come da delibere (il giorno
1 e 20) della Giunta, la prima delle quali vistata dalla regia Prefettura il
16.
La seconda versione scrive che fu realizzata nel 1908 pare su proposta
ed offerta degli ansaldini (del loro circolo in particolare che aveva sede vicino, in via U.Rela
ai civv. 1n e 3r) ed con opera della
«soc. an. Cooperativa di Costruzione per Lavoranti Muratori ed Affini» (con sede in via UmbertoI civ.
45rosso; essa però chiese al Municipio un acconto di £.4000 per le spese
sostenute per la “costruzione della vasca”)
Il basamento è a scalini di marmo, con forma di croce di Malta; alcune
decorazioni della vasca sono di tardo liberty anni 1910 (stesse decorazioni presenti al
Campasso nel palazzo dei macelli). In
alto un amorino stringe un grosso pesce. Forse il putto, che sembra più antico
dell’insieme, era già appartenente ai giardini della villa e -se fosse così-
sicuramente fu lui a condizionare la destinazione del terreno di questa piazza
comunale.
Ma
stranamente neanche il Novella la cita, pur essendo l’unica fontana della città
(a parte quella dentro
i giardini di villa Scassi), forse
perché non c’era o fu innalzata dopo, non si sa.
Dopo
decenni di attesa, fu ripulita, impermeabilizzata, e riattata nel 1994; poi
nell’aprile 2000 provocatoriamente ed in parte a scopo politico la fontana fu
ripulita delle alghe, incrostazioni e ‘rumenta’ varia, da una squadra di
volontari detti bonariamente ‘acchiappaschifezze’ dei Verdi; ed infine
riattata nei marmi e nell’idraulica a fine luglio 2002
Gli
alberi che la attorniano, nelle foto degli anni attorno al 1910 si
vedono appena appena collocati in sito, piccoli e minuti, a testimonianza che
lo spazio fu adibito a piazza in quegli anni. Si racconta che un uragano a metà
degli anni 50, riuscì ad abbattere una palma, e che per lungo tempo non fu
sostituita, lasciando l’aiuola rotonda vuota ***. Oggi, le palme ai due estremi
sono contornate da un anello di alberi ad alto fusto; (delle palme, quella a levante,
centenaria, è stata sostituita nel 2002 giudicandola malata (le erano state riscontrate delle cavità e fenditure interne al tronco,
pericolose alla sua stabilità ed a rischio cedimento al vento, visto la vasta
chioma); mentre degli
alberi attorno qualcuno è stato cambiato per necessità naturali, come la robinia localizzata più
vicino a via U.Rela che stava rigermogliando dal tronco precedentemente
tagliato e che è stata sostituita all’ultimo restauro del 2002 con un acero;
anche un platano non c’è più. Oggi di alberi se ne contano 7 dal lato ferrovia
ed in totale 17, così ripartiti: 3 nuovi aceri, 4 bagolari (o spaccasassi), 7
tigli, 2 robinia pseudoacacia, 1 ippocastano). L’angolino a
ponente, più vicino alla ferrovia, è stato da sempre occupato da persone che
entrarono nel folklore cittadino: nell’84 morì ultranovantenne la Gilda, che
vendeva le caldarroste all’aperto, nei rigidi inverni, coperta da uno
scialletto, amata da tutti; poi, più attrezzato, c’è stato un chiosco che
vendeva frutta e verdura ed in stagione anche cocomeri (un breve periodo di
abbandono del manufatto per avvicendamento, ha fatto gridare allo sconcio). Per
anni, nella parte a levante invece, c’era una bancarella di libri usati,
gestita da “Giuseppe”, che certo non faceva concorrenza alla libreria vicina ma
al contrario serviva piuttosto a fare della piazzetta un “centro lettura” .
CIVICI
2007=
NERI = da 2 a 6
ROSSI = da 1r a 13r
(compreso 3Ar. Sotto il
viadotto) e da 2r a 24r
===civ.1r la
microinsegna posta all’angolo col tunnel lascia pensare che prima di tutti vi
fosse una osteria. Sicuramente, negli anni 1950 divenne sede della SPI (soc.per
la pubblicità in Italia) che raccoglieva inserzioni per il quotidiano
indipendente genovese ‘Corriere del popolo’ diretto dal dr Arrigo Ortolani,
che si autodefiniva ‘il più diffuso di informazioni’. Oggi è un piccolo locale adibito a
deposito merci privato.
===civ. 2:
edificio progettato forse dall’ing. Giovanni Crier (il nome è insicuro) costruito nel 1908, distinto per l’elegante
decorazione in stile liberty, nelle cornici delle finestre, negli elementi in
ferro che ornano i balconi. Era di proprietà Ravina Rina, vedova Castello. Fu
realizzato con tetto a mansarda. Divenuto sede dell’ufficio postale, è rimasto
nel gergo popolare il “palazzo delle poste” ed ha dato alla piazza sottostante
lo stesso nome .
Dopo
5 lustri di lungaggini burocratiche fu completamente rifatto per ragioni di
staticità, dall’impresa Gadolla nel 1983-6, in un complesso comprendente due
unità ravvicinate: quella a mare, ricalca in modo eguale il palazzo
preesistente ed abbattuto, in stile liberty e con l’ultimo piano a piramide (la critica fu non aver ricalcato
gli antichi spazi, senza porticato continuativo dei vicini palazzi di piazza
Montano, addossati ai margini stradali da ridurre lo spazio pedonale, al punto
da far criticare il ‘casermone’ così rinnovato quale ‘speculazione edilizia); quello a monte, moderno, che dalle piazze Montano e
Settembrini, arriva sino a via U.Rela in unica superficie di oltre 1500 mq., per 6 piani, più degli interrati, avente il tetto ad
ampie terrazze degradanti in modo da non soffocare le case vicine, destinato dapprima ad ospitare al
piano terra la sede di una filiale della BNL, ed a quelli superiori con
apertura via U.Rela, la sede itinerante (da via T.Molteni) delle Poste e
Telegrafi con uffici per il pubblico; poi fu modificata la delibera, per
“inserirvi” la direzione compartimentale delle PT, impegnandosi a trovare
un’area equivalente per i sevizi pubblici;
infine, attualmente è
occupato solo dalla Direzione, ed gli sportelli per il pubblico sono stati
definitivamente spostati - si spera- in piazza del Monastero.
Sotto la ferrovia
===civ. 3r fu un altro piccolo locale occupato nel dopoguerra da un
artigiano che riparava penne stilografiche e vendeva francobolli da collezione;
===civ. 3Ar (sul
Pagano/50 è al 5r): c’era un servizio ‘Albergo
Diurno’ ovvero ‘gabinetto pubblico’,sotto la ferrovia; l’ unico
della delegazione a parte sparsi vespasiani (Lamponi dice che vi erano delle docce, ma viene smentito da
testimoni e …dallo spazio a disposizione).
Era molto opportuno per tutti, ma soprattutto per gli assidui frequentatori
delle panchine i quali generalmente sono di età pensionata (e -relativo alle loro stanche e
flaccide membra- fu dato alla piazza un volgare popolare nomignolo: “ciassa di
belin molli”-). Fu chiuso agli inizi
degli anni 70, vanamente sostituito da una struttura posta vicino in piazza
Vittorio Veneto, di
quelle autopulenti ed a entrata a pagamento che funzionò pochi giorni, stette
lì per alcuni anni e poi fu rimossa e riproposto similare lontanissima, nei
giardini Pavanello.
===civ. 5r corrisponde al retro del negozio coltelleria Dossi di
piazza V.Veneto
Dal lato a monte:
===civ. 4 In stile
prime decadi del 1900: semplice ma pur sempre con una decorazione:
caratteristiche –anche se nascoste alla vista dalle fronde degli alberi- le
due lesene*** che dividono la più antica parte di facciata del palazzo in tre
porzioni interrompendone così la sua piattezza e rendendola più gentile (in
altezza arrivano sino al quarto piano e non ai due superiori che furono
sopraelevati anni dopo). Anche le finestre, sono più basse al primo e quarto
(ex ultimo) piano e più alte nei piani centrali quasi a ricercare
l’architettonica esistenza del ‘piano nobile’ delle vecchie ville
===civ. 6 = appare
sopraelevato di un solo piano. La sua semplicità lo colloca costruito prima
degli altri, negli anni a cavallo tra 1800-1900.
===civ. 10r: ospitava
(si sono perdute le tracce storiche dell’apertura; a voce dovrebbe risalire
agli anni 1896-8) la mitica libreria-giornalaio di Roncallo
Attilio dal 1908 anche rappresentante di case editrici e punto di riferimento
per tutti gli studenti ed amanti della lettura. Negli anni 60 divenne di
Roncallo Manlio; e lì era ancora nel 1968 quando rilevata dagli eredi, si
trasferì in via C.Rolando. Fu poi affidata alla signora Macciò Andreina finché
alla fine degli anni 90 divenne una filiale del ‘Libraccio’.***
===14r nel 1950 c’era
l’osteria di Parodi Mario
===20r. “da Enzo”,
per Monatti è un “locale
giovane e accogliente che mantiene però i buoni sapori d una volta. A
cominciare dalla farinata preparata nel forno a legna, che ancora tiene testa
alla concorrenza della pizza (peraltro assai gustosa). In menù anche le
versioni meno classiche ma ormai richiestissime: bianchetti (di stagione),
cipolle e carciofi”.
DEDICATA: al
letterato e patriota napoletano, che per le sue idee libertarie, subì nel regno
delle Due Sicilie lunghi e travagliati affanni.
Nato
a Napoli nel 1813, come ricorda se stesso in un libretto intitolato “Le
ricordanze della mia vita” pubblicato nel 1879 (un secondo volume, curato dal
figlio, contiene tutte le dichiarazioni processuali e testi vari), fu educato alla maniera illuminista ed avviato
agli studi legali; ma lui preferì non seguire la carriera forense quanto
piuttosto studiare la letteratura classica; così messosi alla scuola di Basilio
Puoti, si laureò in lettere e vinse nel 1835 il concorso di insegnamento
di “eloquenza” a Catanzaro, allora sotto i Borboni.
In
quell’anno, l’8 ottobre, si sposò a Napoli con Maria (Bruzzone scrive Raffaela) Luigia Faucitano, detta Gigia, andando in viaggio di
nozze…a Catanzaro. Dall’unione nacque Raffaele; e poi nel 1839, mentre
lui languiva in carcere da tre mesi, anche Giulia.
Le ampie letture fatte, specie del Mazzini, avevano stimolato le sue idee
libertarie, favorevoli all’unità d’Italia, ed ostili alle dittature; così con
l’amico Musolino, fondò una società chiamata “figlioli della Giovine Italia”,
che ovviamente dalla polizia borbonica fu giudicata fuori legge.
E
poiché aveva scritto un manifesto giudicato insurrezionale, tradito da un
sacerdote, fu arrestato e dapprima condannato al carcere di Napoli per tre
anni, dall’8 magg.1839 al 1842; ma in tutto ne scontò venti mesi, perché al
processo d’appello fu assolto per insufficienza di prove; ma perdette la
cattedra di insegnamento.

foto al Museo del Risorgimento-Milano
Senza
lavoro stipendiato, visse per altri 5 anni a Napoli, dando lezioni private; ma
ben tosto reinserendosi nei circoli clandestini animati dalla medesima
aspirazione dell’unità ed indipendenza nazionale.
L’animo libertario, lo portò ad associarsi con Silvio Spaventa e Filippo
Agresti, per fondare ed esserne presidente, la “Grande società dell’Unità
d’Italia”; ma nel 1847, essendogli stato attribuito un opuscolo (seppur pubblicato anonimo, ma che
ebbe grande risonanza nel regno ed intitolato “Protesta del popolo delle Due Sicilie”) ricco di
severi rimproveri contro il Borbone Ferdinando II (accusato nella persona, quale
ignorante, ricco di pregiudizi, volgare, perfido e soprattutto insensibile alle
necessità del suo popolo) dovette
fuggire, raggiungendo Malta ove rimase
un anno, potendo ritornare a Napoli solo l’anno dopo, alla promulgazione della
Costituzione (sotto la
spinta libertaria che pervase l’Italia in quell’anno, anche il tiranno aveva
concesso la costituzione; ma dopo pochi mesi, abiurando il
giuramento fatto e protetto dall’impero austriaco, la revocò).
Cosicché
nel 1850 il Settembrini fu
riarrestato, il 1 giugno processato (durato sei mesi); lui ed altri 5,
condannati a morte –pena commutata in ergastolo malgrado la fervente autodifesa indirizzata inutilmente agli “uomini
di buon senso”- da scontarsi dal 6
febbraio 1851; si ritrovò così assieme a Silvio Spaventa ed altri
ergastolani politici. Iniziò la pena
nel carcere dell’isola-penitenziario di santo Stefano, ove trascorse i primi
otto anni ristretto in cella illuminata da una finestra posta in alto
irraggiungibile, traducendo dal greco le opere di Luciano da Samosata (antica città della Siria, residenza
reale, che fu assediata da Marcantonio nel 33 a.C. e che diedei natali al
faceto e sofista scrittore). Di questo periodo lasciò la documentazione ne ‘Le
ricordanze’. Rifiutò domandare la
grazia, e -appena poté- tentò inutilmente una fuga.
In questo periodo, il figlio divenuto marinaio su navi
militari piemontesi, tornò nel 1856 dalla Crimea gravemente ammalato di
tifo e ricoverato in fin di vita a Genova nell’ospedale di Marina, assistito
dai cappuccini e dalle suore di sAnna (suor Giuseppina, ‘suora della carità’,
fondate da s.Vincenzo de’ Paoli). La madre per assisterlo, dopo essere stata
sottoposta a salasso terapeutico e ricevuto un passaporto, arrivò via nave fu
qui ospitata -prima in pzza Carlo.Felice per interessamento del gen. Mengaldo-
e poi, quando dopo 20 gg. –a luglio- il giovane potè uscire ed esservi portato
in portantina, ‘camallata’ da 4 marinai, in piazza Acquaverde, ove godeva il
panorama della città ed ebbe visite anche dal conte Terenzio Mamiani (vedi).
Il sacrificio del Settembrini non era ignoto a Genova e la
moglie fu confortata dalle più alte autorità locali, e fu aiutata dal medico
Agostino Bertani quando dovette rientrare –nei primi di settembre- a Napoli,
essendo in corso segrete operazioni mirate a far fuggire il marito.
La signora Settembrini tornò a Genova due anni dopo 1858,
quando il figlio, ripreso il mare sulla nave Beroldo, dopo essere stato in
estremo Oriente, fu bloccato agli esami (da marinaio a ufficiale di marina
perché ‘ straniero’ (dopo 4 anni di servizio nella marina sarda). Si tentò la
strada della naturalizzazione sarda, ricorrendo personalmente anche al Cavour
a Torino. Alla fine, dovette congedarsi. Ma quando da Genova la signora si
accinse a rientrare a casa per assistere la figlia partoriente, il console di
Napoli a Genova ed accreditato a Torino Canofari, dopo averla fatta seguire e
vigilare, le rifiutò (pare per diretto ordine di Ferdinando II) il passaporto
di rientro, catalogandola esule pericolosa.
Solo con l’attivo aiuto di NBixio rientrò in patria: dopo
due vani tentativi di imbarcarla, sventati dalle spie borboniche –di cui uno su
vapore postale francese travestita da cameriera- la affidò a Paolo Fassiolo
(che per due volte aveva fatto emigrare Mazzini in Svizzera) che usò la via
terra, più soste e variazioni di itinerario, per non destare sospetti.
Nel
1859 il governo borbonico, decise di
disfarsi dei 500 e più prigionieri politici. Accordatosi con il governo della
repubblica argentina (laggiù
avrebbero avuto un pezzo di terra da coltivare ed una somma per iniziare), decretò trasformare tutte le pene in esilio. Il
viaggio, a spese del Borbone, fu organizzato anche per altri 65 prigionieri
politici (L’ES dice che
fu graziato e così poté emigrare). Ma
per loro fortuna, il figlio Raffaele -che prestava servizio nella marina
mercantile inglese- riuscì ad imbarcarsi a Cadice in incognito come cameriere
ed a convincere il capitano a sbarcare i condannati a Queenstown in Irlanda del
sud.
Solo
l’anno dopo, 1860, liberata Napoli da Garibaldi, tornò in patria
passando per Torino e Firenze; a Napoli venne riammesso alla cattedra
universitaria di letteratura italiana. L’insegnamento è documentato dalle “Lezioni
di letteratura italiana” riguardanti il periodo
1866-72. Reinserito nella società partenopea, poté diventare scrittore e
giornalista, essere nominato socio di Accademie e società politiche (fu a lungo presidente
dell’”associazione Unitaria costituzionale”, fondata assieme al De Santis).
Conosciute le sue capacità, fu nominato capo divisione nel ministero
dell’istruzione, ma dopo due mesi diede fermamente le dimissioni non
sopportando il clima di clientelismo e di incapaci ambiziosi di chi lo
dirigeva. Anche la pensione, che gli fu offerta, venne rifiutata giudicando non
meritarla per il troppo breve periodo di servizio.
Eletto deputato, preferì rinunciare per non lasciare l’insegnamento.
Nel 1873 fu nominato senatore del regno.
Morì tre anni dopo, nel 1876, a Napoli .
Importanti pubblicazioni sono raccolte in volume, specie le “Lezioni” di storia
della letteratura italiana (tenute all’Università dal 1866 al 1873); un “Epistolario”, ed il memoriale già citato “Ricordanze della mia
vita” pubblicato
postumo ed importante per capire le vicissitudini dei carcerati politici sotto
i Borboni.
Da una lezione, si trae questo brano, valido ancor
oggi : “ restare al proprio posto di combattimento, che pei giovani è
principalmente lo studio il quale è il più vero strumento di libertà e di
civile milizia perché un popolo ignorante è sempre servo di uno, di pochi o di
molti”.
BIBLIOGRAFIA
-Aimonetto
L.-il Risorgimento-Lattes.1958-pag.153.282
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4194
-A.sconosciuto-Storia
del trasporto pubblico a Genova-Sagep.’80-p. 208fot
-AA.VV.-Archivio.guida
archidiocesi—ed./94-pag.446---ed./02-pag.482
-AA:VV.-Sampierdarena
1864-1914 Mutualismo..-Ames.2005-p.169.170
-Bonatti
E.-Torte e farinata, dove e come-Sagep.1999-pag.34
-Bruzzone
GLuigi-la famiglia di L.Settembrini a Genova-opuscolo
-Enciclopedia
Mottafoto +
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
S. 3/73.10 + 5/74.3 + 10/75.5 + 1/81.3 + 3/81.1 + 6/83.9 + 8/83.3 + 3/84.12
+ 6/84.3 + 9/84.3 + 3/85.9 + 2/86.11 + 3/86.3 + 2/87.14 + 9/89.11 + 2/90.6 +
5/94.11 + 7/97.5 +
-Genova,
rivista del comune : sett./40.XVIII. pag.19itratto
-Lamponi
M.-Sampierdarena – LibroPiù.2002- pag. 87
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.8.17
-Il
Secolo XIX- del 30.11.99 + 01.04.2000 + 6.10.01 + 27.11.01
-Montefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.41
-Pagano/1933-pag.265---/1950
– pag. 605
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1700
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.34
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag. 26.50.64.95
SIVORI piazza ammiraglio Sivori
Corrispondeva alla zona dell’attuale via G.B.Gaggino, da via Fiumara a via
Bombrini, prima delle trasformazioni legate all’Ansaldo.
Nell’anno 1900, alla Giunta comunale venne proposto la
titolazione al Sivori della “via di fronte allo stabilimento Dufour verso notte
contro la seconda piazzetta” (vedi a Antica Fiumara civ.1)
Il Novella negli anni 1900-30 segnala una “ammiraglio
Sivori (piazza), da via Fiumara (G.B.Gaggini)”.
Una ‘Via Ammiraglio Sivori’ e non piazza, ‘da via
Bombrini a via Fiumara’ appare ufficialmente già riconosciuta nell’elenco delle
vie cittadine pubblicato nel 1910.
Ma ritorna ad essere ’ piazza Ammiraglio Sivori’ quella
offerta dall’amministrazione comunale sampierdarenese alla nuova toponomastica
quando nel 1926 confluì nella Grande Genova. Ed esendo in duplicato con la via
del centro, fu destinata ad essere sostituita.
Nel 1933 esisteva ancora, ed
era ancora “da via Fiumara a via Bombrini” , di 4.a categoria, con un civico
solo .
Il nome fu cambiato per
delibera firmata dal podestà il 19 agosto 1935, lasciando a Castelletto la via
omonima classificata di 2a categoria..
DEDICATA all’ammiraglio
Francesco Salvatore Stefano Sivori , nato a Palermo da genitori (GB e Teresa
Punta) genovesi (Villa santa Giulia, Lavagna) il 6 magg. 1771, famiglia
patrizia dal 1528.
Divenuto –dapprima allievo-
poi ufficiale della marina borbonica sul veliero ‘Leone’, da questa passò nel
1797-8 (o disertò) alla Marina francese ritrovandolo pilota ai segnali su una
nave della spedizione napoleonica in Egitto (imbarcato
a Genova con 2400 soldati su navi in buona parte di proprietà di Bavastro,
rientrò con il Buonaparte nell’ago.1799 ).
Il 27 genn 1799 lo troviamo
sottotenente nella Marina Ligure della Repubblica democratica Ligure (che aveva iniziato ad essere dal 14 giu.1797, alla
morte della Repubblica di Genova, e che aveva una parvenza di Marina seppur
ufficialmente riconosciuta: quattro trascurate galere, alcune golette e brick o
navicelle armate ‘in corsa’, affidate al comando del cap. di fregata
G.Bavastro. Il Sivori fu assegnato alla goletta ‘La Giustizia’ ove prestò
servizio fino all’ott.1802 vivendo l’assedio di Massena in una guerra spietata
di astuzia, agguati, abbordaggi mai resi noti a nessuno per ragioni appunto di
guerre corsare).
Nell’arte
guerriera, Napoleone favorì sempre la via di terra, trascurando quella
marittima : ne approfittarono gli inglesi divenendo rapidamente padroni del
mare , permettendosi quasi impunemente di distruggere o requisire tutto il
naviglio che potesse essere di aiuto ai francesi ; se questa concezione
tattica diede ragione al Corso nelle innumerevoli vittorie raggiunte, ben caro
pagarono i francesi rivieraschi e noi liguri: il generale Massena quando
nell’anno 1800 si trovò assediato in Genova accerchiato -dalle truppe di terra
austro russe attestate a Cornigliano e Bolzaneto-, e dalla flotta inglese che
bloccava l‘unico accesso utile, il mare, visto che praticamente non esistevano
strade facilmente agibili per raggiungere la città boccheggiante, unici
rifornimenti potevano arrivare solo dal mare per opera di ardimentosi marinai
(vedi Bavastro) capaci di forzare il blocco navale. Erano gare di abilità,
velocità, agguati, da corsari, con cannonate ed arrembaggi , spesso in perdita
visto che gareggiavano barche cariche di viveri contro altre cariche di armi .
Nell’ordinamento marittimo internazionale, esistevano ancora ‘i corsari’
legalizzati (una sorta di guerriglieri che operavano per una nazione e non per
lucro personale) ; nonché -in guerra- il “diritto di preda”(consistente nella
vendita del sottratto -tramite un apposito “tribunale delle Prese” posto a
Gibilterra- e successiva distribuzione del ricavato tra l’equipaggio
vincitore). L’Inghilterra era riuscita con la forza a requisire tutta la
flottiglia anche quella minuta a tutti i liguri (nei porti di Camogli, Portofino,
SestriL. Savona, PortoM. ed in tutte le spiagge aperte come a Rapallo, Foce,
da San Pier d’Arena a Voltri e Loano) con un danno vitale per le attività
della nostra Repubblica ancora solo legate alla vita sul mare. Il naviglio
ligure, a seconda della stazza e della forma, comprendeva vari scafi : per
rifornimenti da costa a costa c’erano i pinchi - i più noti, a tre alberi con
due vele latine molto grandi alla maestra ed al trinchetto ed una più piccola
alla mezzana a poppa-, le golette, le feluche, le bombarde).
Dalla goletta, passò a comandare il brick ‘Giano’ e
condurre la stessa guerra a vantaggio della Repubblica Ligure che nel frattempo
era stata invitata da Napoleone a potenziarsi imponendo la bandiera francese su
tutti i vascelli fino ad incorporare la Marina Ligure in quella francese
praticamente estinguendola : il 1 lug. 1806 il Sivori divenne tenente di
vascello di complemento, ebbe il comando della goletta imperiale ‘La
Sentinelle’ con la quale continuò la lotta corsara pro Napoleone fino a che
tallonato da una fregata inglese, piuttosto che arrendersi preferì bruciare il
vascello. Per questo atto di coraggio, fu nominato tenente di vascello
effettivo, ed inviato il 26 nov.1810 a comandare il brick Janus sul cui ponte
rimase sino all’inizio del 1814.
Il 15 magg.1815
l’amm.G,DesGeneys scelse Genova per fondare la regia Marina Sarda; assunse il
Sivori per comandare una ‘mezza galera’ inviata a Moneglia per cercare di
distruggere una barbaresca segnalata in quelle acque (non fu trovata); e poco
dopo a rioccupare l’isola di Capraia (rimasta a
Genova dopo la cessione della Corsica, quando Napoleone fu inviato all’Elba, la
Capraia fu evacuata dai Francesi; con la restaurazione del trattato di Vienna,
i francesi di Luigi XVIII la rioccuparono indebitamente perché appartenendo
essa alla Repubblica di Genova –anch’essa da allora faceva parte del regno di
Piemonte,. Dopo Waterloo, le truppe francesi vennero ritirate ma rimase un
manipolo di corsi che affiancati dagli isolani, non volevano divenire sudditi
piemontesi). Due mesi durò la navigazione (continuamente
sospesa per timore di barbari tunisini che avrebbero potuto recar danni alle
navi impossibilitate a combattere perché piene di truppe e carriaggi),
finché il 7 nov. poté sbarcare ed assalire la guarnigione che però dopo pochi
colpi si arrese. Il Sivori ebbe una promozione divenendo capitano di vascello
in 2°. Dopo questa impresa, per un anno navigò con tre vascelli, per
difendere le costa sarde dai pirati, forti di una flotta di oltre dieci
vascelli, che non solo depredavano ma traevano schiavi.
Sebbene col trattato di Vienna , la pace era scesa sul mediterraneo tra le
nazioni ‘civili’, persisteva l’esistenza dei pirati mussulmani , persuasi che
le nazioni europee sarebbero state imbelli contro il brigantaggio. Algeri era
stata sottomessa alle nuove regole navali nel 1816, con l’aiuto determinante
della flotta inglese; ma altri nidi di pirati barbareschi come Tunisi e Tripoli
, apparentemente avevano accettato una convenzione di abolizione della
pirateria e schiavitù dei cristiani, ma in realtà si dimostravano ostili ,
arroganti e continuavano i loro attacchi: ancora nel 1815 ben 158 sudditi del
re di Sardegna “erano stati trasportati, pressoché nudi e sanguinanti, a
Tunisi e là venduti come bestie” .
Nel 1819, mentre il Sivori diveniva capitano di
fregata, fu approntata a Genova ed a spese dei commercianti locali, una fregata
a tre alberi che venne battezzata ‘ Commercio di Genova’ (voluta dalla Camera di Commercio genovese sia per farsi
promotrice di un ripopolamento della marina sarda del nuovo regno della casa
Savoia, sia per contrastare e proteggere con maggiore utilità i navigli ancora
esposti alle piraterie barbaresche): a scortare la nuova nave in un
viaggio oltre oceano (il primo della Marina sarda), l’ammiragliato prescelse il
capitano Sivori a comandare la corvetta Tritone (che però fu fermato a Lisbona)
cosicché nei primi mesi del 1820, sbarcato,assunse sevizio all’Arsenale
genovese. quale vice direttore assumendo un ruolo fondamentale nella difesa del
porto nella rivolta cittadina del 23 marzo e nel salvataggio di una fregata che
aveva divelto gli ormeggi in porto durante un fortunale.
Nel 1822 partecipò come comandante in seconda ad una
‘crociera’ di controllo delle coste africane e spagnole (dalle quali ultime si
temeva la partenza di fuoriusciti), ricevendo la decorazione della Croce di
cavaliere Mauriziano.
Nel settembre 1825 venne
l’occasione tanto sospirata : il bey di Tripoli ebbe l’impudenza di comunicare
una nota con toni che vennero considerati lesivi al decoro ed all’onore della
marina sarda: fu così inviato il Sivori al porto africano per distruggere con
un attacco la flotta nemica all’ancora, protetta da fortificazioni molto ben
armate e per questo, attacco mai tentato prima : anche se riuscito in parte
causa il maltempo, e quel poco fu eseguito dal Mameli, fu sufficiente ad
ammansire il bey. Questa brillante operazione gli guadagnò la promozione a
contrammiraglio, il titolo di barone conferitogli dal re Carlo Felice nel 1829,
la commenda dell’ordine militare di Savoia e, dai genovesi, una spada con
l’elsa d’oro (sull’elsa la scritta “IMPERANTE CAROLO FELICE PIO AVG.INVICT.” e
sulla lama la dedica “Al Cav.Com.Sivori il comercio (sic) di Genova”); una pensione
annua di 1500 lire; Martin Piaggio gli dedicò una poesia in dialetto
intitolata “a spedizion contro Tripoli” .
Morì a Genova il 22 luglio
1830, e sepolto nella chiesa della Madonnetta, ove –presago- aveva già fatto
scolpire l’epitaffio su un marmo (sepulcrum – hoc D.Franciscus Sivori – eques
sibi suisque – paravit – anno MDCCCXXIX).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica , scheda n.4224
-AA.VV.-La Consulta dei mercanti
genovesi-Camera Comm.1928-p.86foto
-Brizzolari C-Storia di Genova
sul mare-Vallecchi-1981-vol.2-pag.297
-Costa Bernadette-I
Dufour-Erga.1999-pag19 e segg.
-DeLandolina GC-Sampierdarena
-Rinascenza .1922 - pag. 55
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Genova, bollettino municipale:
1/25.30miniatura
-Novella P.-manoscritto guida di
Ge-1930-pag. 16
-Pagano 1933-pag.248
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.85-p.1714
SOLFERINO vico
Solferino
 in rosso, via
solforino. In giallo via Garibaldi (A.Pacinotti); in verde
via Pieragostini; grigio ferrovia
Ge-Sv, con via S.Dondero
sottostante.
in rosso, via
solforino. In giallo via Garibaldi (A.Pacinotti); in verde
via Pieragostini; grigio ferrovia
Ge-Sv, con via S.Dondero
sottostante.
Prima dell’anno 1900,
c’era una unica casa, di proprietà Mongiardino, e senza alcuna denominazione.
In quell’anno, fu proposto questo nome al vicolo (oggi
–all’incirca- vico Alberto di Bozzolo; scrivo all’incirca, perché nella carta
senza data sopra riprodotta, si riporta il nostro vicolo (in rosso) che però -rispetto
ai limiti del palazzo dei tabacchi (linea nera marcata)-, appare più a ponente
dell’attuale vico AdBozzolo) che si era formato in zona Crociera,
trasversalmente tra via Garibaldi e via san Cristoforo, lungo lo stabilimento
Solei Hebert (scritto a mano - di non facile
comprensione).
Con la fantasia e la cartina
sopra, perché non esiste più -ma c’era in quegli anni-: occorre costruire una
grossa casa (o, un complesso di case e cortili)
posta a ponente del nostro vicolo, delimitandolo da quella parte, ove ora sono
i giardini. Questo casermone fu abbattuto negli anni ’30, e lo spazio
rimasto vuoto utilizzato per allargare la strada della Crociera e lasciarvi il
giardino.
Identico era nel 1910,
con civici solo pari fino a 4. Dopo questo anno, nel vicolo definito ‘privato’
vi vengono ricordati –non solo la presenza ma soprattutto gli odori e rumori- di
un’osteria, proprietà di un certo Pesce che riceveva -con un camion
direttamente dal Piemonte- l’uva da spremere con i piedi; di un fabbro, che
ancora ferrava i cavalli; di una trattoria posta d’angolo aperta ai lavoratori
dei Molini; dei bimbi che vi giocavano a piedi nudi ed a fare le monellerie per
creare con il nulla un po’ di interesse e fantasia. Dietro il palazzo, passava
il treno merci, che dal porto, tramite il Canto, andava alla ‘stazione
piccola’ posta sulla riva del torrente.
Nel 1926 fu creata la
Grande Genova e con essa si propose l’unificazione dei nomi stradali. Dedicata
alla battaglia erano strade di Prà (anche una
piazza), Pegli e SPd’Arena: tutte dovettero soccombere di fronte
all’omonima in Centro (zona di Castelletto) che conservò il titolo.
Nel 1933 era ancora
tale, di 4.a categoria, con 2 civici; ma intanto
via san Cristoforo era stata chiamata via Cesare Battisti. In
quest’anno, una proprietà privata venne ceduta gratuitamente al Comune, ma non
è precisato quale.
Attualmente, dal 19 agosto 1935
per delibera del podestà di Genova, è intestato vico
Alberto di Bozzolo.
DEDICATO: al comune mantovano
ove il 24 giu.1859 fu combattuta per quindici ore l’epica ed asprissima
battaglia del Risorgimento (2.a guerra di
Indipendenza), tra 80mila francesi guidati dall’ imperatore Napoleone
III, e gli austriaci forti di 90mila uomini, guidati da Francesco Giuseppe (i Piemontesi, erano schierati all’ala sinistra e
contemporaneamente impegnati nella vicina san Martino: un unico fronte ma con
due battaglie distinte; erano guidati dal re Vittorio Emanuele II, che riuscì
ad avere il sopravvento solo alle ore 21: soldati e re, si addormentarono
esausti, accanto ai soldati morti e non ancora raccolti).

E.
Meissonier – museo del Louvre - Solferino
Quindi nelle due località
vicine, separatamente, si scontrarono in assalti e contrattacchi furiosi e
sanguinosi all’arma bianca, 250 mila soldati (in
vari testi, sono controverse le cifre : per PastorinoVigliero: 118m
francesi-120m austriaci-imprecisati gli italiani ; per l’Enciclop.Motta
80m francesi-90m austriaci-imprecisati gli italiani; per Barbagallo 130m
pari . Nella carneficina generale, morirono o furono gravemente feriti, secondo
PastorinoVigliero: 22,5mila austriaci, 17mila francesi; secondo l’Enciclop.Sonzogno 13m francesi, 13m
austriaci, 5521 italiani; secondo l’Enciclop.Motta
17m francesi e 21m austriaci ; per Barbagallo 50000 morti e 23m feriti
tra tutti).
I francesi mandarono in battaglia gli zuavi (soldati
africani,caratteristici per gli ampi pantaloni fino al ginocchio, una fascia
alla vita ed il fez in testa) di
straordinario vigore, genericamente feroci e scarsamente rispettosi
dell’avversario tanto che compirono vere e proprie stragi tra gli austriaci:
furono loro che a Palestro riconoscendo il coraggio del re italiano, lo
promossero sul campo al grado di caporale.
Solo a sera, la spinta
dell’armata francese contro il centro dello schieramento austriaco ebbe il
sopravvento, rompendo il fronte nemico: cosicché alle ore 15 Francesco
Giuseppe ordinò la ritirata. Stremati, i soldati si addormentarono sui prati di
battaglia: la Lombardia era liberata e poteva entrare nel regno lanciando
contemporaneamente un chiaro messaggio alla popolazione di tutti gli staterelli
in cui l’Italia era ancora divisa.
Malgrado la vittoria,
Napoleone III sconvolto dalle perdite subite (disse: “non
dimenticherò mai più l’urlo disperato dei morenti”), firmò la pace di
Villafranca deludendo i patrioti italiani; Cavour si dimise da presidente del
Consiglio.
In
quegli anni, in guerra, era concetto generale considerare la morte come una
fortunata alternativa alla vita, mentre rimanere feriti era un po' come morire
lentamente in agonia, sia per le ferite (molte
d’arma bianca, generavano emorragie inarrestabili o infezioni con necessità di
medicazioni o amputazioni da svegli, senza anestesia , in un ambiente
genericamente sporco, infetto) sia perché
c’era il rischio sostanziale di rimanere abbandonati trascinandosi infermi
alla misericordia degli altri, non esistendo alcuna forma assistenziale né
immediata né proiettata nel futuro). Fu in questo scempio, in mezzo agli
innumerevoli casi di penosissima sofferenza fisica e morale che a Enrico Dunant
-svizzero, e per questa iniziativa premio Nobel per la pace nel 1901- nacque
l’idea di proporre a tutte le Nazioni un codice di protezione per i feriti in
guerra, chiamato “Croce Rossa”, che ancor oggi, ampliando il servizio al di là
degli eventi bellici, è benemerita di infiniti casi di assistenza nel mondo.
Re
Vittorio Emanuele II , presente e partecipe alla battaglia di san Martino,
promosse sul campo i due generali italiani che - con metà soldati rispetto al
nemico-, seppero condurre con estremo valore e sacrificio sei successivi
assalti frontali contro 50 mila austriaci.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica
, scheda 4234
-Barbagallo C.-Storia
Universale-UTET-vol.V -pag.1432
-Colombo E.–Epoca rivista
Mondadori.1964-documentari
-DeLandolina GC.-Sampierdarena
-Rinascenza.1922-pag,55
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino Sampierdarenese:
8/80.12 + 7/89.4 +
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1930ca-pag.19
-Pagano/1933-pag. 248
-Tuvo.Campagnol-St. di Sampierdarena-D’Amore.1975-p1716dice Napoleone II
SOMMEILLER
vico Sommeiller
Strada scomparsa nel
rivoluzionamento edilizio operato nella zona della Coscia.

STORIA: nell’anno 1900
venne proposta la titolazione all’ingegnere, del vicolo che porta “alla via
delle scuderie Carpaneto”; nel 1910 -con due civici dispari, 1 e 3- era
ufficialmente riconosciuto dal Comune locale,“da via Demarini verso la
collina”; una cartina locale (1925) riporta –col nome sbagliato- una “via
Somoiller” distaccatasi da via DeMarini verso nord, poco a ponente dell’
inizio di via Balleydier (verso mare); ed a sua volta con l’inizio-verso
levante- di vico Chiuso; per il Novella (1930ca) era “da via De Marini”.
Nel 1927 il vicolo viene
riconosciuto facente parte -nella grande Genova- della delegazione di
SPd’Arena, nel momento della unificazione comunale e quindi della
toponomastica.
Nel 1933 era ancora tale, di
5.a categoria, con due civici e chiuso alla fine ed infatti definito ‘vico chiuso
Sommeiller’.
Nel 1940 non c’era più; e la
parte di strada rimasta fu incorporata in via Balleydier. Però il Pagano/40 la
cita ancora come “vico Sommeiler” (con una elle
e senza null’altro come civici).
DEDICATA all’ingegnere
italiano, Germano Sommeiller, nato a Saint Jéoire nell’ Alta Savoia, nel 1815 (proprio in questa data, col trattato di Vienna, la
Savoia fu data al re di Sardegna, che la tenne sino al 1860; il Sommeiller optò
rimanere italiano); ed ivi deceduto nel 1872 (Tuvo però precisa: 17 settembre 1871; due mesi prima l’inaugurazione
del traforo del Fréjus).
Ricordato perché cooperatore del progetto e dei lavori,
assieme a Grattoni e Grandis, di varie opere pubbliche stradali e ferroviarie,
primo fra tutte la macchina perforatrice ad aria compressa- basata su
precedenti invenzioni di compressori da parte del Sommeiller (a colonna ed a
tromba; da Ogliari viene citato che nel 1853 i tre ingegneri furono “nominati dal Governo Piemontese ‘ingegneri aggiunti’
della ferrovia (Torino-Genova appena aperta) con l’incarico di occuparsi della
circolazione dei treni sulle rampe dei Giovi. Essi fanno brevettare un loro
‘ariete compressore’ destinato ad utilizzare la forza della cadute d’acqua
degli Appennini per comprimere l’aria in un tubo posto in asse alle due rotaie
del binario, per spingere i treni sulle rampe in salita. Il Parlamento stanzia
fondi per l’esperimento: il termine è di due anni. Ma questo non ha luogo:
l’’ariete compressore’ –su idea dello stesso Cavour- verrà invece usato per praticare
nella roccia i fori da mine nello scavo della galleria del Frejus”).
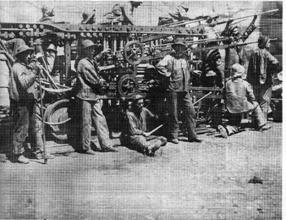
Ansaldo - perforatrice di
Sommeiller - 1857
Era stata costruita nello stabilimento dell’Ansaldo nei
primi tempi della sua nascita a nuova “società” acquistata da Taylor e Prandi.
Fu sperimentata nel febbraio 1857 alla Cava proprio per
bucare san Benigno ed aprire delle gallerie per la ferrovia; il giorno 2 del
mese dopo, venne a Genova il Cavour col ministro dei lavori pubblici Pietro
Paleocapa, per visionare lo strumento: soddisfatti dei risultati, fecero usare
la macchina perforatrice a compressione idropneumatica capace di accelerare e
semplificare il lavoro (fino ad allora eseguito solo a braccia) non appena
iniziarono nell’estate i lavori di apertura della galleria del Fréjus (iniziata nel 1857 fu terminata nel 1871, adibita ad
uso ferroviario, di 13.636 m. sotto il Monte Cenisio (o Moncenisio) -: massiccio delle Alpi Graie-Cozie , che divide il
Piemonte -Susa e Bardonecchia-, dalla Savoia -val d’Isère. La carrozzabile
attuale fu invece aperta per volere di Napoleone).
All’imbocco sud ovest della
galleria ferroviaria sotto san Benigno, fu poi posta una lapide che ricordava
con uno scritto apposito di Federico Alizeri: “NEL
MDCCCLVI – QUESTE ROCCE – OBBEDIENTI AL POSSENTE ORDIGNO – DEI PRODI INGEGNERI
– GRANDIS, SOMMEILLER E GRATTONI – MOSTRARONO POSSIBILE AD UOMINI – ENTRAR NEL
CENISIO- E APRIR L’ALPE AI COMMERCI – LA CITTA’ DI SAMPIERDARENA – IN APRILE
DEL MDCCCXXVII (errata ovviamente, nds)– STANZIO’ QUESTO SCRITTO – GLORIANDO –
CHE QUI S’AUGURASSE CON IMPEGNO ANIMOSO – L’ESTREMA FATICA DEL SECOLO”
Era divenuto nel 1854
onorevole, deputato al parlamento subalpino dove
fece un rapporto a nome di una Commissione che si interessava della spesa
straordinaria per l’acquisto di locomotive ad uso della strada ferrata; proprio
quando l’Ansaldo decise iniziare a fabbricarne a proprio rischio e pericolo,
pur essendo sotto apparente ‘tutela politica’ sul piano della produzione: si
ottenne così un contratto, similare ad una sfida intendendo che se non
funzionavano a pennello non sarebbero state acquistate; la battaglia fu vinta
perché la prima locomotiva prodotta, battezzata ‘San Pier d’Arena’ eseguì le
prove di esperimento con soddisfazione generale tale che fu messa in esercizio
subito sulla linea Torino-Genova (la quale era stata completata alla fine del
1853) .
Andò a lavorare anche in
America (per la ferrovia che univa l’Atlantico col Pacifico), e collaborò col
Paleocapa al taglio di Suez (1869).
Erano gli anni in cui era in
dirittura d’arrivo lo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico che
avrebbe trasformato il mondo: la luce elettrica; il telefono (Bell che rubò
l’idea a Meucci); i motori (Gramme che rubò l’idea a Pacinotti); la legge Coppino,
dell’istruzione elementare obbligatoria laica e gratuita; le grandi finanze in
mano alle banche, ecc.
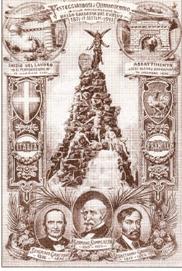

40°
inaugurazione del Frejus
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-A.sconosc.-Storia del trasporto
pubb. a Ge.-Sagep.’80-pag. 230cart.- Somoiller
-Castronovo
V-St.dAnsaldo-Laterza.94-v.I-p.104.f.13049.206n17.268n42.49.291
-DeLandolina GC-Sampierdarena
Rinascenza .1922 - pag.55
-Enciclopedia Motta morto nel 1871
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino Sampierdarenese :
4/85.15
-Museo SAgostino-archivio
uff.Toponomastica
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Ogliari&Muscolino-150anni di
trasporti in Italia-Socimi.1989-pag.41
-Pagano/1933-pag. 248 chiama Gerolamo ; /40-pag.412
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.68
---non citato da
Pastorino.Vigliero + 38 +
SPATARO via Giuseppe Spataro
TARGA: via - Giuseppe
Spataro – caduto per la libertà – 1925-16.1.45


angolo con Largo Jursé


finale strada, a nord
QUARTIERE MEDIEVALE:
Mercato – Ponte
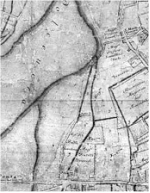 da MVinzoni, 1757. Zona di futura
apertura della nostra strada.
da MVinzoni, 1757. Zona di futura
apertura della nostra strada.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2852, CATEGORIA: 2
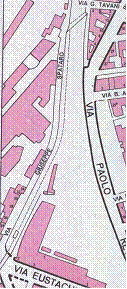 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 59380
UNITÀ
URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
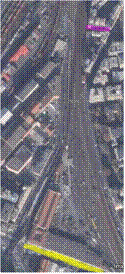 da Google Earth 2007. In giallo via EDegola; in fucsia via
GTavani.
da Google Earth 2007. In giallo via EDegola; in fucsia via
GTavani.
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: doppio senso viario; inizia da largo E.Jursé,
affianca a ponente la ferrovia verso nord; finisce, chiusa ai veicoli, ma
percorribile ai pedoni che possono usare lo stretto e basso sottopassaggio
della ferrovia, per sbucare in via G.Tavani.
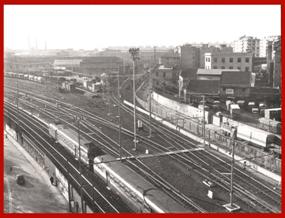

parallela
a via W.Fillak – foto anni ‘80 via Spataro in basso a sinistra, dal grattacielo
– 2004


dove – con
un cancello – finisce la strada imbocco del voltino verso via
G.Tavani
 il sottopasso
il sottopasso
STORIA: Nella carta del Vinzoni non appare alcun
segno di un tracciato sovrapponibile mentre possiamo concepire dei sentieri ai
limiti delle proprietà, se non altro per consentire a chi abitava vicino al
ponte e sottostante Fiumara, poter raggiungere la parrocchia a san Martino.
Così, dal ponte verso nord, tra la proprietà GBGrondona e
quella dei fratelli Veneruso; quest’ultima seguita fino alla attuale via
GTavani, dalle terre del mag.co Ventura (già del mag.co Stefano Lomellini
Carlo).
Il
percorso attuale, via Pacinotti-Spataro, era divenuto studio ingegneristico
pochi anni dopo, a fine del settecento (anche da Giacomo Brusco nel 1781), mirato a collegare la Marina del Canto con san
Martino per proseguire verso nord, allo scopo di evitare il centro - quartiere
Mercato - già evidentemente congestionato allora. Però, allora non fu
realizzato. Il progetto
fu proposto ai gestori comunali, sottolineando anche il basso prezzo –visto che
attraversava dei prati- rispetto una bonifica e ristrutturazione -peraltro
“senza raggiungere risultati di gran bellezza”- della vecchia via centrale
(cioè dell’attuale via C.Rolando). Dalla strada al Ponte verso nord, la nuova
strada sarebbe passata (sino all’altezza della chiesa di don Bosco), nei
terreni allora (1781) di proprietà dell’ecc.mo Domenico
Spinola (questi terreni erano estesi est-ovest, un poco arcuati, dalle
attuali via Degola-via C.Rolando ove era la villa padronale, l’attuale civ. 8).
A nord di questa proprietà, proseguiva tra -a levante quella del ‘m.co Vontegra
(non sicuro perché si legge malissimo) ora Cambiaso’-
ed a ponente ‘dell’Ospitaletto’ a livello della attuale via B.Agnese; ed infine
sui terreni del m.co Steffano Lomellino q.
Carlo, fino all’attuale via Tavani.
Nel 1853, con l’apertura della linea ferroviaria, specie, subito dopo,
della linea che portava a ponente, nuovamente si ravvide pressante
l’opportunità e l’utilizzo di una strada che proseguisse dalla Fiumara verso
Rivarolo, ‘bypassando’ il centro: si allargarono i sentieri e carrettabili già
tracciati da molti anni per uso pedonale dalla gente del luogo per andare a
messa nella parrocchia. Fu dapprima chiamata “strada reale di Torino” in prosecuzione della omonima già stesa dalla
Lanterna lungo la riva del borgo (attuale vie SanPierd’Arena+Pacinotti+Spataro).
Il nome poi fu modificato in via Garibaldi
agli inizi del 1900 per il percorso dal Canto a san Martino “da via C.Colombo
allo scalo Piccola Velocità” e poi “a via G.Tavani”. Ma qualcosa -che non conosciamo- dovette
modificare i progetti, forse l’apertura di via P.Reti o il raddoppio dei binari
dei treni: il
sottopasso ferroviario –stretto ed angusto- rende inspiegabilmente
inutilizzabile lo sbocco verso nord; e
–così stando le cose in superficie- impossibile chiedere alle ferrovie di
alzare il sottopasso, ed altrettanto approfondirsi per costanti allagamenti.
Il podestà di Genova, con l’unione delle delegazioni
nella Grande Genova, onde eliminare in periferia strade già titolate in centro,
il 19 agosto 1935 deliberò modificare il nome, titolando la strada via
A.Pacinotti; così rimase fino alla fine dell’ultimo conflitto bellico.
Con nuova delibera della Giunta del 26 aprile 1946 la lunga strada fu
denominata diversamente nei due tratti, lasciando via Pacinotti nella parte a
mare e dalla zona Crociera al sottopasso della linea ferroviaria venne
titolata al partigiano.
CIVICI nel 2007:
Neri=
da 24 a 36 (mancano da 2 a 22; compreso 32a, 34ab)
Rossi=
da 2r a 124r (mancano
da 36 a 58, da 62 a 100, da 104 a 122)
===agli inizi secolo, vi
era una fabbrica di olio intestata a Scerno e Gismondi
(Enrico Scerno aveva fondato nel 1860 una
piccola fabbrica di chinino e biacca che usava metodi di lavorazione
primordiali, non più modernizzati e così perdendo il mercato; così poi fu
trasformata –assieme al Gismondi- in raffineria del salnitro chiamata ‘Nitrum
Scerno-Gismondi e C’ per l’uso fatto dalle polveriere militari statali,
raggiungendo i 30 operai, ma già ridotti a 10 nel 1874. Nel 1875 l’azienda
passò alla fabbricazione di olio di semi, creando una soc. per azioni con gli
stessi imprenditori, e ricca di un modesto capitale (740mila lire) proveniente
da numerose fonti.( Dei suoi due figli, prevalentemente Fausto fu presente in
molteplici azioni di imprenditoria (tra cui ricerche petrolifere in Emilia
–antesignani dell’ENI a Cortemaggiore- con perdita nel 1877 di tutto il
capitale impiegato. Con alterne fortune, scelse infine divenire importatore di
cereali, e da qui azionista di peso nella società Molini Alta Italia).
Carlo
Gismondi, dopo la società chimica fondata assieme al precedente, divenne
commerciante all’ingrosso di cereali, e dopo anche lui fu azionista nei Molini.
Mori’ nel 1900
===Nella strada nei lontani
anni 1920 vi aveva negozio di costruzione, riparazione ed affitto biciclette, un asso del ciclismo di allora, Libero Errante; corridore di rilievo nazionale, si
distinse in molte gare favorendo l’entusiasmo e lo sviluppo di questo sport. Il
padre era venditore di giornali, ove è ancor ora l’edicola, nella piazzetta di
largo Jursé.
Nel Pagano/1950 sono segnalate due osterie (68r di Quaglia V.; 82r Grillo B.); un bar
all’84r di Maia Teresa; nessuna trattoria).
Invece nel Pagano/1961: sempre le due osterie dove solo la seconda è divenuta di Manno GB; il
bar è divenuto bottiglieria di Marino G.; in più= 64r canc-Rossi D lubrific.;
76r Campana M. commest; 78r Pigoni A noleggia moto; 86r la Amuchina disinfett. ha uno stabilimento; 88r fino a
92r lo spaccio commest- dell’Eridania.
Solo nel 1987 si sistemò definitivamente la numerazione stradale (dalla
scheda della toponomastica, appare solo per i civv.rossi).
Molte costruzioni sono di proprietà comunale e per alcune di esse in angolo con
via T.Grossi, è stata prevista la utilizzazione ad autosilo per auto,
abbattendo i capannoni ed usando prefabbricati metallici moderni; ma nel 2008
tutto giace.


la lapide


anno 1930 cerimonia deposizione di lapide ai caduti



sottopasso di ingresso e uffici lapide nel
sottopasso piazzale (uffici a destra)
===civ
34 si apriva la Raffineria Zuccheri Ligure Lombarda (poi ’Eridania’; descritta alla E).
Oggi
è sede della soc. “fratelli Pagano” trasporti. Pagano Giuseppe (da piccolo autotrasportatore
autonomo che iniziò in via del Molo nel 1945, subentrò come sede al grande
complesso, nel 1946; con i dovuti sacrifici e valenza, e col subentro dei due
figli, sono riusciti a rimanere uno dei pochi efficienti servizi di
autotrasporti nazionali, ristrutturando anche due vecchi capannoni per l’uso di
deposito, svuotati dei macchinari e rifatti dalle fondamenta. Nei vari passaggi
ci si infilarono anche gli speleologi del Gruppo di Roberto Bixio –vedi in via
Avio- ma appurarono che solo erano vie di comunicazione tra i vari capannoni e
di scarico verso il torrente). Nell’ingresso dell’area di lavoro, c’è un
iniziale sottoèpasso nel quale èmurata una lapide che ricorda la visita del re
ai vecchi zuccherifici.



ristrutturazione del 1998 valvola di chiusura di
recipiente


===civ.34A e 34B furono assegnati a costruzione
scolastica ristrutturata nel 1979. (===ex-civ. 34): edificio scolastico, vincolato dalla
Soprintendenza per i beni architettonici.
Da
foto del 1930 ca (riferentesi
ad una lapide ai caduti con la scritta: ‘vivono nella gloria’ (illusi,
poverini!) apposta sopra la porta dedicata ai Caduti in Guerra della
Soc.Lig.Lombarda con concomitante premiazione di 17 vecchi –dopo 50 anni di
lavoro- operai benemeriti; dei quali 5 riconosciuti meritevoli dal Governo di
una Stella Nazionale del Lavoro) si
rileva che la palazzina, allora singola (ovvero senza l’aggiunta del prolungamento a nord), era la sede della Società stessa.
Probabilmente
durante l’ultima guerra, tutta
l’ala destra, a monte, della palazzina
–a nord- è crollata e nel ricostruirla nel dopoguerra (mancano così due finestre al lato
del portone che appare decentrato; e la lapide) hanno aggiunto un corpo similare, diverso strutturalmente distinguibile dalle finestre più piccole e basse.


ristrutturazione del 1998
Divenne
dapprima succursale (1978) della ‘scuola Cantore’ (sul Gazzettino del lug.1979
si legge “l’anno scorso
la scuola Cantore ha usufruito della nuova scuola di via Spataro; quest’anno
avrà a disposizione l’ex istituto suore di sant’Anna” (in via Currò)), poi della
scuola succursale “istituto magistrale statale Piero Gobetti”; poi infine è
stato a lungo abbandonato ed occupato abusivamente da extracomunitari. Nel
febbraio 2002 è stato circondato da impalcature per lavori, previsti da
completarsi in un anno, di ‘adeguamento normative’.
Nel 2007 la facciata è deteriorata da innumerevoli e
ovviamente stolide scriutte con bombolette. Una targa sopra l’ingresso
principale segnala semplicemente «Istituto Magistrale statale Piero Gobetti»;
altra sopra il civ.102r segnala «Istituto
Statale “P.Gobetti” – succursale (di largo Gozzano, 5) – via Spataro N° 34 –
indirizzo “Brocca” – socio psicopedagogico», tel. 010 64.69.787.
L’indirizzo ultimo descritto è a carattere sperimentale, con
due diplomi dopo 5 anni: A) di maturità magistrale, conseguibile con tre
diramazioni convergenti=liceo delle scienze sociali; =idem a indirizzo
musicale; =socio-psico-pedagogico Brocca. B) di maturità linguistica seguendo
il corso ‘linguistico Brocca’.
===civ.
38 la sede della soc. Libertas Genoa Tennistavolo
(della FIT-T; vulgo “ping pong”), nata nel 1992, iscritta alla Federazione
Italiana (FIT) iniziò una politica di stretto collegamento con le scuole locali
al fine di attingere nuova linfa, raggiungendo dopo soli tre anni risultati da
campioni nelle varie categorie della disciplina. Sotto la guida del pf. Quaglia
(tecnico di fama europea) militano una campionessa mondiale (bronzo a Budapest
di Fracchiolla Marina nel 2002), e pluricampioni d’Italia.
Nel
2007 appare presidente Sergio Montisci e, delegato della struttura federale:
Patrizia Boccacci di via GB Monti 56/9b.

a sinistra, la sede della società nel piazzale
Forse
è su questa area –definita ‘molto grande’ - che alla fine del 2009 si parla
verrà costruito un polo sportivo – già progettato e presentato al Coni- che
conterrà due palestre: una grande, per eventi (basket, volley su tutti) di alto
livello; ed una più piccola per allenamenti; ed altre aree da dedicare allo
sport.
DEDICATA al
partigiano, nativo di Roccella Ionica (RC) il 18 mar.1925; operaio dell’Ansaldo
Meccanico, fu tra i primi degli abitanti del quartiere san Martino-Campasso a
sentire il bisogno di ribellarsi in modo concreto alle crescenti irruenze dei
fascisti. Inizialmente con approcci vaghi, non organizzati, facili ad essere
captati dal nemico, si limitò a contattarsi con pochi compagni per fare
propaganda orale, distribuire manifestini ciclostilati, raccogliere materiale
vario, opportuno per il futuro: dai vestiti alle armi.
Dopo l’ 8 settembre, da questo nucleo isolato, nacque più organizzato il
”fronte della gioventù”, col compito di favorire scioperi tra gli studenti,
organizzare il “soccorso rosso”, reclutare nei luoghi d’incontro (Croce d’Oro,
don Bosco, bar, Società di mutuo soccorso ) chi condivideva le idee o
quantomeno in quei giorni desiderava fuggire per non essere obbligato nelle
truppe di Salò.
Nel giu.1944, tutte queste iniziative confluirono nelle SAP (squadre di azione
patriottica), ove lui scelse il nome di battaglia “Roberto”, divenendo
comandante del distaccamento Carlo Roncati, della Brigata SAP Giacomo
Buranello.
In una prova generale della agognata liberazione di Genova, malgrado essa fosse
stata programmata ed eseguita in gran segreto, le Brigate Nere vennero a sapere
del fatto ed organizzarono a loro volta una contromossa che sfociò in uno scontro
a fuoco in cui persero la vita due fascisti: il cerchio si strinse fino al 16
dic.1944 quando lo Spataro venne catturato assieme a Jursé nelle sale della
Ciclistica. Furono assieme condotti alla casa Littorio, e sottoposti ad
interrogatori con pestaggio e tortura. Il 15 gennaio successivo, condotti
assieme sotto l’archivolto ferroviario del Campasso, nella notte e senza
precisa condanna da tribunale, furono fucilati, lasciando i corpi a terra come
monito a tutti gli abitanti della zona .
In tasca ambedue avevano un panino ed una mela; di dubbio significato:
falsificare che avessero tradito, e quindi avessero ricevuto promessa di
trasferimento, oppure di calmiere onde evitare la fuga se avessero saputo del
loro reale destino.
Sul giornale cittadino, il giorno dopo, si fece riferimento a “salme di due
sconosciuti, rinvenute al Campasso, presumibile scontro tra fuorilegge o bande
di ribelli, abbandonati a se stessi dagli angloamericani”.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4260
-AA.VV.-annuario
guida archidiocesi-anno/94-pag447 anno/2002-p.483
-AA.VV.-Contributo
di SPdA alla Resistenza-PCGG 1997-pag. 197
-AA.VV.-35°SPd ’A
-Comune
di Genova- stradario anno 1953 – pag. 169
-Corti
M.-Annuario ligure dello sport-LoSprint 2008-pag. 400
-Doria
G.-Investim e sviluppo econom. a Ge.-Giuffrè.1969-vol.I-pag396
-Gazzettino
Sampierdarenese: 7/79.1 + 4/81.7 + 2/89.11 +
-il Secolo XIX , del
27.04.02
-Lamponi M.-Sampierdarena-
LibroPiù.2002- pag.119
-Pagano/1933-pag.246;
/1961-pag. 399
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
strade di Ge-Tolozzi 1985-pag. 1724
-Poleggi
E&C-Atlante di Genova-Marsilio 1995-tav.21
-Stringa P.-La Valpolcevera-
Agis 1980-pag. 92cartina
SPAVENTA via Silvio Spaventa
TARGA : via – Silvio Spaventa
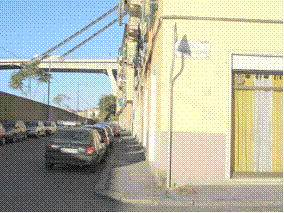

angolo con via del Campasso

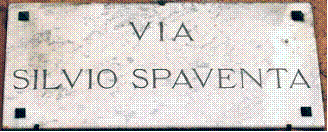
angolo con
via Pellegrini
QUARTIERE
ANTICO: san Martino
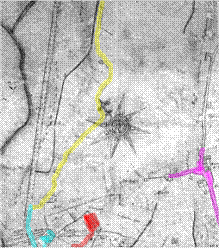 da MVinzoni 1757. In rosso, villa Durazzo-Currò; fucsia
santuario di Belvedere; celeste, chiesa e oratorio di san Martino; giallo, via
Vicenza e Campasso.
da MVinzoni 1757. In rosso, villa Durazzo-Currò; fucsia
santuario di Belvedere; celeste, chiesa e oratorio di san Martino; giallo, via
Vicenza e Campasso.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2853
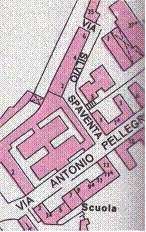 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 59400
UNITÀ
URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
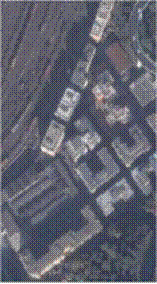 da Google Earth, 2007.
da Google Earth, 2007.
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Cuore di Gesù (Campasso)
STRUTTURA: senso
unico veicolare, da via A.Pellegrini a via Campasso
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
Si sviluppa a S rovesciata con un primo e terzo tratto
perpendicolare alle vie Pellegrini-Campasso, e quello centrale parallelo alle
due strade.


primo tratto ( a sinistra
l’ala nord del mercato)
STORIA: la strada è
nata nei primi del 1900, con la costruzione della prima casa (dal 1908, i proprietari dei civv.
2-4-6, non pagarono tassa di proprietà fino al 1980), ma rimase anonima. Ancora nel 1910 non compare
riconosciuta ufficialmente dall’autorità comunale, però nell’elenco delle
strade pubblicato in quell’anno, compare il nome aggiunto a penna (‘dalla via A.Pellegrini alla via G.Bruno, con civv sino all’ 1 ed 8’; tipico delle
vie approvate nel periodo 1914-20).
Infatti l’Ente Autonomo Case Popolari, istituito nel 1915, ed approvato
con regio decreto il 4 feb.1917, ricevette
dal Comune, all’atto della fondazione, un lotto di terreno edificabile, ed una
casa già eretta nella zona.
L’ente si affidò all’ing. Adriano Cuneo, per
progettare la sistemazione delle aree, ed al Consorzio Ligure delle Cooperative
di Genova, per costruire. Difficoltà finanziarie impedirono di attuare il
progetto; sino al 1930 quando esso si fuse nello IACP (oggi ‘Arte’), che ereditò i beni ed il programma.
Per attuarlo, inizialmente l’Ente trovò necessario chiedere la partecipazione
economica delle varie industrie cittadine ritenendole responsabili e
beneficiarie del grosso afflusso immigratorio. Da allora, il tratto fu
completato con altri edifici a speculazione privata.
La strada, fu quindi dapprima, agli albori del 1900, considerata solo una
traversale di via G.Bruno (via Campasso); poi fu collegata con via Pellegrini acquisendo
autonomia e nome ben dopo il 1910 (comunque nel 1927 viene segnalata strada di
SPd’Arena nell’elenco pubblicato dal Comune delle neonata Grande Genova, e di
5a categoria) e probabilmente con carattere di via privata se risulta essere
entrata nell’elenco delle strade comunali solo agli inizi del 1956.
Nel 1921 viene segnalato un aumento di tasse ad una azienda esistente nella
strada: ‘Garbarino e Sciaccaluga, trasporti ‘.
Nel 1956 viene iscritta nell’elenco delle strade comunali
CIVICI nel 2007:
neri
da 1 a 7 (compreso 1a); e da 2 a 6
rossi
da 1r a 31r (mancano
da 13 a 17 e 21) e da 4r a 10r (manca 2)
Nel
Pagano/40 va “da via A.Pelleghrini a via Campasso” ed ha ai civv. neri 7
s.a.Ind.Frigorifere; senza civico l’Asilo Infant.«Campasso»; nei civv. rossi: 2
commestibili; 3 fruttiv.; 27 bottigl.; 29 commestibili.
===civ
.1, 1A, 3: posizionato a
destra, dopo una entrata aperta di pochi metri, si accede ad un cortile sul
quale si aprono i tre portoni, il primo dei quali è rialzato ed ha accesso con
una breve scala esterna.
Costruito
nel 1919 dall’ICP di San Pier d’Arena, copre un’area di 578 mq.; fu colpito dai
bombardamenti nel ‘43-4 ed andò abbondantemente distrutto. Ciò malgrado negli
appartamenti più o meno illesi trovarono ospitalità in periodo postbellico
emigrati del sud arrivati per lavorare all’Italsider (baresi e napoletani, oggi
normalmente integrati nella città). Fu ricostruito nel 1954 con il contributo
della Cooperativa dei Carbonai genovese, da ciò il nomignolo di ‘palazzo dei carbonai’ (o ‘carbonê, camalli,
coffesanti’). Il Gazzettino fornisce la versione che il nome proviene dal fatto
che vi abitavano questi lavoratori (e che ‘tornavano a casa con le tracce del minerale sulle
ciglia’, portando i mandilli a quadretti bianchi e rossi entro cui avevano
custodito il cibo).
===civ.
2 posizionato a sinistra della
strada, è probabilmente il primo civico costruito nella strada, risalente
quindi alla prima decade del 1900. Viene ricordato che molti appartamenti erano
di proprietà di un porcaio che aveva negozio in piazza Masnata ove era il
trippaio (oggi
gelateria Maracanà). Nei fondi del
palazzo ed aperto anche nel retro in via Campasso 97r c’era negli anni 1950-60
una fabbrica di detersivi, specie lisciva e poligrina (di proprietà di Gallino S., ora in
via Vezzani); nel retro (sempre in via Campasso) invece c’era anche una fabbrica di bottiglie di
vetro e di tappi (si legge ancora la scritta sopra le saracinesche), e su
questo lato la facciata fu decorata con riquadri posti tra e sopra le finestre,
contenenti immagini a rilievo di stella, e di decori di fantasia (non frequente la decorazione sulla
facciata posteriore e non sulla anteriore, a significato di maggior pregio
della via principale).
===civ.
5: inizialmente, al posto del
palazzo esisteva un rilievo tipo collinoso libero a prato con una generosa
fonte d’acqua potabile; il rilievo fu spianato e vi costruirono nel 1949 una
baracca adibita a depositi ferrosi di proprietà di Pittaluga, a cui fu
assegnato il civ. 5; nel 1963 la baracca fu demolita, e sul luogo l’anno dopo
fu eretto il nuovo attuale palazzo.
=== civ. 6: Durante l’ultima guerra, fu
parzialmente colpito .
===
civ. 7: Agli inizi dell’anno 2000
si completò l’ultimo edificio eretto al posto di una vecchia fabbrica di ghiaccio, andata demolita pochi anni
prima (L’industria del
freddo, giudicata di sicuro avvenire, nacque nel primo decennio del secolo
1900 in genere affiancata alla produzione di birra; ma nei cinque anni dopo
l’insieme delle piccole aziende ebbe un brutto ridimensionamento con spesso
perdita di tutto il capitale impiegato, segnando un colpo negativo per le
minori imprese industriali, a vantaggio dei grandi trusts).
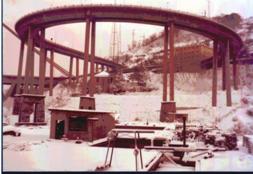


neve–foto presa dal tetto della fabbrica di ghiaccio;
la fabbrica nei preparativi della demolizione
e rimozione recipiente x anidride carbonica
Questa,
nata nel 1933 su progetto dell’ing.civile Adriano Bagnasco, si chiamava SAIF
(società anonima Industrie Frigoriferi genovesi, ed affini; si apriva in via
G.Bruno 83-85r), di proprietà Ghezzi Elio & c.: veniva fabbricato il
ghiaccio in lastre (favoriti
dalla possibilità di attingere localmente da numerose sorgenti esistenti nella
zona ed opportunamente incanalate; di infantile memoria in assenza dei
frigoriferi nel ventennio seguente la fine del conflitto mondiale, col ghiaccio
sia come conservante dei cibi nell’apposita madia rivestita di metallo, sia da
grattare con apposita pialla per farsi saporose e rinfrescanti granite
casalinghe); si caricavano bombole di
anidride carbonica ed aveva dei frigoriferi atti a grossi depositi (nel Pagano/61
coesiste alla SAIF anche una VEGA srl, deposito di gelati); il figlio del
proprietario con altro imprenditore Berni cessarono tale produzione negli anni
1980 trasformando il fabbricato in deposito derrate scandinave ‘Stokafiss Norge’: l’arrivo pressoché giornaliero di grossi TIR , sia
per la ristrettezza di tutta via Campasso che per la secca curva per immettersi
in via Spaventa fu per vari anni un gravissimo problema di traffico e posteggi.
Collaborava ai grossi ingorghi la presenza negli stessi ambienti della società
‘Coop-45’ che lavorava pesci e verdure surgelati (poi trasferitasi a
sant’Olcese).
Distrutto
l’edificio, ne fu ricostruito uno nuovo a scopo abitazione, completato
nell’anno 2000.
Nel
Pagano/61 esistevano ai numeri rossi: civ.2r, Parodi Luigi-commestibili; 3r, Giordano A.-frutta; 5r
canc., Pittaluga P.-ricup.demoliz.; 6r, Raddino M-latteria; 27r, Magnani
O-osteria; 29r, Accornero P.-pizzic.commestib.
DEDICATA al
patriota ed uomo politico nato a Bomba (Chieti) nel 1822.
A 21 anni si trasferì a Napoli, aprendo una scuola privata di filosofia, fondò
il giornale politico “Il Nazionale” ove sosteneva la necessità di allearsi col
Piemonte contro l’Austria e fondò una società segreta chiamata “Unità
Italiana” con idee antiborboniche (Ferdinando II) e con sentimenti unitari.
Dopo pochi anni di attività clandestina, a 26 anni quando era divenuto anche
deputato al parlamento napoletano, venne individuato dalla polizia ed
imprigionato assieme a Luigi Settembrini e Carlo Poerio. Tutti e tre
processati, vennero riconosciuti colpevoli di tradimento e condannati a morte
(pena che venne commutata nella reclusione a vita, da scontare nel bagno penale
di Ventotene). Un successivo provvedimento giudiziario –1859 - commutò
l’ergastolo in esilio.
Così fu imbarcato per essere trasferito in America; ma quando la nave raggiunse
l’Irlanda, assieme al Settembrini riuscì a sbarcare, rifugiando presso altri
componenti del liberalismo italiano residenti nei paesi anglosassoni. Da
Londra, scese in Piemonte attendendo un anno per poter tornare a Napoli nel
1860-1, dove – d’accordo con Cavour - fu incaricato di fomentare la
rivoluzione nel nome di Vittorio Emanuele II prima ancora dell’arrivo di
Garibaldi.
Durante il periodo di luogotenenza gli fu affidata la direzione delle forze di
polizia (dette allora “Comitato dell’Ordine”), affrontando gravissimi problemi
con somma intelligenza e provveduta severità (ma questo lo pone in situazione
inversa, di servilismo ai Savoia: fino ad arrivare a eserciare per loro, lo
stesso ‘spirito indomito’ che lo avevo posto a combattere contro i Borboni).
Finché in attrito con Cialdini, diede le dimissioni.
Ma intanto era cresciuta gradatamente la fiducia nel suo operato e gli
incarichi amministrativo-politici: 1861, deputato nel paese natale del nuovo
regno; 1862, segretario generale agli interni; 1868, consigliere di Stato;
1873, ministro ai lavori pubblici (furono in questa occasione due importanti episodi: uno che
statalizzò le ferrovie romane e meridionali pur lasciandole affidate in
esercizio a compagnie private causando così la sconfitta della Destra al
parlamento. Secondo, di interesse genovese, lo ebbe protagonista nella vicenda
con quel Raffaele DeFerrari a cui Genova ha dedicato la sua piazza centrale:
quando questo banchiere, noto per la sua enorme ricchezza associata a
taccagneria, si propose per regalare a Genova l’impensabile somma di 20milioni
di lire-oro necessarie per costruire nuovi e decisivi moli nel porto, non fu
preso sul serio dal ministro e pare che alla prima richiesta non fu ricevuto:
lo Spaventa fu obbligato a chiedersi dove stava il negativo di una simile
proposta, fatta da un simile personaggio, teoricamente improponibile senza
esserci un tornaconto pericolosamente non evidente. Alla fine però, perorato
dal Cavour , il duca fu creduto, e l’offerta venne accettata ed utilizzata per
creare il molo Galliera, il Giano ed il Lucedio. Altre opere di imponente
impegno vennero donate alla città dal divenuto senatore del regno e principe di
Lucedio, e poi dalla sua vedova Maria Brignole Sale: doni elargiti dai due
in tarda età, dopo una vita vissuta nel fruttuosamente impegnare i capitali in
grandi e redditizie operazioni bancarie e di borsa, e finanziamenti di grosse
imprese come il taglio di Suez).
Divenne senatore nel 1889, e nel medesimo anno eletto presidente della IV
sezione del Consiglio di stato (organo di giustizia amministrativa); fu
riconosciuto membro d’onore della corte reale e iscritto a molte associazioni (specie di stampa in quanto
scrittore autorevole di politica, schierato a destra essendo ardente seguace
del sistema parlamentare inglese con l’idea dello stato forte e capace di
assicurare a tutti sia protezione che giustizia ed a cui dovevano essere
subordinati gli interessi particolari).
Morì
a Roma nel 1893.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4261
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.447—ed./02-pag.483
-AA.VV.-L’Edilizia
residenziale pubblica-Comp.Librai-1999-scheda 286
-AA.VV.-La
storia d’Italia-biblioteca di Repubblica.2004-vol.18-p.389foto
-Balletti.Giontoni-Una
città fra due guerre-DeFerrari.1990-pag. 151cartina
-Bampi&Oneto-L’insurrezione
genovese del 1949-IlCerchio 2010-pag.5
-DeLandolina
GC.- Sampierdarena -Rinascenza.1922- pag. 56
-Dolcino
M.-Storie di Genova-Frilli.2003-pag.66
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese : 7/92.7
-Genova, rivista del Comune
: 2/56.43
-Lamponi
M.-Sampierdarena- Libro Più.2002 –pag. 161
-Novella
P.-Strade di Ge.-Manoscritto B.Berio.1900-pag.19
-Pagano
1933-pag.248.1388 Pagano/61-pag.399
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1085-pag.1700
-Poleggi
E. &C.-Atlante di genova-Marsilio.1995-tav.10
SPEZIA via La
Spezia
TARGA: 2 – 2866 -
via – La Spezia

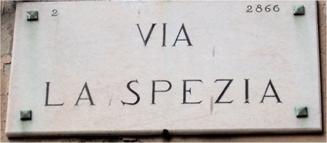
angolo con via A.Cantore
QUARTIERE ANTICO:
Mercato
 da MVinzoni, 1757. In fucsia salita
SRosa; celeste villa Doria-Franzoniane e salita sBarborino; giallo, villa
Imperiale la Bellezza. In verde ipotetico tracciato di via La Spezia
da MVinzoni, 1757. In fucsia salita
SRosa; celeste villa Doria-Franzoniane e salita sBarborino; giallo, villa
Imperiale la Bellezza. In verde ipotetico tracciato di via La Spezia
N° IMMATRICOLAZIONE:
2863 (non conforme con
la targa)
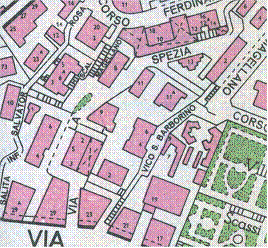
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 32840
UNITÀ URBANISTICA: 27
- BELVEDERE
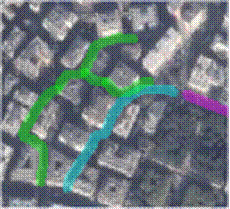 da Google Earth 2007. In celeste
salita sBarborino; fucsia corso OScassi; verde via La Spezia
da Google Earth 2007. In celeste
salita sBarborino; fucsia corso OScassi; verde via La Spezia
CAP: 16149
PARROCCHIA : (civ. 1
e 2)=sM.della Cella – (il resto)=Cristo Re
STRUTTURA: da via
A.Cantore a corso F.Magellano
La strada percorre solo un tratto di una ripidissima valletta secondaria della
pendici del colle di Promontorio: quest’ultima, dopo un breve tratto
semipianeggiante in origine si impennava bruscamente verso l’alto, da cui in
senso inverso scende un rio, anonimo nella topografia generale, che si scarica
a mare ancor oggi con tragitto sotto terra lungo via Gioberti.
Tutto l’appezzamento, dalla attuale via N.Daste, oltrepassando la strada
soprastante di c.so Magellano fino a raggiungere l’apice del colle, era
proprietà dei Pallavicini.
Nel 1936 avvenne una trattativa con gli eredi della famiglia Pallavicini da
parte del dopolavoro Ansaldo. La spesa prevista di 350mila lire aveva il fine
programmato di costruirvi un complesso sportivo ristrutturando un palazzo
esistente chiamato “Smith”, sconosciuto; attorno sarebbe stata riattata una
grossa vasca soprastante, e sarebbero sorti campi da tennis e bocce. La trattativa
fallì, così prima che subentrasse la guerra, tutto fu acquistato da una
impresa che solo a fine guerra iniziò a lottizzare i terreni.
L’erta valletta, quando in alto a metà fu tagliato il corso Magellano, fu come
bloccata a guisa di diga dal relativo muraglione; resistette ancora qualche
anno isolata e selvaggia, ma dal 1954 in poi fu invasa dal cemento che
ovviamente ne radicalmente cambiò l’aspetto; nei 5-6mila mq esistenti sorse ad
opera di numerose e diverse società una fungaia di case così addossate una
all’altra da non lasciare spazio alla fantasia diversa dalla vile speculazione,
anche in virtù del fatto che esisteva preciso un piano regolatore (si presume
non quale poi applicato) tra cui l’obbligo di munire le case di garage o box per
auto. Quando le varie cooperative ritirarono i propri mezzi ed attrezzature,
rimase uno spiazzo di 60 mq a metà via che fu proposto in donazione al Comune;
questi accettò, purché fosse adibito ad aiuola alberata: nacque così quest’oasi
di verde e vi furono messi a dimora 11 abeti.

anno 1978
Prima dell’urbanizzazione, sotto la strada scorreva un
corso d’acqua torrenziale anonimo; negli anni 1950 era ancora un rivo libero a
cielo aperto che allora fu coperto e rinforzato con cemento ai lati che già erano
tenuti da muretto di pietre; residua quindi un cunicolo a soffitto
tendenzialmente piatto, alto da 1m fino a 1,60 percorribile per 50m circa fino
ad un crollo in alto sotto il cui pietrisco filtrano dall’alto le acque
provenienti da Promontorio ma che prima ancora dell’ultimo evento bellico erano
dapprima fermate in un vascone collocato alla fine della strada ed alla base
dello scoscendimento oggi contenuto da un alto muraglione. (vedi RioPromontorio
e relazione del CSS, in classificatore rosso)
Ora è strada chiusa, seppur con doppio senso del
traffico veicolare; quasi al sommo è bloccata alle auto, ma collegata
pedonalmente con il corso soprastante di Quota 40, attraverso due scalinate:
una rettilinea ‘scalinata Magellano’ di 135 alti scalini abbastanza
mozzafiato, e quella meno impegnativa ma raggiungibile dopo altri 100 metri di
ripida salita, che sbuca di fronte all’ascensore dell’Ospedale.
CIVICI
2007= NERI = da 1 a 13
e da 2 a 14 (compreso 12A)
ROSSI = da 1r a 85r (compresi 1ABCr, 7Ar, 9ABr, 19Ar,
43A→Er, 55Ar, 83ABr)
e da 2r a 80r (compresi
14ABCDr, 26Ar, 68Ar, 76Ar)
I numeri civici neri, arrivano sino al 13 e 14: un
vantaggio è che gli appartamenti sono muniti di terrazzi ben esposti al sole e
godibili: qualcuno con più gusto ne ha fatto una serra, vincendo più volte il
premio del poggiolo fiorito messo in bando dall’Assessorato del Turismo.
===i civv 1, 2, 4: furono trasferiti
da via Cantore ove erano rispettivamente il 25,25A,27, all’atto della
denominazione stradale. Il civ. 4 si dice eretto
sulle fondamenta di una costruzione preesistente –forse la ‘casa Smith’-
demolita nel 1954; viene descritto anche che alla demolizione, fu trovata una
galleria sotto il palazzo che lo connetteva alla salita S.Rosa: ma
presumibilmente era solo il cunicolo di interramento del rio, che
presumibilmente fu fatto durante i lavori per l’apertura di via A.Cantore);


tratto iniziale da via
A.Cantore civ. 1 – foto 2008
 civ. 2 –
foto 2008
civ. 2 –
foto 2008
===i
civv. 3 e 5 (viene descritto esserci stato un cunicolo sottostante e che la roccia
fu spezzata a colpi di dinamite- vedi torrentello su descritto), 7 ed 8 furono eretti nel ’54; il 10 nel 1955; 6,
9,13 nel 1957; il 12 e 14 furono assegnati a nuove aperture nel 1957 ; l’ 11
ed 11a nel 1960.


civ. 3
===Nel
1958 i condomini del civ. 1 e 3 di salita Inf. S. Rosa preferirono divenire 6a
di via La Spezia con scala sinistra e destra.
===civ.
r: Il Cantinone un pub all’inglese, forse il primo a Genova. Aperto nel 1980,
su due piani, attira i giovani che trovano momenti di vivace aggregazione.
===civ.
r : il marmista Nebbia; subentrato nel 1962 alle stalle degli spedizionieri
Mottura e Fontana che con alcuni capannoni occupavano il terreno dove ora il
civ.4 e 6. Il terreno fu comprato dal pescivendolo Carletto di via Ghiglione,
convertito in imprenditore: creò una Coop per erigere i palazzi nella strada
usando il negozio quale punto di agenzia.
===civ.7:
inaugurata da Pietro Nenni nel 1953, c’era la sede della locale sezione del
Partito Socialista Italiano , chiamata ‘circolo ricreativo Pietro Chiesa’e
la sede redazionale del quotidiano “il Lavoro”.
Oltre a punto di incontro per dibattiti e di riferimento politico di tutto il
ponente cittadino, con ospite più volte Sandro Pertini, venivano proposte
attività anche ludiche : ballo (con due scuole chiamate ‘Primavera’ e
‘Lucchini’) e con tutti i ritmi (liscio, rock, latinoamericano, ecc); biliardo;
ginnastica artistica (nel 1979 vi aveva sede lo ‘Sporting club’; contava
duecento iscrizioni alla sezione ginnastica) e di mantenimento; paninoteca e
giochi elettronici per i giovani. Il Circolo era arrivato a contare un congruo
numero (circa mille) di iscritti.
Il Circolo fu sfrattato nel 1997 da un istituto bancario,
nuovo proprietario dei muri, e dovette abbandonare ogni attività dopo lo
smembramento del partito in seguito ai fatti di tangentopoli.
Nel 2000 divenne sede della “A:G:D:G:A:D:O: Massoneria, grande Oriente d’Italia, Circoscrizione
Ligure”.
La Massoneria, nacque come club prettamente maschile, in
Inghilterra ove ancor oggi esiste la “Gran Loggia Unita d’Inghilterra”
quale madre di tutte le diramazioni mondiali, diretta da un Gran Maestro dei
Gran Maestri. Avvenne circa a metà del 1700: tra il 1747 e 1787 si aprirono le
prime e più antiche associazioni (chiamate “Compagnia della felicità”, e “la
Compagnia della stella”, la “Fidelté”, l’ “Old british and ligurian lodge”, e
la “Saint Jean des vrai amis réunis”, nessuna sopravvissuta) prima di confluire
in una ed unica più potente struttura..
Oggi in Italia è suddivisa in quattro Logge: Il
“Grande Oriente d’Italia” (la più numerosa di iscritti che raggiungono poco
meno di 20mila); la “Gran Loggia Nazionale d’ Italia” o ‘Loggia di piazza del
Gesù’ che ne conta poco meno di 10mila; la “Gran Loggia regolare d’Italia” con
circa 3mila iscritti, nata da una scissione dal Grande Oriente ed unica
riconosciuta da Londra; la “Gran Loggia femminile d’Italia” con appena poco più
di 150 iscritte.
La nostra sampierdarenese è una delle 13 logge
genovesi (delle 35 in Liguria) con circa 600 iscritti. Si chiama “rispettabile
Loggia ‘La Verità Labor’ n. 95 all’Oriente”. Due grosse targhe ai lati del
portone segnalano che vi sono ospitati “il Collegio dei maestri venerabili
della Liguria” e che vengono accettati il “rito scozzese antico, di York’ ed
‘Ordes on the lastern star”.
Le nostre Logge nacquero tutte repubblicane,
mazziniane-garibaldine, quindi con un orientamento prevalentemente politico.
Nella sede si conserva un libro d’oro contenente le ‘tavole’ e le ‘balaustre’
inviate da garibaldi (quale Gran Maestro del Supremo Consiglio del Grande
Oriente d’Italia, con sede a Palermo). Punti di inserimento sociale sono
nell’economia e nella finanza (molti degli iscritti sono professionisti, grossi
imprenditori, personaggi dell’alta finanza e del ‘business’).
Mezzo usato è la valorizzazione degli ammessi (gli antichi
‘muratori’che tra loro si chiamano ‘fratelli’) tramite la dignità, la libertà,
rispetto del singolo e della diversità individuale e sociale.
Cerimoniali da applicare nei templi, sono l’uso di vesti
speciali (paramenti, grembiulini, fasce al collo con medaglioni, mantelli e
spade, e così via) e di simboli (usati dal demiurgo di Platone per segnare
l’inizio del mondo: compasso e figure geometriche –cerchi, quadrati,triangoli,
ecc.).
Scopi prefissi sono l’autonomia (in epoca della religione di
Stato, iniziò come ‘segreta’ con chiari atteggiamenti anticattolici; oggi è preferito
il termine ‘coperta’, o ‘riservatezza’) e la più completa ‘trasparenza’ nei
rapporti con le istituzioni e con i cittadini; in modo di essere eticamente
attivi nella società, ricusando antiche e più recenti (gli episodi della P2 con
Licio Gelli) storture dell’operato. Infatti, più lo Stato è debole, maggiore
possono essere le interferenze ed il ‘dominio occulto’ nelle transazioni
economiche e finanziarie, con possibilità di devianze non volute dallo
statuto.
Personaggi di spicco, vengono citati Wahington, Garibaldi,
e – numerosi - da Cavallotti a Bixio, da Pertini a Cossiga.
A fianco della società di cui sopra, si apre una porta che da accesso a
depositi del Monopolio
===10 int.19 abitava Roncagliolo Aldo Lorenzo, storico del Gazzettino, morto nel
2006 alla veneranda età novantenne e più. Figlio di Emilio (pioniere di ciclismo –con tessera dell’Unione Velocipedisti Italiani
n°79 - e detentore del record di 17 km., in 30’, nel 1896, su pista in terra
battuta e poi dirigente della categoria),
in gioventù aveva
praticato il Canotaggio nella Sampierdarenese
(dai tempi della sede a levante dei bagni Italia, a SestriPonente; con
conquista di numerosi titoli regionali ed uno anche nazionale nel 1974 al
timone di una jole, assieme a Vespa, Casalini, Fornaciari, Scotto) quale
timoniere, divenendo poi dirigente ed insegnante della disciplina. Andato in
pensione si era dato ad acculturarsi sulla storia genovese e sull’arte
divenendo un esperto riconosciuto.
===il 12A fu assegnato nel 1977 ad una porta secondaria
del civ. uguale di corso Magellano. Dal 2005 ospita l’assoc.
culturale Azzurra che ha scopo di proseguire
l’attività radiofonica di Radio Azzurra 88 rete Liguria in atto dal 1988 con
propositi di intrattenimento, informazioni, canzoni. Proseguendo con l’attuale
assc. si propongono anche recital di poesie (e narrativa), mostre di arti
figurative, e trasmissioni radio.
===58r
ospita il Camper Club Liguria (tel.o1o.463261)
e la Federazione Italiana Escursionismo (FIE tel.010.414194, espone
una bacheca di programmi in via Cantore presso il civ.48).
===ospitò per molti anni il GEAM (gruppo escursionistico
amici della montagna); il settore sci club sampierdarenese, ottenne buoni
piazzamenti in gare regionali della FIE. Alla fine del 1976 cambiarono la sede
sociale.
STORIA: Questo nome
stradale fu deliberato dal Consiglio comunale il 16 mar.1954 (il n° di immatricolazione è quello
subito successivo a P.za V.Veneto).
DEDICATA: al
capoluogo provinciale ligure, 90 km a levante da Genova, sorta in fondo ad un
golfo profondo 10 km., difeso alle spalle da alti monti. Comprende
32 comuni, conta circa 115mila abitanti.
La sua storia è difficile racchiudere in poche righe.
Comincia col nome: fin dall’antichità
medievale, il centro veniva chiamato “dela speza”; con “speza” preceduto dall’
articolo “la”.
Quando francesi prima, ma sopratutto piemontesi dopo,
costruirono l’arsenale, tutto il centro attorno ad esso lo chiamarono
semplicemente Spezia. I cittadini, nel 1926 fecero ricorso ed il 2 ottobre 1930
il re decretò per legge che - sia per tradizione storica che per l’uso locale
- da allora il nome della città sarebbe stato “la Spezia”. La scelta favorì
l’equivoco della “la” minuscolo, come vuole la grammatica italiana per un
articolo semplice e declinabile; e non “La” facente parte del nome e quindi non
più articolo e quindi indeclinabile. Nel 1996 il consiglio comunale ha posto
nel suo statuto la forma originale, che vuole “la” come semplice articolo e
quindi definendo che il nome della città è Spezia.
L’origine della città conta tre ipotesi:
si fa dipendere dagli
abitanti di Vesigna (paese posto sulla parte alta del golfo) che scesero al
mare nella località Poggio per favorire il commercio, e tra esso
presumibilmente più ricchi quelli delle spezie d’oriente (da cui:
spetie,spezie,spezia); oppure ai fuggiaschi di Luni che diedero -al posto di raccolta - il
nome di “hospitia”; oppure dall’estendersi di un primitivo
villaggio, chiamato Bagno Antico e riferito all’antro delle ninfe descritto da
Virgilio.
La zona era già abitata in forma evoluta dai liguri apuani nell’età del
bronzo e del ferro; nel III secolo aC si allearono con i Cartaginesi contro
Roma perdendo il conflitto; i soldati romani ne invasero il territorio e
fondarono nell’interno in posizione strategica (177 aC) la città di Luni. Essa
diventò centro dell’Italia Marittima bizantina e poi longobarda. Ma sotto i
normanni, fu depredata e saccheggiata scomparendo in decadenza.
In contrapposto, sul mare e solo nel secolo XII in
epoca feudale, fu rivalutato l’antico borgo limitandolo da una cinta muraria e
mantenendolo autonomo (fino al XIV secolo) con ampi territori estesi a levante
sotto il governo dei Malaspina confinanti a ponente con i Fieschi, conti di
Lavagna.
Le mire espansionistiche di Genova (ma anche di Firenze e Milano) orientate ad occupare la Lunigiana fino al passo della Cisa per poter
controllare la via di transito verso l’Emilia e Padania, riuscirono ad
indebolire i due feudatari che umiliati ed irati dovettero vendere il potere -
prima uno, i Fieschi (1276); poi l’altro (ne fa fede Dante Alighieri, ospite dei Malaspina e
portavoce dell’astio verso i genovesi),
alla Repubblica genovese.
Da allora la cittadina portuale seguì le sorti della Repubblica, anche se sempre
alla ricerca di una propria identità ed autonomia. Già aveva un proprio
podestà nominato da Simon Boccanegra (1343); forti mura col castello di san
Giorgio (del XIV e XVII secolo); un tribunale; ed un vicariato con il duomo
(1409, sulle fondamenta di una duecentesca chiesa).
Nel 1506, ebbe un primo governo popolare gestito dalla famiglia Biassa (nobile - ricca - rappresentata da
arditi navigatori).
Riuscì a conservare la propria integrità, anche se spesso coinvolta in lotte
vitali: ricordiamo dapprima con la vicina Carpena (dapprima dipendente dai loro
signori; poi ne furono vincitori nel 1412, radendo la nemica al suolo), poi con gli Sforza (1464: le truppe viscontee la saccheggiarono); con i pirati saraceni; e con gli austriaci: del gentile Botta Adorno nel 1746;
fu saccheggiata dagli austro-russi nel 1799 mentre erano in assedio di
Massena; e da loro ancora occupata dopo la sconfitta napoleonica del 1814 nel
fronte russo.
Solo nel 1797, governante a Genova la Repubblica Ligure, venne proclamata
‘capoluogo’ del distretto del golfo di Venere.
Dopo Marengo, Napoleone volle crearvi un porto militare: iniziarono i lavori
per la costruzione di un poderoso arsenale (furono aperte solo una strada litoranea e le basi del forte
sul monte Castellana)
Al congresso di Vienna (1815), la Spezia, la val di Vara e Sarzana furono
riconosciute al Piemonte (la
val di Magra e Pontremoli passarono al granducato di Toscana).
Durante il regno sabaudo, l’opera napoleonica fu proseguita dal Cavour (tramite progetti del gen. Chiodo) e nel 1857 si decise trasferirvi l’Arsenale. Così
che - quando nel 1860 l’Italia fu unita, e l’opera conclusa con
l’approvazione di una legge il 28 luglio 1861- la Spezia divenne il primo
porto militare italiano. Questo fu il primo importante avvenimento nella storia
economica della città, da cui essa trasse fondamentale impulso per la crescita,
da divenire per importanza, la seconda città della regione.
Solo dal 1923 è provincia a se stante.
Ricca di monumenti, di edifici e di opere d’arte di grande interesse risalenti
fino al XIV secolo, ha ricevuto di recente una donazione da parte dell’ing
Amedeo Lia, che ha arricchito la città di un museo d’arte (autentico tesoro di misura
internazionale, assieme a quelli donati da G.Cozzani e E.Capellini).
La vocazione turistica di molti suoi comuni rivieraschi, ne fanno una delle
province di richiamo e riconoscimento più interessanti d’Italia.
BIBLIOGRAFIA
-ACI-Guida
turistica e cartografica delle provincie...-vol.I-1980-pag.108
-Archivio Storico Comunale
- Toponomastica , scheda 2348
-AA.VV.-annuario guida
archidiocesi-anno/94-pag.413; /2002-pag.450
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese: 2/74.14 + 9/75.13 + 8/76.12 + 4/78.5 + 6/79.12 +
9/86.2 + 2/89.9 + 8/89.4 + 8/92.9 + 7/97.15
-Il
Secolo XIX : 22.3.04 + 12.01.96
-Lamponi
M.- Sampierdarena- Libro Più.2002- pag.186
-LaRepubblica
–quotidiano- 27.11.07 pag.34
-Ogliari&Sapi-Signori,
in vettura. Liguria-Ed.Autori.1965-pag.52
-Pagano/1961-pag. 443.597
-Pastorino&Vigliero-Dizion.
delle strade di Genova-Tolozzi 1985-pag 961
-Poleggi E &C-Atlante di
Genova-Marsilio 1995- tav. 34.35
SPINOLA via Spinola di san Pietro
TARGHE: via – Spinola
di san Pietro.

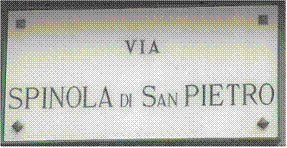

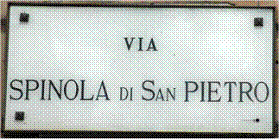
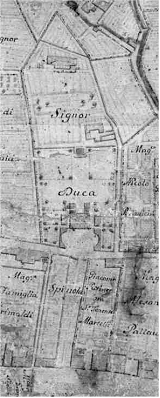 da MVinzoni, 1757. La villa del Signor Duca Spinola –aperta
sulla via Centrale (via LDottesio)- è al centro di un
vasto appezzamento a monte, ed una più stretta striscia -a valle- sino al
mare.
da MVinzoni, 1757. La villa del Signor Duca Spinola –aperta
sulla via Centrale (via LDottesio)- è al centro di un
vasto appezzamento a monte, ed una più stretta striscia -a valle- sino al
mare.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2791 CATEGORIA: 2
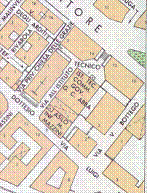 da Pagano 1961
da Pagano 1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 59605
UNITÀ
URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella (sic)
STRUTTURA: da via
L.Dottesio doppio senso viario ma senza sbocco perché chiusa a nord da una
ampia scalinata che consente solo il passaggio pedonale in via A.Cantore.
Strada
comunale carrabile; lunga 92,6 m.; larga 7,20, più due marciapiedi di 1,1 m. cadauno.
STORIA: La antica proprietà Spinola. È rilevabile dalla
carta del Vinzoni come una grossa striscia verticale al mare, divisa in due
porzioni perché tagliata a metà –trasversalmente- dalla strada principale (via LDottesio).
Essa
iniziava in alto presso le falde di Promontorio e scendeva fino al mare, con la
villa in posizione centrale, posizionata poco sopra la strada. Si presume che i giardini si proiettavano verso
l’alto, lasciando il terreno a mare coltivato a orto, frutteto, vigneto, ecc.
Sopra
la strada, a ponente, la proprietà
confinava con quella altrettanto vasta dello sconosciuto ‘Prencipe di
Francavici’- imparentato con gli Spinola; mentre a levante c’è quella parimenti
vasta del mag.co Nicolò Pallavicino (la cui villa è stata abbattuta lasciando
solo il muro di facciata in via LDottesio-vedi).
Sotto
la strada, la proprietà è più
stretta. A ponente, una stradina - aperta dalla strada principale al mare e che
il Vinzoni chiama “strasetta Stretta” - la
divide dalla vasta proprietà della “mag.ca famiglia Grimaldi” (anch’essa estesa dalla strada al
mare; con villa sulla strada a levante rispetto la Fortezza; e con tre case
sulla palizzata a mare, di proprietà non facilmente leggibili per
deterioramento della carta: quella a levante della famiglia Grimaldi, quella
centrale del sig. Nicolò xxx, quella a ponente d’angolo con la crosa Larga del
xxx del fu M.co xxx Imperiale). A
levante confina con altro terreno appartenente a (illeggibili sulla carta vinzoniana) “Giacomo fam.? Sr? Tanente? Martelli”.
Strada attuale.
Il primo nome datole ufficialmente fu di “via
R.E.S.” in riferimento all’impresa edile che - acquistati
i terreni della villa e proprietà vicino - effettuò lo scempio paesaggistico
locale (non c’è però la scheda alla Toponomastica).
Nel 1924, regnando Vittorio Emanuele III, gli fu dedicata la scuola; la via
divenne così “via regio Istituto Tecnico”, a cui si accedeva solo dalla strada a mare che ancora
si chiamava via DeMarini (oggi,
via Dottesio); solo più tardi nacque - nel
retro della villa - la grande strada (che dapprima ebbe il nome di via G.Carducci , poi ‘via A.Cantore’), collegata
con una scalinata, stando un discreto dislivello che ovviamente quando c’era il
giardino, non esisteva.
Presumo
sia in questi anni che fu colta la necessità di usufruire del retro-villa come
ingresso principale per la scuola, essendo già stato invaso il vero piazzale
d’ingresso dalla bassa e gretta costruzione ora adibita ad asilo.
Nel 1945, tolto il ‘regio’, divenne “via Istituto
Tecnico”, con un solo numero civico, quello della villa.
L’attuale titolazione della strada, fu deliberata dalla Giunta comunale nel
1997, ma fu posta in atto nel 1999 senza alcuna informazione alla cittadinanza,
cambiando la precedente senza una significativa e conosciuta motivazione; anche
se dal punto di vista nostro, è meglio così.
Scuola:
Nel 1924 (16 ottobre) venne istituito con regio decreto l’apertura nella villa
dell’insegnamento, effettuando lezioni alle 8 classi dei corsi inferiore e
superiore, chiamandolo “regio Istituto Tecnico”, e dedicandolo a Vittorio
Emanuele III; l’aver
aperto un istituto superiore di cultura ed indirizzo professionale, fu
considerato nell’ anno 1925 il massimo di una antica aspirazione culturale
cittadina; nel 1927 aveva 14 insegnanti, 137
alunni maschi e 35 femmine.
Dopo l’ultima guerra, ed ancora nel 1961, con l’avvento della Repubblica, fu
tolto il ‘regio’ e intestato semplicemente “Istituto Tecnico” per la permanenza dell’istutito scolastico
commerciale, però dedicato a G.C.Abba.
Non so quando divenne “Istituto magistrale «P.Gobetti»”, unico nel
ponente genovese, per la maturità magistrale ovvero formazione di insegnanti
maestri, educatori dei giovani - dalla scuola materna alla superiore -. Dotato
di diverse succursali (largo Gozzano, 5; e dopo restauro via Spataro, 34),
raggiunse quasi i 2000 iscritti.
In esso, in parallelo, sorsero tre indirizzi diversi:
nel 1980 circa la ‘scuola pubblica Magistrale’, gestita dalla Provincia e
destinata alla formazione in tre anni degli insegnanti di scuola materna
(questa raggiunse l‘iscrizione di oltre 800 allievi); e dopo anche i ‘Corsi
sperimentali’ della durata di sei anni, ad indirizzo linguistico mirato ad
iniziare il rinnovamento scolastico molto sentito in quegli anni.
CIVICI
2007=
neri = solo 1
rossi = 3r (manca 1r) e da 2r→18r
Nel
1961, numero nero= 1 Istituto
Tecnico «G.C.Abba». Numeri rossi= 2r-Termoindustria Ital. (termometri)
e Lerma W (costr.edili); 3r-Cimadoro (autorimessa ); 6r-Mazzucco
G.(gross.birra); 10r -Negro M. (sacchi usati); 16r-Benasso F&L (sacchi
juta).
===civ.
1: La villa
Spinola fu costruita a monte della strada centrale, sopra un rialzo
del terreno (ancora nel
1922 DeLandolina scrive: «è sito sopra una dolce altura sulla via DeMarini»), nella seconda metà del cinquecento (XVI secolo). Riguardo al periodo di erezione non
è valido, se è vero che ospitò CarloV (ma molto probabilmente è una notizia
falsa). Riguardo la zona che aveva attorno valgono le parole dell’Alizeri
“quanto importi il mostrarsi allo sguardo del passeggero, e il campeggiar
tutto quanto sulla campagna che le verdeggia ai due fianchi e alle spalle”.
NOTA STORICA DEI TEMPI sono anni, quelli nella seconda metà del 1500, della
adesione politica di Genova alla Spagna, con diretta fornitura a prestito di
soldi, navi e milizie, tali da consentire alla Spagna di divenire la prima
potenza a dimensione mondiale; di conseguenza feconde possibilità di commerci,
appalti, ricchezza e gloria (il famoso detto: l’oro nasce in America, vive a
Siviglia, viene sepolto a Genova). Un terzo delle potenti famiglie genovesi
vive lungo tempo a corte spagnola; dodici di esse -Spinola, Doria, Cattaneo,
Gentile, Lercari, Centurione, Piccamiglio- vi vivono perennemente; nell’arco di
pochi anni diverranno centinaia, coinvolgendo i DeMarini, Imperiale, Doria,
Pinelli, Squarciafico, Pallavicino, Sauli, e tanti altri). In un clima ambiguo,
perché ufficialmente si doveva dare l’impressione di voler soprattutto
mantenere la neutralità, soprattutto con la Francia diretta rivale.
LA FAMIGLIA: (vedi sotto, a ‘DEDICATA A’).
LA VILLA Non si
conosce la data di costruzione, né il committente, né il nome dell’architetto
(fu attribuita
all’Alessi, ma la stima delle date lo esclude). Fu una delle prime, più o meno contemporanea con villa
Imperiale-Scassi: si risale quindi ad un periodo paraalessiano, riscontrandovi
elementi architettonici tipici dello stile primitivo locale (le logge ad
ambedue gli angoli del piano nobile, e la torre) mescolati ai nuovi indirizzi
dettati dall’Alessi per le ville dell’aristocrazia genovese a cui si dedicò.
D’Oria
dice che la villa ospitò CarloV (nato nel
febb.1500 e morto nel sett.1558) quando venne a Genova diretto a Bologna nel 1530
per cingere la corona di re d’Italia dalle mani di Clemente VII,
contemporaneamente ai titoli di imperatore di Alemagna e di Carlo I di Spagna; fu accolto con
magnificenza da Andrea Doria. Ma forse fu in realtà ospitato per 17 giorni a
palazzo Ducale; sicuramente, quando dopo 4 anni fece ritorno a Genova via terra
per tornare in Spagna, fu ospitato dallo stesso Doria a Fassolo nella villa del
Principe, ove poi fu riaccolto in altri 4 successivi soggiorni).

Foto prima decade del 1900-al centro della metà destra della
foto, con torretta, la villa Spinola
Quindi,
a commissionare la costruzione fu uno SPINOLA
del ramo dei duchi DI SAN PIETRO, sconosciuto
come persona. Dopo lui, abbiamo una serie di personaggi, ‘sciolti’ da
successione specifica conosciuta.
===Si sa che nel 1569 Pietro Carlone,
importatore e rivenditore di marmo, fornì ottanta colonne a un ‘Daniele Spinola, per il suo palazzo in San
Pier d’Arena’ da adibire a villeggiatura, e - come iniziò ad entrare in uso in quei tempi - al
godimento dei propri beni e della natura; NB== gli Spinola avevano in SPdArena numerose ville:
evidentemente quella di daniele non è questa e la notizia l’ho scritta qui non
sapendo a quale villa riferirla; sul Battilana (pag.132) esiste un Daniele (q.Giacomo
e Battina Negroni q.Carozio) ma Spinola di Luccoli vissuto nel 1458; che in
seconde nozze sposò Maddalena Imperiale q.Andrea e che in totale ebbe 11 figli
tra cui Gironima (vissuta nel 1514 ed andata sposa ad Antonio Spinola q.
Spinetta). Ma non combacia con la Gironima sotto scritta, per via del padre.
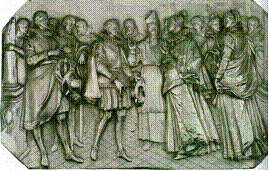
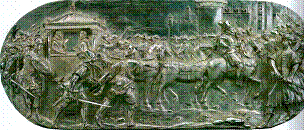
M.Meljin-.nozze di GBSpinola con Maria GB
Spinola fa ingresso a San Pietro- Amsterdam Rijksmuseum
===Boccardo
scrive che Geronima Spinola di
Cristoforo (nel
Battilana, come scritto sopra, ci sono Spinola di s.Luca e di Luccoli, non di
s.Pietro: ci sono tante Geronime ma nessuna figlia di Cristoforo, e viceversa) vendette la villa e quindi ovviamente tutta la
proprietà, al primo della famiglia che ufficialmente viene riconosciuto, forse solo perché meglio conosciuto ed accertato:
===Gio. Batta Spinola, di Gio. Maria.
Negli affreschi, riportate 3 generazioni: GiovanniMaria Spinola+Pellina Lercari (per lei la storia di Megollo; a
lutto nel dipinto delle nozze di Luca)→il nostro GB (feudo di Galatina; vestito alla
spagnola, alle nozze)+Maria
Spinola (con diadema
alle nozze)→GioFilippo (principe)+Veronica
Spinola→Francesco Maria.
Scorza
scrive che fu GiovanniBattista che nel 1621 comprò il feudo di san
Pietro in Galatina, nel vicereame di Napoli, nel quale fece trionfale ingresso
in quell’anno. Era anche signore di Torrione.
Nel 1622-1624, concluso 1625, fece ristrutturare la villa,
commissionando Andrea Ansaldo nella decorazione (rappresentando la conquista di
Gulick, ma non ancora quella di Breda del 1625) ponendo a memoria del fatto una
iscrizione sul portale interno (dove però è scritto solo ‘Battista’). Tale
opera è stata documentata dal Rubens (1607- Palazzo C) e poi anche dal Gauthier
(XIX secolo). Dovrebbe esistere una iscrizione attorno all’arco della porta con
scritto: «Io Baptista Spinola dux Santi Petri ornavit Anno Domini M.DC.XXV».

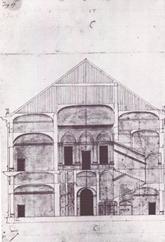
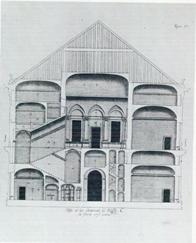
PalazzoC prospetto (cornici finestre taglio da ponente
mezzanino appena schizzati) a levante
Londra Royal Inst. of British Arch.
Si sposò con
Maria Spinola di Filippo di Ambrogio, con la quale ebbe come secondogenito:
===Gio.Filippo, figlio di GB. Nato
nel 1610, visse sino al 1660; anche lui provvide a far migliorare gli interni,
lasciando che continuassero le loro opere sia Andrea Ansaldo (che affrescò le memorabili imprese
del grande avo materno Ambrogio) che
Giovanni Carlone (che
affrescò le imprese di Megollo, avo materno di GB).
 Rubens-Veronica
Rubens-Veronica
Sposò
Veronica Spinola di
Luca del ramo di San Luca, che gli portò
in dote il feudo di Molfetta (già appartenuto a Ferrante Gonzaga di Guastalla) facendolo divenire principe, e padre (1659) di Francesco Maria. Dapprima Gio.Filippo andò a
vivere vicino a piazza Banchi, ma poi trasferì la famiglia in affitto in via
Balbi (l’attuale
Palazzo reale, già di Gio.Agostino Balbi, dopo dei Durazzo-Pallavicino e
Cattaneo-Adorno).
Ebbe
incarichi diplomatici a Milano (1643) e Napoli (1649) divenendo conosciuto
dalle alte personalità straniere come Salvatore Castiglione (questi quando comunicò a Carlo II
Gonzaga della morte di GiovanniFilippo scrisse che ciò aveva ‘affatto privata
questa città di chi si dilettava a poteva spendere in pitture di questa
qualità’) ed il cardinale Mazarino (quest’ultimo che si rallegrò per
scritto della nascita del figlio).
Importante collezionista, di argenti, (ordinò i famosi argenti a Matthias Meljin – vedili sopra,
conservati al Rijksmuseum di Amsterdam, nei quali alcune figure sono molto
somiglianti a quelle dipinte dal Carlone nel fregio del salone), sculture, paramenti, ben 65 dipinti e miniature (tra essi il 1 settembre 1660 furono
inventariati dal notaio Monleone 1 VanDick, 3 di Veronese, 1 Tiziano, 9 del
Grechetto, 3 del Rubens, molti di altri maestri veneti. Di una tela del Veronese, la ‘cena in casa di Simone’, allora
conservata a Verona nel refettorio del convento benedettino dei santi Nazario e
Celso si ha notizie scritte dell’interesse all’acquisto per una cifra enorme
pari a 21 kg. di oro; l’impegno con i frati era di sostituirla con una copia
fatta a Genova da David Corte causa la proibizione di far uscire opere d’arte
dalla Repubblica di Venezia; ma quando tutto era pronto, non si fece il
cambio forse perché scoperti, ma la tela originale venne lo stesso a Genova,
andando in successione al figlio Francesco Maria, e nel 1735 al nipote nato nel
1686 e suo omonimo Gio.Filippo, che la cedette ai Durazzo che a loro volta la
vendettero col palazzo a Carlo Felice, che la fece trasferire a Torino).
===Luca è il personaggio di san Luca, titolare
delle nozze disegnate nella ‘striscia’ sottostante la storia di Megollo. Si
suppone fosse uno dei figli di GB; ma non è certa la sua posizione nella
genealogia di questi Spinola (ci sono i due
sposi: lui – con un servo-; la sposa Pellina__ - al centro tra due sorelle-; la
vedova di GiovanniMaria Pellina Lercari vestita
a lutto; la padrona di casa Maria – con diadema-; GB vestito spagnoleggiante; Ambrogio
-col toson d’oro-).
==La villa, pur essendo dimora di vacanza, era vissuta per
molti mesi all’anno dagli Spinola i quali favorivano frequenti incontri
musicali ospitando i più famosi cantanti e suonatori; le figlie stesse e le
nipoti del proprietario, erano assai capaci nell’arte musicale, anche
esibendosi con gli attori.
L’11 novembre 1702 vi fu ospitato proveniente da Milano Filippo V, ventenne re di Spagna, capo della
dinastia dei Borboni (1683-1746).
Nel 1701 era scoppiata la guerra di successione per il trono
di Spagna tra le case dei Borboni (Francia, Napoli) e degli Asburgo (Austria);
Genova prudentemente si teneva equidistante, prediligendo i primi. Filippo,
acclamato a Napoli, dovette combattere in Lombardia per far valere il
privilegio di divenire ‘sua maestà cattolica’. Sopraggiunto l’inverno, si mosse
da Milano (5 nov.1702), e -via Pavia- a Pieve del Cairo, Alessandria, Novi (9
nov.), Voltaggio, Bocchetta, Campomorone (palazzo del march. Balbi), SanPier
d’Arena ove giunse alle 22,30 alloggiando nel palazzo Spinola. Preceduto di 2
giorni dal Duca di Mantova (con cavalieri e 30 ‘carabinieri’) ed accompagnato
dal principe di Vaudemont (con le sue truppe), scesero (tutti spesati di
tutto) -sotto il diluviare della pioggia e percorrendo una strada assai
dissestata malgrado le riparazioni approntate dal Capitano della Polcevera - a
San Pier d’Arena - per imbarcarsi verso la Spagna.
Così il territorio genovese fu attraversato dal corteo reale
proveniente dal nord.
Il Magistrato di Guerra (allora l’ecc.mo Francesco
M.Imperiale) ordinò al ‘sargente maggiore generale’ (ovvero il capo delle
truppe della Repubblica) di non andare incontro a S.M. e rimanere in città. Si
mossero invece sino al confine della Repubblica poco oltre Novi, i Commissari
Forieri (Domenico Doria ed Agostino DeMari, con 8 soldati corsi, “per guardia
degli argenti”) e sei Ambasciatori (GioAgostino Centurione, Clemente Doria,
FrancescoMaria Balbi, FrancescoMaria Serra, Giacomo Viale, GioGiacomo
Imperiale, scortati da un reggimento – comandato dal sergente maggiore di
battaglia, Michelangelo Gentile - e 40 servi in livrea vergata d’argento,
cavalli e carrozze). Furono poi seguiti dal doge Federico DeFranchi (doge nel
periodo 1701-3) e tutti i Senatori, che ricevettero il re al confine del
territorio genovese - in magnificenza, vestiti per l’occasione in abito con roboni
di velluto anziché il solito di damasco - offrendo un ricco dono ed
accompagnandolo fino a San Pier d’Arena.
Al seguito, numerose le personalità tutte ospitate nel
borgo: tra essi l’ emin. cardinale D’Estré (futuro ambasciatore); i
rappresentanti del Consiglio di Stato: il conte di Marsin (ambasciatore di
Francia), il principe di Vademon (governatore di Milano), il duca di Medina
Sidonia (maggiordomo maggiore), il conte di SantoStefano (cavallerizzo
maggiore); non ultimi il duca di Osona (gentiluomo della Camera di esercizio),
il duca di Candya, il marchese de los Balbases (comandante generale della
guardia), il conte di Calmenaro, don Garzia de Gusman (governatore della
‘cavallerizza’), il conte d’Ora (capitano della compagnia de’ Carabinieri), marchese
de Rivas (segretario del dispaccio universale), don GioAntonio Albizzo
(ambasciatore di Torino).
A Genova, poi gli fecero visitare la città e sostarono in
preghiera anche presso le sacre ceneri di san Giovanni Battista, dopo la messa
celebrata dall’arciv. GB Spinola (il re camminando a destra del doge, rifiutò
il baldacchino e più volte appellò il doge ‘altezza’ anziché ‘serenissimo’:
significativo di maggiore valore rivolto al governatore della città). Durante
il soggiorno, unico avvenimento fuori protocollo fu un incendio del caminetto
in casa Doria provocato da ufficiali di scorta al re e descritto alla villa di
via Daste.
Dopo breve soggiorno, rottosi un sontuoso pontile
preparatogli per l’imbarco presumibilmente alla Coscia, fu accompagnato al Passo
Nuovo dove si imbarcò nella feluca del magn.co Giuseppe Doria salutato da salve
di artiglieria. Scortato sino a Vado da 5 galee della Repubblica, il sovrano
ritornò in Spagna con la sua flotta di 12 galee (metà francesi, metà del duca
di Tursi).
Sicura l’appartenenza agli Spinola, fino al 1757. Probabile fino all’inizio del
1800.
Infatti
nel 1840, proprio nel
periodo di ‘misurazioni territoriali per il passaggio della ferrovia’ e quando da tempo ormai
l’appezzamento non era più degli Spinola, appare avvenuta la vendita: la metà a
levante della crosa della Catena (che separava in due la proprietà a mare della
villa, quella degli orti e giardino) all’avv. Carlo
Cambiaso (poi
divenne proprietà della sua vedova Gioannina
Geronima Carlotta Pagano e del figlio Gerolamo); e la metà a ponente ai fratelli
Derchi (nel 1847 questa metà compare divenuta
del marchese Negrotto GB, fu Lazzaro).
Altra
fonte, dice che la proprietà fu acquistata nella prima metà del 1800 dai Negrotto, a cui rimase però per breve periodo
perché è documentato che nel 1848 fu occupata dalle DAME
DEL SACRO CUORE (controversa la data: così si scrive nelle ‘Ville del genovesato’;
P.Novella dice genericamente che cessarono d’esserci; Lamponi a pag..29 precisa
‘fino al 1848’; Alizeri a pag.642 conferma che nel 1875 c’erano ancora), che lo utilizzarono quale collegio femminile per
le figlie di ricchi possidenti. Nel 1848 in Genova avvennero gravissimi disordini a carico
dei Gesuiti, con vandalismi e saccheggio della loro sede in sant’Ambrogio; a
colpa di questa Congregazione si attribuirono sia la loro invadenza politica,
sia la loro intransigenza; d’altra parte l’astio della compagnia era quasi
generale nel popolo repubblicano ed in special modo nei seguaci di Mazzini e
nel clero stesso. Temendo e ‘buccinando’ che i disordini coinvolgessero le Dame
sampierdarenesi (anch’esse espressione di Congregazione potente sia perché
Collegio per giovinette di ricca famiglia e sia perché già gestivano Montmartre
a Parigi e Trinità dei Monti a Roma) fu spedito un reggimento a custodirle e
proteggerle. Ma nulla successe di male, anche se esse furono invitate ad
andarsene; cosa che non fecero. Durante il loro possesso, apportarono
sostanziali modifiche che deturparono le caratteristiche seicentesche: riempimento
dei porticati –degli avancorpi e dello spazio dell’avancorpo stesso-;
sopraelevazione di un piano; correzione della torretta.
Ad esse subentrarono le suore del Collegio della
Immacolata Concezione, o FIGLIE DELLA
CARITA’ di san Vincenzo de Paoli, quelle cappellone presenti ancvhe
nell’ospedale, qui come collegio per le giovani meno agiate.

Effettuarono
due grandi modifiche, sulla scia di un utilizzo personalizzato alle esigenze
momentanee e borghesi, ordinando la sopraelevazione di un piano ed un
ingrandimento della cappella ( essa già esisteva sul fianco sinistro del porticato d’ingresso creata
dagli Spinola per loro uso privato, con altare marmoreo; dalle suore fu
intitolata all’Immacolata Concezione con effigie uguale all’immagine impressa in
una medaglia giudicata miracolosa e che le stesse fecero incidere anche sul
centro dello stemma degli Spinola che incoronava il sommo della facciata, in
memoria della grazia ottenuta da una loro consorella a Parigi il 27 set.1830).
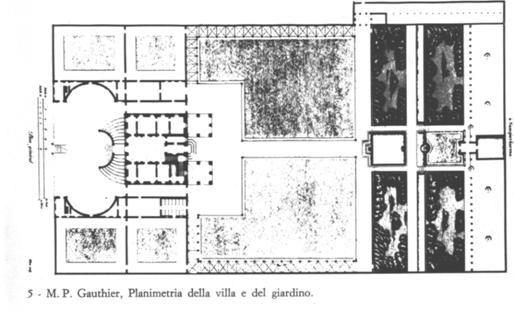
Mantennero
intatti i due giardini (aspetto che la differenziava dalle altre ville):
quello a sud, davanti all’ingresso principale, che attraversato dalla via
principale (via DeMarini - Dottesio),
proseguiva sino al mare (
coltivato ad orto -giudicato nel 1847 di prima qualità-, frutteto, vigneto; e
creando col suo viale centrale chiuso sulla via principale da una catena, i
presupposti alla lottizzazione per una strada che fu appunto chiamata “ crosa
della Catena”, e che diede nome negli anni attorno al 1850 alla zona “quartiere
della Catena”); quello a nord invece,
esteso sino alle pendici della collina di Promontorio, era il vero e proprio
giardino privato, all’italiana, simmetrico, con lunghi viali diritti -e coperti
da berceaux- per arrivare in alto alle peschiere, ninfei (di cui rimane un minuto residuo
sulla scalinata di via Pittaluga) sino
al bosco nella parte estrema (ove la proprietà terminava confinando con altri orti di una villa ora
demolita -villa Piccardo, che a sua volta era stata eretta nel 1911 sui resti
della villa del duca di Molfetta, e dove ora troneggia il grattacielo
di fronte all’ospedale).
L’erezione nei primi del 1900 del palazzotto prospiciente la strada principale via
DeMarini (oggi Dottesio), ma anteposto così
vicino alla facciata principale, da esserne separato solo dalla terrazza
costruita al posto della scala, obbligò a spostare l’ingresso principale sul
retro, dando alla facciata a nord una priorità, a cui non era adibita.
Questo gruppo religioso, conservò l’uso della villa fino al 1920 ( quando si trasferirono a Coronata).
Nell’anno 1919 la Soprintendenza alle Belle arti vincolò l’edificio a tutela.
Questo atto forse favorì la concretizzazione del progetto reciproco in base al
quale, in quell’anno, le suore cedettero la villa al COMUNE di San Pier d’Arena (acquisto per lire 600mila, firmato
dal commissario prefettizio dr.cav.Ferdinando Ferretti) che iniziò ad adibirla a scuola adattandola per la
sistemazione delle aule con lavori diretti personalmente da inviati del
Ministero e diretti dal prof. Giacomazzi Lorenzo e mirati a non nuocere alla
grandiosità ed al carattere dell’immobile (caloriferi; gabinetti; illuminazione; arredi e
suppellettili: gli stessi mobili, essendo anacronistici quelli “moderni” per la
loro fragilità, furono ordinati tavoli massicci, lampadari e torciere in
ferro battuto, banchi solidi e comodi, cattedre ed armadi intonati alla
severità dell’ambiente; biblioteca; nonché fu previsto il trasloco della
scuola professionale femminile “Principessa Jolanda” alloggiata nel palazzo in
via provvisoria, e l’eliminazione dopo espropriazione del palazzo antistante in
modo da ridonare lo spiazzo d’onore e la doppia scalea di ascesa = ahinoi non
eseguita dal comune di Genova che ereditò il progetto, coperto nelle spese dalla
cifra necessaria dal Comune e tramite donazioni e partecipazione dei Comuni
limitrofi interessati). Il Comune -encomiabile per la
salvaguardia del bene immobile, fu drammaticamente scellerato per le decisioni
successive ( forse per pagare la quota di acquisto o per “eccesso di fame di
case”): lottizzò e cedette tutto il giardino, costruì sul davanti senza
alcuna avvedutezza per il rispetto dell’estetica, permise il soffocamento
edilizio e l’annullamento dell’ambiente.
Dapprima
chiamato regio Istituto Tecnico, nel 1926 –quando era il maggiore istituto
culturale ligure- passò nel patrimonio del COMUNE di
Genova; divenne poi Istituto magistrale Piero Gobetti, frequentato da
quasi 2mila persone tra studenti ed insegnanti in altre tre succursali. Ha
ospitato anche la scuola per insegnanti della scuola materna, ed i corsi
sperimentali ad indirizzo pedagogico e linguistico.
Rispetto le originali strutture -intendendo per tali l’aspetto descritto dal
Rubens nel suo libro, laddove la villa è identificabile con il “palazzo C” -
lo stabile fu soggetto a periodiche ma sostanziali modifiche tali da rendere
nel trascorrere dei secoli la villa quasi irriconoscibile: soprattutto quelle
apportate nel 1625, poi dalle suore ed infine dal Comune (questi, negli anni vicino al 1900
eresse un nuovo edificio scolastico proprio sul terreno del piazzale d’onore,
davanti all’ingresso principale, coprendo la facciata a mare con una
insensibilità estetica assurda e stupefacente; e costringendo nel futuro -come
per la villa Scassi- a considerare il retro come fosse la facciata principale ). Anche il giardino, dal 1850 in poi subì le
terrificanti modifiche ambientali: il taglio a mare della ferrovia -con via
Vittorio Emanuele affiancata-; ed ottant’anni
dopo via G.Carducci (via A.Cantore) a
nord.
In conclusione, uno scempio immorale, da non meritare
neppure una cartolina ricordo nel libro di Tuvo (SPdA come eravamo), né la
citazione su Pastorino-Vigliero (pag.1736): il che vada a gogna di chi ha
governato la città in quei tempi. Geomar, sul Gazzettino, dice che è giusto l’«utilizzo
del complesso da individualistico e privato a collettivo e pubblico». Non
polemizzo: dico solo che c’è modo e modo di trasformare in socialmente utile
quello che era privato; ed il modo attuato è il più stupido che l’uomo di
cultura politico amministrativa potesse adottare.
Il Pagano 1950 include l’edificio, unico di SPd’Arena,
nel gruppo dei 30 ‘palazzi’ genovesi, includendo breve accenno alle altre
‘ville’.
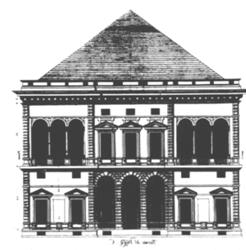

a
sinistra la facciata della ‘villa C’, come descritta da Rubens- a destra foto
della facciata riferibile al 1910 circa.



come era
negli anni del fascio – con un come è
malamente visibile dalla strada terrazzo, eliminata la scala di accesso
La facciata esterna principale, era a mare, conosciamo l’immagine
originaria, dal disegno del Rubens del 1622: ad una triplice loggia centrale
d’ingresso, corrispondevano due eguali laterali al piano nobile, separate da
finto bugnato che dava l’aspetto tripartito; era completamente dipinta e
fittamente decorata, con cornici alle finestre.


a sinistra
manca la chiesa; in erezione il palazzo a destra
Nel 1625, l’organismo cubico cinquecentesco venne trasformato con l’aggiunta di
avancorpi porticati ad ala, verso il giardino a monte, e di una corte d’onore a
sud all’arrivo del viale, concluso da una doppia rampa molto larga per
collegare il fronte dell’edificio col giardino; tutte e tre le logge furono tamponate, aprendo -al piano nobile- al loro
posto due finestre. La facciata principale a sud, fu decorata con riquadri a
chiaroscuro, e ponendo in quattro finte nicchie altrettante figure
femminili: furono dipinte dall’Ansaldo (rappresentanti le 4 virtù; così belle che raggiunsero
particolare meritata fama; ma ora scomparse per incuria e sovrapposta
intonacazione)-
Il
tutto fu documentato dal Gauthier nel 1818-32.
Ancora
negli anni 90 attorno e sopra al portone principale residuava una illeggibile
decorazione affrescata –come visibile da foto sopra e da altre.
Aveva sul portale, uno stemma gentilizio che nel giu.1798 dalla Municipalità
francesizzante ed anti aristocratica fu ordinato fosse distrutto. Permane
tutt’ora, vuoto di decorazione, uno spazio sopraelevato, con volute laterali, a
livello del tetto.
Mentre nell’800 venne chiusa tutta la facciata a nord, tamponando i porticati
delle due ali e lo spazio tra esse, nonché sopraelevando di un piano in modo di
falsare sia il prospetto che i volumi; venne eliminata la corte d’onore
antistante fornita di ampio scalone formato da due
scalinate curve in crescendo ascensionale maestoso, e sostituita con una
terrazza
che oggi malamente separa la villa dall’edificio a lato mare, costruito davanti
in maniera da togliere tutta la vista ed annullando tutta la scenografia
originale altamente plateale.
Viene
segnalata sulla facciata prospiciente via Dottesio la presenza di un presunto
affresco di una Madonna, che già nel 1980 era fatiscente divenendo più evidente
quando la pioggia bagnava i colori.
La
facciata sul retro, che dava ai
giardini, ed ora ingresso unico della scuola è assai semplice con finestre
centralizzate escluso quelle del piano nobile.
Sia
l’ingresso unico attuale, sia la presenza dei palazzi attorno, sia via
A.Cantore: tutti e tre hanno criminalmente snaturalizzato l’edificio.

La
torre quadrata, di vedetta e difesa nei tempi di ancora facili
incursioni piratesche, forse si pensa preesistente alla villa e che fu inglobata
nella fase di costruzione, ed aggiustata quale appare oggi con, a sbalzo, il
percorso di ronda. La Soprintendenza per i beni architettonici dal 1935 la
vincola a parte, con atto diverso dall’insieme della villa (per questa, come
detto, risale al 1919)


scorcio dalla scalinata –ex giardini
facciata di levante dalla strada nel retro
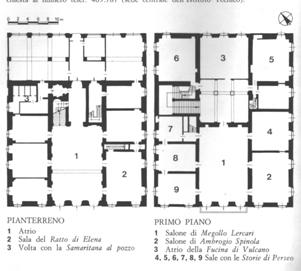

L’interno evidenzia architettonicamente le mescolanze dell’arte ligure
preesistente, con le impostazioni suggerite dall’Alessi (tipo la tripartizione
dei muri portanti, le logge contrapposte, la posizione dello scalone).
I dipinti sono firmati nel 1611
da Bernardo Castello (1557-1629, già presente nel 1602
nella villa Imperiale-Scassi, diventerà presidente della corporazione dei pittori
di Genova); e dal 1621-5 dal genero
genovese Giovanni Carlone (24 apr.1584-1630, fratello del più
noto GB) e dal coetaneo voltrese Andrea Ansaldo (24 ago.1584- 1638); già nel 1766 il Ratti riconosce che la rinomanza e l’ammirazione per
questa villa non sono tanto “per la struttura, quanto per le sontuose pitture
che al di dentro lo adornano”; tutta l’opera pittorica è mirata alla
celebrazione dei fasti familiari (dei Lercari e degli Spinola) utilizzando
situazioni mitologiche per indicare le qualità e virtù dei singoli, come era
nel costume cinquecentesco; fu completata nel 1625, come testimonia la
scritta sul portale d’ingresso “io Baptista Spinola dux santi Petri ornavit
anno domini M.DC.XXV“ (NB:
su Pastorino-Vigliero non c’è alcuno riferibile al nostro in quanto era
Gio.Battista e nemmeno potrebbe essere Battista di Tommaso, perché “di san
Luca”).
All’ingresso -originario a sud- (attualmente si accede solo da
quello posto a nord, più semplice, che dava adito ai giardini), segue un
imponente atrio la cui volta presenta un paesaggio centrale
contornato da grottesche assai fitte e paesaggi; sopra le porte, sono dei
medaglioni con finti busti di personaggi ricordanti le glorie familiari, come
era in uso a quei tempi.



atrio di ingresso – finestre a
mare verso il
retro
La cappella: il Remondini riferisce che il cardinale Sauli, con
lettera del 2 ott.1606 al vicario arcivescovile, dava autorizzazione a farvi
celebrare la Messa se la cappella era sufficientemente ornata. Questa era stata
aperta ed apprestata per volere di Maria Spinola; nel 1609 papa Paolo V
accordò a Filippo Spinola aprire al pubblico per il culto la cappella esistente
nel suo palazzo.
Nella seconda sala, 5 affreschi firmati da Bernardo
Castello (in
basso a destra del riquadro centrale: “B.C.1611”) caratterizzati dalla disposizione sulla volta dentro dei riquadri, ed
dalle “cartelle” angolari utili per riempire quegli spazi, altrimenti non
facilmente utilizzabili; rappresentano con colori di grande morbidezza: nel
mezzo il “rapimento di Elena , la bella laconese, da parte di Paride”, e d’intorno nelle lunette, “re Priamo che prega” , “Priamo che consegna Paride fanciullo ai
pastori“, “Paride che
decide tra le
tre dee qual sia la più bella”, “il consulto
dell’oracolo”, “gli dei
dell’Olimpo che decidono”; negli
angoli quattro figure di donna, simboliche. In questi dipinti, il fare
pittorico appare più maturo e ‘morbido’ rispetto quelli della villa Imperiale
eseguiti nove anni prima.
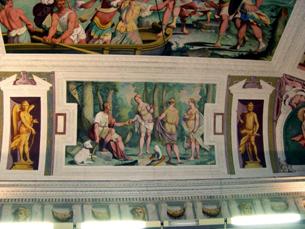

Alle
pareti un colonnato che fornisce l’illusiva sensazione di dilatazione dello
spazio; nelle nicchie angolari le figure di Nettuno, Saturno, Eros, Giove. Tutte queste immagini mitologiche,
valgono a ricordare la parte avuta da Ambrogio Spinola nello sventare il
rapimento di Margherita di Fiandra.
Vicino, e sempre a piano terra, una terza
sala posta a levante con affresco
attribuito a D.Fiasella (qualcuno dice al Castello) descriventi “Gesù e la samaritana al pozzo” (originariamente rappresentava una storia mitologica o quantomeno
profana, in cui la figura femminile era armata di lancia, e non c’era il pozzo;
ed il dipinto era più largo e meno alto).
Sotto lo scalone -come nella Fortezza- è il bagno, ottagonale, comprendente
un vano a nicchie semicircolari per l’uso delle acque calde, e vicino un vano
più piccolo, stretto e lungo per quelle fredde.
Lo scalone (unico, assieme al bagno, rimasto intatto della primitiva pianta
cinquecentesca) dopo la prima rampa
presente affisse alle pareti due lapidi: una riporta «QUESTO ISTITUTO SI INTITOLA – AL
NOME DI – GIULIO CESARE ABBA – 1838-1910 – “UNO DEI MILLE” – SEGUI’ GARIBALDI –
DA QUARTO AL VOLTURNO – SOLDATO E STORICO DELL’EPICA GESTA -------LETTERATO DI
CHIARA FAMA – DOCENTE EDUCATORE – CON GLI SCRITTI LA PAROLA L’ESEMPIO – FU AI
GIOVANI MAESTRO – DI DEDIZIONE AL DOVERE – DI DEVOZIONE ALLA PATRIA.
------14.VI.1947»
E l’altra «1-2-64 ------ VINCENZO TOSI –
1877-1962 – FONDATORE DELL’ISTITUTO – CHE PER 24 ANNI RESSE – CON AMORE E
SAGGEZZA – EDUCANDO I GIOVANI – ALL’ONESTA’ E AL DOVERE – CON L’ESEMPIO
COSTANTE – E PAROLA SUADENTE E ARGUTA».

Porta, tutto decorato con
grottesche al piano nobile, presso la loggia
(anch’essa con grottesche e quattro paesaggi che contornano
l’immagine centrale dipinta dal G.Carlone di “Vulcano nella fucina, assistito da Minerva mentre
prepara le armi per Perseo”
-allusivo: per
Ambrogio Spinola-), e -centralmente- l’ampio salone
recante le porte di accesso alle varie camere e sale laterali secondo l’antica
concezione genovese.
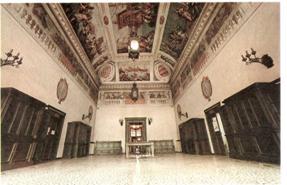

Vi sono rappresentati il
capolavoro dei due pittori Carlone ed Ansaldo, in collaborazione -sommando nel
lavoro le loro diverse capacità espressive provenienti da distinte tradizioni
pittoriche: di pittore- disegnatore l’uno, di pittore-colorista l’altro; e
sempre tesi alla celebrazione della famiglia commissionaria: di G.Carlone la volta, con 5 grandi quadri
rappresentanti la storia di Megollo Lercari.
La
fantasiosa (o quantomeno ricordo amplificato;
esasperato simbolo di crudeltà adottata col fine di salvaguardare l’onore e
l’orgoglio familiare con esempi significativi ed esemplari) storia di Megollo (nome
diminutivo o volgare di Domenico; qualche storico sospetta essere mai esistito
perché è nome troppo frequente tra gli schiavi, per essere stato di un signore)
fu narrata in una
lunga lettera in latino dall’analista Bartolomeo Senarega, annalista dal 1492 al 1514, cancelliere della Repubblica, diplomatico e
oratore anche all’estero: Francia, Napoli, Lombardia, spedita nel periodo 1475-1514 all’umanista napoletano Giovanni
Pontano; ripresa da Agostino Giustiniani nei suoi Annali scritti in volgare
del 1537 (col fine di instruere il popolo nostro ad essere
amatore della Repubblica) e
da Oberto Foglietta nel
1570 circa.
Megollo abitò a lungo a Trebisonda (Trabzon, città già ben guarnita da
mura costruite da Giustiniano; capitale sul mar Nero del regno autonomo degli
imperatori Comneno al tempo di Alessio III -1349-90– terzo della dinastia) ove è accertata la presenza genovese
dai primi anni del 1300. Nel 1310 circa, il Lercari probabile addetto
commerciale della Repubblica, fu offeso da uno schiaffo da Andronìco – favorito
dell’imperatore - durante una partita a scacchi; alle rimostranze, fu consolato
dal regnante con buone parole ma non con giustizia. Perché non si indebolisse
il prestigio dei genovesi in tutto l’Oriente, tornato a Genova armò due navi
con Accellino Grillo; ritornato nel mar Nero ne vinse, separandole due a due,
tutte e quattro quelle dell’imperatore, e per rabbia aggiunse pirateria e
strage di nasi ed orecchie dei prigionieri. Pare impietosito da un genitore che
offriva la sua vita alla mutilazione dei figli, lo usò come ambasciatore ed
ottenne nel 1316 le scuse dell’imperatore e la consegna - perché fosse punito -
dell’ingiuriatore, più un console genovese ad amministrare giustizia, la costruzione
sia di un palazzo per il console, che di un fondaco, di un forno e di un bagno;
e diverse altre franchigie, immunità e privilegi commerciali. Molto probabile il racconto è n
buona parte leggendario: il rude marinaio, temerario commerciante, non immune
dal titolo di pirata e sadico vendicatore della dignità genovese offesa alla
corte di Trebisonda; una figura necessaria per impersonare l’orgoglio patrio
misto ad ardita tenacia e magnanima clemenza) -celebrerebbe gli ascendenti
materni dello Spinola, essendo figlio di Bettina Lercari-.
A obbiettiva difesa, non è che i costumi di allora nei
confronti dell’onore fossero diversi da quelli descritti: il testo del
Pallavicini su come venivano trattati allora i nemici sociali o malfattori, è
un chiaro trattato di sadismo. E, malgrado fossero molto religiosi, la vita
umana della plebe non aveva valore di eguaglianza, come oggi intesa. In più, il
concetto del rispetto del prossimo e della vita, nello specifico in marina, è
sempre stato assai aleatorio: corsari e pirati non mancheranno certo di ferocia
gratuita. per ancora quattrocento anni dopo, e più.
Nel 1622-5 GB Spinola, figlio di Pellina farà affrescare da
Giovanni Carlone figlio di Taddeo, il palazzo Spinola di SPdA con le imprese di
Megollo, parente significativo della famiglia della madre ‘contrapposto’ ad
Ambrogio eroe nei Paesi Bassi della famiglia degli Spinola e fratello di Maria,
sua moglie. Le 4 ‘Virtù’ che ornano gli affreschi (mentre quelle degli argenti
fanno riferimento alla religiosità del committente) fanno riferimento alle
virtù della famiglia Lercari e nelle quali si riconosce il committente, che
sono “rationabilis ira”, “spes certa victoria”, “fortitudo in adversis”
“humiles beneficentia”.
Per riconoscerli, ponendosi in modo di vedere a dritto il quadro centrale,
cronologicamente andrebbero letti 3), 4), 5), 1), 2):
1)-
al centro “ Megollo
che vendica l’oltraggio di Andronico, dinanzi all’imperatore di Trebisonda” (con la scritta: subiectum inimicum despicit et
amicum recipit imperatorem); infatti la scena è, nella cronologia
dell’evento, l’atto finale
2)-
a destra “il
perdono dei prigionieri” (con la scritta: iniuriam repellere nititur),
3)-
in basso “Megollo
che, spada in pugno, perora con gli amici la causa della dignità e fierezza
genovese”(con la scritta:
amicorum ope ad
vindictam se accingit ),


Megollo a rapporto con i familiari lo
scontro navale
4)-
a sinistra “la
vittoria, con il possesso di due triremi sulle 4 dell’imperatore Alessio II“ (con la scritta: duabus triremibus quatuor
inperatoria vincit),


i barilotti di nasi il
calcio finale ad Andronico
5)-
sopra (a rovescio per chi guarda) “Megollo che fa consegnare i barilotti di nasi ed orecchie
messi in salamoia ”(con la scritta ingemiscentibus parcit),
-
messe alternate a spaziare i riquadri , le nicchie con tra 2 e 5 l’Umiltà (in humiles beneficentia); tra 5 e 4 la Forza (fortitudo in adversis) ; tra 4 e 3 la Speranza (spes certa victoria)
; tra 3 e 2 la Ragione (ragionabilis
ira);
ai
quattro angoli gli stemmi alternati degli Spinola (campo giallo, banda centrale a
scacchi bianchi e rossi, sormontata da una spina), e dei Lercari ( bande rosse e gialle );



la sposa con le sorelle e la vedova
Pellina musici
---
più in basso un affresco continuo, aggirante tutto il salone e raffigurante (qualcuno dice per opera
dell’Ansaldo, altri del Carlone, altri di entrambi) un loggiato parato di tappeti ed arazzi, da cui in
uno sfolgorio di colori si affacciano come visti dal basso -in una veridicità
di atteggiamenti e realismo esecutivo assai sorprendente, dame e cavalieri,
cantori e musici di cornetto, trombone, viole e liuti ((molto presumibile le
nozze tra Pellina -figlia
di Maria Spinola e di Giovanni Battista Spinola-, e Luca Spinola di san Luca- figlio di Gaspare e Maria Doria -
divenuto principe della Molfetta in Sicilia: il giovane elegante disegnato sul
lato opposto con un servo (nel 1625, alla conclusione degli
affreschi, la coppia aveva già 5 figlie, di cui una, Aurelia, nata nel 1620,
era naturalmente predisposta nell’apprendimento della musica, danza e canto,
andò sposa al principe di Monaco Ercole Grimaldi nel 1641 e divenendo duchessa
di Valentinois); tra le donne, col
diadema, è raffigurata Maria, la padrona di casa; ed in abiti vedovili Pellina Lercari madre di G.Battista; a sinistra delle donne è un personaggio con abito spagnolesco,
presumibilmente GB,
il padrone di casa; mentre
vicino a lui, col manto rosso, su cui è appoggiato il tocco rosso insegna del
Toson d’oro: si pensa sia Ambrogio
Spinola -l’eroe delle
Fiandre- della cui onorificenza era appunto insignito dal 1605) ; a destra la sposa Pellina, tra le sorelle Geronima e Violante)).
Dai
disegni del Gauthier, si vedono le pareti anch’esse affrescate, ma oggi
scomparsi.
Delle sette stanze a fianco, spicca d’importanza un secondo salone
- (controfittato per
ricavarne due aule scolastiche, ma così impedendo di vedere il soffitto), con 5 grossi riquadri sul soffitto, affrescati
magistralmente da Gio.Andrea Ansaldo, e da
lui dedicati alle glorie della famiglia, in particolare di Ambrogio Spinola, Al centro “lo Spinola che a Ostenda passa in rassegna le truppe” (con sottoscritta “ Ostende - naturam et
artem expugnat patientia”. T.Grosso vi legge ispirazione e fedeltà alla
tradizione del Tavarone) , dopo la vittoria di Ostenda, alla
presenza dell’arciduca d’Austria Alberto e della sua sposa l’infanta Isabella
di Spagna; in altri sono riferimenti ad
altrettante imprese condotte dallo Spinola: ”quando presso Grol,
si appresta alla battaglia”, “quando (1621)-di fronte alla
sua armata- accetta gli omaggi dei vinti proceri di Giulich”, “quando entra in Vesel”, “quando riceve le chiavi della città di Rimberch” (sottoscritta “ Rimberch - hostis
hostem angit constantia tranget).


Ostenda Grol


Giulich
Rimberch
Nelle
lunette angolari, le allegorie della Fortezza-Valore-Fama-Prudenza, armature e
-nel fregio- l’immagine degli “schiavi o prigionieri in catene, umiliati e nudi “.


prigionieri


armature



la speranza di certa vittoria
l’ira natura
Manca negli affreschi del salone la vittoria di Breda del
1625, perché avvenuta dopo il completamento di essi, quindi tra il 1622 ed il
1625). I dipinti dimostrano il sovrapporsi di una certa influenza subita degli
artisti contemporanei lombardi mescolata ai dettami tradizionali dell’affresco;
ed esaltano simbolicamente la fedeltà alla Spagna purché –sappiamo- fosse
mantenuta l’autonomia politica della Repubblica, essendo l’aristocrazia locale
di allora genericamente intollerante a qualsiasi ingerenza esterna. Identiche
scene verranno riprodotte in argenti .
In altra sala (4
e 5) la storia di Perseo, affrescata da Gio Andrea Ansaldo: evidente rapporto simbolico Ambrogio
Spinola-Perseo, dove l’eroe si identifica nel mito con una sequenza narrativa
che lo porta dall’iniziale sete di gloria, all’uccisione del nemico e del male, al matrimonio col bene ed al trionfo sul male con “Perseo e le Forcidi”, “Perseo in volo sull’oceano”, “Perseo
uccide Medusa“, “Perseo
con il trofeo della testa decapitata“, “Perseo che libera Andromeda“, “Perseo che sposa Andromeda” (Nei primi due riquadri, l’Ansaldo usò come sfondo e scenario delle sue
invenzioni pittoriche, tratti del territorio e della villa stessa: si
intravedono così il palazzo, i giardini, i viali, le fontane marmoree; nel terzo, la grande cupola ricorda la cattedrale genovese di san
Lorenzo; nell’ultimo la trasposizione allegorica del
matrimonio con Giovannetta Bocciadonne. Dagli Spinola di san Pietro fu richiamato -nei primi anni del XVII
secolo- per ripetere negli affreschi i fasti di famiglia, avendo essi acquisita
dai Doria una villa in Acquasola; dei vari decoratori, praticamente era rimasto
lui dei migliori a lavorare in Genova dopo il 1630, sia per la peste, sia
perché Bernardo Castello era morto l’anno prima, Tavarone e
Fiasella un po’ invecchiati e ripetitivi, Giovanni Carlone si era trasferito a
Milano e lo Strozzi a Venezia.
Nella sala 5 viene
citato un affresco raffigurante “Atena e Mercurio che consegnano le armi e Perseo
che le prova”; viene attribuito a G.B.Carlone (16 feb.1603-1684)
fratello -più giovane di 19 anni- di Giovanni.
Vengono segnalati presenti nel palazzo: un affresco dell’Ansaldo raffigurante il “matrimonio di
Argentina Spinola con il figlio dell’imperatore Andronico”; e “moderni quadri” di N.Barabino,
e Plinio Nomellini, senza precisare dove (nell’opuscolo “SPdArena nella sua
amministrazione fascista” a pag.27 una foto dell’aula magna evidenzia due
grosse tele).
Nel 1996 si avvalse dell’assistenza culturale ed organizzativa del FAI (Fondo per l’ambiente italiano), aderendo all’iniziativa “la scuola adotta un
monumento” (gli
studenti fungevano da ciceroni , aiutati dagli allievi in costume della
Compagnia teatrale LaNave ; da quelli del conservatorio Paganini che suonavano
in sottofondo; da quelli dell’istituto agrario Marsano che avevano curato la
coreografia floreale; da quelli dell’artistico Klee che avevano confezionato
uno stendardo; da quelli dell’alberghiero Bergese che cucinarono specialità
liguri).
DEDICATA A: Alla
famiglia degli Spinola, del ramo di san Pietro
-lo STEMMA
rappresenta una scacchiera a dadi bianche e rossi che taglia in mezzo un campo
d’oro; sormontata da una spina di botte.


Il motto era ‘nonc numquam’. In gergo specifico “d’oro
alla fascia scaccata di tre file d’argento e di rosso, accompagnata in capo da
una spina di botte in palo di rosso”. La fascia scaccata rappresenta il cingolo
cavalleresco, e sarebbe quindi un vero simbolo militare: lo scacchiere era
adottato in campo di battaglia, ed era al comando dei capi militari; ma lo
scacchiere era anche il simbolo dell’esattore (lo scaccarium -o abacum-,
necessario per i conteggi; in Inghilterra –ancor oggi- lo scacchiere è il
ministro del tesoro).
-la
FAMIGLIA: Fu una delle prime (secolo X, in
epoca feudale) famiglie di ricchi, con incarichi dirigenziali demandati
dall’imperatore; proveniente dal ramo viscontile di Manesseno (in Val
Polcevera). In particolare, come visconti, -e Visconte era il nome primitivo- erano
incaricati di riscuotere i diritti monetari feudali, legati al movimento delle
merci in transito. Esattori, quindi, per incarico dell’Impero. Divennero una
delle più vaste e potenti famiglie della Repubblica.
Per
l’origine del nome, Canale
racconta una forse leggenda riportata dal Giustiniani: un Guido Visconte (forse
Guidobono o Ido, padre di Oberto e Guido sottoscritti), signore in
valpolcevera, era sempre così cortese che a chiunque passasse a trovarlo non
poteva fare a meno di aprire le sue botti ed offrire del buon vino. Questa
abitudine gli valse il soprannome –come pressoché sempre succedeva a quei
tempi- di ‘spillatore’ e, ai suoi discendenti, di spinola. Ma le leggende si
sovrappongono: fu proposta la ‘spina’ della corona di Cristo, portata dall’oriente
a Genova, dai fratelli Guido e Oberto Spinola, agli inizi del XII secolo; alla
simbolica spina di rosa che ‘punge’ chi la usa impropriamente; al feudo
tortonese nel quale è compreso il monte Spinola, posseduto dal suddetto Ido –o
Guido- Visconte; ai -di mestiere- fabbricanti di botti. Ma molto più
probabile, perché come visconti erano addetti all’esattoria dei tributi, e
quindi ‘spillavano’ diritti fiscali dal commercio del vino
In epoca consolare, la famiglia era già di spicco e di valore
Conosciuto capostipite è un Guido, da cui nacquero Ansaldo
ed Oberto vissuti nella seconda metà del 1200, ghibellini (avversari dei guelfi Fieschi e
Grimaldi), originari in
“san Luca”. Un discendente scelse andare ad abitare poco lontano, vicino all’attuale
salita s.Caterina: questo ramo divenne “di Luccoli”. Seppur imparentati, non
infrequenti furono le divergenze tra le quali la più conosciuta è il
malcontento che distinse i San Luca quali “nobili di vecchia data”, da quelli
di san Pietro “nobili nuovi”; fino ad un primo tentativo di pace con la legge
del Garibetto (=aggiustamento con garbo, del 1547, che però non frenò una
guerra aperta tra i due rami) e la pace di Casale (1576, con nuove leggi
costituzionali che determinarono la nascita di una nuova Repubblica di Genova,
che tale rimase poi fino al 1797).
Le più ampie relazioni, incroci ed alleanze nonché
matrimoni con potenti famiglie, fecero nascere numerosi ‘rami’ che per lo più
trassero nome dai corrispondenti feudi (più vaste numericamente e conosciute,
la stirpe degli Spinola di Luccoli, e quella degli Spinola di san Luca, con i rami ‘signori di Cassano’,
signori di Masone’, ‘signori di Campofreddo’ ed i nostri ‘duchi di san Pietro’).
Nel 1528 formarono il
1° Albergo.
Dal 1531, la famiglia
Spinola si distingue per aver dato 11 dogi (iniziando con Battista
q.Tomaso dal 4.2.1531 secondo doge in ordine cronologico); 12 cardinali; innumerevoli senatori ed un beato
martire; innumerevoli ammiragli (poco meno dei Doria, ma pur sempre ben
inseriti nelle alte cariche cittadine e nel comando delle flotte genovesi) ed ambasciatori.
Erano una delle famiglie
più potenti, schierate nel gruppo dei nobili (e solo nobili) ghibellini, come i Doria (mentre altre
famiglie, comprendenti componenti popolari, erano Guelfi: come i Grimaldi e
Fieschi).
Nel 1800, due divennero
senatori del regno.
I PERSONAGGI in particolare :
-GUIDOBONO Spinola,
è considerato il capostipite, da alcuni specificatoi come ‘major’. Guidò una
spedizione alla prima Crociata nel 1099, divenendo poi Console della città per
oltre 20anni durante i quali Genova conquistò Beyrut, Mamistra e Lavagna)
fondando il castello di Portovenere).
-OBERTO : figlio
del precedente, è il più famoso della famiglia nel periodo del XII secolo
perché fu console per sette volte. Quale capo dei ghibellini, con l’omonimo
Doria formò una diarchia che governò a lungo la città; ebbe il merito di veder
sconfiggere Pisa ed allargare i commerci; di aver difeso la città dal
Barbarossa (1158-64); ambasciatore in Spagna; vittorioso sui saraceni patteggiò
vantaggiosi contratti commerciali col re del Marocco (1161). Ma il demerito,
assieme ai suoi successori, di aver insanguinato le due riviere con
interminabili lotte sanguinose. Nel 1144 (Cappellini dice nel 1188).fu
uno dei fondatori della chiesa di san Luca in Genova, divenuta gentilizia della
famiglia
-OBERTO, altro, omonimo ma del secolo successivo XIII,
fu anch’egli console nove volte, Capitano del Comune e del popolo;
ambasciatore in Spagna; ammiraglio nel 1285.
OPIZZINO
di Luccoli, visse nella prima metà del 1300. Dall’imperatore di Germania
EnricoVII di Lussemburgo, ottenne in feudo un ampio territorio nella zona di
Serravalle-Arquata-Rocchetta, che poi si espanse comprendendo Tortona-Busalla-Mongiardino
-BRIGIDA: Nacque nel 1583, Brigida Spinola, immortalata dal
Rubens, sposa di Massimiliano Doria. Quando rimase vedova con tre figlie, si
risposò con GioVincenzo Imperiale (vedi), vivendo assai spesso nella villa
della Bellezza.
-NICOLO’ Spinola, fratello di un Ambrogio (figlio di
Franco Spinola), esperto e molto attivo mercante
ed uomo d’affari internazionali, vissuto durante la peste del 1656 della quale
fu preciso relatore. Agli inizi di quell’anno quando il contagio
iniziava a Napoli, lui era in prigione per ‘contrasti’ col Magistrato del
Nuovo Armamento (voleva acquistare per Genova quattro vascelli d’alto bordo,
armati ed attrezzati ma costruiti altrove). Arrivato il morbo, a giugno scappò
con la famiglia a Chiavari ma il bisogno impellente di liquidi, lo riportò a
Genova quando era in corso il più alto tasso di mortalità giornaliera e 40mila
erano già morti, facendoli trasportare via nave e depositare a Livorno (dove
per legge, le monete venivano sorvegliate e conservate immerse in un barile
d’aceto, lontano dalla costa). Ritornato a Chiavari visse nell’ansia del
contagio ed incerto se rimanere là (pochi casi isolati, ma che avevano rapito
il padre, un fratello, moglie ed un figlioletto) o scappare nella ritenuta più
sicura casa di Sampierdarena (anche il cardinale Raggi in ottobre era fuggito
nel nostro borgo da cui si allontanò dopo un mese cercando andare a Novi
accortosi che si moriva anche qui: 3200 i morti in Sampierdarena,
su 4mila abitanti). Stessa ansia estremamente dolorosa ebbe quando l’anno dopo
fu nominato commissario di Sanità (se cercava di sottrarsi, sarebbe stato
punito con multa di 500 scudi d’oro ed interdizione ai pubblici offici per 10
anni). Venne qui, con la madre, a fine settembre del 1657 e rimase fino agli
inizi di ottobre . E –ad epidemia finita- dover decidere se sacrificare mobili
ed indumenti dei parenti perduti o affidarsi alle costose ‘profumazioni’.
-DANIELE: nel vastissimo albero genealogico degli Spinola,
unico omonimo corrispondente all’anno della villa sampierdarenese,
fu il Daniele degli Spinola di Luccoli vissuto negli anni 1563-1587 (-q. Niccolò; e nipote di un altro
Daniele che era morto nel 1504 ed a sua volta figlio di Giacomo q. Carozio
(quest’ultimo morto nel 1405)). Se fosse
lui, sappiamo che sposò Maria DiNegro con la quale ebbe 5 figli (essendo: 2 femmine, uno sacerdote, uno morto
infante, l’unico di essi possibile ad
aver ereditato fu Flaminio. A sua volta,
questi ebbe tre figli, uno femmina, l’altro anche lui Daniele ma che ebbe una
sola figlia e quindi di
essi solo GioGirolamo può aver ereditato
negli anni 1636 (ma che fu l’ultimo del ramo avendo generato 5 figli tutti
divenuti sacerdoti o monache).
-GIOVANNI MARIA sposò Pellina Lercari (figlia del doge
GiovanniBattista, erede di un vistoso patrimonio paterno tra cui forse anche la
villa della Semplicità nell’attuale via N.Daste), dalla loro unione discese la casa dei Duchi di
sanPietro.
-AMBROGIO: 1569-1630,
gran condottiero degli Spinola di san Luca. Figlio di Filippo (marchese del Sesto e di Venafro) e Polissena Grimaldi. La sorella
Battina aveva sposato Francesco Pallavicino fratello di Nicolò, e suo figlio Filippo che nel 1625
era a Genova Magistrato della Guerra, seguì lo zio nelle Fiandre. Ambrogio fu coinvolto dal fratello
Federico al servizio del re di Spagna Filippo III, aiutandolo con denari nel
1601 ad affrontare la guerra di Fiandra contro gli olandesi: poi attivamente
nel 1603 sostituendo il fratello Federico, morto in battaglia mentre
organizzava nel porto di Dunquerque una flottiglia di galere necessarie per
combattere sul mare olandesi e Zelandesi. Forte da uno spirito ambizioso, di
far grande il suo casato alla corte spagnola, espugnò Ostenda (che era sotto assedio da quasi 4
anni (a fine sett.1604 la città si arrese
essendo completamente distrutta, e dopo aver perso 50mila soldati; altrettanti
e forse anche di più ne perdettero gli assedianti spagnoli). Nel 1606 era a Genova a parlare al
Senato come ministro-ambasciatore del re spagnolo.
Ai tempi di Keplero nel 1618 si allargò da Praga la ribellione
protestante che covava nell’Europa; il Papa Paolo V e molti regnanti si
gettarono nella battaglia armata, iniziando la cosiddetta Guerra dei Trent’anni. Nel primo periodo di essa
(1618-1625), la Lega cattolica dapprima perse, ma poi affidata nel 1620 ad
Ambrogio -per ordine di Filippo IV di Spagna- (partendo dalla Baviera con 25mila uomini, 12 cannoni
(quanti gli Apostoli) e con gesuiti e truppe spagnole in prima fila) invase i Paesi Bassi ed il
Palatinato cogliendo una successione di oltre 58 vittorie con altrettante
espugnazioni di città (tra
esse (non in ordine) Linghem (con 14mila famnti, 2000 cavalieri piccolo borgo
della Frisia importante perché “nelle viscere de’ Nemici”); Grolio (importante
fortezza militare); Riemberg (grosso ed importante paese delle Fiandre);
Aquisgrana, Vezel, Oppenheim, Creutznach, Jülich (quest’ultima fu rappresentata nella
nostra villa dagli affreschi di GioAndrea Ansaldo su commissione di GB Spinola), fino alla più importante, l’olandese Breda (1625: nel lungo conflitto che oppose la Spagna
all’Olanda, allora Province Unite del Nord, del Brabante, spicca questo grande
successo dello Spinola che facendo uso di inusitati mezzi militari -specie
complesse opere di ingegneria che interessarono tutti gli esperti militari d’Europa-,
in nove mesi espugnò la città comportandosi alla fine da vero grande gentiluomo
verso gli sconfitti, il ché accrebbe a dismisura il valore morale della
vittoria e divenne codice nuovo di comportamento militare: rispetto della
parola data, generosità verso lo sconfitto, invulnerabilità dei negoziatori e
degli ospedali; durante l’assedio ricevette in dono da G.Galilei un telescopio
perché ‘sul sacro campo di battaglia meglio potesse vedere anche da lontano i
ribelli eretici’).
Durante tutta l’operazione, tenne costante rapporto con i genovesi (in
particolare Nicolò Pallavicino) tramite corrispondenti d’affari. Nel 1627
Ambrogio era in Fiandra; scese in Spagna per relazionare Isabella sulle future
imprese militari; era con lui la figlia Polissena e suo marito don Diego Messia
Felipe de Guzman (m.1655), marchese di Leganès. Terminata
felicemente questa guerra contro il conte Maurizio di Nassau, giudicato il più
grande capitano del suo secolo (36 dice Filippo, Boccardo-DiFabio dicono che ‘governatore della
città era Giustino’)
Era divenuto cognato del nostro Gio Battista.
Dopo venne anche in soccorso del duca di Savoia contro i
francesi, nella successione al ducato di Mantova e Monferrato. Nel 1629 nei
pressi di Casale fu sconfitto dai francesi e si ammalò; si spense lentamente (si dice ‘disgustato’ dal vedersi
abbandonato da chi riteneva debitore dei suoi vittoriosi servigi (cioè la
corte di Madrid) e dalle notizie catastrofiche in Fiandra da dopo la sua
partenza) morendo
l’anno dopo il 25 settembre nel suo feudo a Castelnuovo Scrivia ove fu sepolto
nella parrocchiale, nella cappella di famiglia.
Fu ritratto da molti artisti, tra i quali Rubens ed il
pittore fiammingo Van Dyck (merito suo se allora 22enne, fu ospitato a Genova;
qui conseguì una ampia produzione di tele, che onora la nostra città).
Contemporaneamente fu decantato da innumerevoli poeti e scrittori, tra cui
Filippo Casoni .
-GB:
Giovanni Battista, altrove chiamato
Giambattista o Gio Battista, era Spinola di san Luca (Boccardo scrive che era
di san Pietro), uno dei 9 figli di GioMaria e Pellina Lercari, vissuto a
cavallo tra il 1500 e 1600; divenne duca di san Pietro in Galatina; sposò Maria
Spinola (sorella di
Ambrogio il conquistatore delle Fiandre, e figlia di Filippo) da cui ebbe ben 10 figli (tra i quali l’erede fu forse
GioFilippo considerato che tra tutti, fu l’unico ad avere da Veronica Spinola
un figlio, Francesco Maria, anche lui duca di san Pietro in Galatina, molto
apprezzato in città ma anche alle corti di Parigi, Vienna, Madrid e Londra). Ufficialmente risiedeva in via Orefici nel palazzo
dei nonni materni.
Di lui vedi anche all’inizio, dei proprietari a San Pier d’Arena.
-ETTORE fu comandante
di galea che combattè a Lepanto, e che morì in battaglia (7 ott.1571).
-GioFilippo grande ed appassionato
collezionista di quadri: arrivò a sfidare le severissime leggi della Repubblica
di Venezia attuando una illecita esportazione della grande tela del Veronese
‘Cena in casa di Simone’, impegnandosi a pagarla settemila ducati d’oro (pari a
venti chili del prezioso minerale).
-LUCA (di Battista, 2° doge). Del ramo di s.Luca, marchese di
Lerma, signore di Campoligure. Fu 12°doge dal 4 genn.1551 al 3 genn. 1553.
‘Vir strenuus’, uomo di ferro, scrupoloso della legge. Aprì la ‘strada Nuova’.
Soggetto ad un attentato per commissione, ne sfuggì ma morì il suo amico
Pinelli; scoperto il mandante, lo fece decapitare anche se era un giovanissimo
che voleva salvare l’onore del padre caduto nei rigori delle leggi varate dal
doge.
-TOMMASINA fu moglie
di Luca Spinola. Dotata di bellezza ed ingegno, divenne famosa per il suo
platonico innamoramento di LuigiXII, quando lui ebbe a venire a Genova. Tenne
col re una lunga ed appassionata corrispondenza cercando anche di appoggiare i
suoi patrioti e la sua città. Morto il re, ella si ritirò in solitudine morendo
anche lei, nell’anno 1505 lasciando fantasticare i cronisti su questo rapporto.
-CARLO della Compagnia di Gesù, fu per venti anni missionario in
Giappone ricoprendo incarichi di grande responsabilità compreso di vicario
generale dell’episcopato nipponico. Arrestato durante una persecuzione, dopo
quattro anni di carcere subì il martirio andando bruciato vivo sul rogo, a
Nagasaki.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Guida illustrativa per la città di Ge.-Sambolino.1875-pag.642
-Archivio
Storico Com.Toponomastica - scheda 4279°
-AA.VV.-Argenti
“colombiani”-Sagep.1988-
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed.94-pag.412—ed./02-pag.449
-AA.VV.-Catalogo
delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag. 148disegni
-AA.VV.-La
pittura a Ge. e Lig.-Sagep.1987-v.II-74fot52+53.94fot 71 .150.154
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-pag.28disegni
-AA.VV.-SPd’Arena
nella sua amministrazio.. fascista-Reale.1926-p.24foto
-AA.VV.-SPd’Arena
dall’antico borgo marinaro-Agora.1995-pag.37
-AA.VV.-Scultura
a Ge. e in Liguria-Carige-vol.II-pag.79
-Battilana
N.-genealogie delle fam. nobili-Forni-vol.II-p.IV.carte20.64.132
-Bedocchi&Profumo-I
caruggi di Genova-NewtonCompton.2007- pag.578
-Boccardo&Colomer&DiFabio-Genova
e la Spagna-Silvana.02-pag.73.177-9
-Boccardo
P.-L’ Età di Rubens- Skira.2004- pag.455
-Castagna&Masini-Genova,
guida storico artistica-Masini 1929-pag.449
-Dagnino A-Genova e
l’Europa mediterranea -Silvana.2005 -pag.217
-DeLandolima
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922–pag.16
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari 2001-pag.15
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gavazza
E.-la grande decorazione a Genova-Sagep-37.47.53-foto24.32.35.37-52
-Gavazza
E.-Villa Spinola di San Pietro-Guide Sagep.1976-n°27foto
-Gazzettino
Sampierdarenese: 9/80.7 + 5/86.15 + 3/89.5 + 4/96.9
-Genova-rivista
municipale:11/26.1266fotomegollo+4/27.305+10/38.34Labò M
-Gregori
M.-Pittura murale in Italia-San Paolo IMI.1998.IV-pag.79-80
-Grillo
L-elogi di liguri illustri-Pointhenier.1846-vol.II-pag.90=leggere 4°
-Grosso
O.-All’ombra della Lanterna-Erga 1967-pag.109
-Guaita
O.-Viaggio in Italia-rivista trimestr.turismo,cult.-5/94-pag.54
-Labò
M.-I palazzi di Genova di PP.Rubens-Tolozzi-.54
-Lamponi
M- Sampierdarena – LibroPiù.2002- pag.29
-Levati
PL.- Dogi biennali –Marchese & Campora.1930-pag.64
-Levati
PL.-Regnanti a Genova nel sec.XVIII-Gioventù.1910.pag.3
-Magnani
L.Il tempio di Venere-Sagep.1987-pag. 143.188+fig.180
-Moretti
AM-Musica e costume a Genova-Pirella.1990-pag.55.67.151
-Nada
Narciso-Miscellanea di storia del Risorgimento-ERGA-1967-p.252
-Novella
P.-Strade di Ge.-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.12.18
-Pagano/1961-pag.245
-Pastorino&Vigliero-Dizion.delle
strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1727ritr di Ambr
-Pesenti
FR.-La pittura in Liguria, il secondo600-Carige-pag.123.154nota2 -Piastra W. &C-Dizionario biografico dei
Lig.Brigati.1992-v.IV-pag.434
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.51
-Presotto
D.-Genova 1656-Atti SLSPatria-v.79-II-pag. 313
-Ratti-instruzione
di quanto può vedersi...-Forni - Ivol.-384
-Remondini
A&M-Parrocchie dell’archidiocesi-B.Berio-vol 11- pg 77.104
-Reston
J.-Galileo-Piemme.2001- pag.252-3
-Roscelli
D.-Nicolò Barabino-soc.Universale.1982-pag.152
-Sagep
–Guide di Genova- n° 27foto +
-Scorza
A.GM.-le famiglie nobili genovesi-Frilli.2003- pag.203
-Simonetti
F.-Argentieri fiamminghi a...-Ge e l’Europa atlantica-Carige-2006-p.157
-Spinola N.-Cronache di una pestilenza...-SLSP 1965-vol.V
nuova serie-f.II-
-Traverso
C.-Campomorone- Grafica LP.1999-pag. 91
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag.70.141
-Tuvo&Campagnol-Storia
di SPd’Arena-D’Amore.’75-pag.50.78.87soffitto.90
STALLO vico Luigi Stallo
TARGA: vico – Luigi Stallo
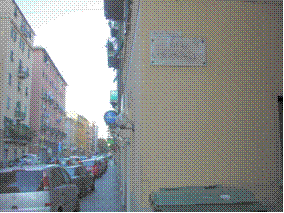

angolo con via W.Fillak


angolo con via Vicenza
QUARTIERE ANTICO: san Martino
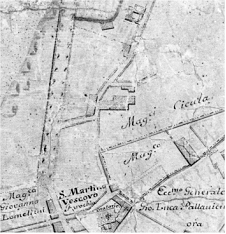 da MVinzoni 1757. la zona compresa tra via Caveri (abazia di
san Martino); l’inizio di via Vicenza-Campasso e il torrente che formerà via
Chiusone.
da MVinzoni 1757. la zona compresa tra via Caveri (abazia di
san Martino); l’inizio di via Vicenza-Campasso e il torrente che formerà via
Chiusone.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2854 CATEGORIA: 3
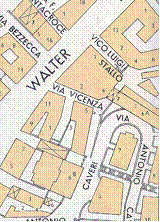 da Pagano 1961
da Pagano 1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 59780
UNITÀ
URBANISTICA: 24 -CAMPASSO
 da Google Earth 2007
da Google Earth 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: da via
W.Fillak, chiusa in fondo da una breve scalinata che consente l’accesso
pedonale in via Vicenza, teoricamente aperta ad ambedue i sensi viari per i
pochi metri che la costituiscono, lunghi quanto la facciata laterale del
palazzo.
E’
strada privata. Nel SecoloXIX dell’ago/04 si legge essere una ‘via privata di
interesse pubblico’ e quindi programmata a divenire municipalizzata (cessione gratuita) e in cambio poter usufruire del mantenimento e
servizi annessi (fognature,
spazzatura con cassonetti, asfaltatura, illuminazione, ecc.).
STORIA con tali confini c’era stata una proposta
di dedicarlo ad un generico “Canepa”, in attesa di approvazione; questo nome
compare messo tra parentesi ma non meglio specificato a chi si riferiva.
Fu
invece ufficialmente titolato allo Stallo negli anni subito dopo il 1910,
quando allora si distaccava da via Umberto I, ed era collegato con via U.Bassi
(via Vicenza). Con civv. 1 , 2 e 4.
Nel 1926, anno in cui SP’Arena fu unificata a Genova, il vico è incluso nelle
strade genovesi; ed essendo unico tra le delegazioni, non subì variazione
Nell’anno
1933, era ancora eguale, di 5ª categoria, con solo un civico.
CIVICI
Nel
2007: neri= 1; e da 2 a 4
rossi= da 1r a 11r;
e da 2r a 10r
Nel
Pagano/40 la strada da “da via d.Corporazioni a Via Vicenza a via G.B.
Millelire “ ed ha: un solo civ.nero, e rossi: 4 falegname; 10 carbone legna.
===civ.
1 Nel Pagano/61 risultano abitanti
il ‘medico della mutua’ Benedetti Renato,
presente sul territorio negli anni 1960 (poi andò ad abitare in sal.Inf.sRosa. Personalità buona
d’animo, un pò forzatamente estroversa ma piena di problemi: in primis il modo
di gestire –troppo disinvolto: ma allora c’erano meno controlli e meno leggi;
il laudano e dolantin erano prescrivibili con semplici ricette e reperibili in
tutte le farmacie- alcuni pazienti diventati assuefatti alla morfina quando
esserlo non era mai secondario a voluttà ma a malattie; in secondo ‘i grappini’
che già dal mattino facevano parte della colazione; in terzo una spiccata
avversione alla burocrazia delle mutue con conseguenza di non essere pagato
perché non mandava relazione del suo operato (copia delle ricette con carta
carbone). Morì per neoplasia cerebrale, apparentemente freddo e rassegnato
conoscendo il suo destino a brevissima scadenza) ed il giornalista Ferro PG.
===civ. 5r Caselli
mobiliere;
===civ. 8r Vi aveva
sede l’ex PCI sezione Spataro; attualmente vi sono circolo e società
ANPI-Spataro, federati Arci (come anche la vicina “Fratellanza” di via
Millelire). Non so quando, il circolo ha preso in gestione anche il civico di
fronte, 9r pianoterra (che sfocia nel retro, in
via Vicenza al 12r, e che nel 2007 è quello aperto, mentre l’8r è chiuso).
DEDICATA: al
mazziniano-garibaldino, membro della società Umanitaria nel cui ambito fu tra i
promotori nel 1854 del settore alimentari a favore degli operai, basato
sull’acquisto delle materie prime (patate, grano e farine, riso, olio, vino, legumi, ecc. ed
anche carbone), tramite un capitale raccolto tra i soci, con obbligazioni di lire 50
cadauna, e creazione di una società in accomandita chiamata “società Filantropica Alimentaria” con sede a Genova
in vico Dritto della Maddalena, 99. I beni di consumi, venivano rivenduti con sopraggiunto solo le spese di
amministrazione, senza lucro. Furono il primo passo verso le più organizzate cooperative di consumo,
che avranno un notevole sviluppo dieci anni dopo.
Nell’ambito
della cospirazione pro Mazzini e Garibaldi, diede un notevole contributo ed
impulso schierandosi a favore di una democrazia popolare basata sul suffragio
universale, diritti dei meno abbienti, educazione e cultura, progresso sociale
degli operai. Fu un soggetto quindi, ben presto conosciuto dalla polizia (come Antonio Mosto e Nicola Ardoino), che durante una delle tante insurrezioni popolari,
il 29 giu.1859, lo arrestò soffocando la sollevazione; riuscito a fuggire, fu
egualmente processato in contumacia (assieme a Mazzini ed Antonio Mosto) e condannato a dieci anni di reclusione (il capo d’accusa era “ sedizione”,
poiché volevano instaurare la repubblica)
.
Partecipò
di persona e volontario alle guerre garibaldine tra i Carbinieri genovesi.
Nel
1868 lo troviamo fondatore e primo presidente (assieme a Garibaldi e Mazzini ovviamente onorari;
poi rieletto nel 1869) della neonata
“Società M.S. dei Volontari italiani di San Pier d’Arena” e della ‘Associazione
Reduci delle patrie battaglie’, con sede per le riunioni in via del Mercato 11, presso il palazzo Boccardo.
Non
fu rieletto l’anno dopo perché il 7 lug.1869 lo troviamo detenuto nella
cittadella di Alessandria; e nel 1870 a Gaeta.
Uscito
dal carcere, dopo la spedizione francese criticò veemenemente Garibaldi,
pubblicando un volume in Francia (a Chambery) nel 1871 «Verità e calunnia in
faccia al generale Giuseppe Garibaldi. Reminiscenze di un volontario italiano
in Francia» in seguito al quale fu allontanato dalle associazioni e finì
emarginato.
Era l’epoca della nascita delle associazioni, che si
costituivano numerose tra i lavoratori, con scopi mutualistici ed umanitari,
come dettato da Mazzini nei suoi scritti (comprendevano la protezione anche
contro l’invalidità, la vecchiaia, le infermità temporanee; e si interessavano
anche di moralità e benessere). In particolare si ricorda il 5 ott.1851 la
fondazione della “Società di Mutuo Soccorso dell’ Unione Umanitaria”, con sede
in via privata Rolla.
Tre anni dopo, assieme alla “S.M.S. Unione Fraterna”,
inaugurarono un gabinetto di lettura, scuole serali elementari e di disegno,
corsi di scherma, tiro a segno e ginnastica; il 24 ago.1862 le due società si
fusero generando la “Associazione Generale di M.S. ed istruzione degli operai
in San Pier d’Arena” con sede sempre in via
del Mercato 11 (la
quale contava 200 soci; fondò una banca operaia; organizzò esposizioni d’arte e
di artigianato; aprì una biblioteca circolante: si fece promotrice di
sottoscrizioni volontarie mensili “pro Mazzini” per il suo apostolato: quest’ultimo
fu il pretesto della polizia - ritrovata la lettera di ringraziamento - per
sequestrare tutto il materiale, mettere i sigilli e sciogliere
l’associazione). Gli operai, ricrearono un nuovo solidalizio, con lo stesso
statuto ma con nome diverso di “Associazione Operaia Universale di M.S. San
Pier d’Arena” (vedi in
via Carzino), la quale
di nascosto ricreò le stesse collette e propose le stesse attività;
ciononostante fu riconosciuta dalle autorità (questore e prefetto),
permettendo di raggiungere anche 500 soci (che sono pur sempre pochi, in un
centro così fittamente popolato da operai: ma c’era contro anche una parte del
clero in quanto oltre all’attività sociale si svolgeva anche attività politica
ed anticlericale).
Esiste una cartolina, viaggiata nel 1909, riproducente a
Genova una “via L.Stallo” (http://www.genovacards.com/genova/vie/vie.html)
che evidentemente non esiste più.
Viene citato un omonimo che nel 1869 militava in città
quale delegato di P.S.; per ordine prefettizio accompagnato da guardie e
carabinieri, il 13 dicembre perquisì e sciolse la Camera del Lavoro ed il
Circolo socialista.
BIBLIOGRAFIA
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.447—ed./02-pag.484
-AA.VV.-1886.1996
oltre un secolo di Liguria-Il SecoloXIX-pag.66
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4294
-Castagnino
P.-immagini e avvenimenti della Resistenza-Basile
-DeLandolina
GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922- pag. 56
-Il
Secolo XIX del 25.11.03 + 23.8.04 +
-Morabito.Costa-Universo
della solidarietà-Priamar.1995-pag. 56.168.383
-Novella
P.Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.18
-Pagano/1933-pag.248;
---/40-pag,415; /1961-pag.400
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
Strade di Genova-Tolozzi.1985-pag.1740
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.9
-Remedi
A-Microstorie-GGaribaldi a SPdA..-Emiliani 2010-pag112
-Stradario
del Comune di Genova edito 1953-pag.171
-Tringali
S-Sampierdarena 1864-1914-CoopTipograf.2005-pag.26
-Tuvo.Campagnol.Stria
di Sampierdarena-D’Amore.1983-pag.242
non
citato da ES + EM +
STAZIONE
via Stazione
Salita alla Stazione
Non sono mai esistite
ufficialmente come tali. Quale “salita alla Stazione” è pure riportata su
alcune cartoline illustrate.
Quando nel 1850 studiarono come
far transitare il treno in pieno borgo, fu ovvia conseguenza erigere l’alto
viadotto che isolasse la linea dalla vita del popolo: un lavoro immane che da
san Benigno percorreva l’interno della linea costiera e si prolungava verso
Rivarolo. Anche la stazione fu eretta in alto, in pari con i binari. Ovvio
creare la salita per arrivare ad essa, ma alla quale mai è stato dato un nome
personalizzato.
Ambedue le titolazioni quindi corrispondono
a quella ancor oggi esistente salitella che porta alla stazione ferroviaria,
dalla via sottostante (che all’epoca del Novella, prime decadi del 1900, era
via Milite Ignoto ma che prima era stata via Vittorio Emanuele e via UmbertoI;
e dopo via P.Reti).
Ci appare quindi che non abbia
mai assunto questo nome in forma ufficialmente riconosciuta dal Comune; così
si includerebbe nelle numerose indicazioni ad uso popolare, atte ad indicare
certe zone in rapporto alla funzione.
Il 9.2.1931 ci fu una
interpellanza nel consiglio comunale, mirante a migliorare la viabilità alla
stazione (il progetto prevedeva poter accedere anche dalla retrostante via
Cavour tramite un sottopasso a piano terra ed ove avrebbero trovato posto
biglietteria, ristorante, diurno e lasciando di sopra oltre l’accesso ai treni,
al caffè e le sale di aspetto: parzialmente fu realizzato dopo oltre
cinquant’anni, per carenza cronica di fondi economici).
BIBLIOGRAFIA
-DeLandolina GC –Sampierdarena
-Rinascenza.1922 – pag. 56
-Genova-rivista municipale- del
3/31.195
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag.62
.non
citata dallo stradario comunale 1953- e dal Pagano/1933
STENNIO
via
Achille Stennio
TARGHE:
San Pier d’Arena – via –
Achille Stennio – medaglia
d’oro ligure – Carso 1916


angolo con
via C.Rolando, lato a monte


in angolo
con via P.Reti
QUARTIERE
MEDIEVALE: San Martino – Ponte
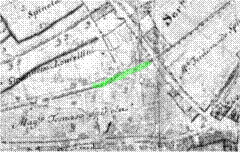 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2855 CATEGORIA: 2
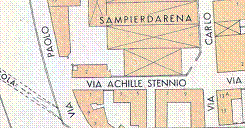 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE DELLA
STRADA - N° INFORMATICO: 60140
UNITÀ
URBANISTICA: 25 - SAN GAETANO
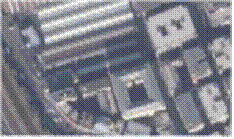 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: san Giovanni Bosco
STRUTTURA: senso
unico viario da via P.Reti a via C.Rolando (oltre la quale prosegue diritta in
via C.Rota).
La
targa in marmo, precedente quella di plastica, in basso a sinistra riportava
l’incisione “già via Montebello”.
STORIA: nella
carta vinzoniana si rileva che allora era un piccolo sentiero interposto tra
la proprietà del Mag.co Tomaso Spinola e quella della Mag.ca Giovanetta
Lomellini (dei quali si
descrive in via C.Rolando). Il sentiero
proseguiva verso il Polcevera, ma fu troncato nel 1850 con l’erezione del
bastione della ferrovia e della conseguente via P.Reti.
Con
la lottizzazione di fine 1800 ed i palazzi, nacque la strada inizialmente intitolata
via Montebello. Questo nome le rimase
sino alla decisione del podestà, espressa con delibera il 19 agosto 1935 (quando collegava via Martiri Fascisti con via
E.Mazzucco) quando fu cambiato con l’attuale,
per evitare doppioni dopo l’annessione nella Grande Genova.
Fin
dal 1895 il tratto iniziale fiancheggiava il lato sud del deposito tranviario
(in particolare con le
case adibite ad abitazione dei dipendenti, e che ancor oggi sono di proprietà
dell’AMT, e poi il muro del deposito sino all’incrocio.
Un progetto presuppose negli anni 30 la possibilità di
farle delimitare un terreno per un mercato ortofrutticolo all’ingrosso.
Ricevette notevoli danni dai cannoneggiamenti navali del
14 giu.1940 e del 9 febb.1941, ma soprattutto dai successivi e numerosi
bombardamenti alla ferrovia (binari tranviari
vicini, sconvolti; muri e tettoie distrutte o perforate da mille schegge; tutti
i vetri infranti; intonaci scrostati; porte e telai divelti; però per fortuna
nessuna demolizione).
Subito dopo la guerra del 45 in angolo con via Reti, a
mare era l’albergo Martini; lato monte c’era un negozio di dischi, macchine da
cucire (in una palazzina eretta dall’AMT per
uffici –sulla facciata a nord; ed abitazioni per i suoi dipendenti sulla
strada). Verso est, quando la strada finiva intersecando via A.Saffi, il
negozio d’angolo a mare era il mobilificio Mazzucco, poi Porcile; a monte c’era
una palazzotto di due piani posto trasversalmente a 45°, al cui piano terra
era una latteria.


da via P. Reti
da via C. Rolando
CIVICI
2007= NERI= da 1 a 9 e
da 2 a 4
ROSSI= da 1r a
25r (compreso 1AB) e 2r
Nel Pagano/40 va “da via M.Fascisti a vie E.Mazzucco”;
Civv.neri: al 5 Dopolavoro Ansaldo;
rossi 2r Gotti Icar macch.p.cucire; 9r-17r
Porcile mobili; 19r frruttiv.
===civ. 1r : Nel 1930 era
di Francesco fu Bartolomeo (ed era in via Milite
Ignoto al 31r.); dal dopoguerra è stato sede per anni della soc.
Piccardo fornitrice di materiali per costruzioni che alla fine del 1990 si
trasferì in via San Pier d’Arena. Da dopo è divenuto sede di box per auto.
===2r negli anni 1960, dal
1930, era un negozio affittato a Gotti; vendeva dischi e radio; poi c’è stato
anche una merceria.
===2 e 4 neri= è una palazzina creata
dall’UITE per i suoi dipendenti e per uffici, con vani alti ed abbastanza
vasti.
===civ.5: fu costruito nella prima decade del 1900 per
adibire il primo piano, opportunamente rinforzato con putrelle e più alto
d’aria, per sopportare il peso di una fabbrica di
latta, finanziata dai sigg. DeAndreis-Casanova. Da vico Scanzi sono
visibili ancor ora le finestre con la struttura tipica di una di fabbrica
(rettangolari ma più larghe, con grata, diverse dalle altre).
La
parte apicale dell’ultimo piano, fu invece sopraelevata negli anni 1930. Dopo
un breve periodo di occupazione di una palestra, fu diviso in appartamenti (di cui, nel 1961, all’interno 1, era
ospitato un dopolavoro interaziendale Ansaldo con telef. 459.959, 412.723). Nel 2004 quando il personale era assente per
ferie, un incendio devastò, al primo piano, la palestra “Body Proiect”.
La
facciata sulla strada è stata ridipinta nel 2004-5
===civ.
7-9 è stato ridipinto esternamente
nel 2002-3. Sopra il portone del 9 in una losanga è l’immagine della Madonna
della Guardia.
 civ. 9
civ. 9
DEDICATA al militare
genovese, nato in Portoria il 4 mar.1866 e - come si diceva allora quando era
obbligatorio segnalare la genitura, “figlio di ignoti”, oppure “di n.n.”-.
Piccolo
di statura, capelli scuri, fare risoluto, signorilità.
Entrato
giovanissimo nell’esercito, seguì la carriera militare dedicandole piena
attenzione e senza formarsi legami familiari.

Avendo
combattuto a lungo nelle guerre coloniali di espansione (Eritrea, la prima colonia italiana,
ove combattendo la guerriglia al comando del III Ascari, si fece conoscere per
eroismo al punto che gli fu intestato un fortino all’Asmara e meritò i gradi
di ufficiale.
In Libia nella guerra Italo-turca del 1914, fu al comando
del 3° battaglione eritreo e fu premiato con un encomio solenne, la promozione
di grado superiore a maggiore, ed il conferimento della “Croce dell’Ordine
Militare di Savoia” (abbreviata OMS: era la massima onorificenza militare
italiana in epoca monarchica e conferita solo per meriti e nei periodi bellici;
la motivazione recita: “con
molta energia, perizia e valore guidò il suo battaglione nell’aspro e
sanguinoso combattimento di Omm (Scikaneb –26 febbraio 1914),prese parte
altresì lodevolmente alle numerose operazioni del sud bengasino, comandando
anche reparti autonomi delle tre armi – Sceleidina 24 febbraio 1914 – Zuetina,
12 marzo 1914 – Gedabia, 15 aprile 1914 – Sira Gemaisil Kleita, 8-9 agosto
1914) . Ad essa seguì un encomio solenne “per l’efficace azione direttiva
dimostrata nell’impiego del suo battaglione durante il corso di operazioni –
regione dell’Uadi Mayur dal 24 agosto al 4 settembre 1914”).
Partecipò alla prima guerra mondiale col grado di colonnello, comandando il 2°
battaglione del 9° reggimento fanteria, brigata Regina.
Nella
primavera del 1916 è sui monti del Carso, rocce insanguinate dallo
sproporzionato sforzo bellico (molte vite umane, in cambio di trincee giudicate imprendibili e di un
vantaggio bellico irrilevante, se non di tenere agganciati i nemici ed impedire
loro di aiutare i tedeschi nella loro offensiva a Verdun).
A
Bosco Capuccio, contro una munitissima trincea chiamata ‘fortino’ posta sulla
sella tra san Martino e san Michele, sempre seguito dal suo fido collaboratore
Carlo Bazzi (decorato
con medaglia d’oro al VM per aver sgominato un pesante contrattacco nemico) nei giorni 11-15 marzo del 1916, seppe conquistarsi
un’altra onorificenza di bronzo ed il grado di colonnello del suo stesso
reggimento per aver saputo adattarsi e gestire la terribile guerra di trincea,
sempre condividendo alla pari con i suoi soldati il pericolo della morte sotto
il tiro incrociato e di sbarramento delle armi pesanti, nonché fronteggiare il
primo impiego austriaco dei gas asfissianti e l’uso delle mazze ferrate per
finire i feriti. (La
motivazione spiega : “comandante di un reggimento di
fanteria diresse con perizia e valore le varie operazioni per opporsi ai
contrattacchi nemici e per riconquistare un fortino perduto. Nella notte
successiva tra l’infuriare dell’artiglieria, delle bombe e della fucileria
avversarie seppe infondere col suo contegno calma e coraggio nei solati
affaticati da quattro giorni di lotta, tenendoli saldi sulla posizione. – Bosco
Cappuccio 11-15 marzo 1916”)
Superata
l’offensiva austriaca sul Trentino e dopo le gloriose giornate di Gorizia, sul
Carso si combatté il 17 sett.1916 la VII battaglia dell’Isonzo; si trovò a
dover avanzare oltre le più valide cime già conquistate, onde poter meglio
difendere Gorizia e mirare a raggiungere Trieste. Sulle doline dopo
cannoneggiamento, iniziò l’attacco da Devetachi, lungo la linea
Oppachiasella-Castagnevizza. Ovviamente il nemico controbatté con fuoco serrato
e micidiale; lo scontro fu per conquistare e difendere poche decine di metri:
palmo a palmo. Infine dopo un furioso assalto alla testa dei suoi soldati ebbe
ragione dei continui rincalzi di cui godevano gli austriaci dalla vicina Loquizza
e si portò sulla nuova linea preventivamente mirata ed appena conquistata; ma
qui pervenuto si accorse che il nemico stava allestendo una nuova linea
d’attacco, che occorreva prevenire. Così dopo aver consolidato la posizione
conquistata, in piedi alto su tutti -mentre indicava ai suoi rincalzi che
affluivano la direzione da seguire ed i compiti da eseguire-, fu colpito al
petto da una pallottola che gli lasciò solo il tempo di dire poche ma
patriottiche parole; meritando così la medaglia d’oro al V.M. (cronologicamente
11° tra i liguri onorati di tale riconoscimento).
Nella
motivazione alla medaglia, si legge “ Preparato con vigile cura e materialmente il suo reggimento,
pieno di fede nella vittoria, alla testa delle prime schiere, lanciava
violentemente due suoi battaglioni all’assalto di una solida posizione nemica.
Sulla trincea occupata, fieramente eretto sui più avanzati approcci, incitava e
dirigeva l’affluire dei rincalzi noncurante dei proiettili e delle bombe che
numerose gli scoppiavano attorno, dicendo essere quello il suo posto per
dividere il pericolo dei suoi soldati. Colpito mortalmente al petto da un
proiettile di mitragliatrice, agli ufficiali accorsi che tentavano celargli la
gravità del suo stato, fieramente rispondeva: «io muoio , ma la vittoria è
nostra ! viva l’ Italia !»”
La sua salma, una delle tante, fu tumulata a
Redipuglia nel cimitero degli Invitti della III armata (dietro l’Ara votiva, a destra per chi entra, all’inizio del primo
girone c’è un cippo formato da un grosso proiettile di bombarda esploso, e
vicino alcune pietre: su una di esse è scritto “colonnello Stennio cav. Achille Decor.Med.Oro“. Facile non accorgersi di essa, nell’immenso numero di
cimeli, di tombe, di nomi e decorazioni).
Numerosi suoi ricordi, sono all’Istituto Mazziniano.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4323
-A.sconosciuto-Storia
del trasporto pubb. a Ge.-Sagep.80-pag. 152.236.250
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.447—ed./02-pag.484
-AA.VV.-Archivio
storico AMT-inventario 1873-1965-Bonati &S.
-Genova,
”La grande Genova”-Rivista comunale del **/24.649 + 11/29.649 +
12/34.1027ritratto + 1/37.25 foto
-Il
SecoloXIX quotidiano del 25.8.04
-Lamponi M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.162
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto b.erio.1900-pag.18
-Pagano/40-pag.
416; /1961-pag. 401.598
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1748
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.33
-non
citato su Enciclopedie Motta e Sonzogno
STORACE
via
Dante Gaetano Storace
TARGA: Via – Dante G.
Storace – mazziniano – 1889-sul Mrzly ott.1915


in angolo con via C.Rolando

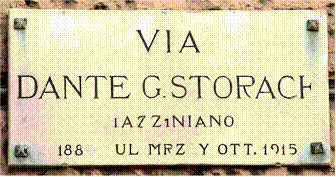
in angolo con via P.Reti
QUARTIERE ANTICO:
San Martino
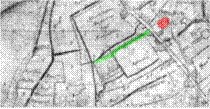 da MVinzoni, 1757. In rosso la
chiesa di san Giovanni Decollato (don Bosco); in verde ipotetico tragitto della
strada.
da MVinzoni, 1757. In rosso la
chiesa di san Giovanni Decollato (don Bosco); in verde ipotetico tragitto della
strada.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2856 CATEGORIA: 2
 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 60200
UNITÀ
URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STORIA: Nella carta
vinzoniana del 1757, facendo riferimento alla villa d’angolo degli Spinola ed alla chiesa
allora intitolata a san GiovanniBttista Decollato, appare sovrapponibile ad un rio d’acqua torrenziale
proveniente da Belvedere e separante i terreni dell’ecc.mo Domenico Spinola
(-a mare- la cui casa era la villa oggi al civ. 12 –la scuola- di via CRolando;
rimane la torre), da quelli -a monte, verso il Campasso- dell’ ill.mo
Magistrato degli Incurabili (la cui ampia villa oggi distrutta, costeggiava la strada principale e
nel retro della quale, verso il Polcevera, rimangono dei muri di delimitazione
della proprietà –vedi via CRolando).
Con
la perdita di potere della nobiltà, i terreni furono evidentemente venduti e
coperti da edifici che delimitarono definitivamente in larghezza il percorso;
in lunghezza invece, quando attorno erano prati ed orti, dalla carta su
descritta si legge che il rio si prolungava di più verso ponente scaricandosi
nell’ampio e senza argini, quindi non delimitato, alveo del Polcevera; ma
l’apertura nel 1850 della linea ferroviaria su massicciata e della
strada sottogiacente da subito titolata a Vittorio Emanuele II, oggi via P.Reti, ne delimitarono anche la
lunghezza.
Nel
dic.1900, il regio Commissario straordinario propose alla Giunta
comunale il nome di “via generale Marabotto”
per quella “via, detta Grosso”, a
ponente di via A.Saffi (via C.Rolando).
Il signor Grosso evidentemente era uno –il più in vista e conosciuto- dei
proprietari delle case o più probabile quello che diventò proprietario della
villa che era davanti all’istituto donm Bosco, ed ora scuola statale.
Esiste
una “via degli Storace” a Sestri (famiglia con famoso fisico-matematico del 1700, e con
diversi personaggi pubblici dell’amministrazione; di esi, nessuno ha affinità
col Nostro).
STRUTTURA: Da libera
circolazione, nel periodo postbellico divenne senso unico viario da via
P.Reti a via C.Rolando.
Nel
febb.1999, il senso unico fu invertito e confermato con i lavori di
ristrutturazione della via CRolando del 2005, opportunamente inserendo un
semaforo all’immissione dei veicoli in via P.Reti)
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
CIVICI
2007-
NERI = da 1 a 7 e
da 2 a 6
ROSSI= da 1r a 41r (compreso 15ABr e 25Ar) e da 2r a
24r (compreso 2ABr)
===Da
un secolo, alcune attività commerciali hanno sede bilateralmente nella parte alta
e sul lato a mare della strada: impossibile ricordarli tutti, ciascuno
caratteristico per gli anni in cui rimase aperto. Vedere in via F.Marabotto quando per esempio nella strada si aprì la prima sede
della Farmacia san Gaetano.
Nel
1961 c’erano una 6r=rivendita di burro, 16r=calzolaio, 8r=commestibili,
5r=costruttore edile, 33r=falegname, 27r=fruttivendolo, 14r=latteria,
21r=lavanderia LaLigure, 25Ar=liquori, 35r=macellaio, 29r=meccanico,
12r=merceria, 11r=mobiliere, 4r e 9r=due parrucchieri (Molinari e Posati);
37r=pollivendolo, 41r=profumiere, 18r= trattoria (nel 1950 di Bottero Gaetano e
nel 1961 di Contatore F.). Al civ.nero 3/11 abitava la pittrice Barabino E.
===Il civico 2 canc., subì nel tempo alcune modifiche:
nel 1964 fu dato alla scuola materna, per cui la palestra divenne prima
2B, poi 2A. Ma nel 1965 tutto l’edificio fu demolito e l’anno dopo
ricostruito; così ebbe il 2nero solo la scuola, mentre divennero rossi tutti
gli altri, compresi alcuni box.
==Palestra
==Società ginnastica
comunale Sampierdarenese. Dal 1850 in poi, la trasformazione della città, è
veramente convulsa, da borgo a città in continua espansione ed immigrazione; la
trasformazione non si assesta, e si esprime con un costante bisogno di case;
all’urbanistica penserà il Comune, ma la linfa vitale proviene dai singoli che
promuovono iniziative e che divide in due i ceti: i benestanti pensano ad
erigere il teatro, a creare -e sfruttare- lavoro, ad immortalarsi nel cimitero
ed a migliorare sempre più le proprie finanze; la massa di operai si organizza
e si difende creando delle regole (sindacali, associazionistiche, ludiche, sociali,
mutualistiche) miranti al miglioramento
delle condizioni di vita, e cercando di superare le frequenti miserevoli
condizioni di base della maggior parte dei nuovi arrivati.
Le prime due nate in Liguria -alla pari- risultano essere state,
nel 1863, le “Tiro a segno”, sezione di Chiavari e di Genova. A seguire,
come terza, appare a Genova nel 1864 la soc. di ginnastica Cristoforo Colombo. Sedicesima (ma quarta tra le società di ginnastica)
nel 1891, la società Ginnastica Comunale
Sampierdarenese (sono
invece 17°, di due anni dopo, il Genoa Cricket and FootBall club; e 27°, del
1901, il Circolo Nautico Sampieraderenese)
Già
da quella data, dalle varie associazioni nacquero le prime iniziative culturali
(scuole serali,
biblioteche, conferenze), nonché
sportive ( con lo scopo
di fornire oltre all’educazione fisica anche quella educativa verso la
mutualità, il senso dell’onore, l’incentivo alla lotta nel periodo delle
guerre indipendentiste -come la scherma,
il tiro a segno
(effettuato nella parte alta della villa Scassi: lassù si selezionarono valenti
esperti nel tiro con la carabina , molti dei quali costituirono gruppi di
volontari che divennero leggendari al seguito delle campagne garibaldine), ma soprattutto la ginnastica (che più delle altre trovò fertile
terreno nelle competizioni ad interesse locale, ben presto estese anche a
livello nazionale ed internazionale)).
Sarà il 6 giu.1891, nascerà la
Sampierdarenese, su iniziativa di alcuni giovani (vengono ricordati Bolzoni,
Cambiaso, Castagnotto, Cipollina, Ferrando, Fossati, Leone, Testa, Sacco. Ma
Tuvo cita molti altri, dei quali i primi quattro col titolo di capo squadra:
Ghiglione, Mararcerio, Passalacqua, Quaglia; atleti Aghina, Anselmi,
Arbanelli, Assereto, Bancalari, Bertini, Boni,
DelCanto, Derchi, Marangoni, Masini, Poggi, Roncallo,
Tuo; dirigenti: Bagnasco Ettore, Cornetto Luigi, DeAmicis Enrico,
Storace Dante, Storace Giuseppe; istruttori: Brembale, Genesio, Marchisio), sia già iscritti alla Associazione Operaia di
M.S.Universale, sia provenienti da una fugace Associazione studentesca chiamata
“Gimnasium”.
Da subito, scelti i colori sociali
bianco e celeste, acquisterà autonomia funzionale dalle due associazioni
generatrici, cercando fondi (tramite sovvenzioni, quote e
manifestazioni) ed una sede per gli allenamenti una lunga odissea segue l’evolversi
di questo problema: --all’inizio, gli allenamenti avvenivano all’aperto,
sulla spiaggia e sui prati del Campo
d’Armi o dove ora
inizia corso L.Martinetti; --il primo asilo fu trovato in un magazzino di piazza dei Mille (piazza
A.Ghiglione). --Subito
dopo, risultano trasferiti in via
C.Colombo (via San Pier
d’Arena) in un
magazzino di proprietà del teatro Ristori in corrispondenza dello sbocco di via
Gioberti (Lamponi
segnala che il palcoscenico fu usato per preparare le figure degli esercizi da
eseguire); --poi in un
capannone ex stalla (posto
di fronte al don Bosco, di fianco alle carceri di via A.Saffi (via
C.Rolando). --Poi a
seguire in via Manin (via GDCassini); --ancora in un’altra ex stalla di via della Cella (vicino alla soc. Croce d’Oro: in
questo periodo –1899- assorbì la
società ‘Liguria’ e partecipò come secondo impegno internazionale al concorso
‘Savona-Como’). --Nel 1901 ritorno in piazza dei Mille (fino al 1906
quando -sostituiti da una trattoria che si chiamò ‘del Canto’ (NB la notizia è tratta da Tuvo, ma
penso sia scorretta perché piazza dei
Mille era a s.Martino
del Campasso e non avrebbe avuto logica chiamare una trattoria col nome di un
rione vicino; invece si, quando erano in via della Cella) -- finché traslocarono in via B.Agnese (1907-1917); 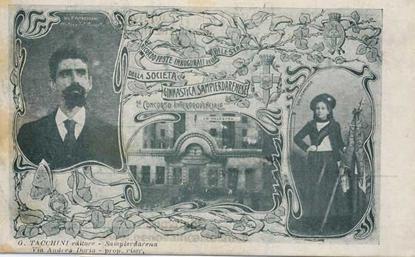

--da qui si ritrovarono per due anni nel chiostro del
palazzo Centurione di piazza Monastero (allora detto “dell’Istruzione”, usufruendo del piazzale
antistante per le esercitazioni, quando il tempo od il clima lo concedevano). Fu solo il 20 sett.1919 che
finalmente (già dal 1910 il Comune si era
interessato al problema sistemazione della società, ufficializzandone il
riconoscimento e promettendo di erigere una sede) dal sindaco
Bettinotti fu inaugurata la palestra
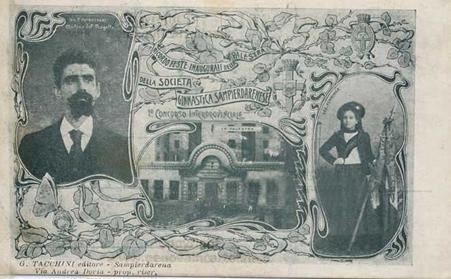
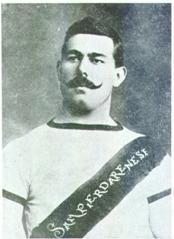
cartolina celebrativa dell’inaugurazione
D.G. Storace
sorta quale sede stabile, a fianco delle scuola A.Cantore,
nella strada allora intitolata al generale Marabotto, e che fu poi intestata al
campione della società caduto in guerra da eroe, Dante Gaetano Storace.

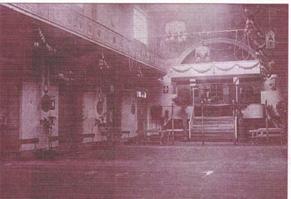
La nuova sede aveva un grande salone alto due piani,
munito di galleria a raggiera per tre lati, un palcoscenico, alcuni retrolocali
per uffici e spogliatoi. All’inaugurazione fu presente il sindaco di Genova e
di San Pier d’Arena, nonché giornalisti delle maggiori testate e personalità.
L’accordo col Comune prevedeva l’uso gratuito, più una somma per le spese,
l’inserimento nel nome societario della dizione “comunale”, la concessione di
tutto il giardino del retro di villa Scassi da adibire a campo per il foot ball
e con l’obbligo di tenerlo decoroso, fino al momento di eventuale richiesta da
parte del Comune, che avvenne per l’apertura di via A.Cantore.
Durante il conflitto, la palestra venne danneggiata e giudicata
inagibile con nuova ricollocazione delle attrezzature --in piazza dei Mille (oggi A.Ghiglione): ma anche questa venne distrutta nel
bombardamento che parimenti distrusse il vicino Oratorio di san Martino, per
cui si dovette attendere lo sgombero delle forze tedesche di occupazione che
avevano riattato e utilizzato la palestra ad uso stalla, e la fine della
guerra. Questo complesso fu abbattuto nel 1964,
quando dovendosi rifare anche le scuole, fu previsto uno sfratto temporaneo dei
250 allievi allora iscritti che dovettero andare ad allenarsi nelle varie altre
palestre cittadine (mentre il materiale ed i trofei, rifugiarli nei più
disparati magazzini, compreso nei fondi del campanile della chiesa di don
Bosco).
La nuova struttura fu consegnata alla società il 4 ott.1968, ridotta di spazio ed utilizzo, dovendo
funzionare anche per le attività scolastiche. Perché non a fianco della scuola,
ma dentro; e –avendo primario interesse le esercitazioni di Educazione Fisica
scolastica- occorre montare e smontare le attrezzature ogni giorno
(materassini, tappeti, travi, parallele, anelli.
Il 5 ott.1977
un incendio distrusse parte delle strutture, che furono riparate.
Nel 1993 pur
onorando il canone convenuto nel 1991, ricevette l’assurdo ordine di sfratto
coatto ed immediato dal Comune, perché inadempiente nel pagare l’affitto
(arretrati e futuri) del canone ‘aggiornato’.
Nel sett2004 si
rinnova l’odissea della sede: palestra condivisa con scuola e quindi non
agibile prima della ore 16 con grave handicap per le 4 istruttrici e 15 atlete
in agonistica (su 100, divise in trenta corsi) che richiederebbero distribuire
meglio la fatica degli allenamenti durante la giornata.
Nel 2009, è una delle 28 società sportive
genovesi centenarie (44
liguri, 611 nazionali).
Le prime
due in Liguria -alla pari- risultano essere state nel 1863, le “Tiro a segno”
sezione di Chiavari e di Genova. A seguire, come terza, appare nel 1864 la
soc. di ginnastica Cristoforo Colombo. Sedicesima (ma quarta tra le società di ginnastica) nel
1891, la società Ginnastica Comunale Sampierdarenese (è invece 17° di due anni dopo, il
Genoa Cricket and FootBall club; e 27°, del 1901, il Circolo Nautico
Sampieraderenese).
Nel 2010 la società si ritrova a dover
condividere la palestra con le scuole: il che significa giornalmente tirare
fuori tappeti, pedane, attrezzature varie; e tutte le sere riporle; e gli spazi
non sono adeguati, specie per i salti mortali, alle necessità imposte dalle
gare.
 2010 la palestra attuale
2010 la palestra attuale
Nel 2011 ritorna lo spettro degli affitti imposti
dal Comune a tutte le società che occupano locali di sua proprietà: l’affitto
appare sproporzionato alle disponibilità della società ridotta a pochi
iscritti.
Presidenti che si
sono succeduti negli anni:
1991=Terrile
Andrea; 1981-3=Cipollina Salvatore; 1984-9=Piaggio Giuseppe; 1900=Roncallo
Alfredo; 1901-2+1905-9+1911-4=DeAmicis Enrico; 1903-4=Bersini Pietro;
1910=Amodeo Luigi; 1915-7=Ravenna Pietro; 1918-sett22=Bagnasco Ettore;
ott-dic1922=Assereto Dario, CornettoLuigi, GhezziPietro; 1923-9=Diana Manlio;
1929-31 =Bianconi Giuseppe e Traverso Salvatore;
1932-41+1950-1+1954-61=Storace Giuseppe; 1042-6+1947-9=Cornetto Luigi;
1947=Storace Antonio; 1962-76=Storace Giorgio; 1977-84=Papi Enrico;
1985-6=Caselli Domenico; 1986- =DeMartini Giovanni. Nel 2010 è
il dr. Cipriani Maurizio
La
storia: Il gruppo iniziale crebbe
lentamente di numero ma velocemente di qualità. I tempi di allora non
concedevano distrazioni popolari alternative efficaci, ed era cultura nazionale
la valorizzazione del concetto fatica ed impegno, premiati con semplici allori
o medaglie. La semplicità della vita e delle esigenze delle classi più povere,
favorirono la dedizione ad attività che richiedevano tali caratteristiche.
L’iniziale continua peregrinazione della sede, si
concluse nel 1919 solo quando i risultati divennero così clamorosi e dominanti,
non solo a livello nazionale ma anche internazionale (con istruttore il prof. Genesio), da non potersi più ignorare
da parte delle autorità comunali
Organizzativamente, dai più svariati esercizi, nacquero
gradatamente per selezione naturale (locale,
nazionale ed internazionale) specializzazioni ancor oggi in vigore;
quando inizialmente invece erano genericamente inclusi nelle gare ed affidati
alle varie capacità dei singoli; così si provarono tutte le possibilità
atletiche: ginnastica (classica ed
artistica, con acrobatica ed equilibrismo, salto in alto e lungo), lotta
(libera e greco romana); sollevamento
pesi; nuoto, pallanuoto e canottaggio; marcia, corsa,
e podismo; calcio; pugilato, tamburello; tiro
alla fune; fanfara e teatro; tiro a volo; bocce;
scherma.
Di
queste, numerose si estinsero da sole per carenza di atleti o di
organizzazione, o si staccarono autonomizzandosi (come il calcio, canotaggio, pallacanestro nel
1950-8, ecc.). Se quei innumerevoli
traslochi non andarono a scapito dei
brillanti risultati individuali e societari, pur sempre furono causa della
perdita di quasi tutti i documenti, obbligando alla trasmissione orale buona
parte della storia iniziale della società (G.Marchisotti).
La cronologia
societaria
I
risultati si videro subito: già un anno dopo l’inizio, nel 1892,
in occasione delle
Colombiane, parteciparono ad un concorso internazionale a
Genova; e
nell’anno 1899 avvenne la presenza al concorso di Savona;
1900: la prima partecipazione alle Olimpiadi: di C.Pavanello (vedi); alla quale seguirono varie manifestazioni nazionali ed internazionali:
dal 1901 al 1930 ci fu
la presenza costante –in media uno all’anno-, ad un concorso nazionale o
internazionale (oltre le Olimpiadi)
La stessa nostra società fu in grado di organizzarne due
gare internazionali, una nel 1902 e
l’altra nel 1925, qui nella nostra città.
1920 alle Olimpiadi di Anversa furono presenti numerosi atleti della società: Romualdo Ghiglione e GB
Tubino vinsero l’oro (allora, un serto di alloro), Pietro Bianchi l’argento (a
loro si doveva intitolare la strada di accesso al complesso sportivo della
Crocera); Bonatti Ferdinando, Roncallo, Cambiaso ). ***
1924 alle
Olimpiadi di Parigi, 3
presenze;
1932 alle Olimpiadi di LosAngeles, 1 presenza;
1936 alle Olimpiadi di Berlino. 1 presenza
1952 alle Olimpiadi di Elsinki, 1 presenza
1956 alle Olimpiadi di Melbourn, 1 presenza.
Nel
1979 la società figurava prima in Liguria,
e quindicesima in Italia (su 240 squadre).
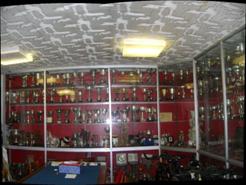


trofei in bacheca





alcuni trofei fuori bacheca
In particolare, L’attività regina ed ancor oggi vitale della società, è la:
--GINNASTICA–--Già nel 1833 lo svizzero Obermann Rodolfo fu
invitato dal governo sabaudo per dimostrare i vantaggi della ginnastica nel
corso per gli artiglieri-pontieri. Fu poi Emilio
Baumann (1843-1917) che riuscì ad inserire l’educazione fisica nel vasto
più concetto sia medico che pedagogico; ed è quindi riconosciuto il fondatore
della ginnastica italiana. Fu nel 1878 che il ministro della pubblica
istruzione Francesco De Sanctis propose una legge specifica n. 4442, approvata
dalle Camere non senza difficoltà, con la quale se ne rese obligatorio
l’insegnamento nelle scuole; dopo una ventata di entusismo iniziale, feroce
reazione e severe critiche rivolte dagli ambienti conservatori e religiosi
soprattutto alla ginnastica femminile che suscitava nei benpensanti di sesso
maschile interpretazioni non puritane ed attenzioni provocatorie. Chiamata
inizialmente “educazione fisica”, poi “artistica”, inizialmente comprendeva
anche acrobatica ed equilibrismo.
-Fino
al primo conflitto mondiale aveva prevalente sfogo in gare locali,
interregionali e saltuariamente nazionali (Colombiane del 1892);
importante ed unica quella internazionale nell’anno 1900 con la partecipazione di C.Pavanello (-vedi- primo ed unico atleta
italiano presente all’estero).
-Facenti
parte della squadra nel 1912, vengono
ricordati Barberis,
Bianchi, Boccardo, Bottaro, Cocco, Gamalero, Malparsi, Morando, Ravenna, Rossi,
Rota, Storca. Istruttore Quaglia Aldo.
-Decimati
dal richiamo alle armi nel 1914, ebbero
molti morti in combattimento (undici soci iscritti morirono nella carneficina, tra cui anche il
campione G.D.Storace –vedi- ed il maestro Quaglia Aldo che aveva preparato la
squadra per varie gare internazionali. Una lapide posta nel 1920, commemora ed
onora i nomi dei caduti) .
-Nel dopoguerra del 1918, fino al secondo conflitto mondiale,
inizia il periodo di gloria. Alle varie Olimpiadi, numerosa fu la
partecipazione: uno solo a Parigi 1900 (Pavanello Camillo. Era allora
presidente DeAmici Enrico e preparatore ginnico il prof. Bombale Domenico); sei atleti ad Anversa 1920 dei quali quattro sul podio
dei vincitori (Bonatti Ferdinando, Ghiglione Romualdo, Roncallo,
Savio Filippo, Tubino GB, Cambiaso Luigi);
-Nelle gare nazionali spesso faceva
la parte del leone, sia per singoli atleti che per squadra: nel 1921 al concorso Internaz. di Lussemburgo, in
quattro vinsero il titolo di Campioni: Bianchi Pietro, Cambiaso Luigi, Gianassi
Alvaro, Bruzzone GB.
-All’Olimpiade di Parigi del 1924
parteciparono Bruzzone
Emilio e Cambiaso Luigi;
-Capuzzo Oreste fu l’atleta presente alle Olimpiadi
di Amsterdam 1928. Lo stesso a quella
di LosAngeles 1932 (medaglia d’oro per la squadra.
Aveva iniziato nel 1923 e nel 1930 faceva parte della squadra nazionale
classificandosi secondo nelle gare nazionali del 1932). -La Federazione arrivò a dichiarare la società essere “squadra ginnica
campione d’Italia“.
-L’inserimento obbligato nel secondo gruppo della
Polisportiva Fascista Sampierdarenese, politicizzando l’ambiente determinò inizialmente
un grave disinteresse generale, calando gli iscritti da 1800 a 50.
Una
lettera pervenuta alla sede da un atleta in difficoltà economiche, dimostra
quanto l’attività fosse proprio a livello dilettantistico (Mecheri Alessandro era stato un
ginnasta che per 18 anni aveva gareggiato da campione con i colori della
Società. Poi sfruttando le doti atletiche, si era dato allo spettacolo
teatrale; ma un incidente ad un piede lo aveva bloccato nel lavoro,
costringendolo a chiedere urgente sussidio agli amici).
-Riottenuta
una certa autonomia, rapidamente ricuperò le forze al punto di essere già nel 1934 la più numerosa compagine presente alle
competizioni romane del regime e Capuzzo potè coronare il sogno di partecipare anche a quella di
Berlino nel 1936 (ove la squadra arrivò quinta; dopo
la grande guerra, Capuzzo continuò a frequentare come istruttore.
-Nel 1938 compare il
nome di Mario Maestri, quale campione italiano junores
-Dopo il conflitto
mondiale, la sezione ginnastica definita ‘artistica’ tornò a primeggiare in
tutte le gare regionali
e rimanendo in altissima classifica nelle nazionali, e con presenza alle
Olimpiadi di Helsinki e Melbourne, tanto che nel 1967
era 11ª a livello nazionale, prima in Liguria, con due donne (Scarsi Renza campionessa italiana e
Volpi Clelia campionessa ligure e bronzo nazionale);
-Nel
1969 fu riconosciuta dal CONI meritevole
della “ stella d’oro al merito sportivo”; la motivazione recita: «un alto e meritato riconoscimento
al Solidalizio che per lunghi anni ha servito ed onorato lo sport nel nostro
paese. L’opera svolta in campo organizzativo, morale, educativo e
propagandistico è stata indubbiamente determinante per lo sviluppo della
attività sportive alle quali la Società ha dato fecondo apporto».
-Nel
1977 si classificò seconda in Liguria e
21ª (su 305 società) in Italia.
Nell’anno
1993 vinse con le proprie ginnaste
diversi titoli regionali e si classificò seconda nel campionato regionale di
serie C.
-Ancora
nel 1998 si classificò terza al
campionato di serie B e partecipò al campionato di serie C con una squadra
maschile e femminile.
-Nell’anno
1999 la società decise dedicarsi solo al
settore femminile qualificandosi per due anni consecutivi per la finale; nel 2001 si classificò terza al camp. regionale
(vincendo la prova della trave) e qualificandosi per l’interregionale.
-Nel
2002 risultò 4ª nel campionato di
serie B, e 3ª in quello di serie C; all’interregionale di serie C avvalendosi
di un ottimo 8° posto, si qualifica ai campionati italiani.
Questo settore, ancor oggi attivo, ha visto sempre più ridursi il numero dei
partecipanti, non essendo di moda né facendo parte del concetto giovanile di
quest’epoca il doversi sacrificare molto per poco riconosciuta gloria e
guadagno. Nell’ottica di sempre avviare i giovani allo sport –anche non
competitivo agonistico- si iscrivono ragazzi che desiderano oltre ad una vita
sana in comunità, anche una vita attiva motoriamente, sono previsti corsi per
bambini (4-5 anni), per ragazzi (6-18 anni), sino a dopo dove si può accedere
ai veri corsi di ginnastica artistica utilizzando i vari attrezzi (trave,
cavallo, sbarra, anelli, tappeto per i salti, ecc).
-Ma
ancora nel genn.2004 si legge la
vittoria nella prima prova del campionato di artistica femminile sia di serie B
(parallele
asimmetriche, volteggio, trave, corpo libero; con Sara DiPerna, Simona Risso,
Michela Belgrano, Alice Romani; davanti alla squadra della s.Michele,
proChiavari e Canaletto); sia di serie C
con la prima squadra (Giulia
Pioggia, Corinne Boschi, Martina Oliva) e
quarte con la seconda squadra. Nel 2008
ha presidente il medico Maurizio Cipriani.
Nel 2009, è una delle 28 società sportive genovesi centenarie (44
liguri, 611 nazionali).
ATTIVITA’ ESTINTE
----ATLETICA LEGGERA: visse tra gli anni 1903 e 1933; con
atleti in competizioni di impegno solamente locali . Comprendeva oltre la
corsa, salto, maratona, il getto del peso (“getto della palla di ferro”) e nei
primi anni il sollevamento della pietra.
--CICLISMO: i primi passi del ciclismo, vengono tratteggiati
parlando della Ciclistica di via W.Fillak . In seno alla
Sampierdarenese la sezione nacque negli anni a cavallo tra il 1800-1900. Non
ebbe atleti di spicco dovendo competere con avversari locali di maggiore
calibro, della Raffaele Rubattino prima, della Nicolò Barabino e della
Ciclistica poi.
Nel 1931 si sciolse trasferendo
tutti gli iscritti ed i trofei alla soc. Ciclistica.
--ESCURSIONISMO: nacque subito
dopo la prima guerra mondiale, la voglia di misurarsi nella marcia, aprendo una
sezione PODISMO, che concluse le sue attività in epoca prebellica del 1940
.
Ritornò vitale dal 21 lug,1945 ma limitata all’
escursionismo, effettuando economiche gite a piedi sui monti e località interne
con promozioni allettanti e campeggio. Nel 1947 i soci convennero più
opportuno confluire nel CAI locale.
--FANFARA: nata prima del 1903, nel 1920 vinse un
concorso nazionale Si estinse con l’inizio della seconda guerra mondiale.
--FILODRAMMATICA: Nata nel 1921, aiutava la società madre
nella raccolta di soldi, vitali per la partecipazione ed organizzazione delle
gare. Terminò di vivere con l’evento bellico del 1940.
--PALLACANESTRO: nata nel
lug.1950 come sezione autonoma, giocò le sue partite utilizzando quando
possibile i campi da bocce; partecipò al campionato nazionale maschile di
serie C nel 1956-7 dopo aver vinto il campionato di promozione.
-PALLAVOLO: fiorente attività
capace di vincere i campionati nell’anno 72-3 sia maschile che femminile.
--PUGILATO (BOXE) affiancata alla lotta, ebbero vita
fiorente sino al 1923.La sezione fu fondata dal pioniere del settore Cereseto
Ettore. Il ring era nel chiostro del Monastero e la Società organizzava
mensilmente incontri con boxeur di tutta Italia, prevalentemente a livello
dilettanti (vengono ricordati Baiguera Innocente
campione italiano pesi massimi del 1936 battendo il campione d’Europa per KO al
primo round; Borzone; Ponte; Ulivieri; Tripoli; Galliano; Visani Alfredo;
Coccia; Lotti; Peloni; Colombo; alcuni in odore olimpionico. Forse professionista
lo divenne solo il forte Baiguera).
Non sappiamo quando, ma divenne società sportiva autonoma.
Isolate partecipazioni a serate di incontri, avvennero sino alla fine del 1940.
Ripresa l’attività dopo la grande guerra, ancora nei primi anni 1970 si registravano
lusinghieri successi sopra tutti dell’azzurro Provenzano Angelo.
Personalmente ricordo che negli anni 50 la sede si apriva
nel palazzo d’angolo del vicoletto che da via Storace portava alla palestra.
--SCHERMA: nata il 18 sett.1945, ebbe un iniziale gran
successo , con vittorie in gare regionali ed interregionali. Dopo tre soli anni
però, riducendosi gravemente il numero degli iscritti, obbligarono il
presidente Martini e sciogliere la sezione.
--SOLLEVAMENTO PESI alla sua nascita fu una delle attività
più attive e produttive; ebbe una folta schiera di seguaci, divenuti tra i più
forti d’Italia, capaci di vincere per sette volte il titolo nazionale a
squadre; nonché innumerevoli trofei.
Come dirigenti vengono ricordati Pietro Bianchi (per trent’anni e più. Ebbe l’argento alle Olimpiadi
di Anversa del 1920 nella categoria ‘medi’) ed il cav. Renato Fossati (successore per altri decenni), sotto la cui direzione, tra il 1951-8, la società
vinse per 5 volte il titolo nazionale a squadre.
Tra tutti, primeggiò il titolare Dante Gaetano Storace -vedi- che fu campione locale dal 1905 ed
assoluto italiano per vari anni nei pesi massimi (Tuvo
a pag 289. scrive tre, dal 1908 al 1910; ed a pag. 298 scrive sette, dal 1905
all’11)).
Tuvo ricorda Bianchi,
Bugoni, Canti, Clavarino, Conrado, Derchi, DiGenova, Durante, Fornaciari,
Gabetti, Iurillo, Lenti, Meriggi, Seggi, Vassallo
La sezione era ancor viva, con alcuni atleti, negli anni
90.
--TAMBURELLO: Innanzi tutto, va ricordato che il ‘gioco
del pallone’ effettuato dal cinquecento (vedi in
via Larga), è da considerarsi il padre di questo sport. Sicuramente
anzi, il tamburello è una evoluzione di esso, avvenuta tra metà e fine 1800,
quando il gioco della “palla al tamburello” era lo sport più seguito dai
cittadini, contendendosi l’interesse con gli altri emergenti (su tutti,
ginnastica, calcio e ciclismo).
Il tamburino era fatto con pelle di cavallo tesa tra i due
cerchi (i migliori erano della ditta genovese Trucco&Boni); la palla, dal
cuoio passò alla gomma dura la quale segnò un miglioramento dei rimbalzi e
quindi della qualità del gioco; il gioco vedeva possibile colpire e rimandare
–prima al di là di una riga per terra, poi di un cordino, infine di una
reticella- la palla dopo un primo rimbalzo o direttamente al volo.
Le società di San Pier d’Arena, Sampierdarenese e
N.Barabino -nell’anno 1897 parteciparono a Treviso ad un incontro
polisocietario (vinto dall’Udinese),
risultando subito tra le migliori in campo nazionale.
Possiamo quindi concordare nell’affermare che agli esordi
del secolo scorso, questo sport parlava soprattutto sampierdarenese.

L’anno dopo, 1898, la seconda società andò a vincere a
Torino il primo campionato nazionale assoluto; per ripetersi l’anno dopo ed
ancora nel 1904. Solo nel 1905 nacque la Federazione Italiana Tamburello con i
primi ‘scudetti nazionali’ nei quali iniziò a primeggiare invece la
Sampierdarenese vincitrice negli anni 1908 e 1909.
Questa sezione, distaccatasi per divenire autonoma nel
1924, raccolse atleti che avevano già vinto campionati nazionali anche nel 1911
e 1920 . Nel 1925 si unì alla compagine di Cornigliano, di Sestri e la soc.
C.Colombo, per formare la Associazione Ligure Tamburello & affini, andando
a giocare nella zona ancora libera della ‘piazza d’Armi’. Nel dic.1927, Manlio
Diana ordinò l’immediata cessazione della società, per assorbimento
dell’attività nella Polisportiva fascista. Ripresa l’autonomia funzionale dopo
il conflitto del ‘45, sopravvisse sino al 1954 cessando l’attività per
carenza di appassionati e di stadio.
Lo sport del tamburello,
negli anni 2000 è ancora vivo negli sferisteri del Basso Piemonte circa 80m
x20): il paese di Castelferro (frazione di Predosa in Ovada) sono i
pluricampioni d’Italia (11 scudetti; 2 coppe Europa; 5 Supercoppe) dello sport
vissuto ancora con gare nazionali (con serie A, A1, A2, B e C) ed
internazionali. Singolarmente, gli atleti più famosi furono: per primo un
17enne varazzino, Bagnasco Attilio,emerso nel 1898 a Torino, rimase campione fino
al 1907. Dall’anno dopo iniziò la
‘carriera’ di campionissimo, Lorenzo Bruzzone nativo di Campoligure e laureato
in chimica, valutato un mito quale giocatore invincibile e battitore
impareggiabile.
--TIRO ALLA FUNE: scarse le notizie su questa attività.
Nel 1910 la squadra della Sampierdarenese composta da DelPonte, Avio e
DanteGStorace più due di cui non viene riportato il cognome, vinse il
campionato italiano.
--TIRO A VOLO: la sezione nata nel periodo post bellico,
vide vittorioso in una gara preolimpionica del 1947 il concittadino Polo
ATTIVITA’
POI DIVENUTE AUTONOME:
--BOCCE sezione nata nel 1946
raggiungendo ben presto gli oltre 100 soci, ebbe i campi vicino alla palestra
arricchiti da bar, locali per segreteria. Nel 1964
la struttura venne tutta distrutta a favore del nuovo edificio scolastico e
delle appendici annesse, che però non previdero la riapertura dei campi ed
obbligando il trasferimento dapprima presso il Dopolavoro Ferroviario di via
E.Degola e -dopo il 1970- in gestione
autonoma, ma con l’antico nome- nel retro della villa Scassi in via A.Cantore.
Dal
1948, le innumerevoli vittorie arricchirono il
palmares del titolo nazionale; due volte in ciascuna delle tre principali
categorie: nel 1958 e ‘60 in categoria C ; ‘73 e ‘74 in cat. A ; ‘80 e
‘82 in cat.B.
--CALCIO. Già nel 1899
(qualcuno scrive1897) si era strutturata una sezione foot ball, con uno
statuto proprio, fondato da un gruppo di
soci studenti.
Già nel 1896 a Treviso era stato messo in palio un titolo
nazionale di football, ancora limitato alle società di ginnastica, vinto dalla
soc. Udinese. Nel 1898 (15 marzo) si costituì
una ‘Federazione italiana’ a Torino: essa organizzò l’8 maggio il primo
campionato nazionale che fu vino dal Genoa.
Nel marzo 1903, sulla
spianata del Bisagno, la squadra partecipò alle gare di foot ball per una coppa
a carattere interregionale: nella finale per il 3° o 4° posto, fu esclusa
perché -posta di fronte alla seconda delle due squadre dell’A.Doria (vincitrice poi –la prima squadra-
nella finale sulla Mediolanum)-, al punteggio perdente di 6 a 2 un giocatore fece un gestaccio al
pubblico e la partita fu sospesa.
Usufruivano
anche della piazza d’Armi per gli incontri, spesso con l’incerto che se non
riuscivano ad arrivare in tempo -rispetto altri atleti di altre discipline-
trovavano occupati gli spazi ove giocare.


contro la A.Doria nel 1903 (disegno) la
squadra all’inaugurazione del campo. Primo
a
sinistra, Marchisotti
Il
settore inizialmente originato dalla sezione ginnastica e con presidente
DeAmicis (giocatori
Luigi Cornetto, Lenuzza, Riccardi, Scatti, Berlingeri, Pastorino, Calvi,
Lancerotto, Siegris), nel dic.1911 si iscrisse alla FIGC ed adottò la maglietta
bianca con la tipica –per l’associazione di ginnastica- fascia pettorale nera
trasversale; giocò prima in terza categoria, poi in seconda e nel 1915 in prima categoria sul campo della Rivarolese
(chiamato dapprima
Sauli dalla famiglia sul cui terreno era sorto; poi Cereseto Oreste dal
dirigente fondatore della squadra locale, infine Torbella dal torrente
vicino). Vengono ricordati: attaccanti Migone Carlo, Garrone mario, Mazzella
Pietro e Gatti; mediani Melandri Ermenegildo, Boldrini Renato, Carzino Ercole;
terzini Riparelli Giuseppe, Bellini Delfo; portiere Canepa Enrico; presidente
DeAmici.
La
banda, divenne rosso nera solo nel 1919
a seguito dell’assorbimento della prima “pro Liguria” (Questa polisportiva sampierdarenese
(calcio, nuoto, pallanuoto) era nata -per iniziativa di alcuni giovani- nel
1910 circa; aveva sede in una ‘casetta’ sugli scogli dietro il municipio e come
le altre giocava in piazza d’Armi. Nel 1914 però era già una squadra emergente,
partecipando ad un girone ligure-piemontese, finendo ultima. L’inizio della
guerra non fece finire il campionato seguente formato da squadre dell’Italia
del nord, assegnato al Genoa e dove la nostra era ultima. Nel 1919, la società
non riuscì a riprendere gli impegni, e –presidente Mainetti- dovette soccombere
nella Sampierdarenese, concedendo però a quest’ultima di entrare nella Prima
categoria. La fascia nera venne dimezzata per fare posto all’affiacata banda
rossa). Con questa fusione, ottennero
di entrare nel campionato di prima categoria, e sia di avere un campo proprio
-vicino al palazzo Spinola, affidato alle suore cappellone, e perciò detto
“delle monache”. Nel 1920, in attesa di
applicare quanto già il piano regolatore prevedeva a proposito di una nuova via
centrale (via
A.Cantore), il Comune concesse un campo
nel retro di villa Scassi (detto “la scatola delle pillole” perché piccolo).
Presidente era divenuto Ravenna che firmò l’autonomia dalla società
madre.


la squadra nel campo Villa Scassi stemma
fascista della federazione Sportiva
Nel 1921 tre giocatori (Boldrini Renato, Ramasso
Sebastiano, Carzino Ettore) sono in
Nazionale (Italia
Svizzera 1-1); nel 1924 vittoria sul Genoa campione d’Italia.
Nel campionato diviso in gironi, inizia in quello B nel 1926-7, quando istituita la “grande Genova”; in data marzo 1927 si legge una
lettera del presidente Alfredo Nasturzo, mirata a raccogliere fondi per creare
un nuovo campo, la “Sezione Autonoma Giuoco Calcio / della Società Ginnastica
Comunale Sampierdarenese / affiliata alla FIGC / con segreteria in via
G.Mameli, 11r e campo : Villa Scassi. In essa si accenna che ‘la prima squadra
, passando di vittoria in vittoria si appresta , con salda fede a sormontare
gli ultimi ostacoli per arrivare a conquistare il diritto all’ingresso nel
torneo finale, ambito appannaggio delle sei migliori squadre Nazionali’.
Dal governo fascista fu imposto (anche a Roma si diede una spinta alla fusione, per far
posto alla Roma) la fusione con
l’”Andrea Doria” per divenire la “Assoc. Calcio ‘la Dominante’” (divisa nera, con stemma di un
grifone affiancato dal fascio; ma con un destino inverso al nome. Per le
ripetute sconfitte subite, nel campionato 1927-8
fa ancora parte del girone B ove arriva penultima e non ha diritto ad entrare
nella serie A del primo campionato nazionale). Nel genn. 1929 ne era presidente
Manlio Diana
Si smise giocare a villa Scassi e furono trasferiti a Cornigliano allo ‘stadio
del Littorio’.
Furono così imposte ulteriori fusioni
coatte (con la
Corniglianese; la Sestrese: la divisa nera assunse i bordi verdi; e la
Rivarolese) riusando per la seconda
volta il nome di “Liguria” FBC (“Associazione Calcio Liguria”), con maglia a banda rosso-nera e bordi verdi;
ciononostante nel campionato 1931 la
squadra più volte non riuscì ad avere il numero di giocatori sufficiente a
disputare una partita perdendo a tavolino (la scusante fu non avere i mezzi per
pagare gli ospiti): non si evitò la retrocessione in serie C.
“Separando e strasse” dopo fusioni e nomi nuovi, il segretario locale del fascio Benvenuti, riconvocò Cornetto, accettando i vecchi dirigenti già
esautorati (Lenuzza,
Buttignol, Riccardi e Barenghi presidente), e che si tornasse a chiamarla Sampierdarenese.
1933-4 nel nuovo campionato, iniziò a risalire la china tornando in B (una
lettera datata marzo 1934, firmata dal presidente on.Com.te M.Barenghi, intestata «Associazione
Calcio Sampiedarenese / Genova – Sampierdarena – (in timbro:) “Sede Casa
Littoria / Campo di giuoco: Stadio municipale del Littorio / Genova
Cornigliano / Coni-Figc-Fidal» = segnala che la squadra sta
disputando il Campionhato Italiano Divisione Nazionale B, con diritto a
disputare la finale “per consentire la tanto agognata promozione fra le
elette...”; chiede soldi... 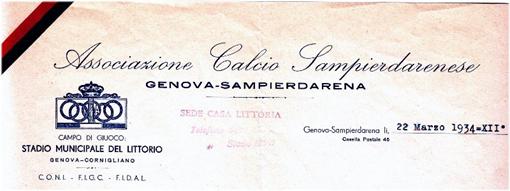
E poi in A (dopo che, avendo vinto prima il girone d’Italia del nord, sul
neutro del ‘Comunale’di Bologna a giugno vinse 1 a 0 –indossando una
provvisoria maglia verde che era la seconda del Bologna- anche la disfida col
Bari vincitore del gruppo SudItalia e che aveva una maglia similare alla
nostra (ricordati
Felsner allenatore magiaro; Ciancamerla Edgardo, Poggi Gino detto Gipo, Bossi,
Lancioni, Rigotti, Gay, Nervi, Bodrato, Gallina (altri scrive Galli), Munerati,
Barisone, Fossati; e infine, imprestati dal Genoa -che retrocede in B- Comini
(che veniva incitato al grido di “hoppo, hoppe”) ed il portiere Bacigalupo
Manlio). Apoteosi della squadra in
piazza VVeneto.
1934-5 va via Felsner
(per Bologna, dove
vincerà due scudetti) arrivano Busini e
venturini; si piazzerà tredicesima.
1935-6, presidente
Tito Nasturzio, arriverà dodicesima. A fine campionato verrà ceduto Comini alla Fiorentina mentre Venturini sarà chiamato per la squadra
olimpica a Berlino.
1936-7 presidente
Barenghi, salvezza in A per un solo punto, a scapito del Novara.
1937-8- Cambia di nuovo presidente in Moio (ex maresciallo dei Carabinieri, in
qualità di dirigente capo del personale dell’Ansaldo: fa finanziare la squadra
dalla società; fa allontanare Cornetto &C, vende al Milan Gipo Poggi e pretende la rinomina con rinomina
–terza volta- di A.C. “Liguria”; finì all’11 posto.
1939-40 Ricambiato
presidente e sponsor (l’AGIP) di nuovo retrocessione in B. Nuova riassunzione
di Cornetto che – 1940-1- con Balonceri,
fa tornare la squadra in A (la partita con LaSpezia avvenne nel giorno del bombardamento navale
del 9.2.1941).
Durante il
campionato 1941-2 in A, probabile nuova
retrocessione in B ma non fu concluso per questioni belliche. E tutto rimarrà
sospeso per tre anni.
Alla ripresa post bellica, nell’apr.1945-6 la
Sampierdarenese calcio si ritrovò che
nell’ultimo campionato svolto regolarmente, era in A -seppur ultima-. Diviso il
campionato in due settori, la Sampierdarenese (tornata tale dal Liguria) rimase d’ufficio in serie A-Alta Italia finendo di
nuovo ultima mentre l’ADoria terzultima; ma senza retrocessione, perché quel
campionato fu definito ‘di transizione’ e venne deciso che il vero Campionato
di serie A, girone unico, iniziasse con 20 squadre scelte tra quelle con
maggiore tradizione nel 1946-7 (questo costò all’ADoria finire in B
perché la Sampierdarenese risultò più titolata).
La
società quindi era stata scelta per la serie A assieme al Genoa; ma era in
condizioni economiche disastrose e nell’impossibilità di affrontare un
campionato con trasferte in Italia ed acquisto di calciatori adeguati. Grosso
problema, non trovando il mecenate che apportasse i dovuti mezzi finanziari. Un
gruppo, guidato dagli inossidabili Cornetto e Buttignol, preferì riperdere l’
autonomia rifondendosi -tra fischi ed insulti, il 12 ago.1946- con la più
florida Andrea Doria di Aldo Parodi che era destinata alla serie B e che
portava 17 milioni di capitale, dando vita nello studio dell’avv. Bruzzone alla
Unione Calcio Sampierdarenese-Doria “Sampdoria”, con maglia azzurra,
fascia bianca contenente le strisce rossonere, lo stemma di Genova sul petto e
primo presidente Piero Sanguineti.
I ribelli si riunirono, e diedero vita alla Sampierdarenese/46
descritta in via GB Millelire 4 avendo oggi sede nel campo del Morgavi.
Nel campionato 2005-6 dalla Promozione sono stati promossi
in Eccellenza essendo arrivati secondi nel campionato e vinto il play-off; e
l’attaccante Carbone capocannoniere . I Lupi sono diretti da Gino Grasso e
Gianni Siri.
Le ragazze cresciute all’ombra dei maschietti, furono
però promosse al campionato interregionale nel 1973. Divenute Sampierdarenese-Serra Riccò, sono la punta di diamente del
calcio femminile regionale (inserito nella FIGC che a Genova iscrive 8 squadre femminili) giocando in A2 dopo esserne state
promosse nella stagione 04-05 ed aver mantenuto la serie con un sesto posto
(05-06) ed un terzo (06-07, con coppa disciplina). La società nel 2008 ha
presidente EugenioBuscaglia e 150 soci
--CANOTTAGGIO: sezione
nata il 27 sett.1920, con una sessantina di
soci, sede presso i bagni Italia di via C.Colombo, e regolare iscrizione
al regio Rowing Club.
La prima grossa difficoltà fu “armarsi” di imbarcazioni
idonee alle gare: gli stessi atleti l’anno dopo dovettero comperarsene una,
facendo un prestito, e battezzandola col nome della nostra città. Ma il gruppo
si estinse il 23 lug.1926 lasciando poche tracce
della sua breve esistenza. Soci e materiale confluirono nel Club Nautico
Sampierdarenese mentre però i lavori portuali resero necessario
assecondarne supinamente gli spazi compreso l’area dell’Idroscalo.
Essi, col nome ‘Canottieri
Sampierdarenesi’, in sigla CAS, furono coinvolti come tutti, prima dalle
leggi fasciste che cercarono di cambiare solo la maglia (azzurra per tutti)
sulla quale loro applicarono le strisce orizzontali rosso-nera; e dopo dal
conflitto mondiale. Ma la
ristrutturazione del porto nel dopoguerra obbligò al trasloco nel 1962 in Sestri con sede in via Cibrario 3, bacino
d’acqua prospicente l’aeroporto. Dal CONI è stata insignita del merito di
“stelle d’oro e d’argento a merito sportivo. La Società, negli anni 2000 svolge
atletica nel campo del canotaggio, canoa e diporto
Negli anni 50 l’otto (con istruttore e timoniere Aldo
Roncagliolo), si qualifica per le olimpiadi; nel 1956
e 1960 GCarlo Casalini ne prende parte a
Melbourne ed a Roma. Negli anni 60 si evidenzia il due-senza juniores con la
conquista del tricolore; ed altrettanto nel 67 e
70 per i canoisti. Negli anni 70 molti atleti
vestono la maglia azzurra: vengono citati
Pezzini, Rossi, Armezzani, Pidatella, Saracino, Firpo, Conti, Buffa, Gabbia,
Maspero. La Società vedeva ancora negli
anni 70 varie difficoltà (articolo di Spadaro): «il reclutamento; apparendo difficile ”chiedere ai giovani di
sottoporsi ad una disciplina sportiva che richiede grandi sacrifici”; gli
allenatori ovvero mancanza di preparatori all’altezza della situazione; nessuno
sponsor che contribuisca ad aiutare questo sport (anche –come in Russia- ove l’industria da tempo
libero a chi pratica allenamenti);
disinteresse delle autorità; giornali che non dedicano spazio. Però si
riconosceva che in Liguria l’unica società che ha dato “un grande contributo di
vittorie, è la S.C.Sampierdarenese” con presidente il comm. Salvaneschi che
rimarcava la più alta riprovazione per il sovrano disinteresse, anche di chi
per preciso compito dovrebbe sostenere le società. (e sarebbero il Comitato di
zona che dovrebbe organizzare gare locali ed il Provveditorato scolastico). Nel
sett/74 Roncagliolo segnala due ori, un argento
e tre bronzi nell’incotro Francia (del sud)-Liguria. E pochi giorni dopo
Campioni D’Italia nel 4-con/categ.veterani (=Vespa, Casalini, Fornaciari, Scotto,
Roncagliolo); e nella categ. Skiff-baby (<11anni =Scotto jr).
Nel 1998 (ottobre) le sorelle Trenta, Angela e Paola
allenate dal padre Pino (vecchia gloria
del club) conquistano l’argento ai
campionati italiani nel doppio senior.
Per la sopravvivenza,
conforta che nell’anno 2002 ha fornito, più di
tutte le altre società liguri, quattro giovani alla Nazionale canottieri. Dal 2003 è subentrato alla guida del settore giovanile
Simone Bruckner (cresciuto nello
stesso nostro club a livello agonistico, dovettepassare a club di maggiore
spessore come il Rowing per continuare e raggiungere zona medaglie, sino al
1998; da allora tecnico) con paralleli
risultati a livello nazionale; dal Coni provinciale nel genn.2004 ha avuto premiati con ‘stelle al merito sportivo’
campioni italiani in varie specialità relativi agli anni 1998-01: Bo Nicolò
(bronzo, 1999 e 2000), Boninelli Andrea (bronzo,
2000), Gobbi Andrea (bronzo, 2000), Scionico Davide (bronzo,
2000), Verardo Fabio (bronzo,
2000). Poi sarà DiVietro Flavio a raccogliere
una medaglia al mondiale del due-con juniores. Nel 2006
tocca a Kevin Missarelli essere azzurro ai mondiali di Amsterdamn (nono posto
finale); a Silvia Vignolo essere campionessa italiana juniores; e bronzo al
quattro di coppia seniores al titolo italiano.
Nel 2008 la soc. fa parte della Struttura Federale FIC
dove è scritto essere S.C.Sampierdarenesi; vede
presidente Giuseppe Spatola, con nutrito gruppo di tecnici e di validi
atleti che mirano molto in alto avendo vinto molte gare nazionali di selezione
--LOTTA GRECO ROMANA:
attiva dai primi anni del 1900, acquisì fama per merito di un “foresto”
savonese, Mario Cocco, arrivato in città per lavoro: iniziò una scuola che
sfornò campioni, perla quale dal 1913 al 1928, si ebbe una delle sezioni più
forti in campo nazionale. Vengono ricordati anni 1911-12: Azzarita; Bovone Italo (campione
italiano medi); Lanzone; Montano Tesio; Morando detto Belzebù; Ponzini Tito
Vezio; Torre; Divenne autonoma; non
sappiamo quando.
--PALLANUOTO e NUOTO
sicuramente una delle prime attività della società; assieme alla pallanuoto (Tuvo mescola i due sport in una
miscellanea unica; mentre il nuoto ha la storia parallela alla vita col mare,
lo sport della pallanuoto nacque inInghilterra nella seconda metà del 1800; nel
1877 vennero scritti i primi regolamenti e la disciplina venne ammessa ai
giochi olimpici del 1900 col nome di water-polo). Però, mancando le piscine, all’inizio le gare erano solo marine, da
boa a boa, con sede direttiva presso i bagni Colombo gestiti da un socio
dirigente ed appassionato atleta. Nel 1919
la sezione si fuse -come il calcio (vedi)- con la società “Pro Liguria” (che era nata nel 1910 ed era una
delle più forti d’Italia. Aveva tra gli iscritti (quelli sottolineati,
giocavano anche nella pallanuoto) Pippo Rolla –divenuto poi organizzatore-; Azzariti, Baiardo Davide,
Brugnera, Costa Malito, Frassinetti Silvio ed Agostino, Guaraglia, Lungavia
Umberto, Sachner (detto il siluro), Sommariva Adriano), acquisendo un forte gruppo di atleti che assieme
agli atleti presenti e partecipi a questa fusione: Bertoli, Bertorello, Boero,
Brusati, Devoto, Frassinetti Settimio (fratello dei due sopra), Maretti, Patrone, Rasia dal Polo, Rollo,
Storace, Secondo, Valle, Veschi, Zignone, permisero
essere iscritti nella Prima Divisione Ligure (la più alta)
e dominare in Italia.
Da
ricordare anche
Quintarelli, Sommariva Elio, Bianconi, Cocchetto, Avvanente, Bagnasco,
Bisagno.
--La squadra fu campione d’Italia nel 1922 e nel 1927
--Singolarmente vincitori: Baiardo, veniva da Voltri,
fu quattro volte olimpico
Frassinetti Agostino, fu tre volte olimpico (A JonvilleLePont=1919,
Anversa=1920, Parigi=1924), e campione italiano nel 1921 e 22. Campioni anche i
fratelli Silvio e Settimio
Marchisotti Giuseppe, detto Pinin, fu argento italiano nel 1919
Sommariva Adriano era un fondista
Sommariva Silvio 1929 campione d’Italia dorso e 1930 staffetta.
Lungavia Umberto olimpionico
nel 1920, uno dei migliori d’Italia; ricordato da Tuvo come quello che
introdusse ‘la rovesciata’ Ad Anversa partecipò alla gara in
mare rischiando l’assideramento: metà iscritti si ritirarono
Bacigalupo Luigi fu definito “il Coppi del nuoto”. Iniziò la carriera
nel 1913 a quattordici anni vincendo una gara di fondo internazionale; fu la
prima di cinquencento vittorie.
Gamba Giacomo ; iniziò tredicenne e venne nella squadra nel 1929 esoerdendo
in nazionale


1919
1921


1924
allievi
Dai
più alti livelli nazionali, breve il passaggio a partecipare
alle Olimpiadi nel 1920 e 24 (Dalla nascita ad oggi, gli
olimpionici della società sono stati sedici, di cui nove presenti assieme ad
una olimpiade; primato mai raggiunto da nessun’altra società nazionale.
Poi
arrivarono altri atleti tra cui indimenticabili Angrisani, Baldini, Bianconi –(vincitore delle ‘traversate di
Roma’), Bisagno,
Bonadeo, fratelli Caorsi, Cocchetto, Ghibellini senior, Giannitrapani, Manzini,
Marchisotti, Piano, Paraboschi, Quintarelli –detto bacchaê-, Sommariva Amleto,
Sommariva Elio -azzurro
d’Italia, il più forte della famiglia-,. Dirigenti erano diventati Scasso, Riccò, Maretti,
RasiaDalPolo.
Il
10 lug.1922 -campioni d’Italia-, si riconobbe l’opportunità di separarsi dalla società madre, e
mantenere una attività autonoma. Nel 1924
avvenne –nel bacino del porticciolo- una grande manifestazione natatoria
preolimpionica, e Frassinetti fissò un record di 1’04” sui 100m..
Nel
periodo fascista, fu cambiato il nome in “32.a Legione m.v.s.n.” che nel
1926 giocò la ‘coppa Littorio’ vincendo la
finale contro la Libertas-Sestri in una accesissima partita che subì anche la
sospensione a 5’ dalla fine per scorrettezze.
Nel
1946 riprese il vecchio nome, partecipando
anche ad incontri nazionali.
Leggiamo
nel 1952 che la FIN decise far giocare a
girone unico le eliminatorie del campionato pallanuoto di serie B: la squadra
arrivò seconda a pari punti col Nervi, dietro al Recco. Poiché l’anno dopo la
ritroviamo in serie B si deduce che nel 52 non aveva vinto.
L’anno
1953 si concluse al secondo posto a pari
punti con il Genoa, dietro all’Olona. L’anno successivo, 1954 –mentre l’Olona è ancora in B- non vi
compaiono né il Genoa né la Sampierdarenese (e questo ancora nel 1955,56 e 57); lascia presupporre siano ambedue passate, dal
campionato cadetto, a quello di A o, come per la Libertas di Sestri, per
chiusura degli spazi balneari, non solo trasferimento a ponente o declino
peggiore.
Ad imperitura memoria e testimonianza ai giovani, degli
atleti olimpionici Tubino GB e Capuzzo Oreste, la società ha avuto in dono dai
familiari e mette in mostra in una bacheca chiamata ‘stella d’oro’, tutti gli
allori da loro conquistati.
DEDICATA all’atleta
sampierdarenese, qui nato nel 1889 e cresciuto frequentando la società
Universale ove alla scuola di Rota ed Armirotti, assimilò le teorie mazziniane
e repubblicane di cui divenne fedele assertore.
Lavorò in collaborazione di Pietro Chiesa, occupando la carica di “console”
nell’organizzazione sindacale regionale di allora, e quale rappresentante degli
operai di San Pier d’Arena.
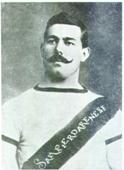
Come attività collaterale, si era iscritto nella Sampierdarenese, sezione
sollevamento pesi, divenendo a 19 anni già campione societario, e negli anni
1908, 9,10 campione d’Italia.
Arruolatosi volontario nell’esercito, col grado di sergente di fanteria (89°
reggimento) nella notte tra il 23 e 24 ottobre 1915 cadde eroicamente
combattendo la terza (di dodici) battaglia dell’Isonzo, sul Mrzli Vrh – su alcune carte italiane riportato
Merzli, o Smerli; un monte del bastione monte Nero sulla sinistra dell’Isonzo. Il nome, in
slavo, significa ‘Cima fredda’; e la zona - più conosciuta come Tolmino - ora
non è più territorio italiano –; a fine guerra (quando la popolazione civile
poté tornare dall’evacuazione forzata) fu trovata corrosa dal lavoro umano di
trincee, ma soprattutto da migliaia di bombe.
La battaglia era iniziata il 2 giugno con un fronte lungo
600 km; la dorsale Monte Nero - Mrzli è da conquistare per aggirare da nord
Tolmino sull’Isonzo, base logistica determinante austriaca; con sanguinosi
assalti di alpini prima e bersaglieri dopo, alla baionetta (gli ufficiali con
la sciabola sguainata), dopo aver superato mitragliatrici e filo spinato. Alla
fine di quel giorno, un terzo del reggimnto fu falcidiato assieme alla totalità
degli ufficiali superiori, e costretti a ritirasi, non aver guadagnato un metro
di terra. Seguiranno attacchi fallimentari ed eroismi sanguinosi, immortalati
da Achille Beltrame sulla Domenica del Corriere, ma con morti a migliaia (in
rapporto a nostro svantaggio perfino di uno a tre) e feriti a dismisura,
inumanamente molti lasciati a morire sul posto o trasportati senza conforto né
norme igieniche, senza lenire il dolore e mediczioni adeguate. Ben presto i
camposanti di fondovalle divennero saturi, ed i morti vennero sepolti in buche
naturali (“prima i pezzi irriconoscibili, coperti di calce; poi strati di
cadaveri coperti di calce; infine terra, terra, ed infine una croce catramata
nera”).
Gli italiani lanciati alla conquista – reggimenti di
minatori soprattutto - inizialmnte non avevano né ripari né rifornimenti; e
solo con la loro opera ricuperarono qualche grotta. Ma fondamentalmente
all’aperto, sotto teli militari, sretti l’un l’altro per sopportare la neve
prima ed il fango dopo. Mentre invece gli austriaci avevano un campo militare
trincerato molto importante e ben rifornito dalle retrovie, che fu lungamente
conteso con asperrime e sanguinose lotte, ricche di colpi di mano e di eroici
sforzi e vittime: per entrambi i contendenti, ma con gli italiani in posizioni
militarmente svantaggiose (sottoposte come posizione, a volte di solo pochi
metri; melma a non finire; freddo; scarsità di rifornimenti; assalti per
conquistare posizioni svantaggiose; tutto ai limiti etremi della sopportablità
umana.

la zona di guerra dove ha perso la vita Storace
Dopo una giornata relativamente tranquilla, alle ore 15 del 23 ottobre la
brigata Salerno va vittoriosamente all’attacco alla baionetta del primo fortissimo
trincerone, sulle pendici vicine alla vetta del Mrzli (snaturatamente immortalati dal
Beltrame: non alpini puliti, ordinati e impeccabili e tra rocce pulite; ma
belve accecate dal bisogno della sopravvivenza in sparsi giochi mortali della
vita reciproca, in un contesto pieno di macerie sconvolte centinaia di volte,
filo spinato, ma soprattutto tanti morti e tantissimi feriti urlanti), e per vari giorni resisterà ai feroci contrattacchi
dei temuti bosniaci.
In queste operazioni, fu riconosciuto meritevole della medaglia d’argento al
V.M.; la motivazione recita: “nei combattimenti svoltosi durante la
notte e nell’assalto della postazione nemica eseguito il mattino successivo,
tenne costantemente contegno eroico, servendo d’esempio e d’incitamento ai
propri dipendenti, fino a quando cadde morto.
Mrzli, 23-24 ottobre 1915”.
All’alba del 24
ottobre, l’89° fanteria riparte dalla trincea per cercare invano di conquistare
la cima. Ogni grosso attacco, costa due-trecento morti; in ottobre la Brigata
ha perduto 1200 soldati e 24 ufficiali. Per nulla, sarà da queste trincee che due anni dopo, il 24
ottobre 1917, dopo aver fatto brillare una mina che sconvolse le nostre
trincee, il generale Gerabek - comandante della 50a divisione austroungarica e
della affiancata 12a divisione di germanici slesiani – travolse il fragile
sbarramento e dilagò fino a Caporetto).


lapide nell’Universale
cerimonia 28.10.1934 a Roma- il Coni consegna
ad
un balilla sampierdarenese un moschetto, in
memoria di DGStorace unico campione della FIAP
caduto
in guerra e decorato al V.M.
Una lapide lo ricorda, affissa nelle pareti della società Universale, presso la
palestra : “caduto eroicamente a Tolmino - il 24 ottobre 1915 – emulo di
antiche glorie repubblicane - nei giochi ginnici crebbe le forze – negli
insegnamenti di Giuseppe Mazzini – educò il cuore alla lotta e al sacrificio –
la democrazia sampierdarenese – personificando in lui – le anime generose dei
compagni di fede – che alla loro vita – anteposero la libertà e la grandezza
d’Italia – lo addita ad esempio di magnanime opere – ora e sempre – “.
BIBLIOGRAFIA
-Alliney
G.-Mrzli Vhr, una montagna in guerra-Nordpress,2000-pag.60
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4327
-AA.VV.-Annuario
guida arcivescovado-ed./1994-pag.448;/2002-pag.484
-AA.VV.-GenovaCalcio-DeFerrari.1998-pag.49.55.61.71
-AA.VV.-Il
donBosco nella storia urbana-donBosco.1997-pag.31cartina 1904
-AA.VV.1889.1996
oltre un secolo di Liguria-SecoloXIX.1996-pag.108
-AA.VV.-Stradario
del Comune di Genova-ed.1953-pag.171
-Carboni.Rinaldi-Cento
anni di Libertas-ATA.2005-pag. 30.81.82
-Corti
M.-Annuario ligure dello spoort 2008-LoSprint-pag.214
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese : 7/73.13 + 8/78.5 + 6/79.5 + 4/81.8 + 9/88.20 +
6/90.13 + 8/90.11 + 4/92.8 + 8/95.3 + 07/02.12 +
-Genova,
rivista municipale : 8/31-pag.673
-1891-1991
cento anni di storia - un secolo di sport . stemma e foto
-Il Secolo XIX, quotidiano
: 7.10.98 + 10.10.00 +
24/6/01 + 8/2/02 + 19/1/04 + 23/1/04 + 23.8.06 + 11.06.09/pag. 41 +
-Lamponi
M.-Genova in bicicletta-Valenti 1977-pag. 45
-Lamponi M.-Sampierdarena –
Libro Più.2002- pag. 162
-Novella P.-Strade di
Genova-Manocritto bibl.Berio.1930 c.a.-pag.17
-Pagano –Annuario
genovese/1950-pag. 411; /1961-pag.401.593
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.85-pag.1749
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio 1995-tav 21sbaglia con Sestri
-Spadaro E-articolo su
“Liguria notte”-anno 1970 c.a.-pag. 4
-Tuvo&Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore 1975-p.283.298foto
STRETTA strasetta
Stretta
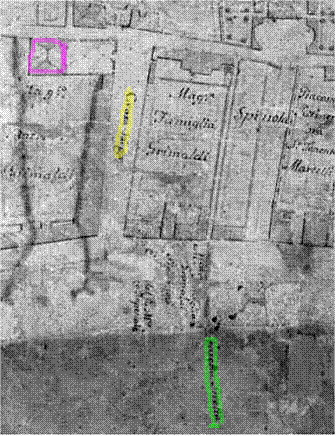 in fucsia la
Fortezza; giallo, la crosa Larga; verde, la scritta ‘Strasetta Stretta’.
in fucsia la
Fortezza; giallo, la crosa Larga; verde, la scritta ‘Strasetta Stretta’.
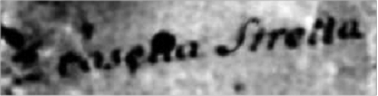
Così appare scritto –anche se non facilmente leggibile- sulla
carta del Vinzoni del 1757, relativa a questa comunicazione tra la strada
principale (oggi via LDottesio) e la
strada a mare-.
A sua volta separante orti e frutteti: a levante della
proprietà degli Spinola ed a ponente quelli dei Grimaldi (questi, con villa sulla strada principale e -della
famiglia- anche la casa fatta a L posta d’angolo a mare. Le case a mare nella
proprietà Grimaldi –per quanto è leggibile- sono descritte a via Spinola di San
Pietro).
Considerato che a ponente della proprietà Grimaldi c’era la
‘crosa Larga’ (la quale la separava da quella di
altri Grimaldi, di palazzo della Fortezza), non sfugge la legge dei
contrapposti nel dare il nome a queste due vie parallele.
Non corrisponde al ‘vico della Catena’ (vedi; che viene
descritto essere stato proprio di fronte all’ingresso della villa Spinola);
potrebbe essere stato quello che in altri scritti viene intitolato ‘strada NS
della Vista’ (vedi). Oppure è un
tracciato che è stato distrutto dalle costruzioni del 1800.
STRETTO vico Stretto
Corrisponde all’attuale vico
stretto sant’Antonio (vedi a A)
Le origini del vicolo,
ovviamente anonimo, traggono fonte dai recinti o muretti delimitanti le
proprietà delle ville cinquecentesche.
Nel 1757 -carta del Vinzoni- si
rileva che lo spazio era occupato da un sentiero delimitato a ponente dalla
proprietà di due signori: ‘M.ci Crosa’ a nord, e ‘Sig. Stefano Cambiaso a
sud, con rispettive ville tuttora esistenti; ed a levante la proprietà del
magnifico Giorgio Spinola. A mare, in corrispondenza dello sbocco di due rii
provenienti da Promontorio e congiungentesi in corrispondenza del nostro
vicolo, viene riportato il nome di “ sc di S.t’
Antonio” dove “sc” non è comprensibile se scalo o cosa altro.
Una carta di poco posteriore
precisa che la proprietà Spinola ha cambiato intestatario (illeggibile= “ora
Adolfo Nazaro”?)
In questi anni attorno al 1840,
il carruggio delimitava il quartiere ‘Comune’ esteso a ponente, dal Borraghero
a levante.
La ferrovia (1845),
affiancata da via Vittorio Emanuele (attuale via G.Buranello), tagliò a
metà questi terreni, che a levante verranno selvaggiamente lottizzati con
costruzione di caseggiati e l’apertura poco vicino anche di via Gioberti, che prima non esisteva.
Ancora a metà del 1800,
la zona attorno era tutti orti coltivati; i proprietari terrieri erano
cambiati, ed anche il nome pare definito anche se non ancora ufficialmente,
assumendo la titolazione “crosa sant’Antonio”. Allora delimitava a ponente
-nella parte a monte sempre della famiglia Crosa (poi
divenuta proprietà Diana), -nella parte a mare la proprietà di Parodi
Bartolomeo (fu Giacomo evidente allora
proprietario della villa Cambiaso, poi ex Pretura); a levante la
proprietà di Sasso Emanuele fu GB (dalla strada
comunale ora via
N.Daste, alla strada Reale a mare ora via Sampierdarena).
Come anche scritto in basso
sulla targa attuale, già agli inizi del secolo 1900,
alla popolare dedica al santo, fu dato ufficialmente il nome di” vico Stretto”,
da via C.Colombo (via
Sampierdarena) a raggiungere la
strada comunale (via N.Daste ).
Può apparire ovvia la scelta di chiamarlo così, in contrapposizione
alla vicina “via Larga” (via
Palazzo della Fortezza), posta poco più a levante.
Allora vi erano ubicate le case
della vedova Parodi al civ. 1 ed il baraccone Ronco-Carosio al civ.2.
Nel Pagano 1902 è scritto solo al civ. 1 lo straccivendolo Frontali
Socrate’*°. Anche nel 1921 al civ.2 c’era il negozio di
stracci (nella classificazione del Pagano,
stracci era anche per cartiere e lanifici) della ditta Veardo Angelo &
figli (che nel 1911-20 era in via V.Emanuele ad un civico non precisato).
Compare nell’elenco delle
strade comunali, ufficialmente riconosciuto come “vico Stretto” nel 1910,
da via C.Colombo a via S.Antonio, con civv. 2 e 4 .
Ma la sua fine fu decretata con l’unificazione della
nostra città nella Grande Genova: anche il Centro e Borzoli avevano un vicolo
omonimo, e la decisione fu ovviamente mirata a salvare quello del centro anche
se attualmente nessuna strada genovese porta più questo nome.
Ancora nel 1933 ,
questo era il nome ufficiale della crosa (quando via N.Daste si chiamava via generale Cantore), di 5.a categoria, e
con civici sino al 2 e 7.
Solo più tardi, il podestà
di Genova, nel riordino delle strade cittadine conseguenti all’annessione di
San Pier d’Arena nella Grande Genova, il 19 agosto 1935 con delibera n.
1657, definì si chiamasse vico stretto
sant’Antonio, unendo in compromesso, il vecchio nome col nuovo (in quell’ anno anche le strade agli estremi mutarono
nome divenendo via N.Barabino e via N.Daste).
BIBLIOFRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica, scheda 4332
-DeLandolina GC- Sampierdarena
-Rinascenza.1922- pag. 56
-Lamponi
M-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.87
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto
bibl.Berio.1900-pag.19
-Pagano 1933-pag. 248
SUPERIORE strada Superiore
Nella carta vinzoniana del 1757
è anonima.
Negli atti ufficiali di prima
del 1850, questo era il nome (probabilmente anche popolare) dato
all’asse interno, dalla Lanterna (oggi l’insieme
di via De Marini, via L.Dottesio, via N.Daste) a piazza del Mercato (la zona via ACantore civ.50, Salvemini-Sciamà); ed oltre, fino
anche a Rivarolo (detta ‘Superiore a nord’, poi
san Martino) o al Ponte; in
contrapposizione alla “strada della Marina” che invece dalla lanterna seguiva
la linea costiera.
Nel regio decreto del 22 mag.1857,
ancora si descrisse con questo nome la via del borgo che dal bivio nella zona
Coscia percorreva il centro (da Largo Lanterna
si apriva un trivio, con via
De Marini a monte; via VittorioEmanueleII oggi via G.Buranello-p.za VVeneto-via
P.Reti-v.W.Fillak nel centro; e la strada
della Marina oggi via
Sampierdarena-via Fiumara).
A fine 1800 la troviamo
chiamarsi anche “Comunale” ed essere così suddivisa: via DeMarini (da Largo Lanterna a
via Larga); via sant’Antonio (da via
Larga a via della Cella); via Mercato (da
via della Cella al trivio (crosa Buoi, san Cristoforo verso il Ponte
e san Martino verso Campasso)).
Nel 1900, alla morte di
don Daste, si volle dedicargli una strada. Fu eliminata la titolazione di via
Mercato e sostituita con il nome del prete.
Nel 1920-30 dopo la prima
guerra mondiale, si volle onorare il generale Cantore. Fu eliminata la
titolazione a sant’Antonio e sostituita con ‘via generale Cantore’, sempre fino
all’incrocio con via della Cella.
Nel 1930-35 con la nascita
di via di Francia e di via Antonio
Cantore, avvennero queste modifiche: via DeMarini
( accorciata da Largo Lanterna a via di Francia); via
L.Dottesio (da via di Francia a via Larga -a sua volta divenuta via J.Ruffini);
eliminata la primitiva dedica al generale Cantore ‘spostato’ di strada, divenne
tutta via N.Daste dalla via Larga (via Palazzo della Fortezza) fino al l’incrocio con via Carzino (essendo
nel frattempo scomparsi gli ultimi cento metri inglobati da via A.Cantore)).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale.
 Dal Pagano 1961
Dal Pagano 1961



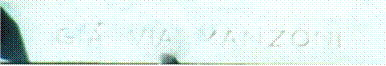
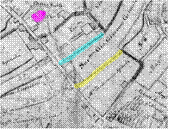 da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni
Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.
da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni
Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.

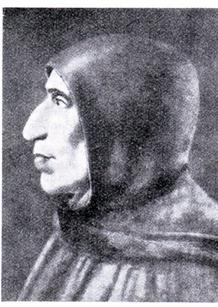





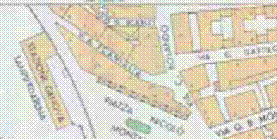

 .
.






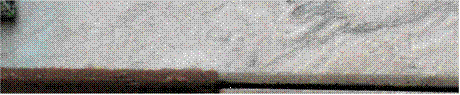


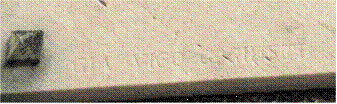
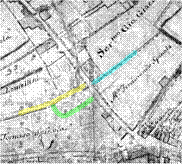
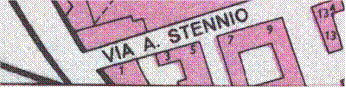
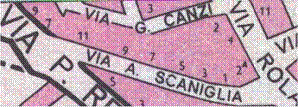





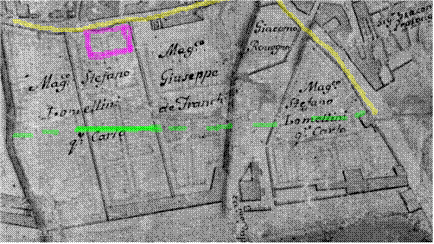
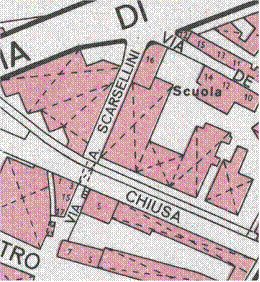







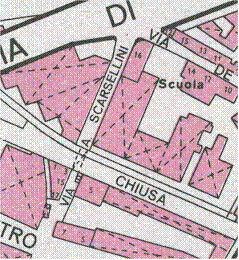


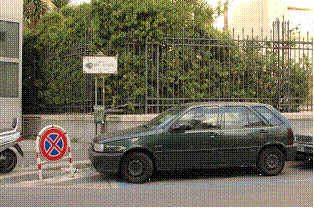













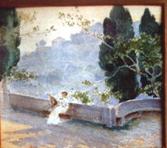

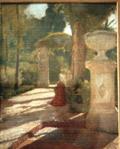






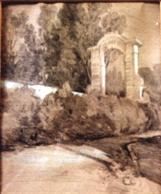
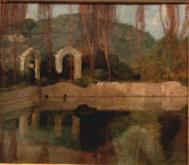

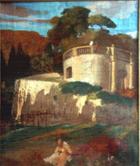

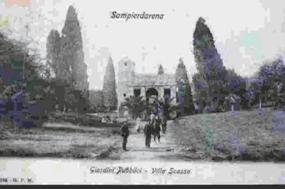










 Atrio con lapide
Atrio con lapide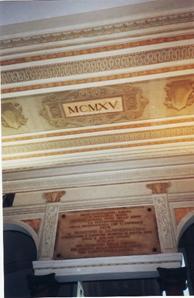















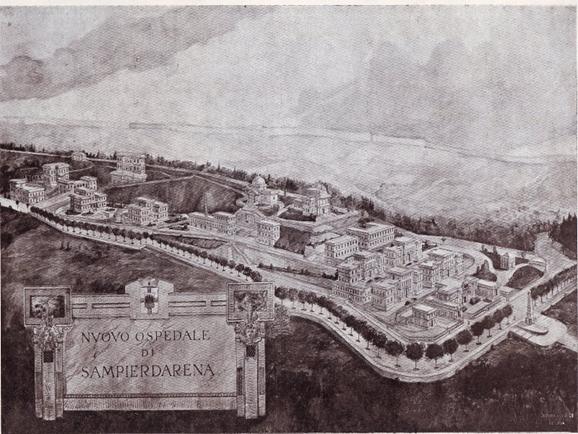
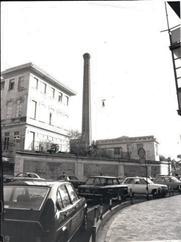





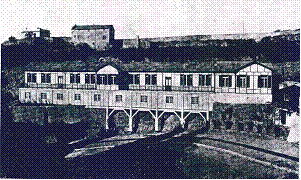









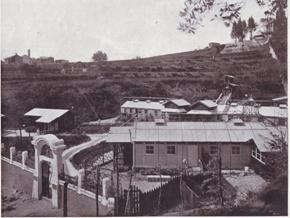











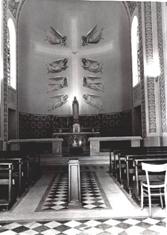







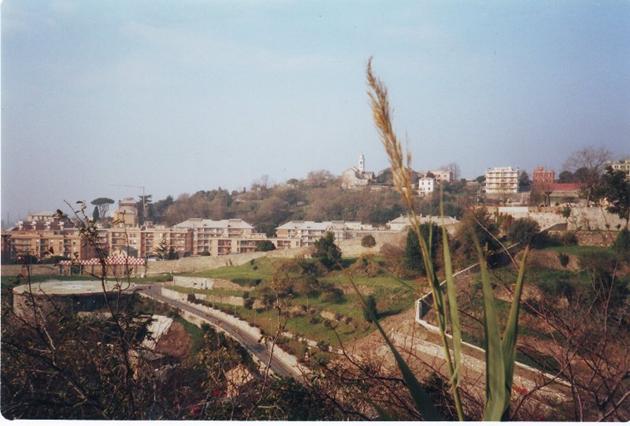

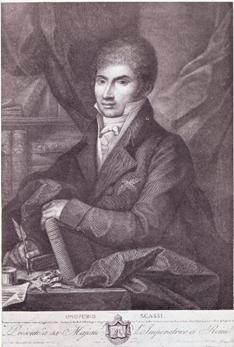 Forte delle
conoscenze raccolte all’estero, ricevette pressoché subito dopo (1795)
una missione nel ponente ligure, per una strana epidemia di ‘febbri
putrido-biliose’, diffusasi nella popolazione e nelle truppe francesi
Forte delle
conoscenze raccolte all’estero, ricevette pressoché subito dopo (1795)
una missione nel ponente ligure, per una strana epidemia di ‘febbri
putrido-biliose’, diffusasi nella popolazione e nelle truppe francesi 


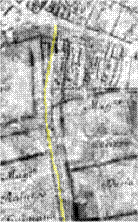
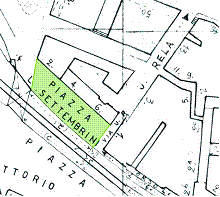
















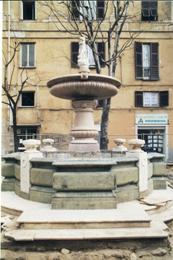




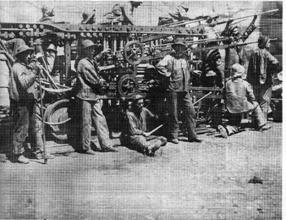
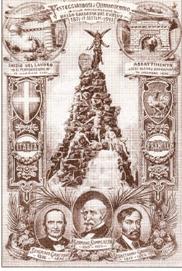





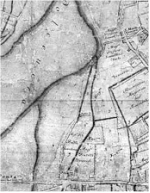
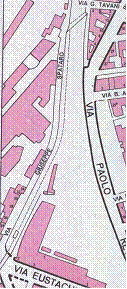
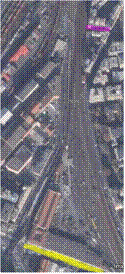
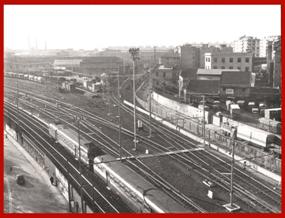



 il sottopasso
il sottopasso














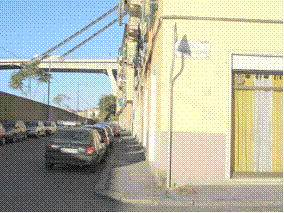


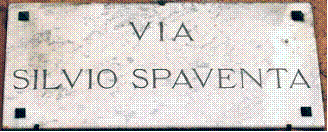
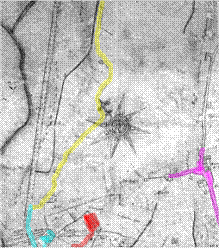
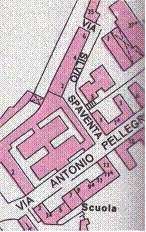
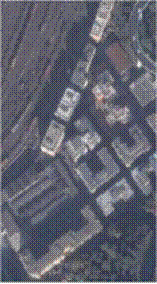 da Google Earth, 2007.
da Google Earth, 2007.