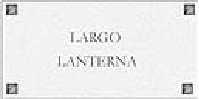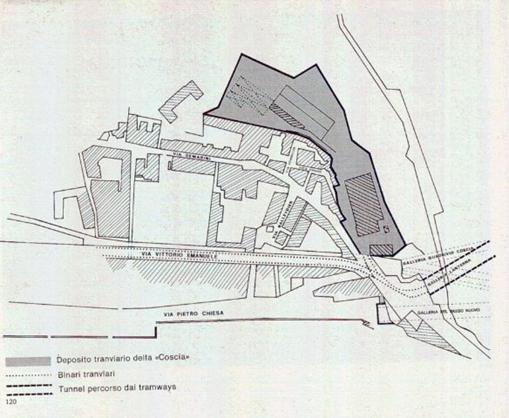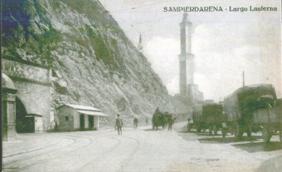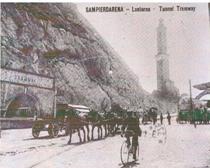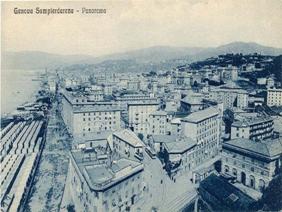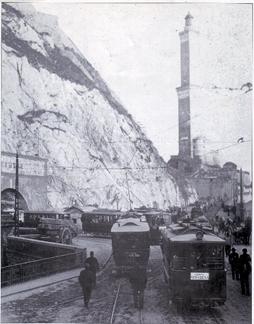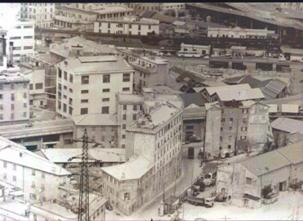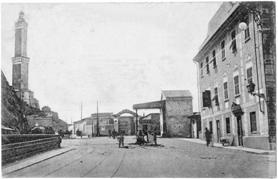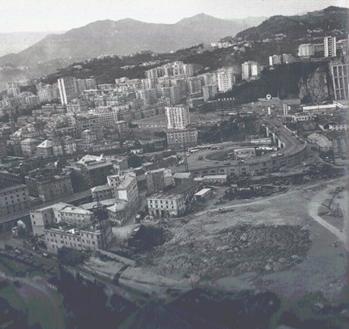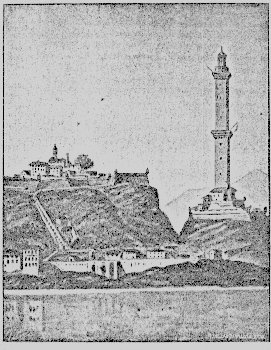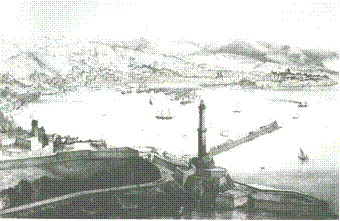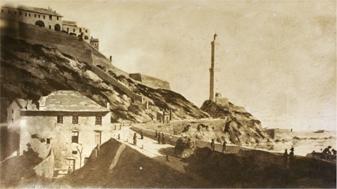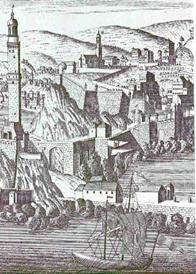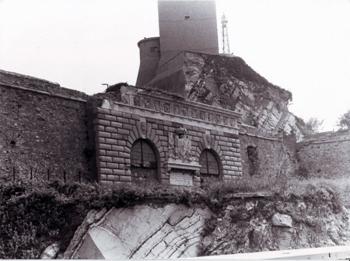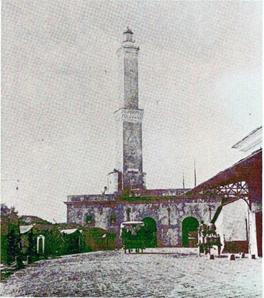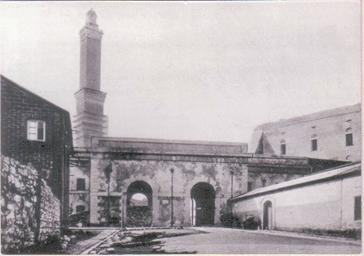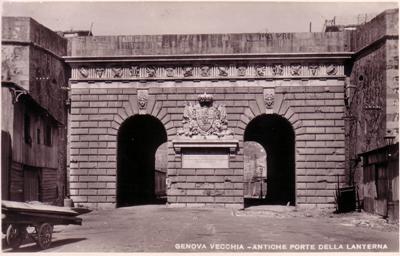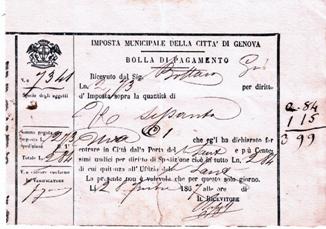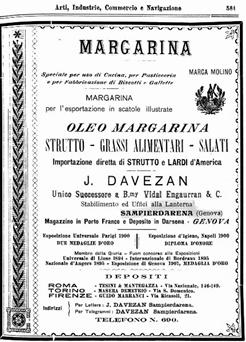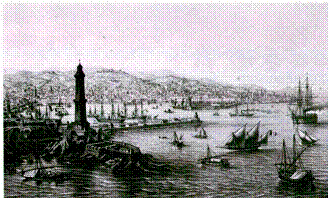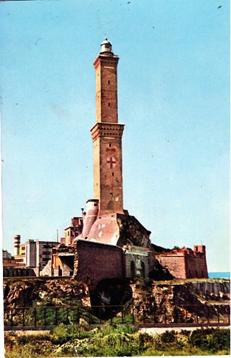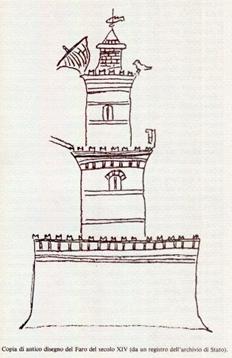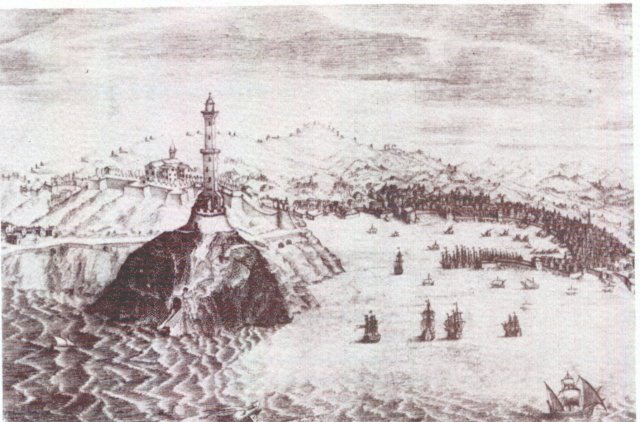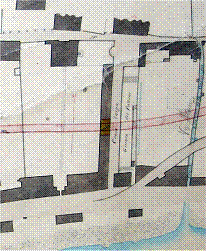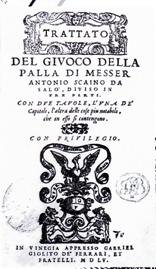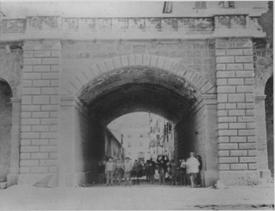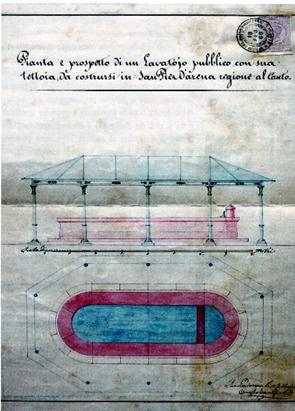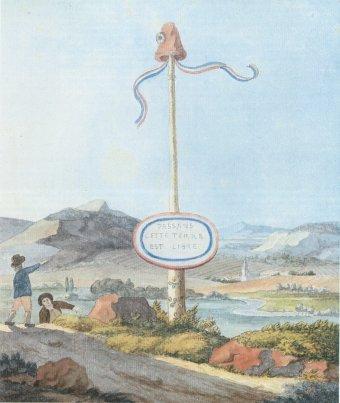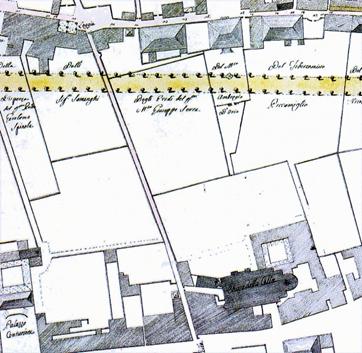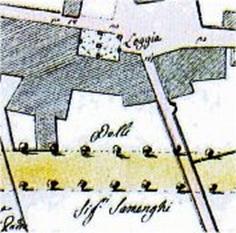LANDI
scalinata
dei Landi
TARGHE:
S.Pier
d’Arena – 2793 - scalinata dei Landi – già scalinata.Guerrazzi
Scalinata
dei Landi
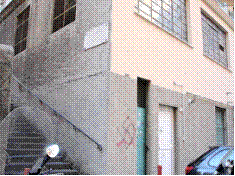
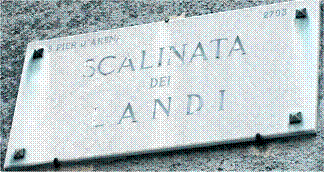
in angolo con via G.B.Sasso

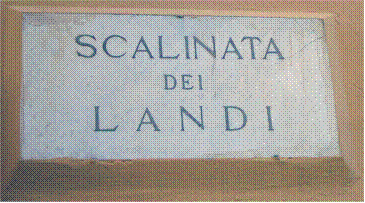

in angolo con via dei Landi
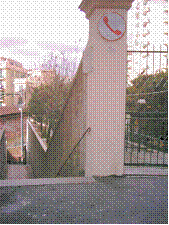

in angolo con via G.B.Monti
QUARTIERE ANTICO:
Mercato
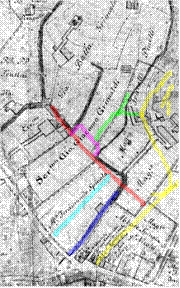 da MVinzoni, 1757. In rosso via
PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico
tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi
da MVinzoni, 1757. In rosso via
PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico
tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi
N° IMMATRICOLAZIONE:
2793
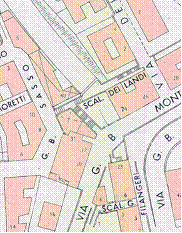 Dal Pagano 1961
Dal Pagano 1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 32560
UNITÀ URBANISTICA: 25
- SAN GAETANO
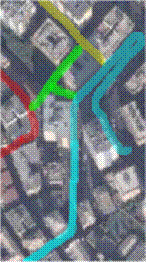 da
Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei
Landi
da
Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei
Landi
CAP: 16151
PARROCCHIA: san
Gaetano e san G.Bosco.
STRUTTURA: da via
G.B.Sasso , a via dei Landi .
Il primo tratto in basso, precede nel tempo la costruzione della strada omonima
soprastante, essendo la scalinata già presente da poco dopo il 1910 e collegata
solo con via GB Monti.
A
quel tempo era ancora anonima.
Nel
nov.2003 compare nell’elenco delle ‘vie private ad interesse pubblico’ e quindi
programmate a divenire municipali. L’elenco è stato ribadito nell’agosto 2004
ma dopo ancora un anno tutto appare fermo.
Il 19 ago.1935, con delibera del podestà, fu ufficializzato il nome scalinata
Francesco Domenico Guerrazzi. La scheda
comunale scrive “da via Manzoni (via G.B.Sasso) a via G.B.Monti, vicino
alla fonderia Fava “. Con l’erezione dei primi
palazzi della futura via dei Landi (1936), la scalinata fu prolungata diritta,
fino a sopra. (Il nome
del Guerrazzi era stato proposto prima di quell’epoca anche per l’attuale via
Prasio, ma poi annullato).
A metà percorso: a sinistra, una grata impedisce di vedere la sottostante
imboccatura della galleria - anch’essa
chiamata dei Landi - che collega il parco del Campasso col porto (la galleria nel periodo dei
bombardamenti aerei alleati, era divenuto un rifugio e, per i già disastrati
addirittura un luogo di residenza; vi correvano terrorizzati gli abitanti
vicini, ingorgando l’entrata, attraverso l’officina sita in via GB Sasso che
possiede ancor ora una porta che da accesso alla linea ferroviaria; i
nazifascisti approfittandosene, vi facevano delle retate di partigiani: vengono
ricordati alcuni che catturati, vennero poi deportati nei lager tedeschi da cui
non fecero più ritorno. A metà percorso , la galleria era raggiungibile anche
da via Cantore: questo ingresso fu poi usato per costruire l’ascensore con cui
salire all’ospedale);

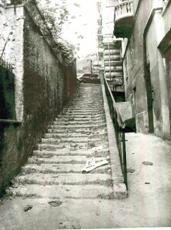

1976
con imbocco galleria sottostante
ed
a destra la più antica e primitiva scalinata-derivazione, che la collega anche
con via G.B.Monti.
CIVICI solo dispari
2007:
NERI = da 1 a 3
ROSSI = da 3r a 7r (manca
1r)
Nel Pagano/40 va da via GB Sasso a via GB Monti (in quanto non esisteva ancora
via dei Landi); aveva un solo civico nero, il 2.
Dal 1951 al 1956,
tutte le costruzioni erette nella strada superiore dei Landi (dal civ.2 all’ 8 e dal 3 al 17) vennero attribuite alla scalinata, finché non
furono tutti trasferiti alla su detta strada (in particolare però, i civv. 7 e 9 –scrive la
toponomastica - provenivano da via C.Cattaneo e furono assegnati alla scalinata
in epoca non precisata: nell’ apr.1954 divennero il 30C e 30D di via GB Monti;
nel 54-nov.55 - eretti altri caseggiati - i nuovi numeri 7 e 9 furono riassegnati
alla scalinata)
Il 17 ott.1955 il Consiglio comunale la fece chiamare
come ora.
Nel maggio 1958 le furono assegnati i civv. 1 e 3 neri, attribuiti a ‘nuove
costruzioni’.
Nel 1981 tutta la crosa fu ripavimentata a nuovo.
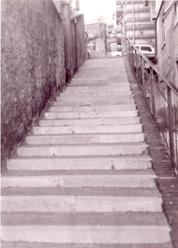

1985
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale -Toponomastica.- scheda 2330
-Archivio
Storico Comunale -Elenco strade 1910
-AA.VV-Annuario,
guida archidioicesi-1994-pag.413; 2002-pag.450
-AA.VV.-Contributo
di SPdA alla Resistenza-PCGG 1997-pag.91
-Gazzettino
Sampierdarenese 10/78.7 + 1/82.11 + 1/93.13 (titolo errato)
-‘Genova’
Rivista del comune: 11/51.48
-Il
Secolo XIX del 25.11.03 + 23.08.04
-Lamponi
M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag. 186
-Pagano
/40-pag. 214
LANDI
via
dei Landi
TARGHE:
San
Pier d’Arena – via - dei – Landi
Via
– dei – Landi
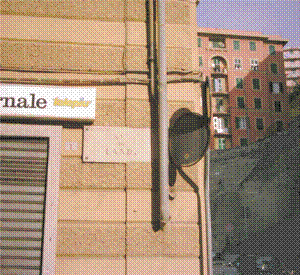
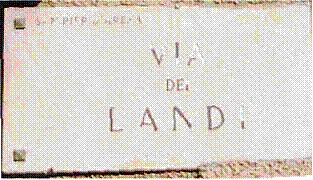
in angolo con via G.B.Monti, all’inizio
strada


nel piano, verso le scuole

nel piano, angolo con chiocciola per via Marabotto

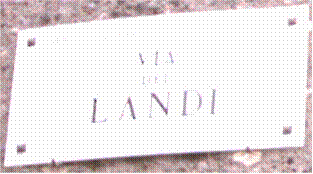
a fine strada, angolo con via V.Battaglini; verso destra
diventa via G.B.Monti
QUARTIERE ANTICO:
Mercato
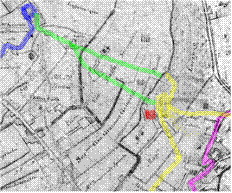 da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato
della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;
rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.
da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato
della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;
rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.
N° IMMATRICOLAZIONE:
posteriore al 1953
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 32580
UNITÀ URBANISTICA: 25
- SAN GAETANO
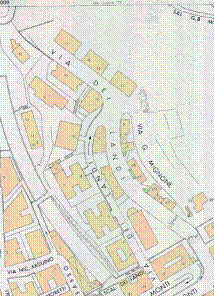
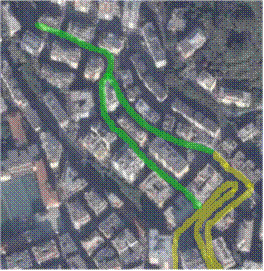
da Pagano 1961 da
Google Earth 2007- In giallo via GBMonti
CAP: 16151
PARROCCHIA: san
Gaetano e san Giovanni Bosco
STRUTTURA: salendo
via G.B.Monti, nasce sulla sinistra poco prima dei suoi “tornanti”; ed
anch’essa sale come numerazione progressiva dal n° 1 e 2 (ma per i veicoli è, al contrario,
senso unico in discesa) sino ad una
piazzetta-crocevia, ove si sviluppa come il ramo orizzontale di una T, lungo la
‘quota 40’: da destra-levante proviene - sia come senso unico viario che
numerazione - dall’incrocio con via Battaglini (in prosecuzione di via GB Monti); mentre a sinistra-ponente proseguono sia la
numerazione che senso viario libero bidirezionale sino al cancello della villa
(la cui presenza ha
probabilmente impedito l’avanzata della strada di quota 40 verso il Campasso).
La
strada possiede pochi negozi concentrati nella parte costruita per prima, ed in
salita.
CIVICI
2007=NERI=
da 1 a 19 (compresi 9ABCDE, e 11AB) e da 2 a 16
ROSSI =da 1r a 69r
(compresi 1rABCD, 3rH, 29rB, 33rABD)
e da 2r a 16r
(manca 6r)
===civ.
19: La villa Pallavicini-Currò:
nel 1979 fu aperto un cancello, seguito da cortile con gioghi fissi per
bambini, che divenne l’accesso principale della scuola col civico 19, a scapito del precedente civ.23 di
via Currò che ancora nel 1757 era strada unica a portare alla villa
soprastante.
Edificata in epoca cinquecentesca, in una zona abbastanza
ripida, ma con l’ampio panorama della riviera di ponente, ha l’aspetto della
tradizionale villa prealessiana: rettangolare allungata, spoglia di qualsiasi
decorazione; ha un corpo laterale aggiunto a levante, più basso, ed a terrazza
per il piano nobile. Aveva una cappella,
citata da mons Bossio nel suo giro compiuto nel 1582 e dedicato a tutte le
chiesuole nel suo territorio arcivescovile ovviamente distrutta nell’ultima
ristrutturazione. La proprietà, stretta e lunga, arrivava in basso verso
ponente sino alla strada principale alla quale scendeva con una strada con
l’identico tracciato attuale; ai lati era strutturata a fasce coltive ed a
giardino.
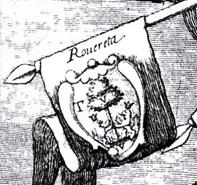

Sulla carta vinzoniana del 1757 la proprietà è
indicata appartenere ora mag.ci Rovereti,
marchesi di Rovereto (TN; nel XV secolo i veneziani
avevano introdotto in zona la sericoltura; ma nel 1509 tutto il territorio
passò all’Austria) -
divennero proprietari a seguito di probabili intrecci parentali; primitivamente
risulta infatti essere una delle famiglie nobili “aggregate” agli Imperiale (DeLandolina scrive che per le palme che posero a dimora, la
zona fu chiamata «la Palmetta»; e che sul palazzo c’era il loro stemma composto
da un’aquila bicipite coronata – laq quale, se quella degli Imperiale, è
coronata ma non bicipite)).
Ma
prima erano dell’”ecc.mo generale (conte) Gio.Luca Pallavicini“.
Sul
Battilana esistono vari Gio.Luca (presumo
che la data, singola, faccia riferimento a qualche documento nel quale sono
citati):
1)
1666.1674 nato da Filippo; poco probabile
perché precoce di data
2)
1724. nipote del precedente nato da uno
dei suoi figli Carlo e da Maddalena Spinola q. Francesco; a sua volta sposato
con Giovannetta Spinola q.Carlo con tre figli dei quali Maddalena andò sposa a
GiacomoFilippo Durazzo q.Marcello
3)
1721. figlio di Giuseppe q.GioLuca e di
Marina Centurione q.Ottavio; sposato con Anna Pallavicino q.Domenico ebbe
figlio Giuseppe e 4 nipoti tutti morti senza prole
4) Giovanni
Luca III nato il 23 sett.1697 da GiuseppeIII e da Livia Centurione. Non
compare sul Battilana nelle varie genealogie, ma
viene da lui citato nella parte iniziale generale quale “il celebre
feld-maresciallo Gio.Luca Pallavicini. Che, grazie alle famose imprese compite
a danno degli Ottomani, reggendo lo scettro imperiale Maria Teresa, meritò il
governo del Ducato di Milano”. Molto probabilmente trattasi di lui: ereditiero da parte di madre anche dai Fieschi, sposò
prima AMaria Pallavicini, ed alla sua morte (1756 ca) la bolognese Caterina
Fava. Fu personaggio politico di primaria
importanza europea: dimostrando sensibilità verso le nuove idee illuministe,
trovando ostacoli locali a qualsiasi riforma proposta, preferì diventare Maresciallo al servizio della corona
austriaca retta da MariaTeresa, ministro plenipotenziario poi delle finanze
austriaco, ed infine (1750-3) governatore del ducato di Milano. All’atto dell’insurrezione
popolare del Balilla (1746), volle prendere una posizione equidistante dagli
interessi dei due, Genova e Vienna, scontentando entrambi: dovette fuggire da
Genova con la famiglia trovandosi in rottura con i suoi stessi parenti locali.
Si trasferì a Bologna adottando il doppio cognome (aggiungendo il Centurione
della madre) ma prima volle fare grossa donazione creando -1772- una ’Opera
Pia’ che istituiva una grossa cifra (40mila fiorini) con la cui rendita (1600
f) dare sollievo a ‘famiglie vergognose’ o ’povere zitelle nobili’. Ed a
Bologna morì il 27 sett.1773 col titolo di conte).
Chiunque
di essi, con lo stesso
criterio, passò più o meno indirettamente (allettante
quella del 2)) ai Durazzo-Pallavicini (che avevano, in planimetrie del 1890 e del 1906, terreni allargati lato
mare, fino a poco oltre l’attuale via san G.Bosco, nel retro ad est della
proprietà dei salesiani; e probabili parenti dei Grimaldi-Pallavicini (nel
1872) poi marchesa Durazzo-Pallavicini (1876) proprietaria della villa Bianca venduta con il terreno ai salesiani
(1889)).
Da loro, nel 1867 e con rogito del notaio Casanova passò
ad Antonio Currò, forse nobile col titolo di
conte (Lamponi dice barone). Forse la famiglia Currò ebbe il titolo stradale anche perché munifici
donatori (quando sulle
targhe è indicato solo il cognome, vale come dedica al complesso familiare e
non al singolo titolare che allora è specificato: così via Bombrini, via
Balleydier, ecc.).
DeLandolina nel 1922 scrive che «proprietario attuale ne è il pronipote sig.
Antoni Elia-Currò»; ma non corrisponderebbe (in affitto?) col Pagano/1908 in
cui vi si reclamizza il III anno di vita dell’ Istituto e Convitto Sociale
(Scuola Tecnica pareggiata della Città
- scuole elementari interne - con sede legale di esami di maturità o licenza -
corso accelerato pel tecnico e ginnasio - Istituto Nautico e Scuola d’Arti e
Mestieri - Preparazione alla Scuola Macchinisti e alla Scuola Superiore di
Commercio ---LEZIONI DI Piano – Forte -- posizione splendida con giardino – accettansi Convittori,
Semi-Convittori ed esterni
– Trattamento Familiare – Retta mite. Prof- A. Bernardi).
L’espansione edilizia dei primi del 1900, occupò
gradatamente gli spazi giardino lasciando solo tratti di muro di cinta -ancora
utilizzati per delimitare le proprietà attuali- e la villa il cui edificio,
all’esterno, seppur con angusto respiro appare inalterato. Circa nel 1928
l’edificio fu offerto alle suore gerenti l’istituto privato della “Congregazione delle Figlie di sant’Anna” (vedi a via s.Bartolomeo d.F.78). Per le Belle Arti si chiamò
‘Collegio Cuore s.Anna’;
istituite dalla
genovese Gattorno Rosa deceduta nell’anno 1900; qui traslocate da un convento
di via san Bartolomeo.
 Esse
ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18
anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.
Esse
ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18
anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.
Nel 1934 fu posta dalla Soprintendenza alle Belle Arti
sotto vincolo e tutela. Tale vincolo fu rinnovato nel 1995
Dopo una profonda ristrutturazione operata nel 1979, è
divenuta scuola materna e dapprima chiamata ‘Antonio Cantore II’ o
‘plesso di via Currò’ ,e poi definitivamente dedicata ad Hans Cristian
Andersen.
Ospita pure la scuola elementare dedicata a E.Montale.
STORIA: col sorgere
dei primi palazzi, i civici furono assegnato alla scalinata che dal nome F.D.
Guerrazzi era diventata dei Landi. Con decisione del Consiglio Comunale, il 17
ottobre 1955 la strada divenne autonoma ed assorbì tutti i civici già costruiti
(dal 2 all’8 e dal 3 al 17 compreso un 9a)
===Al
suo inizio in basso, la prima laterale a destra (prima ancora della rampetta in discesa che conduce al
garage), vi è un piccolo tratto in
salita che porta all’imboccatura - ovviamente chiusa- di una galleria
usata in tempo di guerra come rifugio (mi si dice collegata a quella che ha
l’apertura sotto il muraglione nel curvone di via GB Monti ed ora limitatamente occupata da
un box privato per auto).

===civ.
1 è il primo grattacielo
costruito in Sampierdarena dall’impresa Vicari;
fu eretto nel 1956 dopo aver spianato alcune case precedenti. Dall’erede,
gestore dell’istituto medicale Emolab di via
GBMonti siamo riusciti a sapere nulla, asserendo non conoscere e aver
conservato nulla dell’operazione.
===civ.2
- 4 è il primo palazzo in basso;
come è scritto sulla facciata a livello degli ultimi piani e con caratteri
tipici dell’anteguerra, messi vicino ad un rilievo con il san Giorgio
circondato da affresco (con foglie di alloro ed altre rosse di vitigni ed -in
originale- i fasci littorio), fu costruito nell’ “ANNO XXXVI “.
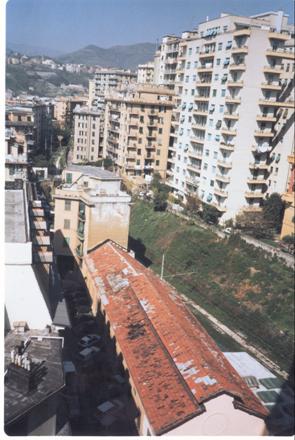

le facciate a ponente, nel retro rispetto la strada, con la
scarpata verso la ferrovia.
===civ.
3 e 5 nel retro, le finestre
più in basso sono con inferriata, essendo già prevista all’atto della
costruzione, la prosecuzione della quota 40.
===civ.
11 fu eretto nel 1940 circa, ancora
in stile arrotondato, stile tipico dell’era fascista; alla nascita era solo,
circondato da orti e brulli prati e - viene ricordata su una fascia vicina
verso est una grossa vasca con pesci visibile nella carta del Vinzoni; la
strada di quota 40 era interrotta da terreno degradante a ripide fasce calanti
sino all’inizio della strada in basso.
===civv.13.15 fu eretto negli anni 1958 dalla soc. Immobiliare di
Fassolo, il cui amministratore unico era l’industriale Tomaso Romanengo.
===tutti
gli altri civv. furono pressoché eretti: nel 1956 (civv 9BCDE), 1957 (civ.10
e 14) ; 1959 (civ 12 e 16).
DEDICATA alla
famiglia proprietaria dei terreni già dalla prima metà del 1800, di origini
semplici e contadine, la cui casa o villa agricola
era posta ove sorge il civ. 7 di via N.Ardoino ed era raggiungibile tramite da
un sentiero carrettabile che partiva da via San Martino (via C.Rolando) comunemente detto
‘vico Landi’ (vedi) . Gli eredi avevano un negozio di frutta e verdura in via U.Rela , in
cui vendevano i frutti dei loro orti .
Gli
ultimi tre fratelli, capaci imprenditori, riuscirono ad ottenere di costruire
nei loro terreni tutti i palazzi attuali, creando negli anni ‘60 un grande
cantiere, pressoché unico, che prese il loro nome e che lasciò il nome alla
strada. (vedi a U.Rela il bisagnino Calvi detto Beppin d’ì Landi).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica : scheda 2331
-AA.VV.Annuario
archidiocesi anno/1994-pag.413; /2002-pag.450
-Bologna
M.-archivi Pallavicini –Soc.Lig.St.P..1994-pag.9.13.325
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.19
-Lamponi M.- Sampierdarena-
Libro Più.2002- pag. 186
-Pastorino
Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag. 954
-Poleggi E &C.-Atlante
di Genova-Marsilio 1995-tav. 22
LANDI vico Landi
ritrovato in vecchie mappe
catastali risalenti alla metà del 1800, ed esistito fino ai primi anni del
1900: collegava via san Martino (v.
C.Rolando) con la casa dei Landi posta ove ora è il civico 7 di via N.Ardoino.
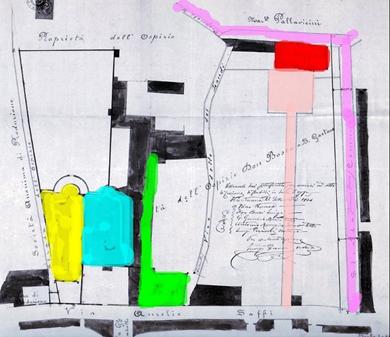 vico detto dei
Landi, mappa del 1914
vico detto dei
Landi, mappa del 1914
alla
base, via A.Saffi oggi C.Rolando; in giallo=il Tempietto; celeste=la chiesa
s.Gaeano; verde=l’istituto d.Bosco con in nero futura espansione edile;
rosso-rosa la villa Pallavicini che diverrà Oratorio; fucsia=la strada oggi via
s.G.Bosco.
Fu eliminato - perché
divideva in due la proprietà dei salesiani - quando fu aperta e poi allargata
in sua vece la via don G.Bosco
(oggi, via san Giovanni Bosco).
I Salesiani di don Bosco con
direttore don Bussi, nel loro lento e progressivo allargamento della proprietà,
acquistarono dapprima i terreni a nord del vicolo (la chiesa ed i fabbricati
vicini); poi, da proprietari diversi inclusero anche i terreni a sud del vicolo
stesso: questo era rimasto quindi incluso a metà della proprietà, e se fosse
rimasto di uso pubblico avrebbe creato delle difficoltà strutturali all’idea
salesiana dell’istituto e dell’oratorio. Così nel 1890 fu patteggiato con il
Comune, nei suoi progetti relativi ad un primo piano regolatore, la
eliminazione del tracciato, ed in cambio, oltre una somma di denaro in
contanti, vennero ceduti dei terreni necessari per allargare a 10 m. quella
che poi divenne via Giovanni Bosco (al confine sud tra la proprietà salesiana e l’allora
proprietà Rebora-Cristofoli), nonché per creare il vicolo di passaggio
a nord (ora via W.Ulanowsky), con
l’impegno da parte del comune di aprire entro 10 anni una strada a monte di
passaggio ad uso pubblico (l’attuale via P.Cristofoli).
In contemporanea, il direttore
dell’Istituto Ospizio san Vincenzo dé Paoli (ora
Istituto don Bosco), concorse alla spesa per la costruzione di un nuovo
condotto d’acqua (che inizialmente passava lungo il vicolo stesso), per
spostarlo a sud, fuori della proprietà salesiana.
Questa trattativa col Comune,
acquista doppia importanza: da un lato il riconoscimento da parte delle
autorità civili (molto laiche e filo repubblicane) del valore dell’opera di don
Bosco; dall’altra la lungimirante capacità dei sacerdoti, di accaparrarsi i
terreni in un momento di già selvaggia costruzione nei terreni limitrofi, con
conseguente allargamento dello spazio a disposizione.
BIBLIOGRAFIA
-Anonimo-dattiloscritto
chiesa di san Gaetano don Bosco-pagg. 200.425
-AA.VV.-Il
don Bosco nella storia urbana-DonBosco 1997-p.31.34.43.56
LANTERNA
largo Lanterna
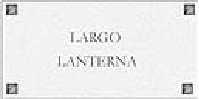
N° IMMATRICOLAZIONE: 2794
N° INFORMATICO: 32700
CAP: 16149
STRUTTURA: lungo la via de Marini, esisteva uno slargo, non una
piazza ma una netta svasatura che dava il via a varie altre strade: a nord via De Marini stessa, a ponente via Vittorio
Emanuele, a sud la strada alla Lanterna e dentro il monte la galleria del tram (ancora negli anni ’30, quest’ultima sbucava a Genova,
nel punto in cui la via Milano –allora
più lunga verso il mare; poi accorciata; ora di nuovo allungata allacciandosi
con via Pietro Chiesa a livello dell’elicoidale - trapassava in via Giuseppe Fantuzzi –che arrivava alla Porta della Lanterna- ed aveva a monte l’inizio di un vicolo che saliva alle caserme di san
Benigno, ed a mare era all’altezza di Calata sBenigno).
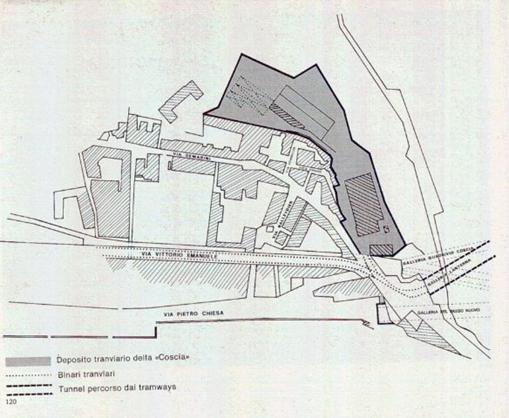
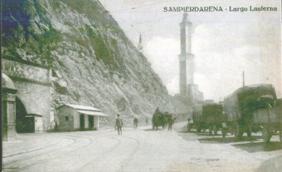
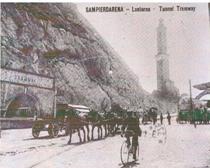
cartolina edit. Traverso e Moretto Dietro ai camion ci sarà
poi l’ingresso dei bagni Margherita
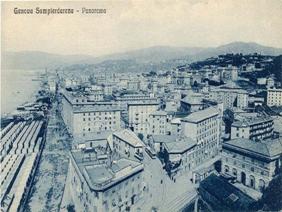
al centro in basso, il Largo Lanterna con terrazzo a prua di
nave. Verso destra via DeMarini (alla cui destra, il deposito dei tram). Dove è
il tram è via Vittorio Emanuele. A sin. Via P.Chiesa. Sulla punta del tetto del
palazzo in basso, la reclame della Creolina Pearson. Foto anni 1920.
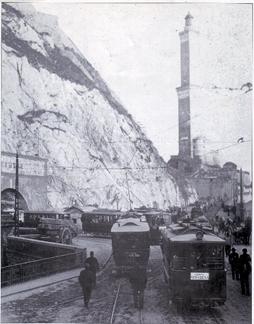
Attualmente, la strada è stata
rialzata, falsando tutte le angolature per chi ritorna ora nel posto: sino al
2010 la recinzione delle case abbattute e il cancello d’ingresso del nuovo
cantiere (da questa data, l’erezione di un
grattacielo che si apre in via Balleydier), delimitano e determinano
una continuità stradale con la via DeMarini,
che sostanzialmente è divenuta un unico: dai grattacieli del WTC al piazzale
della Lanterna; e quindi il ‘Largo Lanterna’ non esiste più. Il passaggio
continuo di camion, ha fatto asfaltare la strada, ovunque sovrapposto al
lastricato antico che si intravede nelle spaccature, proprio in corrispondenza
dell’ antica piazzetta.
Rimane la ringhiera dalla quale
si intravedono sotto lo linee ferroviarie invase dalle erbe selvagge quasi tese
a ricoprire quello che l’uomo ha rubato alla natura
Si precisa che lo slargo era in
terreno di proprietà del CAP. Sulla ‘Guida del Porto’ edita da Pagano nel 1954
si precisa esistere anche una “via al Largo della Lanterna”, compresa nel
territorio di proprietà del CAP ed estesa “dal Largo della Lanterna all’inizio
di via Buranello”.
STORIA: venne a crearsi con
l’apertura della strada scavata e tagliata nella ripida roccia del monte a
strapiombo sul mare, che dalla Porta Lanterna immetteva nel borgo.
Per chi usciva dalla Porta
suddetta, ed era diretto a ponente, dopo aver percorso alcune centinaia di
metri orientato verso il nord ed a strapiombo sul mare, arrivava proprio nel
punto in cui a sinistra iniziava –come la punta di un amo- degradante verso la
spiaggia, la piazza della Coscia; occorreva o voltare a sinistra per
percorrere la strada a mare, o proseguire diritti per iniziare la strada
centrale (via DeMarini): appunto nel trivio c’era lo slargo, non una piazza
quanto piuttosto un largo spiazzo, tra poche case.
Una carta del Brusco (Giacomo, ten. colonnello e ing. militare)
degli anni a cavallo tra 1700 e 1800, visualizza la strada che porta al
nostro borgo dalla Lanterna: ancora anonima e tutta diritta; con – a metà
percorso il ponte levatoio e -dove poi ci sarà il deposito del tram- le case
Samengo.
E ancora nel 1850 circa,
quando non c’erano ancora le case, faceva parte della genericamente chiamata
“piazza della Coscia”, posta nel cosiddetto e più vasto “piano della Coscia“.
Con l’apertura di via Vittorio
Emanuele (1850), e poi l’immissione delle prime vetture tranviarie, si
chiamò popolarmente “largo del Tunnel” (la
galleria, un poco decentrata rispetto alla via Vittorio E., costringeva le
vetture a compiere nello slargo, una S, necessaria per immettersi nella
galleria stessa, aperta nel 1878).
Negli ultimi anni del 1800,
divenne ufficialmente “Largo Lanterna“: una specie di aneurisma di via De Marini.
Nel 1910, si descriveva
lo spiazzo essere posto “fra il tunnel, il casotto del dazio e la via Vittorio
Emanuele“, quando aveva numeri civici che arrivavano dall’ 1 all’8 (sul fianco
del civ. 1 fu posta una targa in marmo che avvertiva: “I VEICOLI - PROVENIENTI DA GENOVA – E DIRETTI NELLA RIVIERA DI
PONENTE – DEVONO TRANSITARE NELLE VIE – VITTORIO EMANUELE C.COLOMBO – E
GARIBALDI“).


lapide
in via Vitt.E.II, in corrispondenza tra i due palazzi a destra (uno
rotondo- l’altro
del
suo inizio da L.Lanterna cuboide), il tram usciva dal
tunnel, in via Milano
Nel Pagano/1911, citato
genericamente “alla Lanterna”, esisteva una
fabbrica di grassi alimentari chiamata “Vidal Engaurran Bmy”, che nel 1919 già
più non c’era.
Ancora nel 1920,
rappresentava un vero e proprio quadrivio, con due direttrici: De Marini-Lanterna
uno, e Tunnel-via Vittorio Emanuele l’altro. I dazieri, facevano sostare i
camion nello slargo, per controllare la merce. La rupe scoscesa, faceva da
insuperabile barriera.
Nel Pagano 1925 al civ.
8 aveva sede la “creolina Guglielmo Pearson”(tel. 41.316.
Telegr.Pearson”--proprietario esclusivo della denominazione “creolina”
disinfettanti-saponi-prodotti chimici; andrà poi in via V.Emanuele).

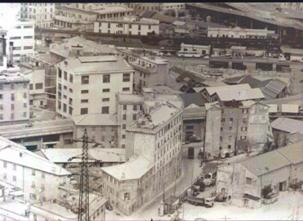
Nel 1926 rimase a San
Pier d’Arena perché unica piazzetta, classificata di terza categoria, nelle
vicinanze del faro.

Al
centro della foto, lo spiazzo di Largo Lanterna. A sin. facciata di case il cui
portone era in via de Marini; con sopra -in alto- il tetto della Nuova Darsena;
dal basso in centro, a salire, i resti della via Vitt.Emanuele; le case in
basso a destra le ultime della Coscia. Foto anni 1970
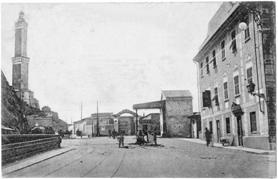
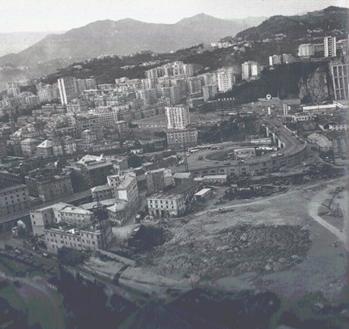
1920
Largo Lanterna – ingresso bagni 1963- spiazzo per costruzione Nuova
Darsena
Margherita-
vista da via DeMarini
Nel Pagano/40 è ancora
posta tra via Vitt.Emanuele e via DeMarini; non ha civv., ed ha segnalato solo
‘Autobus C’.
Come parrocchia, commissariato e
Giudice conciliatore faceva capo a san Teodoro; e per il ‘gruppo rionale’ al
‘circolo E.Toti’..
Tale rimase fino al magg.1999
, da quando praticamente non esiste più, abbattuti i civv. 1, 2, 3, 4 che la
formavano, e via De Marini che prosegue
snellita, ma deformata e snaturalizzata.
Una linea ferroviaria,
sottostante la strada, attualmente non più in uso ma tutt’ora visibile
sporgendosi dalla ringhiera a levante, si divideva subito dopo lo slargo in
due binari che si immettevano in due gallerie distinte (anch’esse ancora
visibili): a destra quella detta “galleria Sanità”(arrugginita, c’è ancora la
targa e porta alla calata omonima in porto ), e l’altra attualmente anonima (si
chiama del “Passo Nuovo”) che dirige verso Di Negro-Principe.


L’imboccatura delle gallerie sottostanti, dalla strada; come
era e come è
Per chi ama le cose antiche,
era un luogo pateticamente poetico; la sua distruzione - legata all’improprio
uso da parte di immigrati clandestini - rappresenta una ferita difficilmente
colmabile: abitata prevalentemente dai minolli e pescatori, vi faceva angolo
una casetta assolutamente non bella, ma con un fantastico terrazzino fatto a
prua di nave (come si vede – vissuto - nelle vecchie foto, e come si vedeva
squallidamente deserto negli ultimi anni); la facciata a mare del terrazzino
faceva supposto alla targa stradale marmorea di “via Vittorio Emanuele”, ora
probabilmente a pezzi in mezzo alle macerie.
Quando fu deciso di costruire
il viadotto soprapassante via V.Emanuele per costruire la salita d’avvio
all’autostrada, la via V.E venne tagliata e chiusa cosicché anche il troncone
di strada rimasto a levante della rampa - lungo un centinaio di metri -
assunse il nome dello slargo: allora sulla targa suddetta, fu sovrapposta la
nuova targa marmorea segnalante “Largo Lanterna”.
Una novella Piccapietra
sampierdarenese, con la beffa dell’abbandono dopo uno squalificante degrado,
non più ricuperabile neanche se arriveranno tempi economicamente migliori.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica, scheda 2337
-A.sconosciuto- Guida del porto
di Ge.-Pagano 1954-pag.731
-Balino Flora-Editori, tipografi
e librai nella Liguria-La Berio-1/2002.7
-DeLandolina GC.-Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.45
-Dellepiane R.-Mura e
fortificazioni di Ge.-NEG 1984-pag. 141foto
-Forti LC.- le fortificazioni di
Genova-Mondani 1975-pag.25
-Gazzettino Sampierdarenese
5/78.6 + 3/90.9
-Pagano/40-pag.314
-Tuvo-Sampierdarena come eravamo-Mondani 1983-80foto
LANTERNA via (alla) Lanterna
salita della Lanterna
via Porta della Lanterna
Sono tre titolazioni ad uso popolare,
e quindi intercambiabili corrispondenti al tratto che univa il Largo Lanterna
alla Porta omonima, scavato nella roccia posta a strapiombo dal forte
soprastante; e, dalla strada sul mare.
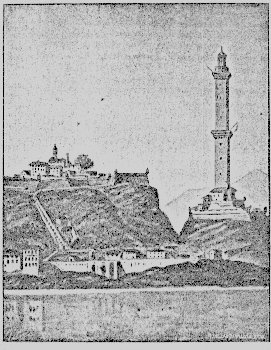

stampa
della salita; segnala la cappella
del
SS Salvatore
La causa della non definita
titolazione ufficiale a questo tratto di strada, può essere ricondotta alla
lunga e non risolta diatriba tra i Comuni di Genova e San Pier d’Arena i quali,
ambedue, ne vantavano diritto al possesso (ed anche al dazio) addivenendo alle
vie legali e quindi nessuna delle due autorizzata a farlo sino a fine sentenza;
che infine non avvenne perché nel 1926 Genova ‘fagocitò’ il Comune vicino.
La prima delle tre è citata solo
dal Novella tra le via di San Pier d’Arena, e già nel 1910 era in disuso da non
esistere più. Però la ‘Guida del porto’ edita dal Pagano nel 1954 segnala la
persistenza di una “via alla Lanterna, dal termine della «via al Passo Nuovo»
alla cinta doganale del «varco di ponte Etiopia»”, in territorio di proprietà
del CAP.
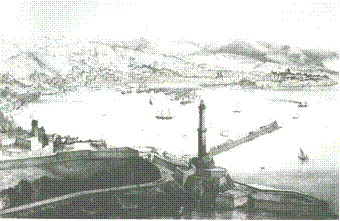
Litog.Schultz;
disegno Guesdon. Vista dall’alto
(da
pallone aerostatico?) – 1850circa –
litogr.
362x469 – Hauser, Parigi.
________________________________________________________________________________
1 STRADA – 2 PORTA –
3 LANTERNA
(ciascuno in sequenza cronologica
- per le Mura, vedi a via Bastioni)
1 -
LA STRADA fin dai remoti tempi dei romani,
il viandante sia appiedato che con animali e carri, dalla riviera di ponente o
dalla Valpolcevera per raggiungere la città o il suo porto aveva una sola
strada più corta ed agevole: salire al Belvedere, superare san Benigno e
discendere alla Chappella (Di Negro), scavalcando dall’alto tutta la lunghezza
della spiaggia. Aprire un passaggio lungo la riviera, dove la scogliera era
dura roccia e ripida, per le 1-200 anime che abitavano il borgo, col rischio
che la via potesse essere usata da nemici invasori, non era convenienza di
alcuno .
Probabilmente, i primi sentieri furono aperti dagli abitanti della Coscia
quando si perfezionò la costruzione della prima torre di segnalazione con
fuochi attorno all’anno 1128. Fu forse
ampliata a carrettabile quando le mura arrivarono alla porta dei Vacca (1155),
ma solo dalla parte a levante: sono di quell’epoca ordinanze mirate a dividere
il traffico tra le due strade, quella sul colle e quella a mare; quest’ultima
regolata anche con sbarramenti a difesa sia dalla parte della Coscia che
dall’altra a levante. La zona divenne Capo Faro quando si iniziò ad usare
vetri di ampliamento della luminosità.
Una
certa viabilità doveva già esserci nel 1548
quando l’arciduca Massimiliano (figlio del re di
Boemia Ferdinando I il quale ricevette la dignità imperiale sugli stati
tedeschi dal fratello CarloV quando il 12 settembre 1555 questi decise di
abdicare), dopo aver sposato per procura
la cugina infanta Maria Teresa figlia di CarloV, proveniente da Augusta-Innsbruck-Mantova-Milano) arrivò a Genova (20 luglio) per imbarcarsi per
Barcellona-Valladolid a sposare ufficialmente Maria Teresa. Seguito da folto corteo di gentiluomini (Alemanni,
Boemi, Spagnoli, Borgognoni, Fiamminghi) fu ospitato a Fassolo; prima, 150
giovani genovesi (con “riche veste tel d’oro e d’argento’; e dame e damigelle,
mirabili per bellezza e ricchezza di ornamenti, che occupavano le finestre e le
porte di tutte le case poste lungo il percorso) gli erano andati incontro a
8miglia; tra suoni di tromba e tamburi lo
scortarono per San Pier d’Arena ove “per la strada de la Lanterna… era concorso
puoco men di tutto il popolo di Genova”.
Lo stesso itinerario nel 1581, quando la su descritta imperatrice
Maria, vedova del Massimiliano di cui sopra, ritornò a Genova arrivando
da Voltaggio e Cornigliano (ove dormì), per il Ponte (riaggiustato per
l’occasione) fino a Fassolo; e nel febbraio 1599
quando arrivò Margherita, figlia di Carlo di
Stiria col cugino Alberto arciduca d’Austria, diretti in Spagna per sposare rispettivamente re Filippo III e la
sorella l’infanta Isabella Clara Eugenia.
Per
l’occasione fu eretto presso la Lanterna un maestoso arco
trionfale costruito dallo scalpellino Taddeo Carlone riutilizzato poi quattro mesi dopo per altra
occasione; vivacemente colorato, costruito con materiali “effimeri” –legno,
stucco, tela a riproduzione di marmi policromi e bronzi dell’”architettura
durevole”; statue degli Asburgo con scene della loro vita: primi nominati a
reggere il Sacro Romano Impero, nozze, vittoria sui turchi a Lepanto). Nel percorso, Alberto “intenditore ed appassionato
d’arte, aveva anche apprezzato particolarmente il “deliziosissimo piano” di San
Pier d’Arena, ricco di “artificiosi palazzi e ville”, del quale aveva richiesto
un “disegno in pittura”.
L’invasione
portata pochi anni prima da Carlo Emanuele duca di Savoia ed i francesi,
determinò negli anni 1626 la necessità
di costruire la settima cinta di mura con
l’istituzione del “Magistrato delle nuove mura”, composto da vari ingegneri ed
architetti militari (tra i quali l’ing.
militare frate Gaspare Maculano -Barozzi scrive Vincenzo perché noto come padre
Vincenzo da Fiorenzuola, un domenicano divenuto poi cardinale; don Giovanni
DeMedici; Ansaldo DeMari; e, con a capo di tutti, Bartolomeo Bianco). Essi, studiando, elaborando ed aggiornando progetti di
Gaspare Vasari del 1568, proposero l’inizio dei lavori partendo proprio dalla
Lanterna. Tutto doveva soddisfare l’esigenza di “bellezza, fortezza,
magnificenza, comodità”, ma anche di salvaguardia alle irruzioni.
Il progetto fu approvato il 6
maggio 1626.
La cerimonia della posa della prima
pietra avvenne il 7 dic.1626,
presenti:
---i
Deputati delle Mura; ---l’arcivescovo di
Savona Domenico De Marini che celebrò il
rito religioso all’aperto su un altare arricchito dal reliquiario contenente il
braccio di san Giovanni Battista poi portato in processione; l’Arcivescovo di
Genova non aveva voluto partecipare per attrito col Doge che gli impediva di
spostarsi in città seguito da armati personali; ---Gio Vincenzo Imperiale (vedi
“villa Scassi”) quale Cerimoniere; ---un
carmelitano chiamato Domenico di Gesù e Maria, che pronunciò il sermone; ---tutte le
confraternite; --- i consoli di tutte le arti, ---i serenissimi Collegi, nobili
e tanta massa del popolo. Il doge Giacomo Lomellino chiuse la pietra: un
cubo di marmo, di due palmi di lato – sulla facciata esterna del cubo marmoreo
fu incisa una iscrizione dettata da Gio Vincenzo
Imperiale procuratore dei deputati e valente poeta (“vedi villa Scassi”)
con questo testo: “divisque io, Baptistae, Georgio - Laurentio et Bernardo
tutelaribus - proflicato bello - ad hostium terrorem civium securitatem
libertatis propugnacolum - hic undequaque moenia montibus
abtanda - se suaque dicabat - ures Genua - religiosa unanimis inconcussa - anno
salutis MDCXXVI - VII decembris (= a Dio, alla Madre di Dio, ai protettori
Giovanni Battista, Lorenzo, Bernardo, terminata la guerra, a terrore dei
nemici, a sicurezza dei cittadini, a difesa della libertà , qui e per ogni dove
poste in assetto le mura, la città di Genova religiosa e inconcussa dedicava
unanimemente se stessa ed ogni sua cosa, anno del Signore 1626, 7 dicembre“).
Questa
pietra, andò perduta durante gli scavi del 1861.
Dentro la quale fu posta una grossa medaglia d’argento di mezzo palmo di diametro, unico conio prodotto dall’orafo Antonio
Assereto, racchiusa da una custodia di rame, raffigurante da un lato lo stemma
della Repubblica e l’iscrizione “Dux et Gubernatores - 1626; e sull’altra
faccia l’immagine di nostro Signore, della Madonna – eretta, col Bimbo a
sinistra in braccio - e dei quattro protettori, circondata dai 4 santi protettori:
alla sua destra Lorenzo e Giovanni Battista; a sinistra Giorgio e Bernardo. Questo
medaglione, del peso di 950 gr. e del diametro di 13 cm fu casualmente
ritrovato nel 1861 durante gli scavi di demolizione di san Benigno; fu
acquistato all’asta dal collezionista locale Luigi Franchini, ma andò disperso
quando la sua collezione andò all’asta nel 1879; si scrive che fu acquistata da
un inglese, del quale si sono perdute le tracce. Sulla base di ricerche
archivistiche, il disegno fu riprodotto nel 1978 (vedi A Compagna, 1977, n.6)).
La
cerimonia fu seguita da una raccolta di oblazioni e da un solenne Te Deum in
cattedrale. Tutte le navi e le artiglierie di difesa cittadina, esplosero
assieme con salve di cannoni, la loro partecipazione.
Dapprima, essendo zona militare, per i viandanti la strada percorribile era sempre quella che da
porta san Tomaso (zona Principe), dalla
zona oggi DiNegro salire a Promontorio; altrimenti era necessario usufruire di
servizio via mare.
I lavori, a ritmo continuato
iniziarono solo nel 1630, e i 20 km di
mura vennero eretti in tre anni sotto la direzione dell’architetto Ansaldo De Mari –
poi di Bartolomeo Bianco da 800 operai,
con il concorso economico – una tassa proporzionata al reddito individuale- per
quasi 20 chilometri. Furono poste ben nove porte (cinque sui crinali all’incrocio con le mulattiere necessarie per i
commerci con l’interno. Tre con le direttrici della riviera: la nostra; la
porta Romana presso il ponte di s. Agata e verso la Valbisagno; e la porta
Pila verso la Foce ed Albaro corrispondente
a levante della nostra. Nonché due sul mare, a Ponte Reale ed a Ponte Spinola).
La
grandiosità finale suscitò l’interesse di papa Urbano VII al quale furono
inviate due tele dipinte da Andrea Ansaldo raffiguranti in pianta ed in
prospettiva la città con la cerchia.
 Tagliata litogr. Louis
Lebreton-Metà 1800
Tagliata litogr. Louis
Lebreton-Metà 1800
Partendo dalla punta estrema di
san Benigno, aprirono una esigua via lungo la scogliera sul mare, arrivando a tagliare
la pietra a monte della Lanerna e riempire la scarpata a mare (da questa opera,
la zona venne chiamata ‘Tagliata della Lanterna’
una terrazza completamente artificiale, aperta
su terreni già di proprietà della villa del marchese G.B. Serra e piazzale
d’accesso alla vera porta di ingresso. Quindi non era una via vera e propria,
quanto solo uno stacco, d’unione tra via De Marini e la spianata alla Porta, e
che iniziò a chiamarsi “via Lanterna”).
Anche lungo la scogliera
vennero eseguiti tagli di roccia, riempimenti, pilastri e muretti di sostegno
sul vuoto sottostante: per chi avesse avuto necessità di oltrepassare
l’ingresso, salendo da San Pier d’Arena, doveva superare quattro posti
successivi di guardia: ---il primo ostacolo
era rappresentato dalla “porta dei grifoni”,
così chiamata per la cancellata a sbarramento, sorretta da due pilastri con
sovrapposta in marmo l’immagine simbolica della città; ---questa era
seguita da un ponte levatoio dietro a cui erano ---altre
tre cancellate la più interna era la più
importante strutturalmente, detta “avanzata della Lanterna”; ---questa
era seguita da un secondo ponte levatoio e ---dall’ultima, la quinta,
cancellata (a ridosso di quest’ultima, era una
piccola cappelletta che racchiudeva un altare e
l’effige del SS.Salvatore; demolita la struttura nel 1719, l’immagine fu
trasferita all’abbazia di san Martino): così si raggiungeva la
“tagliata”.
Così infine, la strada acquisì
dignità di nome specifico.
Una lapide
venne apposta alla fine dei lavori nel 1633 là dove si
prospettava sarebbe stata costruita la facciata della nostra porta, quella
principale verso ovest, nel piano della Lanterna, volutamente - per ragioni difensive - più piccola
delle altre porte, atta da soddisfare appena l’accesso a carretti.
Sul piazzale rivolto al mare, fu
posta una batteria con 12 pezzi di cannoni, sistemata dietro grossi parapetti a
merloni e a cannoniere; risultò inutile nel 1684,
quando ci fu il bombardamento dal mare da parte
della flotta di Luigi XIV, con tentato sbarco sulla nostra spiaggia, per inefficienza
di potenza di tiro ma anche per imperizia.
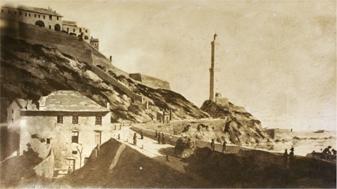 da un quadro dl
1600.
da un quadro dl
1600.
________________________________________________________________________________
2 – LA
PORTA - l prospetto, in stile dorico, ideata dal carrarese Giovanni
Antonio Ponzanelli (1650-1735; Tuvo-Campagnol
scrivono Ponsonelli; Gardella scrive Giacomo Antonio, e 1654-1735).

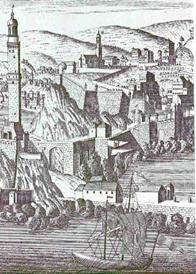
ingresso da San Pier d’Arena la
porta di uscita da Genova,
stampa
del 1632
Al
di fuori, racchiusa tra caserme a monte ed un bastione a mare, appariva
massiccia e con fregi vari; due colonne di stile dorico erano ai lati
dell’unico alto fornice.
_______________________
La
statua -
la porta fu sormontata da una
ben precisa statua, rappresentativa della Regina della città di Genova, della
”Madonna col Bambino“: seduta col Bimbo sulla
coscia, lei incoronata e con lo scettro, e lui con le chiavi (detta anche semplicemente la Madonna di Genova, o
Augusta). Una bolla del 1630 di papa Urbano VIII, stabiliva che aveva diritti
solo chi avesse avuto rango reale; questo indusse la Repubblica ad assumere nel
1637 il titolo regio, tramite l’espediente di nominare regina la Madonna,
salvaguardando così l’integrità repubblicana e la devozione particolare che la
città sempre onorava alla madre di Dio. Nei Libri Cerimoniali, si volle che
l’immagine della Vergine col Figlio -sia sulle mura che sulle monete- tenesse
in mano una pergamena con scritto “et rege eos”, sovrapposta allo stemma della
Repubblica).

Era stata
ordinata a Bernardo Carlone (nato nel 1637 circa; figlio di Giovanni da Rovio;
fratello maggiore di Tommaso; è persona poco documentata ed ha oggi poche opere
attribuite, perché dopo un breve soggiorno a Modena negli anni tra il 1650-60,
morì precocemente in terra d’Austria. Questo fece sì che inizialmente numerose
furono le attribuzioni dell’opera ad altri scultori, tra i quali: il fratello
minore Tommaso Carlone; Bernardo Castello; Domenico Scorticone. Recenti studi
di Elena Parma e MariaClelia Galassi –in sintonia con i Remondini-
attribuiscono l’opera a Bernardo), e fu messa in loco nel 1643.
I Remondini
raccontano che nell’anno 1857 la statua
fu posta a restauro (specie nel rifacimento di
una mano ed un piede della Madonna; di un braccio e dito del Bambino;
indoratura della corona, scettro e chiavi). La
cifra necessaria era stata raccolta dal popolo, in particolare dai
sampierdarenesi: Maddalena (o Chiara) Serra, Domenico Carpaneto, Giuseppe
Sommariva, Lorenzo Bennati, Giovanni Bottino). Anzi, la cifra accolta
–superando le 700 lire a fronte delle 416 necessarie- permise restaurare anche
la Madonna di Porta Pila).
Vi rimase fino al 23 marzo 1878
essendo stata decretata l’anno prima la demolizione della porta per nuovi piani
urbanistici. Rimossa di notte (“per non provocare maggiormente il disgusto
della popolazione”), fu calata tramite una imbragatura che prevedeva un cappio
attorno al collo: nessun operaio volle eseguire la legatura e fu affidata ad un
non genovese. Dapprima fu posta sulla vicina porta di san Tommaso (a Principe),
ma dopo pochi mesi, già nell’ottobre, il giorno 22 si costituì una commissione
della Confraternita di s.Antonio Abate, della Marina, mirante ad una
collocazione più degna e ad un periodo di ‘riparazione’ morale per l’affronto
fatto all’immagine della Regina (tridui di preghiere e s.Messe).
La loro assiduità ottenne che la Madonna fosse
affidata alla Confraternita del suddetto Oratorio, previo pagamento -registrato
con atto notarile (30 ottobre 1878) - di
lire una,05 annuale. Così dapprima fu collocata nella loro chiesa (le spese furono totalmente sostenute da un loro
confratello, il cav. Angelo Borgo, che donò le 308 lire necessarie
all’operazione effettuata da lui stesso con la sua impresa, come da rendiconto
del 1879).
Con delibera del 1884
(3 marzo) il Comune di Genova comunicò ufficialmente l’autorizzazione ad un
collocamento della statua e della lapide col ‘Posuerunt me custodem’,
nell’Oratorio.
Inutilmente nel 1887
una nuova ondata popolare, guidata da alcuni consiglieri, raccolse ben 83mila
firme ad una petizione mirata a ricollocare la statua nella zona della Lanterna
presso il mare.
Solo nel 1937,
per interessamento del cardinale Dalmazio Minoretti la statua fu restituita al
Comune che la donò al Consorzio Autonomo del Porto. Sulla facciata
dell’Oratorio, fu posta una lapide a ricordo della conservazione della statua.
Il CAP, ente nato nel 1903, si assunse l’onere –dopo
solenne cerimonia in s.Lorenzo, con benedizione delle insegne, corona, scettro,
chiavi- della definitiva sistemazione sulla punta del molo Giano, accanto alla
Torre dei Piloti, in posizione sud-ovest e con la scritta “Genova, città di
Maria Santissima”.
Vicino fu posta una lapide
a ricordo: «LA MADONNA - POTENTE PRESIDIO
DEL NOSTRO MARE - PER OLTRE DUE SECOLI – SULLA PORTA DELLA LANTERNA – DEMOLITA
L’ANNO MDCCCLXXVII – DOPO DODICI LUSTRI – PER CONCORDE VOLONTA’ DEL POPOLO –
EBBE QUI NOVELLO TRONO – BENEDIZIONE DIVINA – ALLE NAVI ARDIMENTOSE – CHE NELLE
TERRE PIU’ LONTANE – ESALTANO – IL GENIO E LA FEDE – DI GENOVA CREDENTE ED
OPEROSA»
Durante l’ultimo conflitto mondiale, il 4 settembre 1944 la statua
precipitò in mare.
Il giorno 7 febbraio del 1946 fu occasionalmente ritrovata mutilata sul fondo, da
alcuni operai dell’OARN impiegati nello sminamento del porto (ricerche più
minuziose fecero ritrovare anche le parti mancanti: l’avambraccio destro,
scettro, corona ed il tronco del Bambino). Subito si istituì un comitato, ma i
cui fondi non risultarono sufficienti a coprire le spese. A seguito
dell’interessamento del card. G.Siri e dell’ONARMO, nel 1952 il prof. Ortelli poté completare il restauro
e l’11 maggio la statua fu ricollocata sul molo Giano.
Nel 1999, all’atto
della costruzione della nuova Torre dei Piloti, si decise farne una copia da
collocare sul molo, preservando l’originale in luogo più consono, nel cortile
dentro il Palazzo san Giorgio. Il calco, eseguito dal restauratore Axel Nielsen
permise farne una copia in vetroresina, attualmente esposta presso la Nuova
Torre dei Piloti.
____________________________
In
alto, sul basamento e sotto la statua, fu posto la scritta “ posuerunt me custodem”; sotto
ancora, coperta da due grifoni e stemma, una lunga lapide: NE MUNIMENTA NATURAE - HOSTIS VERTERES IN PERICULA -
TERTIUM SIBI MORORUM AMBITUM - PER ORAM MARIS ET JUGA MONTIUM - PERICOLOSISSIM?
TEMPORIBUS - LIBERTAS TRIENNIO - FESTINABAT- ERECTUM ANNO SAL. MDCXXXIII -
RESTAURATUM MDCCXII : affinché il nemico non volga a danno le difese concesse
dalla natura - il terzo giro di mura lungo il lido del mare ed i gioghi dei
monti - in tempi pericolosissimi - il popolo libero in tre anni si affrettava
a compiere- eretta l’anno del Salvatore 1633 - restaurata nel 1712.
(Questa
lapide fu rimossa all’atto della distruzione della porta, e collocata nel
vicino bastione nel 1884; così è scritto in altra lapide posta-sulle
mura prospicienti via Fantuzzi- una nuova targa a memoria (a sua volta scomparsa con le demolizioni del colle di
san Benigno): «VETEREM PORTAM AD PHARUM - ANGUSTO LOCO EXTRUCTAM
IANDIU COMMEATIBUS IMPAREM - V IDUS FEBBRUARIUS ANNO MDCCCLXXVII - ORDO
GENUENSIS AMOLIENDA DECREVIT - TITOLUM INDE REFIXUM IN PROXIMO DIRUTAE MOLI
PROPUGNACOLO - STATUENDUM CURAVIT MDCCCLXXXIV»: l’antica porta al Faro -
costruita in luogo angusto insufficiente al traffico - l’8 febbraio 1877 - il
Comune genovese decretò la demolizione - L’iscrizione di là rimossa dalla
porta demolita si stabilì di ricollocarla nel vicino bastione il 1884).
Le possenti mura diedero accesso
alla città tramite una porta, posta
circa cento metri più a levante della Lanterna stessa (con un prospetto in stile dorico ed un solo fornice d’entrata-uscita
(lo schema tipico, già elaborato anche dall’altro architetto che si interessava
della porta - Giovanni DeMedicis - aveva il
transito centrale aperto sulla via da unico fornice, ed era affiancato da due
ampi locali a lati, dei quali quello a mare prevedeva anche un vano prigione.
Fu arricchita da fregi dal carrarese Giovanni
Antonio Ponsanelli (1650-1735) e sormontata da una statua della Madonna scolpita da Bernardo Carlone, al cui basamento stava scritto “Posuerunt me custodem”; ed una lapide -retroposta allo stemma cittadino in rilievo -
con l’iscrizione latina: «Ne munimenta naturae - hostis verteret in pericula -
tertium sibi murorum ambitum - per oram maris et juga montium -
periculosissimis temporibus - libertas triennio - festinabat - erectum anno s.
MDCXXXIII - restauratum MDCCXII» = affinché
le difese naturali -il nemico non le volgesse in pericolo - un terzo giro di
mura - lungo la spiaggia marina ed i gioghi montani - in tempi pericolosissimi
- la Libertà in un triennio - compiva - eretto nell’anno del Salvatore 1633 -
restaurata nel 1712.
(Miscosi
scrive eguali le parole della lapide, escluso in fondo ove lui dice che era
scritto “erectum a. salutis MDCXXXIII – restauratum A.D. MDCCXII”= eretta
nell’anno della salute 1633 – ristorata l’anno del Signore 1712).
Il 14 luglio 1794 la porta fu attraversata da Napoleone: ancora solo comandante l’artiglieria
dell’Armata d’Italia, vi passò proveniente da Loano assieme a sette altre
persone tra cui il fratello Luigi e tre generali. Nei quattro giorni di
permanenza, seppur costantemente pedinato, poté liberamente spingersi a
guardare le difese della Tenaglia e di san Benigno
(la Repubblica era con i ‘turisti’ tutt’altro che chiusa e sospettosa; eccetto
nelle questioni private di famiglia o palazzo, permetteva nel suo territorio
ampia libertà nonché una certa cordialità festaiola, ricca e godereccia. Però,
quello che era fuori delle mura sino al confine, era considerato ‘colonia’: era
sì abitudine aristocratica avere una villeggiatura, ma non per valutare la
riviera quanto che fosse opportunamente vicina da non creare distacco dai
propri affari entro le mura).
Il 26 novembre 1796, seguita da un
piccolo corteo, arrivò da Milano Giuseppina
Tascher (o meglio Marie-Josephine-Rose) de
la Pagerie, vedova Beauharnais, viscontessa, già
amante di Barras, da marzo 1796 moglie di Napoleone Bonaparte (una visita diplomatica? una fuga d’amore con
Ippolito Charles suo cavalier servente ed amico del cuore? Una vacanza proposta
dal Serra, corredata da feste, conversazioni, giochi (sui prati –erano in voga
‘il gioco del pallone’ o palla a mano, le bocce, e ‘la barre’-), mondanità e
banchetti, ultimi sussulti di grandezza dei nobili che senza curiosità per
l’improvviso arrivo, le aprirono le case e gli sfarzi?- I Beauharnais erano una nobile famiglia dell’Orleans;
Alexandre -1760-94- aveva sposato Giuseppina con la quale aveva avuto due
figli; di essi Eugenio de Beauharnais diverrà 1805 viceré del regno d‘Italia). Per garantirle
sicurezza, Faipoult - della legazione francese a Genova sita in piazza Fontane
Marose - fece entrare in città delle guardie francesi, accasate in San Pier
d’Arena ove era un ‘deposito’ militare (alcuni ufficiali senz’altro erano
ospitati nelle ville della Fortezza e degli Imperiale). Improvvisamente la sera
del 2 dicembre, richiamata dal marito geloso, riattraversò di notte - per la
Bocchetta - l’Appennino.
Una carta del colonnello Brusco datata 1797,
riporta sulla strada ancora l’esistenza del ponte levatoio. Sarà rimosso con la nuova porta della Lanterna. Sopra
il ponte si prolungava un muro, da esso ai bastioni, già allora con vistose
crepature e interruzioni, presumibilmente limite della vicina casa dei DiNegro.
Presso questo muro era la nicchia con l’effige del SS Salvatore.
Da quest’anno la porta alternò libero transito e chiusura,
a seguito di cambiamenti di fronte, rapidamente
uno susseguente all’altro:
---come
da anni ed anni, ancora nella primavera-estate venne attraversata da lussuose
ed imbaldaccate carrozze -dagli sportelli dipinti dello stemma nobiliare-
condotte da numerosi serventi che portavano i vari patrizi e relative dame
imparruccati ed incipriati, nelle residenze estive, oppure da rade portantine
per singoli signori in movimento tra ville e città, carichi di muli. Il
traffico maggiore, è ancora condotto via mare. Genova, e con lei San Pier
d’Arena, sono ancora speranzose ed alla ricerca di motivi di festa per potersi
distrarre dalla normale routine fatta di sporcizia, fame e sudditanza:
occorreva adattarsi ed inneggiare alle coccarde, agli alberi della libertà, ma
- non era una novità - anche all’occupazione del più forte.
---a
maggio, il primo attacco interno dei ‘Vivamaria’: vincendo i giacobini posero
da dentro le mura uno stato di assedio in conseguenza del quale chiusero le
porte cittadine; fu Napoleone nel luglio che con drastica decisione impose la
condotta da seguire: la nascita della Repubblica Ligure.
---a
settembre il riemergere dei Vivamaria quando il nuovo regime democratico aveva
offerto quanto di più democratico si poteva avere: una nuova Costituzione, da
votare. Ma la stesura del documento, affidata ad una commissione di saggi,
vedeva prevalere tra i religiosi l’idea dei giansenisti del Degola (vedi), in aperto contrasto e molto, troppo
lontana dalla Curia (con l’arcivescovo
allontanato e pronti a sostituirlo con un sacerdote giansenista, dove vasi
creare a fianco di uno Stato laico modellato su quello francese, una Chiesa
volutamente povera (alla quale erano stati confiscati tutti gli arredi d’oro ed
argento) e senza privilegi, con gerarchie e cerimonie non centralizzate; erano
inseriti nel programma problemi grossi come i diritti civili dei preti, le
ordinazioni dei sacerdoti, le dispense per i matrimoni, l’inviolabilità dei
luoghi sacri, la validità delle leggi laiche prevalenti su quelle
ecclesiastiche): tanto bastante perché i
parroci periferici - e per noi della Valpolcevera - impauriti della ritenuta
volontà dei democratici, di distruggere la religione e gli ordinamenti
religiosi, il giorno 3 facessero scattare la rivolta. I paesani, arruolati in
squadre armate solo del numero, della rabbia, della paura, di falci e forconi,
al grido di Vivamaria, e guidati da cittadini più intraprendenti e
politicamente impegnati, da San Pier d’Arena salirono per occupare il forte di
san Benigno, il Tenaglia e poi lo Sperone. Invano l’arcivescovo Giovanni
Lercari cercò di rassicurare che la nuova Costituzione non era poi così
distruttiva (non era del tutto vero; anche se in quel momento occorreva di più
calmare gli animi ed evitare lo scontro con gli armati; difficile ed
improponibile ripetere il 1746 contro l’Austria. Viste inutili le trattative,
il 5 settembre il generale Duphot (di Lione: dopo aver condotto questa
contro-controrivoluzione, fu trasferito a Roma ove rimase ucciso a dicembre
nel sedare anche là una rivolta antigiacobina) con armati schierati in ordine, quasi senza combattere rioccupò
Belvedere, Promontorio, san Benigno, indi liberò il Tenaglia occupato dai
ribelli (e poi infine anche lo Sperone). Di nuovo interpellato, Napoleone
consigliò accantonare gli articoli che riguardavano i religiosi (dando così una
scrollata ai giansenisti ed amicandosi il Papa di cui aveva più bisogno nei
suoi programmi futuri). La Costituzione così modificata, il 2 dicembre fu
sottoposta al voto ed approvata dalla quasi totalità dei 115.890 elettori (1192
votarono contro).
---Nell’anno
1800, le truppe austriache posero assedio
a Genova accerchiandola da terra (la flotta
inglese dal mare) attestandosi a Cornigliano e Rivarolo: appena giunti, il
comandante Hoenzollern all’alba del 22 aprile assaltò con un reggimento
(chiamato Nadasky) le fragili linee franco-genovesi, e giunse quasi a passo di
corsa attraverso il borgo fino al ponte levatoio; qui però la reazione fu più
intensa e mirata, e l’assalto fu arrestato; nel frattempo due battaglioni
discesi dal Belvedere, costrinsero gli imperiali a rientrare al di là del
torrente Polcevera, pagando l’assalto con 115 morti e 328 prigionieri (contro i 37 morti franco genovesi (cifre di fonte francese). In un rapporto fatto da un ufficiale francese, si
legge che durante il combattimento, alcuni abitanti di San Pier d’Arena avevano
sparato contro i suoi soldati, e che alcuni contadini ne avevano ucciso uno già
ferito. Questo fatto dimostra la brutta posizione degli abitanti del borgo,
lasciati fuori e non difesi dalle mura, alla mercé dell’attaccante che
certamente non era tenero: furti, vessazioni, violenze fisiche e sessuali,
reclutamento obbligatorio; anche se coloro che desideravano vivere fuori delle
mura erano genericamente indifferenti alle lotte di potere o addirittura
contrari al governo specie quello francese perché rappresentante di idee
rivoluzionarie anti religiose).
La
strada fu percorsa il 4 giugno di
quell’anno dai francesi di Massena, diretti verso ponente, vinti ma con l’onore
delle armi;ma poi rientrati il 23 giugno 1800, dopo la vittoria di Marengo.
---nel
1805, il 30 giugno, il doge Michelangelo
Cambiaso (allora chiamato “maire”, corrispondente al nostro termine di sindaco,
in quanto che la Repubblica era nuovamente soggiogata dalle truppe e potere
francese) , nei pressi della porta,
consegnò a Napoleone le chiavi della città, che rifiutò sottintendendo il
mantenimento della libertà repubblicana.
Nel 1814
una mareggiata più intensa del solito, distrusse la muraglia
di sostegno della strada e di protezione della strada della marina (via San
Pier d’Arena). I lavori di ripristino furono
affidati con appalto del 1815 all’impresa Cremona Ippolito e la prosecuzione il
26 marzo 1817 a Maffei Domenico, ma tanto si costruiva e tanto il mare si
rimangiava irrimediabilmente tanto che fu riaffidata nel 1826 all’impresa
Picasso Antonio (appalto del 8 maggio per 9.581 lire, ma non eseguita al
completo per mancanza di fondi).
Con l’arrivo del regno di
Sardegna dei piemontesi, nel 1819 circa,
essendo anche cambiata la potenza delle armi e le necessità di difesa, fu
deciso dal Commissario Prefettizio Felice Segre (definito
ebreo borioso, massone e spadroneggiante) dismettere l’uso di questa porta e di tutti gli sbarramenti (cancellate ed i ponti levatoi considerati ostacolo al
transito ‘moderno’ visto che molti ancora preferivano farsi traghettare via
nave raggirando l’ostacolo).
Il 4 dicembre 1822 l’ingegner Argenti Francesco propose
allargare la strada presso il ponte
levatoio in quanto la ristrettezza costringeva i
sempre più frequenti carriaggi a fermarsi, adottando un irritante ‘senso unico
alternato’. L’acquerello di Parker, è
significativo per la scoperta del nuovo ‘punto di vista’ inteso come
circolarità della visione, che troverà poi esito nel diorama di Daguerre.
Nel 1828
(Praga scrive 1827; Alizeri a pag. 565 dice Giovanni Chiodo, e nel 1830)
l’inizio lavori per apertura in Genova dell’attuale via Gramsci (1831) e le migliorie della strada a mare, nonché nuove
e continue necessità militari richiesero la ristrutturazione della cerniera
difensiva: una seconda porta fu
ricostruita vari metri più a ponente, su disegno del generale del Genio Agostino Chiodo (1791-1861
ingegnere militare savonese, che ebbe brillante carriera militare e politica
sino a divenire presidente del Consiglio dei Ministri) (Alizeri-pag.641 dice G.B.Chiodo, fratello di Agostino, ma
sbaglia), in vivo macigno, con due aperture. nel Nel 1831 venne apposta nel centro un grosso stemma
cittadino inquartato con quelli dei Savoia (vedi sotto).
Anche questa porta fu distrutta 50
anni dopo. Ma, ancor prima di procedere alla demolizione – che avvenne in forma
completa nel 1935, furono risistemate alcune parti sul lato ovest del colle, in
particolareil frontespizio con al centro lo stemma sabaudo variamente
inquartato e con la lapide sottostante. Ulteriori restauri a tutta la zona, la
resero visitabile dal 2001 (l’opera del Chiodo
venne ricordata in una epigrafe incisa su una lapide murata all’esterno,
dettata e tradotta da Marco Faustino Gagliuffi).
La targa recita « REX CAROLUS
FELIX / CASTELLIS INSTAURATIS AUCTIS PORTU NOVIS MOLIBUS MUNITO / CLASSE
INSTITUTA EMPORIO IMMUNI AMPLIATO URBE EXORNATA / HANC PORTAM ET MOENIA
DE COLLE AD PHARUM EXTRUEBAT A. MDCCCXXXI / REX CAROLUS ALBERTUS PERFECIT». «Re Carlo Felice – restaurate e ampliate le
fortificazioni – munito il porto di nuovi moli – creata una flotta – ingrandito
il porto franco – abbellita la città – faceva costruire questa porta le mura
dal colle al faro– il re Carlo Alberto nel 1831 la concluse ».
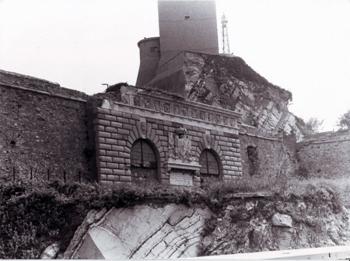

foto 1960
foto 1998


Henry Perlee Parker. Acquarello datato 1822 (partic.):
si vede la nostra strada in discesa, con il ponte levatoio.
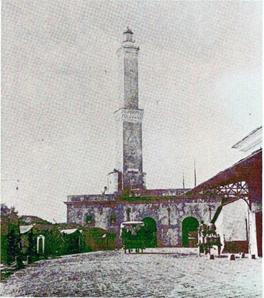
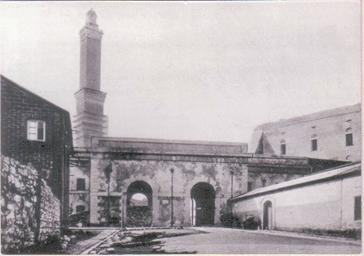
porta di Agostino Chiodo - uscita da Genova, entrata da San
Pier d’Arena
Fu
chiamata “Porta Nuova”, posta al di qua a
ponente della Lanterna a fronte della strada allargata (ovviamente non ancora
lastricata, e quindi in terra battuta) avendo scavato la roccia scoscesa.
Precedente la porta fu collocato anche un fosso,
sormontato da un ponte levatoio le cui catene
ruotavano su anelli di bronzo.
La strada
di accesso da San Pier d’Arena, era protetta ai lati dalla scogliera e dal
colle, ambedue a strapiombo, ma le frequenti mareggiate continuamente
danneggiavano il muro di sostegno rendendone precaria la stabilità.
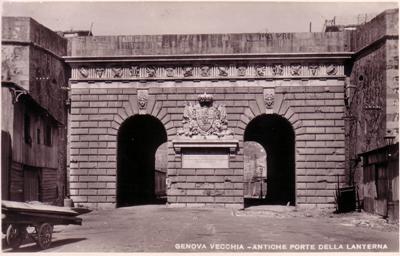

uscita da Genova
2010 attuale residuo
Datato 13 novembre 1839
si legge la relazione di un fatto avvenuto alle 20,30 del giorno prima: “rovina
del muro che verso il mare sostiene la strada
Reale di Genova dove, dal piano di San Pier d’Arena sale alla nuova porta della
Lanterna”. Ben 119 metri di strada furono
ingoiati dal mare. Ad esso seguì il riattamento dell’antica strada comunale
tra la Crosa Larga e la Coscia lungo il tratto di strada Reale rovinato in
parte dal mare.
Ancora nel 1846, la strada
non era lastricata e ciò era di grande incomodità; eppure
attraverso la porta, in quegli anni, è descritto passassero ogni
giorno: “73 persone con carico di erbe in testa; 124 asini; 89 persone col
latte; 73 carri con frutta e legumi provenienti principalmente dai fecondi
orti di San Pier d’Arena e destinati ai mercati di piazza della Nunziata”.
Molto del trasporto, avveniva ancora per via mare.
Nell’insurrezione del 1848, Genova contro i Savoia, non è facile capire
perché il Triunvirato che aveva preso il comando destituendo De Asarta, non
pose fiera difesa alla porta: quando
arrivò La Marmora, seguito sì da 30mila soldati, ma senza combattere la guardia
qui posta fuggì lasciando libera la porta all’entrata del generale piemontese.
Nel 1873 iniziò il servizio di trasporto pubblico,
affidato alla ‘Società Ligure di Trasporto’,
con vetture a traino che passando attraverso la porta,
arrivavano sino a San Pier d’Arena presso la stazione ferroviaria.
Tutto il complesso murario fu demolito nel 1877: per diminuite esigenze difensive e successive
crescenti ragioni di urbanistica e di viabilità (si stava lavorando a
traforare il colle, e si prevedeva che praticamente dalla porta sarebbero
passati in pochi: solo rade carrozze private, rari muli e carri di contadini,
pedoni e viaggiatori che alla via mare preferivano l’uso dell’“imperiale” così
chiamate le diligenze in onore del
Bonaparte, trainate da tre cavalli).
Nella vicina via G.Fantuzzi, a memoria fu posta una terza lapide: «veterem portam ad pharum - augusto loco extructam jamdiu
commeatibus imparem – V. idus febbrarius anno MDCCCLXXVII - ordo genuensis
amolienda decrevit - titolum inde refixum - in proximo dirutae moli
propugnacolo - statuendum curavit MDCCCLXXXIV» = “l’antica porta vicino al faro - costruita in luogo
angusto divenuto insufficiente al transito - l’8 febbraio dell’anno 1877
- il Comune dei genovesi decretò- indi curò nel 1884 - che dalla demolenda
porta l’iscrizione - fosse collocata nel bastione vicino alla porta distrutta”.
La prima e secentesca porta fu demolita
nel maggio-giugno 1877 (completata il 14 giugno) per motivi
urbanistici (versione storica) -o
anticlericale (versione cattolica): una
battaglia vera e propria con sbandieramento bilaterale del bene comune celante
meschini e spregevoli sentimenti antireligiosi e storici (pare che il Segre l’abbia definita ‘goffo ammasso di
pietre’).
Porta Lanterna fu prima a cadere (porta Pila seconda) malgrado 11mila firme che non volevano la
distruzione, disposti a tassarsi per sostenere le spese di una variante o
spostamento (come invece fu fatto per Porta
Pila, ‘esiliata’ altrove). La Madonna scolpita da Bernardo Castello che sormontava la porta, nello stesso anno 1877, fu traslocata assieme alle due lapidi di corredo «posuerunt me
custodem» e «Genova, città di Maria santissima», nell’Oratorio di s.Antonio di
piazza Sarzano (il 20.6.1937 fu posta sul molo Giano)
Nel 1878 la Compagnia Generale Francese dei Tramways inaugurò i
primi binari di un servizio ancora a traino ma con migliore rendimento: aprì
in corrispondenza il primo tunnel - di 256 m.
di lunghezza - per le sue vetture, che, da Genova, ancora nel 1933 – dopo aver
percorso via Milano e prima che essa si biforcasse in via G.Fantuzzi e via alle
Caserme di s.Benigno,deviava a ovest dentro il tunnel - passando sotto il
colle sbucavano proprio in Largo Lanterna. Ai lati dell’uscita di San Pier
d’Arena vennero eretti i casotti del dazio e - per carattere difensivo -
davanti fu anche scavato un fossato sormontato da un ponte di legno e ferro:
per i servizi pubblici venne così evitato il giro dalla Porta.
Nel 1902 appare sul lunario che nella via
(per precisione,‘alla Lanterna’) si apriva una raffineria di strutto e grassi alimentari, margarine ed olio, di
proprietà Davezan J, chiamata Vidal Engaurran Bmy.
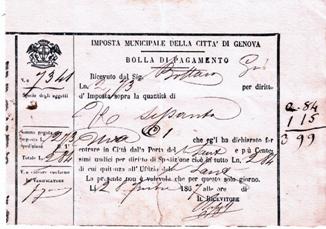
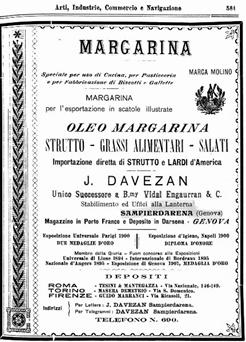
una bolla del Dazio
In una discussione per la
collocazione del dazio, circa i confini tra la città di Sampierdarena e quella
di Genova, fu deciso la divisione lungo il centro di questa strada, che portava
da Largo Lanterna alla Lanterna stessa, anche se Genova vantava alcune carte
francesi che attestavano territorio genovese anche questo tratto di strada; mentre
San Pier d’Arena proponeva le antiche leggi ed il ‘sasso del SS.Salvatore’
dipinto sul fianco a ponente, che fu destinato dal Senato a san Martino e non a
san Teodoro. La diatriba morì da sola all’atto dell’immissione della città
nella Grande Genova nel 1926.
Parti della seconda porta,
quella del Chiodo, con la ristrutturazione della zona avvenuta nel 1930, furono spostate nella sede della vecchia,
ove era la Tagliata e dove sono tutt’ora, messe a ricordo - ma non chiaramente
utilizzabili - a ridosso delle mura della Lanterna.
Con l’apertura di via di Francia e poi di via A.Cantore, il giro dalla Lanterna divenne inutile cosicché
nel 1934, con la gestione dell’ammir.march. Federico Negrotto Cambiaso,
il CAP provvide all’isolamento della Lanterna inglobandola nell’area portuale
e migliorò definitivamente la strada a
nord di essa unicamente per collegare le calate del porto genovese col bacino
di San Pier d’Arena; la facciata della porta fu ricostruita nella parte a
ponente del muraglione della Lanterna.
Nel 1935 la seconda porta,
quella del Chiodo, fu trasferita nel tratto della Tagliata rimasto, ove ancor
ora se ne può leggere la presenza (i due fornici murati sormontati dalle teste
della Medusa e con al centro lo stemma dei Savoia).
Nel 1976 il Gazzettino documentò campanilisticamente che Capo di
Faro era, da sempre, in territorio sampierdarenese: ovvero sino all’anno 1630
quando Genova, unilateralmente decise di allargarsi elevando l’ultima cerchia
muraria, e così – sempre unilateralmente - integrando a sé il colle di san
Benigno ed il suo capo estremo. Si rinnova il ricordo del ‘decretum guardiae
civitatis’ del 1128 in cui gli abitanti del borgo avevano degli obblighi di
guardia e di spese per la torre (probabilmente già eretta dai tempi romani); e
nel 1320 quando la gente di San Pier d’Arena doveva provvedere alle fascine
(dette brische) da ardere sull’alto della torre; ed altre ordinanze di epoca
napoleonica in cui si fa cenno a san Benigno e capo di Faro erano facenti parte
del ‘capitaneato di Polcevera’ e quindi del borgo non della città.
Nel 2006
la strada, superata la zona dove era il
‘Largo Lanterna’ ha un brusco rialzo mirato a passare –sopra, come un ponte- la
strada sottostante perpendicolare che, proveniente da via Pietro Chiesa va ad
evitare la galleria Romairone. Dopo questo ponte, quella che saliva alla
Lanterna ora, dopo trenta metri, si ferma e finisce in un vasto piazzale
‘privato’ ove possono fare manovra dei tir, posteggiare camions, fuoriuscire i
mezzi dalla Nuova Darsena, usare capannoni per deposito merci.
E poiché la Lanterna fu costruita nel 1543 (dai
genovesi, ma in territorio ben lungi dalle mura di allora, limitate alla zona
attuale di Principe –porta san Tomaso: infatti i Padri del Comune, seguiti dai
maestri d’antelamo, dovettero ‘cavalcare’ alla volta di Capo del Faro per
studiare dove ‘ricostruire’ la torre già chiamata lanterna), se ne potrebbe
concludere che l’alta torre rappresentativa della città, nei tempi antichi era
in territorio del borgo. Ma considerata la sua necessità (il porto) e la sua
manutenzione, appare – purtroppo per noi – di proprietà genovese.
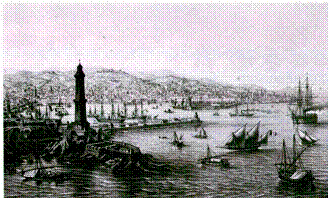 Litogr. Lebreton – 360x600 – ed. Bulla Parigi –
1850-1854
Litogr. Lebreton – 360x600 – ed. Bulla Parigi –
1850-1854
________________________________________________________________________________
LA LANTERNA.
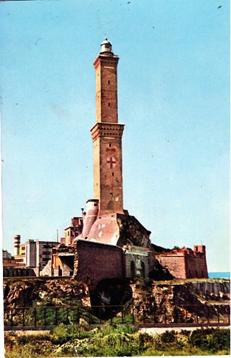
È il simbolo di Genova. Ha
visto un millennio di storia.
Cronologicamente, ha vissuto tre
fasi. Da semplice torre, a faro, alla lanterna classica. Inizialmente era:
==una torre - già dai tempi dell’occupazione romana,
si presuppone esistesse un sistema di segnalazioni con falò (di erica (chiamata
‘brügo’) o ginestre (la ‘brisca’ erano i rami di quest’ultima raccolti in
tutto il territorio: rimane nella valbisagno la località Briscata ed in una via
di SestriPonente) essiccate e poi
eventualmente bagnate per aumentare il fumo), accesi prima a terra e
poi in ‘coffe di ferro’, queste ultime da potersi sollevare affinché - il fumo
di giorno o il fuoco di notte - fossero visibili e l’immagine trasmissibile per
tutte le riviere (e nell’entroterra; sta scritto
che il servizio segnalazioni, di postazione in postazione, arrivava fino a
Milano).
È dibattuto campanilisticamente,
se i custodi fossero abitanti del nostro borgo, considerata la vicinanza di
esso rispetto la distanza della città racchiusa nelle prime mura. La prof.
Corinna Praga dà per sicuro che l’approvvigionamento fu messo a carico dei
cittadini sampierdarenesi.
Questi falò non funzionarono
però nell’anno 935 dC., quando la
città fu espugnata, saccheggiata e distrutta da 60 navi saracene arrivate
all’improvviso. Organizzare il servizio significò – forse dopo questa terribile
esperienza - far dare dei significati ai fuochi visibili anche da dentro città:
si chiamò così “fuoco netto” (dalla luce netta
e chiara) l’avvistamento di nave amica, dal “fuoco brutto” (dalla fiamma di legna fumosa) per le navi
sospette o nemiche; e tanti fuochi = tante navi in arrivo.
Si hanno notizie più certe di
una torre, di avvistamento ed allarme dal 1128,
quando nascono i primi manoscritti. Il Cintraco era la figura plurifunzionale
predisposta dai Consoli per bandire le leggi, per fissare l’ora delle varie
funzioni come lo scarico della ‘rumenta’, ed anche ad organizzare e distribuire
lungo le spiagge i servizi di guardia. Altrettanto precisi erano già i
regolamenti, sia per l’esercizio del fuoco,
già prodotto con l’uso dell’olio (alcuni
centri più abitati (Rivarolo, Torbella,
Granarolo, Porcile, Sosenedo) dovevano
fornire i turni di guardia, probabilmente alternandosi sulla torre di avvistamento
(le torri saracene sampierdarenesi
possono dare una idea di come poteva essere)), la fornitura del
materiale combustibile (alcuni centri, come
Promontorio e Basali (la vallata di san
Bartolomeo), nonché le navi in arrivo
dovevano fornire dell’olio o un ‘diritto’ per alimentare e mantenere una
fiamma: ‘pro igne faciendo in capite fari’). Evidentemente le guardie
(dette “turrexani”) avevano a disposizione una fiamma perenne ad olio, atta ad
innescare il fuoco agli sterpi in caso di necessità, mentre avevano l’incarico
di tenere tutto il necessario sia per il fuoco, sia per la nitidezza della
fiamma (pulizia dei vetri, con spugne, panni di cotonina o orbascio e bianco
d’uovo).
Sono circa di quest’epoca editti
mirati alle varie funzioni del porto, come anche proibire di disfarsi in
vicinanza e dentro esso, di “zettum et romenta”.
Anche la schiuma di pece, e forse
il catrame o il petrolio, furono combustibili usati, ma di minor uso per scarso
approvvigionamento. Ma poiché non mancavano i senza scrupoli che soffocavano i
fuochi per favorire lo “ius naufragi”, il Comune provvide a strutturare
militarmente la zona; Mannoni propone - già in epoca di Guglielmo Boccanegra e
l’erezione del Palazzo del Mare (san Giorgio), ovvero nel 1260 - che «venne costruito sul promontorio
di ponente il primo faro, chiamato Lanterna perché la luce era prodotta sulla
sommità della torre da più di cinquanta lampade ad olio protette da una gabbia
piramidale di vetri piombati».
Tra i numerosi focolai di
lotta tra guelfi e ghibellini (allora chiamati ‘Rampini’ e ‘Mascherati’ (o
Mascarati)) anche il faro fu punto di scontro: si ricorda nel 1318 un vero assedio, con i ‘guelfi rampini’
dentro, che resistettero a sassate lanciate usando una specie di catapulta
chiamata ‘trabocco’ e rifornendosi con fune tesa ad una galea ormeggiata
vicino, attraverso la quale in una cesta far passare vettovaglie, armi e
rincalzi; il 18 giugno dovettero arrendersi alla minaccia di demolizione della
base (l’annalista Stella scrive “fecero sotto di
lei, dalla parte di occidente e infrangendo la roccia, certe escavazioni e
fosse mirabili”). La storia dice che su sette soldati arresi, la
vendetta fu atroce perché furono uccisi ed i corpi catapultati sulle rocce
sottostanti usando gli stessi trabocchi posti in porta san Tomaso e in Santo
Stefano.
Da allora, non necessariamente
secondario all’episodio sopra narrato, divenne luogo di esecuzioni capitali,
tramite impiccagione (in genere i corpi venivano lasciati appesi, a monito dei
passanti, fino alla spontanea caduta in mare dopo il tempo richiesto dalla
corrosione e dagli animali; se si voleva perdurarne l’esposizione sempre a fine
di monito, si spalmava il cadavere di pece.
==un faro - Nel 1326, fu
abbandonato il sistema con i fuochi, per usare sempre quello a olio d’oliva ma
con varianti sulla qualità dei vetri (di Masone
o Altare; poi di Pisa, fino - molto tempo dopo - dei veneti) capaci di
rendere la fiamma molto più vivace e visibile da lontano e di rompersi con
minore facilità causa il calore, fulmini e deformazione dei montanti di ferro
(questa, legato alle oscillazioni).
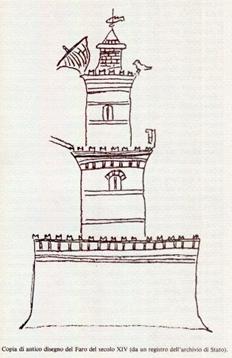
Ovviamente cambiarono pure gli
stoppini ed il numero delle lampade, per contenere i consumi ma arrivare al
massimo rendimento. Da dopo allora, la zona poté chiamarsi Capo di Faro. Sul
portolano “Conpasso da navigare”, del XIII secolo, si descrive l’arrivo al
porto: «Genova è porto facto de molo et ha uno capo da ponente che se clama
capo de Faro, en lo quale ha una torre blanca et alta, en la quale se fa la
notte gran fano».
È possibile che già da allora si
ponesse una cupola a vetri di protezione.
Durante il giorno, complessa e
con differenti significati era la segnaletica attuabile mediante esposizione
-su antenne- di vele (inveuggiâ) e
coffini (nome ereditato dalle coffe del fuoco,
erano cerchi di legno di varia forma a seconda del tipo di nave: l’importante era distinguere il pericolo; le parole
sono quelle antiche dei fuochi, con ‘brutto’ per l’allarme e con ‘netto’ per il
normale commercio); dopo il 1400 si aggiunsero segnalazioni con bandiere
in tessuto a vari colori. Tutte queste variazioni erano oggetto di ampie
discussioni, pareri, chiasso popolare riguardante la pulizia dei vetri,la
qualità degli stoppini, l’attendibilità dei custodi (chiamati ‘nuntii’ cioè che fornivano notizie- Palma li chiama
‘nuncii’).
Nel 1371 fu usato a prigione del re di
Cipro Giacomo di Lusingano e di sua moglie Carlotta, che nel periodo di cattività partorì il figlio,
futuro re di Cipro, chiamato Giano forse per lusingarsi i Senatori. Nel 1372 lo
zio – Pietro Lusignani - fu nominato re di Cipro. In occasione
dell’incoronazione nel suo palazzo di Famagosta, si dice sobillato dai
veneziani o comunque da concorrenti che lo avevano avvertito di una congiura
genovese, uccise defenestrando tutta la rappresentativa della nostra città
recatasi alla cerimonia sia come rappresentanti sia messaggeri di tutela dei
propri traffici e colonie. La notizia arrivò a Genova e scattò la vendetta:
galee al comando di Fregoso, saccheggiarono i paesi dell’isola ed infine
conquistando la città, che da allora rimase colonia genovese, mentre l’intera
isola fu restituita a re Pietro a cui sottrassero una sessantina di nobili tra
cui il nipote. Questi poté tornare in patria dopo una decina d’anni di
prigionia, liberato dal doge Leonardo Montaldo; Famagosta rimase genovese
ancora a lungo.
Nei turni di guardia al
faro, negli anni successivi, partecipò Antonio Colombo
zio di Cristoforo (vissuto attorno al 1450).
Tra essi si distinguevano i ‘turrexani’ dai ‘custodes’ ed ormai erano parte
integrante del sistema difensivo portuale
Nel 1481 una saetta ferì i tre figli del Torrexiano; la torre fu
colpita anche nel 1675; e relative riparazioni
dovute al ‘tuono’ avvennero nel 1702, 1713-14-15, 1731-32, 1758, 1761, 1778 (quest’ultimo
con la morte di un nipote del custode).
Nel 1498 fu visitata da Ludovico
il Moro, accompagnato da Leonardo da Vinci
e da altri studiosi, in valutazione delle fortificazioni in atto.
Nel 1507 Luigi XII occupò Genova e ordinò di
demolire il faro, ed al suo posto erigere la Briglia, che il re invece
inizialmente aveva chiamato “Mauvoisine” ovvero ‘cattiva vicina’; una fortezza
difficilmente aggredibile sia da terra che dal mare, capace di ‘imbrigliare’ il
porto e quindi la città riottosa al suo volere. L’ordine comprendeva
l’abbattimento del faro, ma quest’ultima
imposizione fu evitata ‘dietro cospicuo dono o bustarella -si scrive cento (o
duecento) scudi d’oro- all’ingegnere del re Paolo Beusseraille d’Espy, che
progettò inglobarlo nelle mura della fortezza.
La breve resistenza di Paolo Da Novi non salvaguardò il governo della
Repubblica Popolare, né la tassa di 60mila scudi necessari per la costruzione
del forte, né la liberazione dei nobili.
Ovviamente la presenza del
forte fece spostare la sede delle esecuzioni (fu portata alla bastia del monte
Peralto, detta Castellaccio, a 362 m/slm: la salita da allora fu detta “a
montâ de l’agonìa”).
Nel 1512 la città si ribellò, aiutata dagli spagnoli, e durante la
battaglia conseguente, navale e terrestre, il faro fu gravemente danneggiato ed
inusabile. Tre anni di assedio furono necessari per vincere le truppe francesi
asserragliate: solo l’impresa del marinaio Emanuele Cavallo bloccò i
rifornimenti che pervenivano via mare, così che il doge Ottaviano Fregoso dal
26 agosto 1514 poté ordinare –pare a proprie spese- la demolizione di tutto il
forte e del moncone rimasto. Tanta era stata la rabbia, da indurre tutti a
questa distruzione; ché a mente fredda, il forte poteva essere usato meglio a
difesa -e non solo- ché così dal 1507 al 1544 non ci furono segnalazioni
marinare, se non quelle da una piccola torre già da secoli eretta prudentemente
sul molo quale succursale.
==la lanterna Infatti, solo dopo trent’anni
dall’episodio, finanziata dai magnifici del Banco di san Giorgio e per volere
del doge Andrea Centurione da Pietrasanta,
dal marzo 1543 al luglio 1544 fu
eretta l’attuale Lanterna (Dolcino scrive nel 1549), alta 127 metri (76 di
torre con 375 gradini, e 51 di roccia), tutta di pietre riquadrate a scalpello
e mattoni: un marmo posto nell’interno, ricorda il finanziamento necessario.
Il progetto è attribuito a GioMaria Olgiato (altri
dicono Olgiati, realizzatore della cinta muraria del 500) e la direzione
dei lavori affidata al maestro d’antelamo Francesco da Mandria (altri dicono da Gandria) (la leggenda (che
ha scarso valore, ritrovando l’aneddoto eguale per numerose altre costruzioni
in Italia) volendo sottolineare
l’esclusività dell’idea, racconta che l’architetto fu precipitato dall’alto
della Lanterna stessa, affinché non costruisse opera eguale altrove).
Occorsero 2mila quintali di
calce, 120mila mattoni, 160m² di pietre squadrate provenienti dalla cava di
Carignano. La pietra di Finale fu usata per le balaustre che sostituirono le
merlature ghibelline. Si presume che in contemporanea furono fatte le scale
fisse in muratura – con 175 scalini - in sostituzione di quelle mobili – di
legno e corde - atte agli assedi; e fu dipinto un primo stemma della città.
Unico inconveniente risultarono i
fulmini, che più volte si scaricarono sulla cupola danneggiandola, obbligando
la cittadinanza a tridui di preghiere a protezione, ripetuti fino
all’invenzione di Franklin.
Nel 1632 divenne punto di riferimento per l’ultima cerchia di
mura – le Mura Nuove - estese sia verso il porto che verso san Benigno.
Si ricorda nel 1634 l’esibizione di un funambolo che – seguito
da un’enorme folla e con la partecipazione di oltre trecento navigli - scese
dalla torre tramite un cavo teso con un barcone posto nel centro del porto.
L’esibizione fu seguita da oltre
50mila spettatori. Identica esibizione, notturna stavolta, avvenne nel 1749 ad
opera di due ballerini del teatro di sant’Agostino.
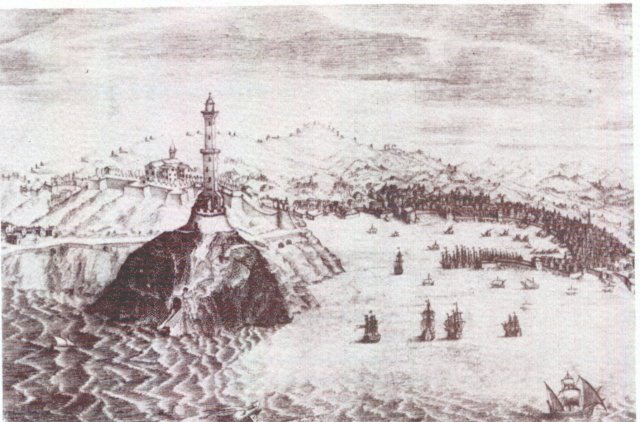
La Lanterna dal mare - da una stampa del 1636 – coll. Dodero
Solo negli 11 giorni di bombardamento francese del 1684 la cupola fu colpita;la flotta di Luigi XIV, detto Re
Sole, sparò 13mila proiettili dalle navi, ma evidentemente non mirò alla
Lanterna se non occasionalmente. Così alla fine della ‘punizione’, si provvide
alla riparazione della cupola, al miglioramento del riparo dal vento, alla ritintura
dello stemma.
Dopo, a parte i fulmini, nessun
altro evento danneggiò la struttura; comunque nel 1711 essa venne ‘incatenata’ a messo di chiavarde e di
tiranti (ancora visibili all’interno).
Nel 1778 venne dotata di impianto parafulmine (realizzato dal
fisico padre Glicero Sanxais; Dolcino scrive nel 1783). E nel 1791 si
effettuarono alla base lavori di consolidamento al fine di renderla sempre più
stabile.
Nel 1805 ai suoi piedi passò Napoleone
Buonaparte: alla porta sottostante gli furono consegnate, da parte del
‘maire’ o sindaco (non più doge) Michelangelo
Cambiaso, le chiavi della città (nobilmente rifiutate) atto ed abbraccio
finale e mortale tra la Repubblica Ligure e l’impero francese (la politica della Repubblica genovese era sempre
stata per secoli improntata alla neutralità; quando fu deciso schierarsi,
pesantissimo e distruttivo dell’autonomia fu il prezzo a pagarsi).
Dopo il 1815 i Savoia fecero erigere lavori di
fortificazione sotto il faro dando la definitiva fisionomia a quanto in parte
vediamo oggi
Iniziante a funzionare il 15
gennaio1841, regnanti i Savoia,
una lampada a petrolio a cui fu applicato dal prof. Piana un nuovo sistema di
lenti capace di ruotare. Inventato dal francese Fresnel, alla sommità -avente un diametro di 4 metri- fu data forma
dodecagonale, fu fornita di quattro ordini di cristalli piani, e fu aperta
verso il mare mentre oscurata a monte (nell’arco
tra i 110° e 290° con lamiere di rame: questo permetteva già allora un fascio
di luce bianca visibile a 15 miglia, con un momento di massima intensità
visibile a 20 miglia).
Da allora in successione,
ricordiamo il 1898 quando viene
usato come combustibile il gas di acetilene fino al 1905 quando fu sostituito da petrolio pressurizzato e nel 1913 a gas vapore di petrolio (fu cambiata pure, su idea francese, la componente
ottica ottagonale di schermi e lenti, galleggiante su mercurio e mossa da un
congegno a orologeria che la faceva ruotare) e nel 1936 da una apposita lampadina ad
incandescenza.
Ulteriori notizie comprendono
lievi danni durante il periodo bellico ma più seria minaccia a seguito del
grave evento della galleria di san Benigno; l’inserimento dell’ascensore dal 1957; la decisione del Ministero della
Marina Italiana che nel 1963
decise sopprimere i servizi semaforici essendo le navi dotate di radar: la
giurisdizione fu affidata alla Amministrazione militare di Spezia quale
competente della ‘zona fari’ locale; l’Autorità portuale istituì un corpo di
operatori specifico cui spetta ancora l’obbligo della conferma visiva
dell’avvistamento radar delle navi, e la manutenzione del faro girevole. Un
ultimo restauro fu nel 1967.70
ed il riaffresco dello stemma nel 1991.
2005 Oggi è localizzata in piazzale Giaccone. Sul Secolo XIX
si precisa l’indirizzo giusto essere “rampa della Lanterna” che in Porto, dal
Passo Nuovo sale al faro. CAP= 16126. Tutta la rocca che circonda la Lanterna,
è stata restaurata ed aperta al pubblico, che può accedere tramite
passeggiata-passerella ad un’area museale ubicata nelle fortificazioni sabaude
che sono ai suoi piedi.
Dalle iconografie della città è sempre effigiata in
primo piano: da allora – ovvero dalla fine del 1400 - è quindi divenuta il
simbolo della città di Genova, il monumento che identifica nel mondo l’intera
Liguria. Non a caso, visto che da essa e verso essa una enorme quantità di
umanità ha viaggiato navigando, recependola rispettivamente come elemento di
nostalgia per i partenti e di sicurezza per chi arriva.
Appare composta di due blocchi
a parallelepipedo ad angoli retti: uno basale, con base nettamente più larga di
quello superiore.
Due lati sono l’osservazione più
frequente; ma in alcuni punti da cui la si guarda, se ne vedono tre: questa
caratteristica è rammentata in una poesiola di autore ignoto, divenuta canto
popolare e nenia, riferita forse ad una contadina che nelle prime ore portava
la verdura al mercato:
«I TREI CANTI DA LANTERNA DE ZENA
: “Lanterna de Zena – l l’è faeta a trei canti – Maria co-i guanti – lasciæla
passâ. - A trae öe de neutte, - e tutti l’han vista, - a fava provvista –
vestia da mainâ. - Cattaeghe ‘na roba, - metteighe un frexetto, -
çerchaeghe ‘n ometto – pe fala ballâ. -»
Il parallelepipedo inferiore ha,
sulla facciata a nord un grosso affresco con dipinto lo stemma crociato della
città sormontato dalla corona ---***; asimmetriche rispetto il dipinto, due
finestre, diverse per numero sulle varie facce; tra il dipinto e le mensole un
lungo marmo orizzontale riporta la data “ V MDXLIII REST I “; culmina con
otto mensole su due ordini, a loro volta sormontate da un muretto con tre
buchi rettangolari. Quello superiore ha sempre sulla facciata a nord due marmi,
uno alla base rettangolare piccolo, altro al sommo rettangolare largo e lungo,
su cui non so cosa sia scritto; anch’esso culmina con sei mensole disposte in
due ordini, sormontate da una terrazza delimitata da un parapetto a balaustra;
le finestre sono distribuite diverse sulle quattro facce ed asimmetricamente.
In vetta c’è la cupola rotonda del faro la cui luce copre un raggio di 36
miglia.
Alla base e non facenti parte del
monumento, varie casette di forma e foggia diversa ospitano i guardiani che
sono alle dipendenze della Marina Militare essendo tutto l’edificio non di
proprietà comunale ma del Demanio
I dati relativi alla Lanterna, dicono:
-coordinate geografiche: 44°,
24’,20”latitudine nord + 8° 54’ 20” longitudine est.
-altezza slm = 117 m. in tutto.
In particolare: lo scoglio (è di 40m.).
Il tronco di base (é alto 36m.; 9m. di lato; mura spesse 2,6m). Il tronco
superiore (é alto 33,95m.; lato 7m.). La
cupola (è alta 7,05m. di cui 3,44 in vetro;
diametro 4m.). L’ottica rotante interna (alta
1,85, larga 1,78; i cristalli sono spessi 700mm; la lampada ha potenza di
700w).
-fascio di luce= portata luminosa: 33 miglia marine;
geograficamente arriva a 27 miglia. =ritmo rotatorio di 20” suddiviso in due
lampi di 0,2” di luce intervallati da due diverse pause, una di 4,8” ed altra
di 14,8”.
-il bacino di mare è ampio 25°,
aperto a sud-ovest al libeccio, ed a sud-est allo scirocco.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri F.-Guida illustrativa
per la città di Ge.-Sambolino.1875-p.565.639
-Annuario sig.Regina-1902-pag.581
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica, scheda 2340
-A sconosc.-Guida del porto di
Genova-Pagano xCAP.1954-pag 41
-A.sconosc.-Storia del trasporto
pubblico a Genova-Sagep.1980-18-27.fot/’02
-AA.VV-I castelli della Liguria
–Mondani.1974- pag.543
-AA.VV-Dizionario biografico dei
Liguri-Brigati.1996-pag 264
-AA.VV.-Scultura a Genova e in
Liguria-Carige- II-pag.21-2foto.80
-Cavalli R-La Lanterna- La Casana- n°3/82-pag.14
-Dellepiane R-Mura e fortificazioni a Genova -NEG. ’84-
-Dolcino-Patrone-Il Faro di Capo Promontorio-Microlito.1982-
-Dolcino M.-Storie di Genova- Frilli.2003- pag.92
-Forti LC–Le fortificazioni di
Genova-Mondani.1975-pag.26.32
-Gardella PL-La statua della
Madonna di Città-Microstorie-I-04-pag.68
-Gazzettino
Sampierdarenese : 5/76.1
-Gazzo E-I 100 anni
dell’Ansaldo-Ansaldo1953-pag. 38.40foto
-Il SecoloXIX del 20.6.05 +
20/8/05
-Massobrio A.-storia della Chiesa a
Genova-DeFerrari.1999-pag94
-Miscosi G.-Osservazioni e
ricordi della vecchia Ge.-Tolozzi 1969-pag.24
-Novella P.-Guida strade di Genova-Manoscritto
Bib.Berio.1930-pag.18
-Palumbo R.- la strada dei Giovi
e il passo...-Luna.2003-pag.80
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi1985-p.958 p.1506
-Pesce G- bollettino de
ACompagna-anno VII-1977, n° 6
-Pescio A-I nomi delle strade di
Genova-Forni1986-pag.186
-Pinto GC-Profili di
Liguria-DeFerrari.2003- pag.119
-Poleggi E-Descrizione della città di Ge da
un..-Sagep.1969-pag.10
-Praga C.-La Lanterna, faro di
Genova-opuscolo Sagep.1998- foto
-Ronco A.-Gli anni della
rivoluzione-DeFerrari.1990-
-Ronco A.-L’assedio di Genova del 1800-Sagep.1976-pag.102
-Ronco A-Genova tra Massena e
Napoleone-Sagep.1988-pag. 108.191.280
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani 1983-pag80foto.119→232
-Tuvo&Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-p.48.61-2.122-5
LARGA crosa
Larga
via Larga
 da MVinzoni,
1757.In rosso, villa Doria Franzoniane; verde villa Imperiale la Bellezza;
celeste villa Grimaldi la Fortezza; verde villa Grimaldi; gialla villa dei
duchi Spinola
da MVinzoni,
1757.In rosso, villa Doria Franzoniane; verde villa Imperiale la Bellezza;
celeste villa Grimaldi la Fortezza; verde villa Grimaldi; gialla villa dei
duchi Spinola
Antichissimo nome,
corrispondente – da mare verso monte - all’attuale via Prasio+Palazzo della Fortezza, testimonianza di cosa
intendevano a quei tempi per larghezza, individuando preferibilmente - anche
per ragioni di difesa - stradine a vicolo o crose.
G.B. Grimaldi, che
ordinò la costruzione della villa della Fortezza, preferì far aprire l’
ingresso non sulla via principale ma - attraverso un ampio parterre- su questa
traversa che costeggiava a levante la proprietà e che quindi senz’altro le
preesisteva (forse per sfruttarne l’accesso al mare, o per non offrire la
facciata agli Imperiale posti dall’altro lato). Della crosa Larga nel 1700
era famoso il teatro omonimo, interno alla villa stessa e quindi inizialmente
limitato al divertimento dei nobili (Schmuckher
fa un po’ di confusione chiamando ‘Croce’ la crosa; e non ricordando che il
palazzo della Fortezza era dei Grimaldi e quindi lo stesso del precedente da
lui citato; ricorda comunque che nel 1779
vi rappresentò una compagnia di dilettanti così brava, che l’unico foglio
giornalistico esistente allora ne fece resoconto) ma, in più
rappresentazioni liriche o prosa anche del pubblico popolano (a quei tempi
pressoché tutti analfabeti)
Da questa strada iniziò il 4 mar.1805 (anno di
Austerlitz, e della Liguria annessa alla Francia) una sommossa femminile: un
gruppo di popolane della Coscia si ribellarono alla coscrizione obbligatoria
dei loro figli in marina: le truppe arrestarono queste madri che furono
liberate dalla galera dopo un mese circa.
Nel 1813 appare sulle
carte che la strada conduceva alle ville degli eredi del principe di Francavilla e a quella degli eredi del principe
di Monaco (alla Fortezza, dei Grimaldi), nelle cui ville esisteva ancora un
locale adibito a cappella privata.
1819 il sindaco acconsente
che il sig. Marassi Antonio dia pubblico divertimento di bussolotti presso il
teatro della crosa; purché osservi le regole del
buon costume. Si rende necessario avere un gendarme per il buon ordine e non
permettere che in teatro si fumino sigari o pippe, neanche sulle scale
Un esposto datato 9 ottobre 1831,
lamenta che “nel palazzo del Teatro posto in cima della crosa Larga sul canto verso
levante (andando verso il mare, ndr),
esiste una fabbrica di candele a sevo (sic) diretta dal signor Pietro Lombardo, che
emana fetide esalazioni “un puzzo angoscioso e nocivo alla salute”. Nel 1847
esistevano nel borgo due fabbriche di candele, che occupavano in tutto due
operai.
Ancora nel 1841, posta
laterale nel quartiere omonimo ‘della crosa Larga’ (dalla via arrivava
sino all’attuale via Gioberti; era
delimitato a levante dal quartiere della Coscia che dalla Lanterna arrivava
sino alla strada, ed a ponente dal quartiere Borraghero che dalla via Gioberti arrivava sino alla crosa
sant’Antonio), la strada andava dalla “strada comunale”, poi divenuta via De Marini, sino alla strada
a mare detta Strada Reale di Torino, ed
era costeggiata dalla proprietà dei fratelli Grimaldi eredi Ansaldo, posta a levante, di 448 mq, curata ad orti, eccetto
la parte a monte coperta da costruzioni e la parte a mare anch’essa occupata
dalla “casa Morando Ignazio” ( una bottega,
con retrobottega e giardinetto, a due piani, usata in molti scritti come punto
di riferimento e per fissare le delimitazioni di tratti stradali in questi
tempi in cui non esisteva ancora una nominativa precisa delle strade - e quindi
le varie località venivano definite in base a quello che vi si trovava di più
caratteristico; affiancata da quella di Luxardo GB posto nella casa Grimaldi
stessa, trasformata in magazzino), e a ponente dalla proprietà del
conte Agostino Scassi (figlio di Onofrio), divenuto proprietario della villa della Fortezza (già
anch’essa dei Grimaldi) e di tutto il terreno che dalla villa -posta a monte
della proprietà - arrivava sino al mare, anch’esso curato al orto .
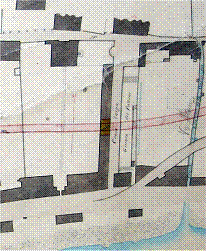 carta
del 1847
carta
del 1847
In questi anni, la via ancora veniva detta “del gioco di pallone“, perché aveva a levante l’ampia
area rappresentante l’attività sportiva più diffusa allora.
Antico gioco del
pallone elastico (già praticato in
molteplici modalità nella civiltà greca e romana ma che trovò nel rinascimento
la massima diffusione) disputato in
partite a punti tra due squadre, da uno a quattro giocatori ciascuna, di palla
lanciata e rinviata in uno spiazzo (poi
chiamato sferisterio) dei quali – alla
fine del 1700 - quello più famoso era all’Acquasola, ove giocavano ballonisti
locali e – in grandi sfide - foresti, di Firenze e Milano.
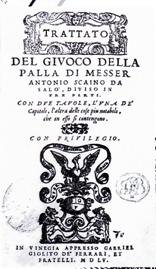
Trattato del gioco della
palla, di messer Antonio Scaino di Salò, edito nel 1555 ‘in Vinegia’ (presumo
Venezia
)
La letteratura descrive
giochi similari ai tempi dei greci e romani; ma fu principalmente nel Rinascimento
che questo gioco iniziò ad essere praticato, con alta cornice di pubblico,
tifosi e scommettitori.
Il vescovo di Alba nel 1528 sottoscrisse una lettera pastorale minacciando
pene severissime per chi col gioco della palla avesse disturbato le funzioni religiose.
Dal 1600 (e poi sicuramente ancora durante l’occupazione
francese del 1800 sino alla metà di quel secolo), il gioco della palla, o pallacorda, o della balla di paramaggio, o
“jeu de paume”, era il divertimento pubblico più seguito, che appassionava
enormemente ed incredibilmente ogni ceto cittadino. Nel 1618 a Firenze per volere del granduca Cosimo II
dei Medici avvenne forse il primo incontro nazionale riunendo i miglior
giocatori dell’epoca provenienti da Ancona, da Venezia, da Cagli; e con premi
superbi, di brillanti e grosse somme di denaro. Uno scontro poteva essere l’avvenimento del giorno, sia per la novità,
ma anche perché includeva l’amor proprio e le scommesse; e come oggi soggetto
a tifoserie accese, litigiose ed anche rissose: non poche partite finivano in
guardina o erano gestite da militi armati di schioppo; e non poche venivano mal
sopportate dagli abitanti intorno (per il
chiasso, la ressa di gente non sempre ben educata, i vetri rotti ed altri danni:
la palla rompeva tegole e persiane, colpiva e contundeva passanti e spettatori), le scommesse, le parolacce (in tempi che col Santo Offizio, una bestemmia costava
molto assai). Le denunce raccolte in ampi
cartolari a seconda della gravità del danno divisi in ‘civilum’ e ‘criminalium’
erano vagliate dal Collegio Magistrato di virtù, più spesso favorevole al
gioco (per rispettarlo essendo ricco di
consenso popolare, tradizione e anche loro partecipazione sportiva) seppur concedendolo in spazi appositi e con
“prohibitioni” varie. Un lungo elenco di
giocatori nell’anno 1741 denunciano vari
cittadini perché rimuovessero degli ostacoli – punte acute di ferro infisse nei
muri per sgonfiare le palle, tende, addirittura barche e telari - che
impedivano un “gioco così onesto, che è sempre stato fatto pubblicamente nelle
strade senza che mai alcuno contestasse detto gioco, un gioco che da centinaia
di anni a questa parte ha continuato e continua a essere giocato senza che mai
alcuno lo abbia impedito”. Preambolo alla rivoluzione francese ci fu -alla
chiusura della sala delle riunioni da parte del re Luigi XVI- che l’Assemblea
nazionale (20giu1789) giurò non uscire dalla
sala della Pallacorda, finché non avessero ottenuto una costituzione. T.Tuvo
segnala che il 25 sett.1809 il sindaco di San
Pier d ’Arena multò e poi – per rifiuto di pagamento - fece imprigionare per
un giorno a Rivarolo i cittadini “Francesco Canale, Giuseppe e Luigi, Francesco
Galleano” perché sorpresi a giocare malgrado il divieto municipale che lo
proibiva (il sindaco fu aspramente accusato dal Prefetto di ‘abuso di potere’,
non avendo diritto ad arrestare, avocato dalla polizia).
Due le tecniche
usata: quella tra le più antiche ed ancora accreditate a fine 1700, fu del
‘bracciale’ (in un campo di 100
passix10 -o 180 palmix40; grossomodo m.50x10-, diviso a metà da una linea ben
visibile, 4 giocatori per squadra si contendevano una palla di cuoio di
circa 16 once (strisce di cuoio cucite, che –rivestivano una vescica di maiale
quale camera d’aria gonfiata -a bocca o tramite cannuccia di bronzo- mediante
l’ uretra lasciata sporgere e poi legata e reinserita nell’interno. Ovvio che
una palla sgonfia impediva il gioco di potenza, quindi ogni partita prevedeva
premunirsi di varie palle sempre pronte. Occorreva che i ‘zûghèi’ (detti
balloneri o ballonisti) non cedessero la palla all’avversario rilanciata col
polso, e se la passassero tramite lanci lunghi e precisi senza farle toccare
terra. Il bracciale (o braccialone) era una protezione in cuoio -a
volte rinforzato con legno tenero- che copriva tutto l’avambraccio, dal dorso
della mano
Altra tecnica citata è
anche quella praticata con una ‘zucchetta’ opportunamente vuotata e rinforzata
e con cui colpire la palla, antesignano del moderno tennis.
Un arbitro
valutava l’andamento con possibilità di raccogliere pareri –i più
disinteressati possibile ed anche in sussurro all’orecchio- tra il pubblico
imparruccato e ricco di crinoline; veniva chiamato ‘marcatore’.
Nel finire del 1800 il gioco subì declino e mutazioni, soprattutto
per impossibilità a confrontarsi nella scarsezza delle comunicazioni; sebbene
ai vari livelli locali ancora molti erano gli appassionati della ‘sferistica’
alla quale lo stesso E.De Amicis dedicò lodi e personaggi di libri (‘Gli Azzurri e i Rossi’ facendo riferimento al
grembialino o fascia che i giocatori portavano davanti, di vari colori per
distinguere le squadre).
Tra le varianti le più descritte sono ‘il gioco del
calcio’ detto anche football; della pallacorda detta poi tennis; della palla al
muro detta pelota; e della palla a maglio quella più affine all’antico.
L’attuale gioco del pallone
elastico ha regole moderne, dettate da solo trent’anni, con un campionato
nazionale e varie squadre locali, declassandosi ad attività sportiva minore a
carattere folcloristico.
Nel 1853, con
l’apertura della strada ferrata e della sottostante via Buranello, fu
spezzata in due tronconi, che appaiono lievemente decentrati causa gli spazi
costruttivi delle case che riempirono tutti gli orti.
Nel 1857, il regio
decreto piemontese, su richiesta del comune cittadino, legiferò chiamandola
ufficialmente“stradone della crosa Larga”. Lo stesso, usava la strada come
confine tra la via DeMarini e la via s.Antonio (come
punto di riferimento rimase in tutte le trasformazioni riguardanti i nomi della
importante strada trasversale: la via De Marini fu accorciata quando con
l’apertura di via di Francia il tratto dal ponte ferroviario fu chiamato via L.Dottesio; la seconda, che arrivava sino a via della Cella,
alla morte di Cantore fu trasformata in ‘via generale Cantore’ e nel 35’,
aperta ‘via A.Cantore’ divenne via N.Daste)
Nel 1863 Gaspare
Alvigini eresse i civv.12 e 14, che furono
sopraelevati nel 1895. Vedi sotto a 1908
Ai primi del 1900 risultano proprietari : eredi Lavagnino del civ. 1; fratelli Dellepiane del
2,3,4, 6, 8, 10; Carlo Lagorara del 5; Morandi e C del 7; Parodi Stefano e C
del 9; Sauli eredi Scassi dell’11e 13; eredi Lombardo del 12; eredi Alvigini
del 14 .
Il Pagano 1902 segnala: al civ.1 un deposito di petrolio di Crescione Felice, presente
anche nel 1908;--- 7 merciaio Dellacasa Stefano;--- 11 negoz.
vini di Auvigini (sic) Gaspare (nel 1908 è al civ. 14, Alvigini Gaspare che
abbiamo già visto come costruttore nell’anno 1863);---13 Pretto(c’è
anche nel 1908) E. e C. fabbrica e negozio di conserve alimentari.
Nel 1908’ il Pagano segnala uniche attività: --–al civ. 7 il merciaio Dellacasa Stefano;---
Nel 1910 invece, (e già forse dal 1901) era divenuta “via
Jacopo Ruffini” , tutta compresa “ tratto superiore e tratto inferiore” , dalla
via C.Colombo (via San Pier d’Arena)
a vico Massimo D’Azeglio (via
Massimo D ’Azeglio) - e già possedeva numeri civici sino all’11 ed al 18
.
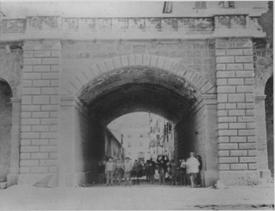
Nel Pagano 1911 e 12
compare l’ esercizio: civ.1 deposito di petrolio, di Crescione Felice (non c’è più nel ‘20); civ.7 il merciaio
Dellacasa Stefano (idem); al civ.13 la fabbrica di
conserve alimentari di Pretto E. e C.(idem); civ. 14 vinaio Alvigini
Gaspare (vedilo nel 1863, 1908 e ancora 1920 quando divenuta via J.Ruffini);
E così era ancora tutto
immutato nel 1933. Erano tempi quelli, in cui i ragazzi che
frequentavano la scuola aperta nella via, con due palanche, in una “sciammadda”
(friggitoria) si premunivano di merenda a base “de fain-a dôçe de castagne,
castagnasso o panella , fainâ, torta de giæe o pörpettön”.
Prima del 1940, presumo nel
terremoto toponomastico del 1935, divenne tutta, fino a via D’Azeglio, via Palazzo della Fortezza.
Ma nel 1945 circa, alla parte a mare fu ancora cambiato il nome,
intitolandola via A.Prasio partigiano
caduto per la libertà , lasciando alla parte a monte l’attuale e per ora
speriamo definitivo nome di via Palazzo della
Fortezza.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.38
-Casaccia-Dizionario
genovese-italiano-2ª ed-1876-
-Caviglia G.-una sfida tra cielo
e terra-IEE.1994-pag1j
-Dolcino M.-Storie di
Genova-Frilli.2003-pag.43
-Dolcino M.-sport e tifo nella
Repubblica genov.-la Casana 2/1993-pag76
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino Sampierdarenese
6/80.3 + 9/92.3 + 7/92.6 +
-Grozio R.-De Amicis poeta del
pallone-La Casana n. 2/88-pag.46
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.12.20
-Pescio A.-Settecento
genovese-Sandrom.1922-pag. 226
-Presotto D.-in «Liguria,
rassegna mensile, n.1/99»-pag.8
-Schmuckher A.-Teatro e
spettacolo…-Mondani.1988-pag.39 non sa che
palazzo
Grimaldi e crosa Larga sono la stessa cosa
LATTE Via
Latte
È scritta solo su una ricetta
rilasciata dalla farmacia Centrale G.Pizzorni, ancor ora aperta in via Stefano
Canzio, il 30 ott.1936.
Il ‘malato’ un certo «sig.
Leto Celso, allievo di attore C.A.P.» (la
ricetta è macchiata e non tutto è leggibile a pieno ) abitava (questo è scritto chiaramente) in “via Latte 2”
; non si sa, se a San Pier d’Arena o altrove.
Ma considerato che anche il
Parroco di Promontorio in una sua rubrica appunta «Ditta Galupini (sic) via
Vittorio Emanuele Sta.nto Latte», forse dove era questa o altre fabbriche di
latta per barattoli di conserva (Diana, Nasturzio), e per il farmacista
sufficiente a determinare il cliente.
Poteva anche aver riferimento
a delle stalle con le mucche, ed in epoca antecedente al 1900 era punto di
riferimento dove andare a comperare il prezioso liquido.
Sappiamo che nel 1933 in via
Malfettani, c’era una ‘soc.an. per l’Industria
del Latte’ che lo raccoglieva in deposito; ed a questa può essere il
riferimento cercato.
LAVATOI
vico dei Lavatoi
Il vicolo - Nel tardo
1800, costruito il vasto emporio di G.B.Carpaneto nella zona compresa adesso
tra via T.Molteni e via A.Pacinotti, si venne a creare un
vicoletto facente parte della via Garibaldi, nei pressi della fine di via
C.Colombo (il Novella la fa dipendere da questa strada).
Portava ovviamente ad un
discretamente grosso lavatoio, in una zona che prima delle costruzioni
abitative e commerciali (dell’apertura della strada ferrata quindi ) era curata
ad orti assai fecondi; ed era altrettanto ricca di pozzi e sorgenti.
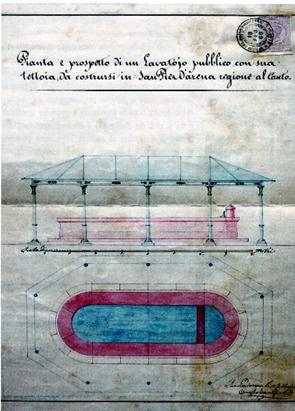
Appartiene a quei toponimi
evidenziati dall’oggetto di maggiore conoscenza nella zona, rimasti quindi ad
uso comune del popolo, e poi riconosciuti ufficialmente: l’ufficio Anagrafe del
comune di San Pier d’Arena, nel 1910 , riconosceva il vico, “da via Garibaldi
verso levante” e con un civico abitativo, l’1.
All’atto dell’unione di
SPd’Arena nella Grande Genova nel 1926, il vicolo esisteva ancora ed era
classificato di 5a categoria.
Ancora esisteva nel 1933 “da
via Garibaldi all’emporio Carpaneto”, sempre ancora di 5.a categoria, e sempre
con un numero nero civico, il 2. Il Comune - nella sua rivista/1934 - segnala
aver ‘ultimato la costruzione di lavatoio’ nel vicolo ancora esistente.
Ufficialmente la denominazione
del vicolo fu soppressa con delibera del podestà, l’ 1 dic.1935.
I lavatoi- In dialetto,
i troeggi.
A Genova -- Quando
divenne impossibile raggiungere la riva dei torrenti, anche se l’acquedotto
genovese aveva origini romane, divenne indispensabile – per mantenere un minimo
di igiene – studiare una soluzione al problema di maggiore diffusione: questo
avvenne solo tra la fine del ‘600 ed inizi del ‘700. Vengono citati i primi
“trogli”, alla Marina, nel 1656; e sicuramente l’espansione delle mura del 1630
tenevano conto di proteggere tutte le vie di rifornimento idrico torrentizio a
partire dall’apice dei monti. Anche se Genova, con il sottosuolo fatto di
calcare permetteva trovare e costruire vaste cisterne sotterranee.
Così non mancano in città la
piazza delle Lavandaie, vico e piazza dei Lavatoi, ed i famosi trogoli di
s.Brigida.
Nel 1908 in Genova ne
esistevano ben 279. In quella data si prevedeva aumentarne il numero:
evidentemente le case non ancora possedevano l’impianto interno di rifornimento
né diretto né con recipienti d’angolo (sorretti da barra di ferro, trasversale)
Esistevano le lavandaie
professioniste; ed era una obbligata consuetudine locale andare a lavare i
panni al lavatoio comunale.
A San Pier d’Arena Cigolini&Tomaselli
segnalano la prima esistenza di un lavatoio, in una planimetria del 1860 in
località imprecisata della Coscia; ed altro ,
del 1862 – chimatato ‘troglio’ nel progetto da costruire in via Doria (Giovanetti)
dietro il caseggiato del sig.r Arnaldi. E dopo questi, altri sette prima del
1900 e quattro dopo:1867 via del Ferro (strada scompasa-alla Coscia); 1877 via del Prato (v.Orsolino);
1884 al Canto (il
nostro);1887 a san Martino; 1890 via Galata (v.P.Chiesa);
1893 via sBdFossato; 1895 Belvedere; 1885 salita
Pietra (sal. Bersezio); 1897 Cella; 1906 Cavour (Dondero); 1909 Balleydier;
1910 Palmetta; 1932 v.
VittorioEmanuele (Buranello-sotto la
ferrovia).
Nel 1891 (era sindaco Pietro dall’Orso) in altra fonte, compaiono
come “immobili di proprietà comunale” i lavatoi di Promontorio,
della Palmetta e del Canto;
Sempre nel 1908 ed a san Pier
d’Arena essi vengono elencati alla voce ‘acqua, dagli acquedotti Nicolay e
De-Ferrari Galliera’; e sono citati quelli di via Larga, via Cella, via
Garibaldi (il nostro); e per altri, presso via Barabino, e via Balleydier.
Sappiamo che pari ad essi,
coesistevano lavatoi in via Milite Ignoto, via
Vittorio Emanuele (nelle arcate ferroviarie, poco prima dell’attuale
vespasiano) ed in via J Ruffini; viene
dimenticato quello sito in salita al
forte Crocetta, distrutto nel
1990 circa; e quello ancora esistente di salita
sup.S.Rosa proprio di fronte alle case di Promontorio.
Molti furono rifatti nel 1934.
Il nostro, costruito negli
anni 1884-1897, era ubicato “in località al Canto, via Garibaldi”. Fu distrutto
con la ristrutturazione della zona di via
Avio-Molteni ed in seguito ai nuovi requisiti igienici ma soprattutto con
la distribuzione idrica direttamente nelle case.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale pal.
Ducale
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica
scheda 2361
-CigoliniMC&TomasinelliF-i
Lavatoi- Ecig.199-pag.61.138
-DeLandolina GC:-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.45
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1900-pag.18
-Pagano/1933-pag.247
-Rivista municipale ‘Genova’ :
12/33.1021 + 3/34.267
LEOPARDI
via Giacomo Leopardi
Nella seduta del 16 genn 1914 fu
proposto al giudizio del consiglio comunale la titolazione - della prima
traversa a mare di via Carducci (via A.Cantore), orientata verso levante, e distaccantesi da
via E.De Amicis (via
Malinverni) - da dedicarsi al poeta Leopardi, essendo già completati gli
edifici che la delimitano.
Un lungo muro proveniente da
qualche villa posta in collina (dei Francavici? vedi Vinzoni), ne chiudeva la
prosecuzione verso levante; ed ancor oggi è chiusa allo sbocco verso est.
Corrisponde all’attuale via degli Arditi.
La dedica per questa “2°
Traversa a destra di via E.N.P.A.L.S.” nacque in quegli anni prebellici
(1915-18), in cui si era alla ricerca ed esaltazione dei valori morali e
spirituali individuali e nazionali, che fossero di esempio, e di alto
significato patriottico ed unitario.
Nel primo elenco delle strade
comunali della Grande Genova, compare in SPd’Arena, come anche a Pegli,
Rivarolo, ed in Centro che naturalmente vinse nella sopravvivenza.
Anche se già programmata ad
essere cambiata, ancora era così nel 1933, di 4.a categoria e con un solo
numero civico, facendola limitare da via E.DeAmicis a via G.Verdi.
Fu cambiata con delibera del
podestà, il 19 ago.1935, appunto per evitare il doppione con la piazza
genovese.
DEDICATA al poeta recanatese,
1798 - 1837, mai venuto a Genova nella sua breve esistenza, caratterizzata da
un continuo stato di depressione ed avvilimento giustificato da un fisico molto
fragile e malato.
Da questi aspetti negativi,
risultò invece esaltata la sua sensibilità verso il lirismo ed il
sentimentalismo, che fecero di lui uno dei poeti più grandi della letteratura
italiana.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale - Toponomastica
scheda 2392
-DeLandolina
GC:-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.45
-Novella P.-Guida di
Genova-manoscritto B.Berio 1930-pag.17
-Pagano/1933-pag.247 +
LIBERTÁ piazza
della Libertà
La rivoluzione francese e le
simpatie dei repubblicani che con entusiasmo avevano accolto le truppe
d’oltralpe, ‘francesizzare’ il borgo era l’ovvio tentativo di far capire alla
popolazione la necessità di adottare il nuovo modo di vivere e di idee ( anche se per il popolino tutto era assai
sconcertante, ma accettato per l’illusione di finalmente un ideale riscatto
sociale, di una giustizia eguale per tutti, di promessa migliore qualità di
vita).
Così, lo slargo davanti al
municipio, sede del ‘maire’ o sindaco, il 22 apr.1799 si volle fosse chiamato
‘Piazza della Libertà’, con l’idea di innalzarvi l’albero della Libertà (come in città, in piazza Acquaverde ),
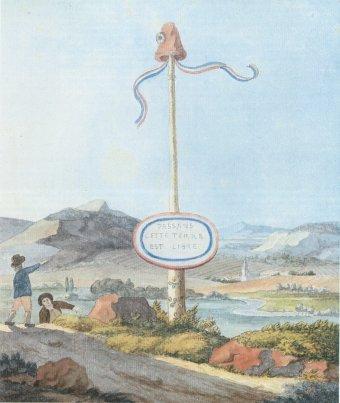 acquerello di JW
von Goethe, da Internet
acquerello di JW
von Goethe, da Internet
punto di riferimento per feste,
canti, tripudi, e roghi (per bruciartvi il
‘libro d’oro della nobiltà’) ed istruzione repubblicana. Allo scopo era
stata appena restaurata con la spesa di lire 119, in quanto rovinata da una
mareggiata.
Nonostante gli ideali, i soldi dei ricchi facevano
gola lo stesso; per cui la nobile Maria Cambiaso
Negrotto, divenne nel febb.1799 “una ‘cittadina benemerita’, per aver
elargito quanto necessario per la costruzione della piazza della Libertà…con
menzione onorevole nel processo verbale del Patriottismo di detta cittadina…”
Ovviamente, di fronte al sincero entusiasmo di chi
ardeva liberalizzare il governo della Repubblica dall’arroganza e prepotenza
degli aristocratici, esisteva di contrapposto un mal represso malumore dei
poveri ingannati dalle vane promesse di miglioramento che loro illusi
agognavano immediato; dei preti non solo inibiti nel loro potere e demonizzati
come conservatori (quindi antirivoluzionari), ma anche allontanati e chiuse le
loro sedi dalle quali erano stati confiscati gli arredi di valore; dei
cittadini più prosperosi che godevano di quella maggiore considerazione una
volta destinata solo ai nobili, ma vessati da tasse sempre più esose che
pagavano ‘mugugnando’ e dai sequestri (di alcool, sale e viveri) ma non
apertamente per paura; di quei cittadini poveri che per difendere la Repubblica
facevano letteralmente la fame; e di quegli altri abitanti con l’obbligo di
ospitare i soldati i quali - con la scusa di garantire le leggi e generare
protezione- commettevano abusi ed irritanti violenze (300 erano alloggiati a
forte Crocetta; 150 nella Lunetta del Belvedere; altri occupavano parte del
Castello o erano dislocati in vari magazzini; ma gli ufficiali e graduati i più
erano alloggiati nelle case private e mantenuti).
BIBLIOGRAFIA
-Gazzettino Sampierdarenese
2/88.6 + 5/88.3. + 7/88.3 + 5/89.3 +
LOGGIA crosa
della Loggia
Citata da Tuvo nella sua
storia di Sampierdarena, a proposito di una istanza scritta ai Padri del Comune
da Gian Giacomo Salinero il giorno 8 ago.1586 col fine di poter fare delle migliorie
alla propria casa posta appunta in “crosa della Loggia”. La risposta del
Serenissimo Senato genovese, del gennaio successivo, ingiunge al Salinero di
non fare modifiche nella piazzetta, che resta in fondo alla Crosa della Cella.
Capacci cita una “Loggia
d’alto”, che assieme alla crosa della Cella delimitava la Coscia, il quarto
quartiere del borgo (dopo san Martino, Mercato, Fiumara) , dalla chiesa sino a
Capo di Faro (quindi, presumo, l’attuale salita Belvedere e, in essa, la villa
dei Doria con la loro Loggia).
Relativi ad anni prima della fine
secolo, leggi sotto a 1825.
Sul Gazzettino, sempre Tuvo
cita che il 4 mar.1800, il Commissario di Governo della Polcevera,
DeFerrari, scrisse alla municipalità: “avendo riconosciuto inutile il sin qui
operato per la vendita della cosiddetta ‘Loggia di San Pier d’Arena’, escluso
l’atrio, non essendovi alcun aspirante all’acquisto della medesima, ne feci
rapporto alla Commissione straordinaria del Governo, oggi” .
L’interpretazione più logica -
a mio avviso - si avvale del principio in uso a quei tempi di dare nome ad un
luogo in rapporto alla presenza di qualcosa di caratteristico (valgono per
esempio “la coscia” “la fiumara” “la crosa larga”, la stessa chiesa della
“Cella”); essendo la loggia una stanza-terrazzo di una villa - caratteristica, e con ben chiaro significato di
estetica e rappresentatività- perché non chiusa da muri ma - seppur
coperta da un tetto - aperta da uno o più lati al panorama del posto (che doveva essere assai bello ed idilliaco a quei
tempi, ma solo a chi aveva i mezzi ed un piano nobile per possederlo ed
ammirarlo ) tramite un colonnato; nei pressi della “crosa della
Cella”, con una loggia, c’erano solo villa Monticelli a levante e villa
Gavotti a ponente (anche se a quei tempi poteva
anche esserci qualche altra casa munita di una simile terrazza, più vicina al
mare della grande villa, di proprietà del Salinero).
Una delibera comunale del 15
nov. 1823 – sindaco Vincenzo Canale -
recita “al fine di sopperire alle spese da effettuarsi per il restauro della
cosiddetta Loggia di proprietà comunale, posta in cima alla Crosa della Cella,
sotto la casa dei signori eredi Samengo, e
che non arreca alcun vantaggio al Comune, ma che serve anzi per ricettacolo
d’immondezza e che può anche favorire di nottetempo qualche male intenzionato,
se ne fosse, mancando i fondi, deliberata la vendita al pubblico incanto,
dichiarando che il prodotto della stessa venga esclusivamente impiegato nella
spesa per l’ingrandimento di questa Casa Comunale”
Una vertenza nata nel 1825
e perdurante nel 1832 tra il Comune–proprietario “della loggia comunale”-(sindaco Salvatore Tubino), ed i fratelli
Samengo, residenti al piano superiore della villa Gavotti: i Samengo evidentemente miravano ad impossessarsi
di tutta la villa il cui piano terra era invece proprietà del Comune; questi
invece voleva aprirvi dei negozi. La contesa portò ad un corposo
carteggio intitolato: ‘riduzione a botteghe della Loggia posta in capo alla
Crosa della Cella’. Angelo Scaniglia,
arch.to, fu incaricato di una “perizia dei lavori da farsi alla così detta
loggia posta in cima della crosa Cella in S.Pierdarena ”…”ad uso botteghe,
sotto la casa dei Ss.mi Eredi Samengo”. Mai viene citata la villa, con nomi
dei proprietari antichi o attuali, ma solo col nome generico di Loggia.
Tuvo segnala aver letto che
nel 1825 la Municipalità rimetteva a disposizione (presumo, per la vendita) il
locale della Loggia, ristorato. Essa era stata chiusa –evidentemente ai tempi
della repubblica Ligure- dall’eccellentissimo Giuseppe Doria -a proprie spese-
al fine di creare una sala di conversazione per la nobiltà che si portava in
villeggiatura in San Pier d’Arena”. Con il sopraggiungere della rivoluzione
però, quei locali furono requisiti e le spese fatte furono rimborsate dalla
Municipalità sampierdarenese.
Quindi infine e secondo me, il
termine in oggetto, indica un negozio posto d’angolo con la crosa della Cella,
o nel davanti della villa dei Gavotti-Samengo, sulla strada principale-, o nel
retro lungo quella che ancor oggi è la via dedicata all’ultima famiglia. A
definitiva testimonianza nel 2010 arriva a conoscenza la carta dell’ing.
G.Brusco del 1782 – la cui precisione è fuori di ogni sospetto - che nella sua
pianta topografia esplicativa del ‘progetto per ampliare la strada di
Sampierdarena’ (oggi di proprietà di banca Carige) pone “la Loggia”
nell’incrocio di via della Cella-via Daste, non nell’angolo ma lievemente
spostato a ponente e limitato alla facciata su via Daste. Questo quando la
proprietà terriera era già “delli Sig.ri Samenghi”.
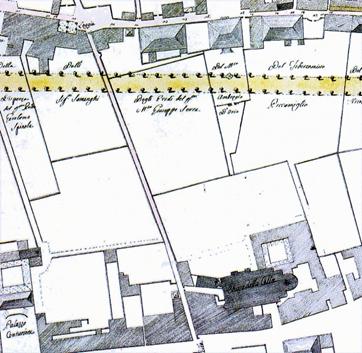
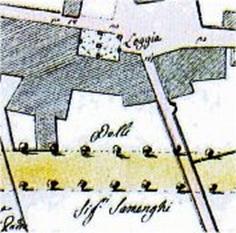
7
febbraio 1782- Giacomo Brusco
particolare ingrandito
Il Dizionario delle
strade di Genova offre un’altra interpretazione al nome, anche se riferita ad
altra zona della città: lo fa derivare da una storpiatura della parola
“Liggia”, che -viene spiegato-significa scoscesa o pendio; cosa che potrebbe
essere ovvia anche a Sampierdarena; ma appare improbabile considerato che in
vicinanza della Cella, non ci sono problemi di alture.
Lo
stesso Casaccia fornisce alla voce “lögia” solo la mia interpretazione
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Capacci A.-Sampierdarena dalle
origini al XX secolo-1975-
-Gazzettino Sampierdarenese
9/89.3
-Isola E.-Quella strada
d’avanguardia...-La Casana n.2/2010-pag.17
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi85-pag.993
-Tuvo T.-Memorie storiche di
SanPierd’Arena-Dattiloscr.inedito-pag.109
-Tuvo.Campagnol-Storia di Sampierdarena-D’Amore
1975-pag.19
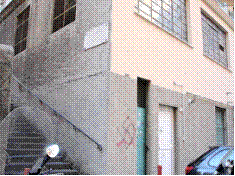
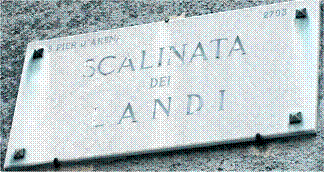

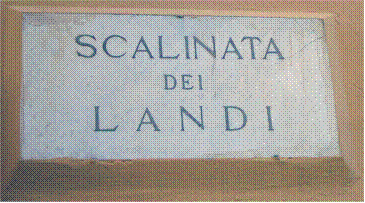

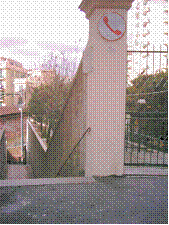

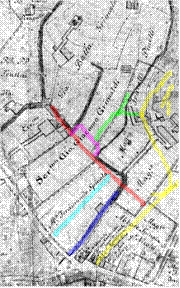 da MVinzoni, 1757. In rosso via
PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico
tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi
da MVinzoni, 1757. In rosso via
PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico
tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi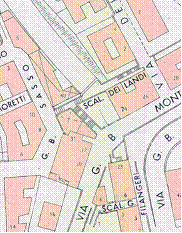 Dal Pagano 1961
Dal Pagano 1961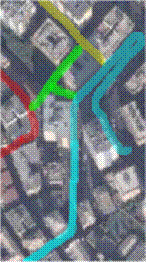 da
Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei
Landi
da
Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei
Landi 
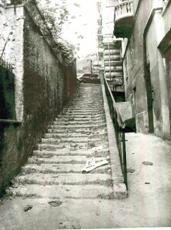

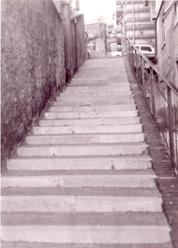

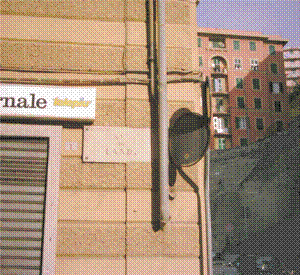
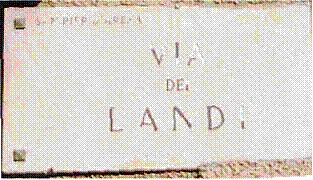




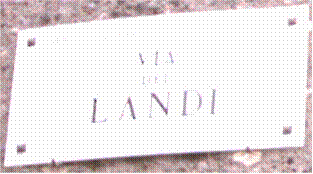
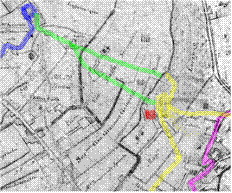 da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato
della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;
rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.
da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato
della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;
rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.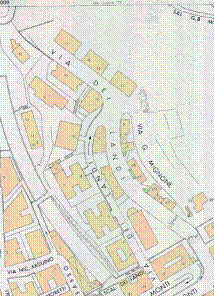
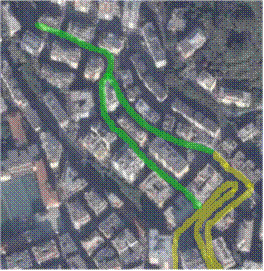
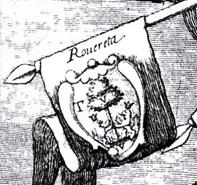

 Esse
ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18
anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.
Esse
ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18
anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.
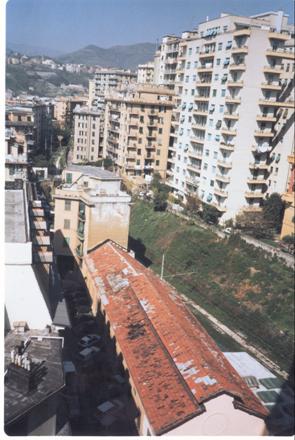

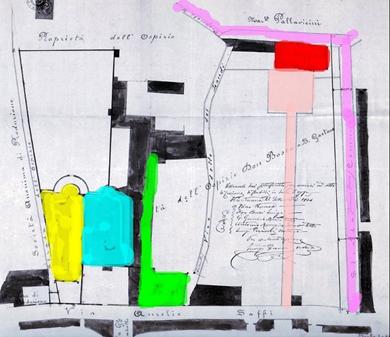 vico detto dei
Landi, mappa del 1914
vico detto dei
Landi, mappa del 1914