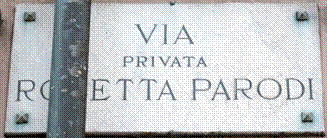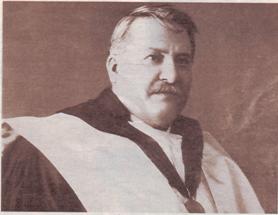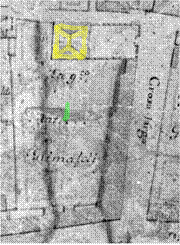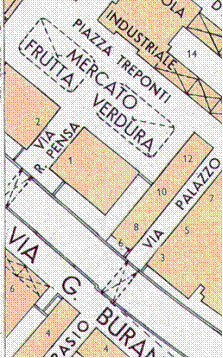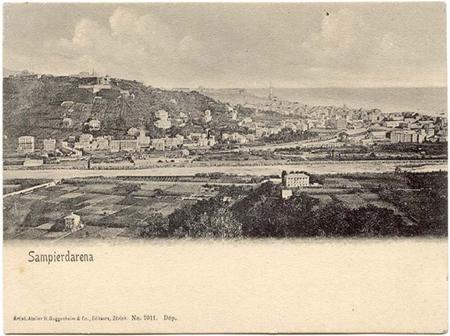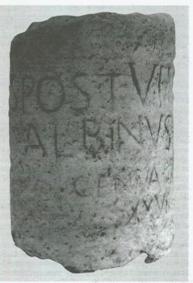PACINOTTI via Antonio
Pacinotti
TARGA:
San Pier d’Arena – via – Antonio
Pacinotti – fisico – 1841 - 1912

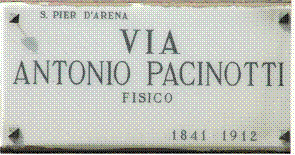
Targa all’inizio, a mare lato ovest

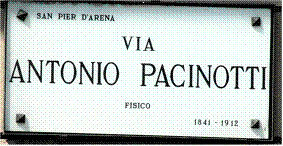
targa a monte, lato ovest
QUARTIERE ANTICO: Coscia
 da Google Earth 2007. In verde, ipotetico
tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via
Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.
da Google Earth 2007. In verde, ipotetico
tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via
Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2817

da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 44520
UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;
blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini
Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;
blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini
CAP: 16151
PARROCCHIA:
s.Maria della Cella
STRUTTURA: strada che dalla fine di via San Pier d’Arena
prosegue fino alla Crociera e Largo
E.Jursè (dalle quali prosegue via R.Pieragostini).
Dall’incrocio
con via F.Avio, la viabilità verso il monte è a doppio senso; quella verso il
mare è invece a senso unico (obbliga i
veicoli diretti verso Genova o a immettersi in via San Pier d’Arena o in via
Molteni); solo i mezzi pubblici possono
girare a sinistra ed immettersi direttamente in via Avio.
È lunga
340 m circa; larga 10,6; in pendenza del 2% e collega il quartiere del Canto (a cui appartiene) con quello della Crociera;
San Pier d’Arena con il ponente. A nord è intersecata dalla ferrovia che le
passa sopra con due suoi viadotti.
La
strada, dal lato levante, termina con l’ultimo civico 57r, che è posto a monte
del ponte della ferrovia, sulla facciata a mare del fabbricato che si sviluppa
in via Alberto di Bozzolo.



la saracinesca è in via
Pacinotti; la targa è di via Alberto di Bozzolo; il civico “57r via Pacinotti”
è sulla colonna di mattoni sopra
il marmo tondo.
STORIA: Nella
carta del Vinzoni del 1757 non c’è alcun cenno alla futura strada che – quando
sarà tracciata - passerà attraversando l’interno di terreni di più
proprietari: da mare, del rev.do Giacomo DeNegri,
di Matteo Castelli (Magistrato dei Poveri) e del rev.do Stefano DeFerrari.
Se ne
deduce quindi che sia stata creata nella prima metà del 1800 quando i
proprietari terrieri iniziarono a vendere in conseguenza delle trasformazioni
progettate, specie ferrovia e Taylor, e della necessità di collegare la strada
a mare col ponte e verso il nord bypassando il centro.
Una
prima carta, del 1846, già la descrive chiamandola “ strada Reale di Genova”.
In quegli anni, le strade del borgo erano in terra battuta senza lastricato;
era necessario innaffiare il terreno per ridurre il polverone, quando vetture e
carri procedevano più spediti. La zona attorno la strada era ricca di acqua e
quindi di orti di eccezionale fertilità rispetto alla generica sterilità delle
terre del genovesato, e quindi il rifornimento di verdure all’interno delle
mura era effettuato passando su questo itinerario per arrivare alla spiaggia e
via mare rifornire la città.
Il regio decreto del 1857, la chiamò “via
Nuova”, quale tratto finale della Strada della marina e la leggiamo - con lo
stesso nome - proseguire lungo l’attuale via Spataro sino al Campasso. In
quegli anni erano già nati nella zona gli stabilimenti di Taylor poi Ansaldo;
ed in beve a seguito verranno il ponte-muraglione della ferrovia verso il
ponente, i Molini, le OEG, i binari a terra (ferroviari e dei tram; questi
ultimi, elettrici, iniziarono il servizio l’8 febbraio 1900).
Ebbe
finalmente il nome ufficiale di “via
Garibaldi”, negli anni di fine 1800.
Dal
1904 (un anno dopo rispetto i similari Molini
Liguri, nati nell’area Fiumara ma prospicienti il mare), su
un lotto di terreno a nord dell’Ansaldo e vicino al ponte, si aprirono sulla
strada al civ.22, i “Molini Alta Italia”.







L’album descrive “ MOLINI ALTA ITALIA / società anonima / col
Capitale di Lire 8. 000. 000. – Interamente Versato e colla Riserva di Lire 7.
034. 955.74 / SEDE in GENOVA /
Stabilimenti di Macinazione /
Sampierdarena – Pegli – Bolzaneto – Ferrara – Bologna – Collegno –
Oneglia / - Vedute interne – del Molino
di Sampierdarena / della potenzialità di q.li 5000 al giorno”
Grossa
industria di farine, con direzione a Genova via XX Settembre, che ebbe le sue
radici dal superamento tecnico dei numerosi mulini a conduzione familiare
disseminati sul territorio (che nel 1882 erano –in provincia di Genova- 37 a
vapore e 1331 ancora idraulici). Nata nel 1899
da finanziamento-investimento di 12 milioni da parte di grosse banche
(determinante quello della Commerciale Italiana, con quote di oltre 5milioni,
divenuti 7 nel 1901; ma anche minori
come quello di una banca Russa nel 1903 per 250mila lire) che fusero tre grosse
imprese private (di Pietro Ravano, f.lli Bozano e della sampierdarenese
Scerno-Gismondi&C. con stabilimento anche a Pegli ed in Emilia), divenne un
colosso finanziario (e come tale soggetto a periodiche recessioni di mercato,
come con svalutazione dei titoli (1906) e ricupero nel quinquennio successivo)
ramificato in produzione e partecipazioni (iutificio a LaSpezia (assieme
all’Eridania), magazzini, frigoriferi, pastifici, oleifici, ecc) ovvero a sua
volta finanziatore e compratore di decine di altre imprese sparse anche in
Piemonte, Toscana, Sardegna ed in Tunisia; con la partecipazione di grosse
famiglie genovesi come i Raggio, Odero, Becchi, Ravano, Scerno, Gismondi e
tanti altri.
Da noi,
i due stabilimenti pluripiano furono eretti dall’impresa ing. GB Porcheddu di
Torino che -con prodotto a brevetto belga- era divenuta esperta nel neonato
cemento armato, sostitutivo del vecchio metodo dei muri in pietra e sostegni
interni in ferro e ghisa. Dei due, un fabbricato era per la pulitura del grano
e macinazione, un secondo quale silos per deposito del prodotto iniziale e
finito; serviti da binario ferroviario collegato su strada con il porto e la
stazione. Il normale trasporto in spalla di sacchi di farina, generava gare di
forza tra i vari facchini: fa parte della leggenda tra fantasia e realtà
quindi, ma che viene ricordato su tutti i testi, tale Antonio Bottaro, detto
Manela, che compì l’ impresa di sorreggere sulle spalle per un minuto 5 sacchi
da un quintale; era capace di tenere un sacco da un quintale sottobraccio, con
la stessa semplicità con cui una madre tiene il suo pargoletto in fasce).
Nel 1903 alla nascita dei confinanti e
concorrenti ‘Molini Liguri’, anziché combattersi tra loro nacque subito una reciproca
integrazione dirigenziale che permise la vigorosa espansione di ambedue. Nel
1937 in concomitanza di una ristrutturazione della zona della Crociera, come
descritto sotto, il muro perimetrale verso via Pacinotti fu arretrato verso
l’interno ove era un cortile, permettendo alla strada di allargarsi oltre il
pilone della sovrastante ferrovia, ed ai tram di eseguire una curva più
dolcemente. Lo stabilimento fu chiuso nel 1965, demolito nel 1969 ed il terreno
acquistato dall’Ansaldo MN che vi edificò di suo.
Una fonte del 1910 scrive che era: “da via C.Colombo allo scalo ferroviario di
Piccola Velocità”, con civici sino al 27 e 42). Ma anche allora, come
detto, comprendeva le attuali via
Pacinotti e via G.Spataro assieme fino al sottopasso di via G.Tavani. In questi
anni la strada non aveva il traffico attuale (oggi, è praticamente una strada
solo di traffico) ma era molto più vissuta dai suoi più numerosi abitanti
(considerata la vicinanza con le fabbriche): piccoli negozietti creavano il
calore indimenticabile di un ambiente di vita vissuta con le picole cose,
specie per i più piccoli; così nella strada vengono ricordati i “Pasin” che
vendevano chincaglierie e cartoleria con una meticolosità e riservatezza da
dare l’impressione di essere dispiaciuti di vendere un oggetto; la macelleria
del baffuto e generoso“ö Pinetto”; la latteria dei Cerrato che col misuratore
travasavano la quantità di latte
richiesta nel proprio “bolacchin”; e la drogheria delle sorelle Duo che tra
l’altro vendevano a portata dei bambini i pescetti di liquirizia ed il
reganisso. Ad ovest si aprivano i
magazzini –forniti di linea ferroviaria
sino all’interno- di Scerno e
Gismondi (posti tra via Operai e la ferrovia; poi inglobati dall’Ansaldo); e
quelli di Luigi Morasso (da via Operai a via Bombrini) a cui apparteneva
probabilmente il caseggiato-villa
seicentesca sopravvissuta alla ristrutturazione totale dell’ambiente.
Sulla
strada, a levante, si apriva la “ piazzetta dei Lavatoi”, dove su due grosse
bocce di pietra era uso agli uomini sedersi per parlarsi un po', mentre le
mamme facevano bucato e i bambini giocavano alla palla fatta di stracci. Sulla
strada passava il tram , ed anche un binario dei treni merci (vi si formavano i
convogli, da agganciarsi ed essere portati al parco Forni).
Inflazionata risultò la dedica stradale al
generale, quando nel 1926 si dovette
scegliere per dedicargliene una sola nell’ambito della grande Genova: ben 11
delegazioni avevano una via a lui dedicata, e tutte dovettero ‘cederla’ a
favore del Centro (oltre al Centro, era a Borzoli, Nervi, Pegli, Pontedecimo,
Rivarolo, SPd’Arena, Sestri, Voltri, Cornigliano, Prà, Quarto). Per la nostra
città fu programmato sopperire, trasferendo la dedica ad Antonio Pacinotti dal
vico presso la Cella a questa via. Però
dal 1926 al 1935 nulla fu fatto di ufficiale, risultando che ancora nel 1933 la strada sempre si chiamava via
Garibaldi ed iniziava al Canto da via C.Colombo, e sempre arrivava a via G.Tavani a san Martino; che era di 3.a
categoria ed i civici erano fino a 27 e
36. In questi anni, il vico Antonio Pacinotti era ancora presente presso via
della Cella (vedi).
Solo il 19 agosto 1935 con delibera del podestà le venne
ufficialmente imposto il nome attuale di via Antonio Pacinotti (da via N.Barabino
a via G.Tavani, spostando in posizione più degna la dedica stradale dal vicolo
collegato con via della Cella che rimase anonimo). In quegli anni
corrispondenti all’apertura di via Avio, una parte del piazzale dell’OEG fu
“acquistato” dalla strada neoformata, per allargarne lo sbocco.
Nel 1937-39, la strada (che alla Crociera per continuarsi
in via Monte Corno (via R.Pieragostini) passava con una stretta angolatura solo
a monte del pilastro a sostegno della ferrovia della linea Genova-XXMiglia) si
deliberò poterla notevolmente allargare, sia abbattendo a levante un grosso
palazzo ad abitazioni (che la separavano da “vico Alberto di Bozzolo”,
divenendo le due strade direttamente affiancate e divise come oggi solo da un
giardinetto); sia espropriando a mare della strada -per ragioni di pubblica
utilità- una striscia di terreno a forma di fuso (di proprietà -e comprendente
la portineria- della soc.An.Molini Alto Italia. Alla fine però si venne ad un
accordo amichevole, con una spesa per il Comune di 30mila lire per l’esproprio
e 120mila per il rifacimento della zona)). Così il tratto nuovo di strada,
quasi una piazza, raggiunse tra i 11,5 e 15,5 m. di larghezza .
Nel dopoguerra, con delibera dell’apr.1946
il tratto a monte dopo la Crociera, venne dedicato ai due partigiani E. Jursé
e G. Spataro.
Nel Pagano 1950 vengono segnalate tre
osterie (3r di Spinoglio F.; 7r Gaj E.;
34r Gastaldi Lidia); nessun bar caffé; una trattoria (di Pesce Emilio al
69-71-73r).

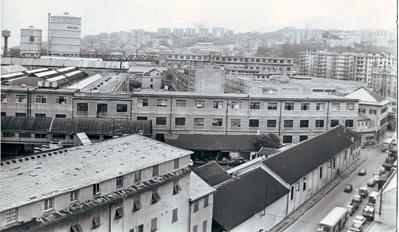
anno 1970 1980



tre foto anno 2002
retro
Negli anni 2000 frequenti sono stati gli
incidenti: più eclatante l’ improvviso rovinoso spontaneo cedimento e caduta di
un palazzo disabitato da oltre trent’anni,
(i civv.14-16-18; il 30 giugno
alle h.16. Cedendo un arco a piano terra, la facciata -in via di demolizione da
parte della soc.genovese Edilpamoter- si trascinò dietro le impalcature; per
fortuna senza vittime; gravissime ripercussioni sul traffico, dirottato e
capovolto in via Dondero e su una tubatura dell’acquedotto spezzata. Nel 2007
gli otto imputati di Fiumara Nuova –società destinata alla demolizione
dell’Ansaldo- e di Coop7 alla progettazione, quindi responsabili del piano di
sicurezza, sono stati tutti assolti perché ‘il fatto non sussiste’); e la morte di alcuni autisti (un
veicolo precipitato in una fossa mal recintata; una motociclista scivolata e
finita contro un tir) con qualificazione di strada
ad alto rischio veicolare.
Nel 2004 fu lanciato – per Ge. capitale della cultura - il concorso
“Urban Regeneration” col fine di far proporre a giovani architetti nuovi
progetti sulla città in cambiamento. Per via Pacinotti, tema: “ area di 1 ha, residenziale per 100
abitanti, attività commerciali e direzionali, verde attrezzato, parcheggio per
250 vetture.
Ne furono presentati quattro (uno
di appartenenti alla facoltà di archit. Diparc, con parcheggi e piani a diversa inclinazione; due belgi, uno
con parcheggi e palazzine multiple;
l’altro con collinetta e sei edifici a torre. Uno dell’univ. di Ge, con
edifici a gradoni, verde, parcheggi ed auditorium.
Con
l’apertura dei centri della Fiumara, la strada è attraversata da migliaia di
persone al giorno.


foto 2002
foto 2008

CIVICI
2007=
NERI= dall’1 al 19 (mancano 7 e 9) e dal 2 al 20 (mancano 12→18)
ROSSI=dal 3r
al 57r (manca 1r; in più il 21Fr e 21Gr)
Dal 2r al 52r (mancano
38r→48r; in più 6Ar e 26Ar)
Nel Pagano/40 sono segnalati: la strada che è limitata ‘da
via N.Barabino e da via
G.Tavani’: civ. 1n = RollaTraversi&Storace, s.a. ferri, met.; 1n
=L’immobiliare finanziaria s.a.; 9 canc. e 13/1 Offici.Elettr.Genovesi; 20n
s.a. Ansaldo; 22n s.a. Esercizio Molini; 34n Eridania zuccher.nazionale e
spaccio commest..
Civv.
rossi dispari= 3r trattoria BozzoloF.; 5r s.lle Storace pasta
fresca; 7 osteria Gaj; 9r macelleria; 11r chincagl.; 19 comm.; 59r orologeria;
61r parrucchiere; 63r calzolaio; 65r fruttiv.; 69 trattoria Brusco Isabella;
77r vini; 81r vini; 83r latteria; 85r salumeria; 87r drogheria e bar.
Civici rossi pari = 2r salum.; 4r tabaccheria; 6r parrucchiere; 8r
latteria; 10r drogheria; 14r fruttiv.; 18r fonderie FavaM fu G.; 22r calzolaio;
26r polliv.; 28r mercerie; 30r falegname; 34r osteria; 66r osteria; 68r osteria;
76r commes.li; 78r rip.biciclette; 82r osteria; 84r Distillerie Italiane (laborat.);
84Ar bottigl.
===civ.1: ancora nel 1950 il prof. Rolla Luigi era consigliere della “soc.an. Rolla, Traverso & Storace, di prodotti
siderurgici e metallurgici” ( fabbrica di lavorazione del ferro, lamiere,
metalli, tubi. Bande estere e nazionali, depositi di bande e lamiere stagnate e
piombate). Già nel 1933 aveva un
capitale di 3milioni ed una filiale in piazza Cavour. Lavorava materiale minuto
il più vario, reclamizzato in ben 41
articoli come l’acciaio, apparecchi per riscaldamento ed illuminazione
elettrica, articoli di idraulica ed igiene,
ecc.. Nel 1961 aveva sede in via F.Avio al 4/2bis con capitale
aggiornato a 25milioni, dei Traverso nel consiglio di amministrazione, ed un
magazzino doganale proprio, e produzione allargata all’alluminio, al rame ed
allo stagno, lana di piombo (unici fabbricanti della cosiddetta ‘stoppa di
piombo’ per giunture di tubi, ponteggi tubolari con brevetto proprio per i
giunti d montaggio, ferro per cemento
armato, il tutto anche ‘a vagoni completi’ e per l’esportazione, vantando una
anzianità di oltre sessant’anni e di essere il ‘più assortito deposito di
materiali siderurgici e non ferrosi della Liguria.
Nell’area
fu costruito un palazzo nuovo con portoni che si aprono in via T.Molteni; sulle
facciate si vede ripetuta in rilievo la sigla TRS.
===civ. 2 i primi civici pari sono case da abitazione popolare, alcune a villetta
settecentesca, alcune fatiscenti perché trascurate.

===civ. 5:
nel 1849 vi abitava l’ing. Tomaso (Thomas)
Robertson, facoltoso scozzese, proprietario dell’omonima società, uno
dei pionieri dell’industria siderurgica genovese che godette della fiducia del Cavour -vedi-.
Arrivato quell’anno a San Pier d’Arena, per primo rispetto altri conterranei,
con discreto capitale ed un pacchetto creditizio da Glasgow - quale forse unica
iniziativa britannica di un certo rilievo nel campo dell’industria
manifatturiera - aprì nel 1851 nella zona “sud occidentale” il suo stabilimento-officina meccanica e
fonderia che diverrà terzo grande opificio del borgo specializzato nella
produzione di ruote idrauliche e turbine. Utilizzando commesse statali e di
privati (tra i quali c’era il gruppo Rubattino: egli in proprio ne era socio
per lire 70.800) si specializzò nella produzione di ruote delle quali appunto
il gruppo necessitava per i propri piroscafi. Sposato, aveva tre figlie. Dopo soli 12 anni di attività,
improvvisamente morì appena 49enne, nel
novembre 1863.
La sua
fabbrica, nella quale nel periodo
1858-61 lavoravano 230-400 operai, gradatamente divenne fortemente indebitata
al punto di crisi irreversibile, fino ad
essere messa in liquidazione l’anno successivo (con grossi crediti vantati su
ipoteche e prestiti da banche ‘foreste’, nonché professionisti e nobili
genovesi). All’epilogo di questa situazione a poco valse l’ultima boccata
d’ossigeno proveniente dalla regia Marina che nell’estate 1863 fece una
ordinazione per 133.683 lire (di fronte ai 2.647.120 per l’Ansaldo); la crisi
era ormai un dato di fatto. Gli eredi dell’impresa si trovarono senza
commesse – in uno Stato (Destra storica) tendenzialmente restio ad investire
nel settore industriale preferendo in quello agricolo - e, fortemente
indebitati, dovettero liquidare tutto. (Pare
che nel frattempo l’azienda si fosse trasferita nell’attuale via W.Fillak -vedi
di fronte alla casa civ.15 ma invece probabilmente fu quella dei suoi
conterranei Wilson&Maclaren).
Dalle lettere del Cavour a suo
riguardo si leggono particolari parole di elogio e riconoscimento di capacità
professionali, quando in contemporanea formulava aspre e sfiduciate critiche
nei confronti dei dirigenti dell’Ansaldo. Al suo servizio –dopo la guerra in Crimea- erano
venuti anche i conterranei Alexander MacLaren e John Wilson, che forti del
titolo di ingegnere, di macchinisti e di una generosa liquidazione ottenuta
dopo il servizio in Marina -approfittando che il governo torinese aveva tolto
l’obbligo del passaporto per gli inglesi, si fermarono proponendosi come
capotecnici per una scelta definitiva genovese, ed aprirono dopo il 1862 uno
stabilimento proprio, il quarto in città, divenendo pure loro pionieri
industriali della San Pier d’Arena metalmeccanica.
L’edificio
venne demolito nel 1952 e ricostruito
nel 1955.
===civv.
11.13.15: erano
dapprima palazzine isolate.
La
palazzina n° 11, era di proprietà di Luigi Morasso,
un ricco industriale del sapone (insieme al fratello aveva aperto
alcune fabbriche di oli e saponi (tra le
quali quella poi posseduta nel 1833 da Salvatore Tubino - padre –comunque omonimo- del futuro sindaco GB? - a sua volta
‘sfrattato’ da Taylor (vedi Ansaldo) nelle sue necessità espansionistiche), con la
passione della pittura, e capace al punto di essere stato chiamato a realizzare
degli affreschi nella parrocchia della Cella. Nato
a Sampierdarena il 7 apr.1797 da famiglia facoltosa di commercianti.
Trasferitosi a Cadice, stimolato dai pittori e dalle cose d’arte locali nonché
dalla sua indole espressiva, iniziò a produrre opere figurative sempre più
interessanti. Tornato al “Canto” nel 1840 circa, continuò la produzione di tele
assai di pregio e divenute di grande valore locale e praticamente limitato a
collezioni private. Nella chiesa della Cella, un affresco riproducente “Valentiniano
salvato dalle fiamme miracolose” è l’esempio visibile da tutti della sua
validità artistica. Morì in San Pier d’Arena il 13 dic.1872.
Essendo
unica, si ritiene che inizialmente quando la strada si chiamava ancora via
Nuova, la casa avesse il n°12: dove nel 1860 vi era andato ad abitare lo
scozzese John Wilson affittuario del Morasso.
Lamponi
dice primitivamente sede degli impianti della società francese ‘Unione del Gas’
(con capitale interamente francese, era negli anni 1860-00 ed oltre, monopolio
dell’erogazione del gas a Genova, con dimostrate spese negli anni 1880 di
‘nuovi impianti’ mirati a tentare di ostacolare la nascente scoperta di Edison
della illuminazione con lampada elettrica. Questo costò alla città possedere un
iniziale impianto in centro (nel 1890, 108 lampadine) sei anni dopo le altre città).
Esse furono nel tempo inglobate in un edificio unico dalle officine
elettriche che si chiamarono OEG (Officine Elettriche Genovesi).
I suoi impianti, con macchine,
caldaie ed alti camini costruiti su progetti della AEG tedesca, iniziarono l’attività nel 1897; e furono
all’altezza di sostituire negli anni attorno al 1901 i precedenti impianti di
illuminazione a gas, con una nuova rete elettrica, ampliata sempre più nel successivo decennio.





Possedeva grossi tubi che arrivando sino al mare: assorbivano ingenti
quantitativi di acqua, necessaria per raffreddare gli impianti. L’energia elettrica diffusa in città, favorì l’inserimento dei tram ways eliminando
la trazione animale , e della
illuminazione stradale fissa per tutta la notte con lampade appese alle
case (visibili ancora in via Buranello ed altre) o a piloni di legno pitch-pine
muniti di traverse graziosamente lavorate in ferro e poste a mensola, e poi di
tutte le case con il relativo conseguenziale enorme progresso.
Il complesso, era dell’ ENEL (ed
usato come deposito e magazzino; mentre sono stati decentrati gli uffici). Nel 2010 con la privatizzaziobne della
corrente elettrica, tutta l’area appare sgomberata dall’Enel ed il piazzale
segnato per terra per area di posteggio veicoli
Esternamente appare come un lungo
edificio a doppia scaletta di altezza, con portoni distribuiti irregolarmente a
significato di – seppur fatti tutti eguali con la parte alta arrotondata, escluso
il 43r rettangolare- aperture in tempi diversi per uso diverso. Al centro
quello più alto a tre piani senza portone; lateralizzato da due costruzioni a
due piani delle quali quella a mare ha un portone (civ. 13 nero), quella a
monte due (civv15 nero e 45 rosso); a sua volta ancora lateralizzato da
costruzione più lunga ad un piano di cui quella a mare ha il civ. 11 nero e 43
rosso, e quello a monte con due portoni,
i civv. 17 e 19 neri.


progetto OEG – 1908 - sala
macchine 1914


l’area Enel in una panoramica
dell’anno 2000
===civ.
15r Nel Pagano 1950 viene descritta la “fonderia metalli di Fava
Mich. succ. Palazzo Luigi”
===civv 14-16-18 (oppure 12-14-16?) erano stati sgomberati da casa di abitazioni
trent’anni prima, e poi chiusi per evitare abusivismo dagli extracomunitari.
Nel programma di demolizione da parte della ditta genovese Edilpamoter
nell’ambito del progetto di utilizzo della “zona Fiumara” già di proprietà
dell’Ansaldo, l’ultimo giorno di giugno 2000, l’intera facciata del civ. 14 in
quel momento alta una diecina di metri e lunga una ventina crollò
spontaneamente sulla strada, trascinandosi l’impalcatura, bloccando il traffico
e occludendo una condotta d’acqua; fortunatamente senza vittime divenne
obbligatoria la chiusura al traffico della strada per alcuni giorni, con
pesanti ingorghi, inversioni di traffico; avvisi tecnici di garanzia alla
Coopsette (titolare dei lavori di demolizione), alla Edilpamoter (che aveva
acquistato il sub appalto) ed alla Ira sas, (che gestiva una parte del
subappalto), per sopralluoghi e perizie al fine della tutela della pubblica
incolumità.


1999. L’arco, presumibilmente
faceva passare un treno, per servire un grosso stabilimento (Ansaldo?)


 2000
2000
===Civ. 19.
Un palazzo, in angolo con via Degola, nato presumibilmente come resendenza
operaia (senza terrazzi e decorazioni), nel 3/2007 è in fase di
ristrutturazione e vuotato di abitanti. Reca cartello con scritto: «proprietà
di Spazio Industriale 2 srl, di Milano».

anni 1980

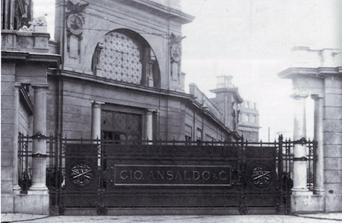
foto 1918 cica
Ne
ususfruirà l’Agenzia di Produzione INPS, per suoi uffici.
===civ.
20: una palazzina in stile secentesco, della cui
origine non si conosce nulla
(proprietario, data, architetto).
 Dagli anni
1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio Scerno
e Gismondi, che poi era divenuta ‘Oleifici
Nazionali’, con una fabbrica eretta dietro alla villa stessa; a loro
rimase una trentina di anni. Il 30 ottobre 1913 il proprietario Carlo Pastorino
firmò un compromesso di vendita - della villa e dei 5mila metri quadri di
terreno racchiusi tra il viadotto ferroviario e la via G.Ansaldo - con
l’Ansaldo (Mario Perrone); l’impegno che fu onorato definitivamente il 3 giugno
1915.
Dagli anni
1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio Scerno
e Gismondi, che poi era divenuta ‘Oleifici
Nazionali’, con una fabbrica eretta dietro alla villa stessa; a loro
rimase una trentina di anni. Il 30 ottobre 1913 il proprietario Carlo Pastorino
firmò un compromesso di vendita - della villa e dei 5mila metri quadri di
terreno racchiusi tra il viadotto ferroviario e la via G.Ansaldo - con
l’Ansaldo (Mario Perrone); l’impegno che fu onorato definitivamente il 3 giugno
1915.
L’Ansaldo conservò la villa ad uso uffici e, per accedere alle officine
retrostanti dall’arch. Ravinetti fece disegnare un cancello in ferro battuto da
aprire a fianco della casa (e distrusse l’oleificio retrostante per
costruire una officina di 600 mq ad uso ‘presse e proiettili’ - disegnata
trapezoide dall’arch. Ravinetti Adolfo e costruita dall’impresa Porcheddu specializzata in cemento armato-, a
sua volta demolita negli anni 1940 per un fabbricato ad uso uffici appaltato
alla ditta Bo&Celesta di tre piani, che fu poi occupato dalla Ansaldo
Sistemi di componenti fotovoltaici).
L’appropriazione
di questo lotto a levante, concluse una serie di acquisti che inglobarono nel
complesso Ansaldo la via G.Ansaldo che il 27 novembre 1920 fu acquistata a sua
volta e privatizzata.
In una
carta del 1918 appare (inserita in un vasto
terreno racchiuso tra via Garibaldi=viaPacinotti e via Bombrini, di proprietà
Dufour) di proprietà ‘fratelli Feltrinelli’; divenne poi
l’ingresso-portineria per l’Ansaldo
Meccanico (poi Nucleare, poi ASGEN=Ansaldo soc.generale
elettromeccanica); la società, nata nel 1966, subì un drastico
arresto nella sua espansione produttiva, quando un referendum popolare bocciò
in Italia qualsiasi attuazione di progetti per l’energia nucleare . Nel 1998
ancora in vita, attraversava momenti di gravissima crisi, con minaccia di
accorpamento anche con società straniere, o riconversione ad altre tecnologie.
Un cartello avverte nel nov.1999 che è sede della società Coop 7 che si
interessa dell’area retrostante da ristrutturare.
===civv 21-23-25 furono demoliti nel 1963. Al civ. 23 c’era il 4° distretto di polizia,
Il Commissariato di P.S. era locato come in un appartamento ancora negli anni 60, diretto dal
dr.Fatigati. Poi il tutto fu trasferito a Cornigliano.
===civ. 22
nel 1950 avevano sede i molini della Società Esercizio
Molini, in quegli anni unica del genere, in Sampierdarena, a parte una
soc.an. Molino di s.Giuliano Piemonte localizzata in via B.Agnese in un
appartamento del 7°piano del civ.2.
===civv.dal 24 al 36 passarono a via G.Spataro a seguito della nuova denominazione
stradale, nel febb.1946.
===civ. 27
fu demolito nel 1962.
DEDICATA al celeberrimo fisico pisano (a lungo
fu ritenuto genovese), nato il 17 giugno1841.
Studioso
di problemi correlati all’induzione elettromagnetica, inventò – nel senso che
progettò e costruì nel 1859 – il primo generatore di corrente continua,
comunemente poi utilizzata per motori e dinamo. Detto “anello di Pacinotti” è un anello -
rivestito di fili di rame – girevole su un asse – posto ai poli di un magnete
nel quale, la rotazione induce nel filo una corrente elettrica, e viceversa,
quest’ultima imprime un moto rotatorio all’anello.
Principio
che - poi perfezionato da lui stesso e da altri - è divenuto la dinamo
necessaria per il motore ad energia elettrica.
Il
padre Luigi, fu un valente fisico e per
anni rettore della cattedra di fisica tecnologica a Pisa. Il nostro, studente
liceale al collegio santa Caterina, si iscrisse all’università nel 1856.
Ancora
studente partecipò alla guerra di indipendenza del 1859, quando già aveva
intuito di ottenere un generatore di corrente continua facendo rotare un
piccolo anello elettromagnetico: il principio di base del motore fu scritto
come appunto in un diario personale che aveva intitolato ‘sogni’. Con l’aiuto
del meccanico G.Poggiali, l’anno dopo sui ciglioni del Mincio sperimentò
l’invenzione della prima macchina capace di trasformare energia elettrica in energia
meccanica motrice, e viceversa; sia quindi come motore che come dinamo; ma nel
subito non si rese conto delle enormi e rivoluzionarie possibilità che
l’invenzione possedeva.
Si
laureò dottore in matematiche applicate nel 1861. Pubblicò i risultati nel 1865 su “Nuovo Cimento”:
fortunatamente, perché nello stesso anno esibì la sua macchina ad uno studioso
belga di nome Gramme, il quale la diffuse industrialmente brevettandola come
sua invenzione. La polemica si trascinò per una diecina d’anni finché Pacinotti
ebbe esplicito riconoscimento del mondo scientifico (all’esposizione di Vienna
del 1875, ed al Congresso internazione di Elettricità di Parigi nel 1881),
anche se al Gramme rimasero gli enormi vantaggi economici avendo intuito
l’importanza industriale dell’ invenzione.
Dopo essere stato
assistente del padre, entrò in carriera di insegnamento accettando l’incarico
a Firenze di
aiuto dell’astronomo GB. Donati pubblicando ricerche sulle comete
e sul calore solare; poi a
Prato (1863, insegnante di fisica e chimica nel collegio Cicognini); fu
inviato dal regio governo
in Francia, Belgio e GranBretagna quale studioso di meteorologia;
divenne professore di fisica e di chimica nell’ ist.Tecnico di Bologna da cui
passò alla cattedra di fisica nell’ università di Cagliari nel 1873 a soli
32 anni; ed infine - dopo il riconoscimento parigino - fu chiamato
quarantenne a succedere al padre nell’università pisana, rifiutando il titolo
nobiliare di conte.
Quest’ultima scelta e le
vicende della scoperta sottolineano il carattere schivo, modesto e severamente dedito alla famiglia,
lavoro e studio.
Nel 1906 divenne senatore
del regno, essendo già membro delle principali accademie internazionali - compreso
i Lincei - nonché presidente onorario dell’Associazione di elettrotecnica
italiana.
Accettò nel 1911con
dignitosa pazienza, le solenni onoranze nazionali, al cinquantesimo
anniversario dell’invenzione.
Lasciò numerose
pubblicazioni scientifiche
Morì a
Pisa il 25 marzo 1912
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archio
S. Comunale Toponomastica - scheda n°
3231
-A.sconosciuto-storia
dattiloscritta chiesa san GaetanoDonBosco-pag.16
-AA.VV.Annuario-guida
archidiocesi—ed./94.-pag.426---ed./02-pag.463
-AA.VV.-Urban
regeneration-Erredi per Assedil-2004-
-Balletti
Giontoni-Una città tra due guerre-DeFerrari.1990-pag.77
-Castronovo
V.-Storia dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag. 104carta
-Cevini-Torre-Architettura
e industria-Sagep.1994-pag.56.117.121.167.
-Ciliento
B.-Gli scozzesi in piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.26
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena -Rinascenza.1922-pag.50
-DoriaG.-investimenti
e sviluppo economico..-Giuffré.1969-vol.I-pag.395 .
1973.vol.II.pag.75
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese. 7/75.3 +
4/87.7 + 9/88.10
+ 7/89.10 +
8/89.6 + 5/96.3
+ 3/97.8 +
-Gazzo
E.-I 100 anni dell’Ansaldo-Ansaldo.1953-pag.34
-Genova, rivista municipale : 6/37pag.46.52 + 1/39pag.31 +
-Il Secolo XIX del 1,2,4,5/07/00 + 30/10/04 + 28/10/07
-Lamponi M.-Sampierdarena-
LibroPiù.2002-pag.106
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-C.Civico SPdA.1986-p.58.62.106-8.141
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1900-pag.16
-Pagano/1933-pag.247---/40-pag.358---/1961-pag.464.555
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1355
-Poleggi E. &C-Atlante di
Genova-Marsilio.1995-tav.33
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani.1983-pag.43
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Ampore.1975-pag. 211-2
PACINOTTI vico Antonio
Pacinotti
 in verde la primitiva via A.Pacinotti
in verde la primitiva via A.Pacinotti
Nel
febbraio, e di nuovo il 14 sett..1914, al municipio di San Pier d’Arena fu
proposto dare il nome di vicolo A.Pacinotti al caruggetto (verde) “da via della Cella a vico
Nicolò Bruno (giallo), posto a levante e parallelo a
via Cella superiore”. Fu accettata.
All’atto
della unificazione di SPd’Arena con Genova, il Comune stilò l’elenco delle
strade presenti nel territorio: dedicata al fisico c’era solo il nostro ‘vico’,
di 5a categoria, e quindi passò indenne alla massiccia trasformazione dei nomi
fatta allo scopo di eliminare i doppioni col Centro.
Ed uguale appare ancora esistere nel 1933 quando il Pagano
però lo descrive “da via della Cella a vico Scaniglia A.” (celeste).
Sembra facile collocare
vico A.Pacinotti nel tratto parallelo a via della Cella nel retro del civ. 9-11,
e collegato con via della Cella dal tratto parallelo alla ferrovia, visto che
anche il Novella dice: “vico Antonio Pacinotti da via della
Cella”. Ma questo presupporrebbe che il
nostro vico Pacinotti, mentre ora è chiuso verso monte, a quei tempi
continuasse nel retro delle case sino a raggiungere vico N.Bruno, come
descritto nella proposta su citata.
Alla Toponomastica non
esiste una scheda con questo vicolo.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.16)
-Pagano/1933-pag.247
PALAZZO via Palazzo
della Fortezza
TARGHE:- via - Palazzo della Fortezza –
già via Ruffini.



tratto a mare, angolo via
G.Buranello



tratto a mare, angolo via
L.Dottesio-Daste



tratto a monte, angolo con
v.N.Daste



tratto a monte, angolo con via
M.D’Azeglio
QUARTIERE ANTICO: Coscia
 da
MVinzoni, 1757.
da
MVinzoni, 1757.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2818
CATEGORIA: 2
 Da
Pagano/1961
Da
Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 44780
UNITÀ URBANISTICA: 26 – SAMPIERDARENA
28 –
s.BARTOLOMEO
 da
Google Earth, 2007.
da
Google Earth, 2007.
In giallo, via NDaste;
celeste, via LDottesio;
fucsia, via Md’Azeglio.
CAP: 16149
PARROCCHIA: (civ. 2 e 4)=s.Maria della
Cella—(resto)=s.Maria delle Grazie
STRUTTURA: Da via G.Buranello, a via M.D’Azeglio.
Senso unico veicolare, da mare a monte, escluso i giorni di mercato***
Strada comunale carrabile, lunga 133,3 m e larga 4,80 con 2 marciapiedi
larghi m 1,30; viene intersecata da via L.Dottesio.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
STORIA: la strada nacque nel 1560 circa, praticamente con l’erezione della villa dei Grimaldi, in
conseguenza della loro necessità sia di sfogo al mare dall’esterno delle mura
di cinta della loro villa, e sia per separare i terreni dei vari altri Grimaldi
posti sia a ponente che a levante della strada stessa (poi divenuti degli
Ansaldo). Probabilmente vi scorreva un torrentello che, a quei tempi, faceva da ‘smaltimento’ e da divisione.
Sulle prime carte scritte del borgo, appare col nome di “crosa Larga“,
ed andava dalla strada reale della Marina (via San Pier d’Arena) alla strada Comunale
interna (via Daste-via Dottesio).
Nella seconda metà del 1700,
il lungo spiazzo fu adattato – probabilmente dagli stessi ‘signori’ – per
adattarvi un nuovo gioco importato dalla Francia: il “gioco
del pallone” (ovviamente non si trattava del gioco del calcio attuale,
ma di un gioco con le mani
vicino alla pelota, alla palla a muro ed alla palla-corda, presochè tutti di
importazione francese. Frequenti erano gli incidenti, specie vetri infranti ad
abitazioni o magazzini, con coseguenti proteste, istanze, petizioni (documenti
presenti in archivio) che però pare non trovarono accomodante seguito, se un
esposto municipale firmato nel 1798
dal presidente Galliano ingiungeva che “prima dell’ inizio del gioco, si
tolgano i vetri, e eventualmente si dovranno
pagare i danni cagionati”.
La
stessa, era il limite di separazione del quartiere
Coscia (posto a levante) dal quartiere della Crosa Larga (posto
a ponente, e che arrivava sino a via Albini circa, qui confinando con quello
denominato Boraghero, che a sua volta arrivava sino alla crosa sant’Antonio). Nell’angolo a mare a
levante, si ergeva la casa di Ignazio Morando a due piani, con bottega, retro e
cucinino a piano terra, e tre stanze al piano sopra; completava la casa un
piccolo giardino a nord: nel decreto del 1857, la casa serviva da confine -
nella lunga strada della Marina - tra
quella chiamata via Galata a levante e la via Cristoforo Colombo a ponente.
In alcuni fascicoli del 1843
relativi agli espropri da effettuare per aprire la strada
ferrata, la crosa orta sempre lo stesso nome ed ha ancora - nella sua
metà verso il mare – lo slargo adatto al gioco. Il taglio effettuato, pochi
anni dopo, dalla ferrovia farà cessare ogni aspetto ludico e l’area verrà
ocupata da edifici popolari.
Il
regio decreto del 1857, la chiama “
stradone della crosa Larga”.

In epoca attorno al 1900, le fu cambiato il nome, su
iniziativa del governo regio mirante alla valutazione del Risorgimento, titolandola ad Jacopo Ruffini.
Con
delibera del podestà del 19 agosto 1935 fu deciso il nome attuale, spodestando
il patriota per concomitante presenza in una strada genovese.
Il 14
nov.1946 le fu sottratto il pezzo a
mare che fu dedicato ad Andrea Prasio, che si appropriò quindi dei civv. 1 e
2-2a-4.
Da ché furono
erette le costruzioni che la affiancano, si conosce un susseguirsi a piano
terra di negozi e botteghe di artigiani (marmisti, friggitorie, osterie,
fruttivendolo, merceria, alimentari, ‘la Rapida’ riparazioni calzature e –più
recente- la trattoria con tonalità spagnole ed un negozio di vernici).
CIVICI
2007=UU26=
neri = dal 2→14 (mancano da 6→12)
rossi= dal 2r→48r (compreso
2Ar; mancano 4r, da 32r→46r
UU28= neri = da 1→11 e 18 (mancherebbe 16***)
rossi = da 19r→75r (manca
53r; aggiungi 43Ar)
da 50r →60r
RIASSUMENDO
Neri= da 1→11=UU28
2→14=UU26 +
18=UU28 manca 16
Rossi=
da 2→48=UU26 + 50→60=UU28
Nel Pagano/40 – è delimitata da
via N.Barabino e via Md’Azeglio; ha civv. neri
da 2 a 12 e da 3 a 11. (con al 14 la “scuola ind. «G.Garibaldi») e civv. rossi: 5 osterie
all’ 1,3,13,33,54r ; 2 latterie (7r e
41r); 3 commestib (10, 42,49r); 2 parrucch (11 e 61r); carta da macero(24r);
impr.edile Gentilini (28r); salum (31r); 2 carbone ((32 e 38r); merceria (35r);
ottoniere (37r); droghiere (39r); farinata (45r); fruttiv (47r); riparaz calzat
(59r); marmi (65r)
Nel /1950 per il Pagano, vi si
apriva una osteria al 33r allora di
Meirana Ester; non bar né trattorie.
Possiede
civici sino all’11 e 4 neri; 61 e 32 rossi
Nel
muraglione della ferravia, nella parte a levante rispetto la strada, si nota dietro ad un cancello un tombino in
basso, di non facile comprensione. Nella parte a ponente sovrasta un residuo di
‘archeologia industriale’.


===civ.1
dopo ristrutturazione dell’edificio, fu assegnato nel 1992
===civv. 2 e 4 corrispondono a costruzione
eretta nel 1963
===civ. 5 ha il portone unico ma dà adito a due possibilità -come una V appiattita-: il lato a destra propone subito
le scale per salire nel palazzo stesso; il lato sinistro posto a monte, dopo un
breve e basso corridoio a tunnel, si apre nel retro del palazzo, in una
minuscola aia: si ha di fronte un manufatto assai antico, forse
sei-settecentesco: case fatte ancora in pietra e con travi portanti di legno. Completamente fuori contatto
del traffico cittadino, qui troviamo un angolo assai interessante della antica
città: una aia di pochi mq davanti ad una casa bassa e di aspetto assai
semplice.



A piano
terra, l’ingresso - chiuso da porte moderne - che dovevano dare adito a cantine
o “scagni” di artigiani (oggi magazzini privati, irraggiungibili da mezzi
motorizzati). Tutte le finestre dell’edificio sono piccole. Il portone si apre
rialzato di un metro, raggiungibile tramite breve scaletta di sette-otto
gradini fiancheggiato da un caratteristico scorrimano, fatto tozzo con mattoni
e con l’estremo esterno arrotondato. Sulla facciata e subito sopra il portone,
si scorge uno stemma tipico delle
abitazione di religiosi: esso, sopra il portone, è stato parzialmente
scalpellato nella sua periferia ma conserva ancora il segno di HC sovrapposto a
MV sormontati da una croce esternamente. Internamente al portone si scorgono le
scale strette e ripide travate al soffitto.
Sul
lato a mare della piazzetta è murata una importante immagine in lavagna, di
presumibile datazione medievale, rappresentante il “sacro Agnello”: è un tondo,
con libro sovrapposto da agnello portante una bandiera crociata. L’ “Agnus Dei”
è un motivo simbolico paleocristiano che in origine si trova nel libro di
Enoch; in terra ligure affonda le sue radici nel XII secolo quale segno sacro
relazionato a san GiovanniBattista, patrono della città, quasi sempre
raffigurato con un manto di agnello addosso. Simboleggia la purezza,
l’innocenza, la mansuetudine ed in non meritato sacrificio; da dopo il 1500 ha
pure valore talismatico e protettivo, ed è in questa forma che lo vediamo
applicato come sovrapporta o nei fregi anche nella casa privata di cui si scrive.




il tondo con l’Agnello incombente
la fabbrica che si apre in via Cassini
Il
retro della casupola - a levante confina con un piccolo corridoio esterno di
proprietà della ex-Depa (che si apre in via Cassini).
È
chiaramente un “avanzo” dimenticato della antica SanPierd’Arena.
===civv. 6-8-10-12 furono demoliti nel 1962
===civ. 18
rimane nella parte a monte di via Daste ed è simmetrico al portone di via
D.Chiesa ove è descritto il palazzo.
===19r la sede della palestra “Gymneastic Club”.
===24r nel Pagano/1950 si segnala Cervetto Stefano in
attività nella carta da macero.
===civ.45r nel 1999 la friggitoria “torte
e farinata” si è guadagnata la segnalazione nel libro della Sagep di Nico
Monatti con: ”ci si può sedere a tavola o prendere al volo una porzione.
L’importante è gustare la farinata, qui davvero eccellente. Morbida e sottile,
come richiede la clientela, preparata anche con carciofi e funghi. Ingredienti
genuini e forno a legna completano il quadro, idilliaco per i golosi”.
===civ. 47r ora è chiuso. Vi vendeva e riparava biciclette Grazi Bonfilio
===civ 14 la villa Grimaldi, detta la Fortezza
La famiglia Grimaldi
ha
origini molto lontane, sembra da Vezzano: un ramo stabilitosi a Genova a metà
del 1000 ha per capostipite conosciuto Grimaldo, vissuto nel 1160, arricchitosi
nel traffico marittimo, divenuto console (quindi nobile di origine consolare)
ed inviato a Pavia nel 1162 quale ambasciatore a Federico Barbarossa.
Schierandosi con i Fieschi a formare i Guelfi, furono nei secoli tra il 1200 e
1300 tra i promotori di tutte le lotte interne tra le due fazioni. Un ramo
emigrò in Sicilia nel 1396, mentre il ramo genovese si estinse nel 1824.
Divennero
Duchi nel 1605. Ebbero moltissimi feudi in Liguria e Piemonte ed a Salerno,
nonché in Francia. Dal 1581 la famiglia
fornì alla Repubblica sei dogi, 32 senatori e 3 cardinali, molti ambasciatori,
ammiragli, scrittori.


Il loro
scudo era a scacchiera, con 15 rombi
bianchi (argento) e rossi, con sovrastante la corona o un’aquila ad ali spiegate (vedi Labò, pag.
161). I rombi sono detti anche ‘fusi’ e potrebbero rappresentare sia la punta
della lancia che il fuso per tessere (in omaggio alle dame, a simbolo di
perseveranza e pazienza).
La
famiglia ebbe aggregate altre 24 famiglie:
Bracelli, Carlo, Castello, Cavazza, Ceba, Ceva, Cogorno, Crovari, Durazzo,
Fereta, Jofia, Morasana, Oliva, Pateri, Ricci, Robia, Rosso, Salinera,
Taschifeloni, Vitali, Zino.
1300= Un Antonio fu ammiraglio vincitore dei Catalani nel
1332 ma sconfitto dai veneziani nel 1353 con gravi perdite. Un altro omonimo fu
a capo della Commenda di Prè e cadde in battaglia a Famagosta nel 1403.
Visconte fu ammiraglio con PaganoDoria,
combattè a Morea e Parenzo, 1354. Nel
1395 i fratelli Giovanni e Lodovico (Scorza scrive che fu Francesco nel 1296)
occuparono Monaco e, da quel tempo in poi la famiglia rimase assoluta padrona
del paese. Condottieri di armate e di flotte, nei secoli tra il 1300 e 1500
furono a capo di continue lotte contro i veneziani ma anche contro i ghibellini liguri.
1400=Un Ansaldo (1471-1539) fu senatore, ambasciatore a
PaoloIII, soprannominato “il grande benefattore”; di lui esiste una statua in
villa Rosazza scolpita da Nicolò Traverso. Fu Gaspare Grimaldi Bracelli (1477-1552) ad essere doge 1549-51 e nipote
dello storico Giacomo Bracelli. Istituì il Magistrato delle Monache e scongiurò
il tradimento di Giulio Cibo e Domenico Imperiale.
Dal 26
marzo1476 al 9 nov.1492, uno dei Sauli
fu scrittore dell’acquisto di beni immobili in San Pier d’Arena.
Un
Grimaldi Rosso Cristoforo (1480-1563) fu
medico, filosofo, matematico, ammiraglio
(con CarloV in Tunisia, partecipò con 25 galee, e doge nel 1535-7 ristrutturò
le mura).
1500=Nel
1528 entrarono a far parte di una delle 28 famiglie più potenti in città - chiamate
“alberghi”, e formandone il 10°- ed a cui dovevano aggregarsi le altre
famiglie. Un Giorgio, fu con proprie galee
alla battaglia di Lepanto nel 1572.
Dagli
archivi Sauli emerge che in questo secolo più d’uno di questa famiglia fu
amministratore, in particolare (oltre che della famiglia Doria), di Ambrogio
Grimaldi Cebà q. Antonio.
Ed
altrettanto, dal 1565, un Sauli è scrittore del saldo di un debito da parte del
rev. Alessandro Cicala q. Nicolò che paga Alessandro
I Grimaldi Cebà q. Antonio cedendo una villa sita in San Pier d’Arena.
Un
Grimaldi DeCastro Luca (1530-1611) fu doge
1605-7. Battista istituì nel 1580 una
‘Fondazione Grimaldi’ a scopo di beneficenza.
1600= Alessandro di Pierfrancesco (1621-1683) fu doge
(1671-3); signore di molti feudi e castelli, perspicace ed acuto d’ingegno,
rese grandi servizi alla Repubblica in terra-mare e diplomazia e guerre: da
doge scongiurò la ribellione dei DellaTorre e sconfisse i piemontesi guidati
dal duca di Savoia (1672; vi parteciparono anche tre dei suoi figli). Luca di Nicola (1675-1750) fu doge 1728-30,
combattè contro rivolte di Sanremo, Finale e Corsica. Giovanni
Battista, di PietroFrancesco (nato mag.1678-1757), amato dal popolo, fu
guerriero a Savona e Corsica; fu deputato a trattare con BottaAdorno nel 1745
dimostrando serenità eroica al punto che lo stesso Botta lo definì “novello
Muzio Scevola”. Eletto doge il 7 giu 1752-4. Iscritto alla ‘colonia ligustica
degli Arcadi’ col nome di Uranio.
Antonio Grimaldi Cebà di Nicolò
(1641-1717)fu doge dal 1703-5. 1700=PietroFrancesco di GB (1715-1781) fu doge 1773-5. GianGiacomo di Alessandro (1705-1777) fu soldato
(1746 comandante contro gli austriaci); politico commissario in Corsica (ma
commise l’errore -1753- di sopprimere il ribelle corso Giovanni Gaffori
facendone un eroe; gli si ritorse dovendo fuggire dall’isola nel 1759),
eminente pensatore il migliore filosofo genovese dell’epoca. Doge dal gen1757.
Ad ordinare la villa, fu Giovanni
Battista Grimaldi q.Gerolamo chiamato anche Battista I (banchiere, mercante, magistrato del Banco, massimo esponente della
politica ed economia genovese della metà del 500, ritenuto uno dei più ricchi dell’epoca. Nel 1593
risulta che il figlio Nicolò avesse ereditato un patrimonio netto –in lire
genovesi- = 148.055.6.8; poco
però, rispetto Agostino Doria (696.666,6.8), Imperiale GioGiacomo
(597.221,13.4), Ambrogio Spinola (309.999,6.8) e Filippo Spinola che nello
stesso anno aveva 1.553.666,6.8.
Prestatore di soldi a imperatori e re, committente di artisti e musici. Nacque
nel palazzo sito in piazza della Meridiana a Genova fatto erigere da suo padre
Geronimo (o Gerolamo Grimaldi Oliva di Giorgio, erede delle enormi fortune di
Ansaldo Grimaldi, anche lui prestatore di soldi a re ed imperatori come
CarloV e morto senza figli): acquisì le fortune familiari col fratello Nicolò (Nicolò
era il figlio; 95 dice che il fratello era Luca; E.Parma dice che GB era figlio
unico maschio).
Consentì nel 1565 l’istituzione di una scuola
di canto e di musica- ponendo nei cartolari del Banco di san Giorgio un
apposito multiplico; nonché lasciò al
Banco una enorme fortuna col fine della conservazione del porto, palazzo Ducale
e dell’acquedotto, beneficiando monasteri, ospedali e lazzaretti. Una sua statua, scolpita da Battista Perolli
detto il Cremaschino (Pastorino-Vigliero scrive a pag.914 che è di
Giambattista da Crema, ma forse sono la stessa persona), scolpita nel 1567 (Poleggi scrive nel 1565)), troneggia tra i benefattori della Casa di san
Giorgio, a Genova, nel palazzo omonimo. Sposò Maddalena Pallavicini da cui
ebbe: primogenito GioFrancesco (che sposò Lelia Pallavicini dai quali nacque
Maria poi sposa di Goffredo Spinola).; secondogenito Pasquale (descritto sotto
quale erede della villa di SPdA); e
Nicolò (che sposo di Maria Lomellini, divenne padre di
Caterina, poi prima moglie di GioVincenzo Imperiale). Morì nel 1581).
L’artefice materiale del
progetto ed erezione della villa fu l’architetto ticinese Bernardo Spazio (Pastorino&Vigliero e Tuvo&Campagnol dicono Bernardino (qualche
altro Michele, inesistente per AA.VV.-scultura
a Ge....vol.I e per SopraniRatti), seguace
e collaboratore dell’Alessi - al quale per lungo tempo, ed
ancora nel 1929 fu erroneamente attribuita la paternità del disegno e della
costruzione-; gli studi di Mario Labò (1970) hanno definitivamente chiarito con
documenti, che chi ha curato la “fabbrica”, fu l’architetto ticinese, già
attivo nella vicina villa Sauli ed in Genova alla fabbrica di Carignano ed
altre ville locali. Morì
nel 1564).
Si può accettare l’idea che l’Alessi abbia
dato consigli al suo allievo, considerato le grosse difficoltà da superare e gli stretti rapporti di lavoro tra i due.
Anno di inizio lavori è
controverso: chi dice nel 1551. Chi (Parma e Ciliento) dal 1559 al 1567; Poleggi
tra 1559 e 1570; Stringa,
SecoloXIX e Labò nel 1561; AAVV de “L’amministrazione…”:1562; Tuvo.Campagnol: 1565; Pastorino.Vigliero: 1651 (presumibile errore
di stampa).
Ma
anche l’anno di completamento è
differente: Stringa nel 1565; altri 1567 e
1570; Labò 1568; AAVV de
“L’amministrazione” nel 1580; Pastorino & Vigliero: 1665 (idem
sopra).
Concepita
con caratteristiche di imponente severa e
massiccia struttura ad impostazione cubica, occupante quasi 1000 mq di
superficie, con pochissime sovrastrutture esterne, priva di dettagli
ornamentali che aggiungano eleganza o delicatezza, col tetto a piramide, venne
subito chiamata “la Fortezza” in contrapposizione quasi stridente alla
“Bellezza” della villa Imperiale, e alla “Semplicità” di villa Sauli: tutte e
tre identificate dalle altre ville con aggettivi qualitativi; costeggiano
l’asse principale stradale –allora senza nome, oggi via N.Daste-, su cui si
apre solo la seconda: la prima e la terza hanno il portone uno a levante e
l’altra a ponente in forma speculare simmetrica, con abile e snellente proposta
urbanistica e scenografica: tale – apparentemente banale - scelta dell’entrata
“lateralizzata” fu progettata per preciso calcolo architettonico e voluto distacco ciascuna dalle altre con
appartata austerità, legati forse anche al caratteristico riserbo genovese, e favorita dal fatto che al di là della strada Larga,
i terreni coltivati ad orto erano di proprietà di famiglia (nel 1840 circa erano di Ansaldo Grimaldi,
poi acquistati dagli Ansaldo). Infatti, considerato l’ampio terreno a
disposizione, il fatto che le ville siano
state erette nei limiti vicinali
alla strada non può che essere voluto, quasi a formare un borgo nel borgo.
Queste
“bizzarrie” sono considerate tipiche della mentalità dei Grimaldi.
Anche il piazzale antistante, fu volutamente
studiato rialzato, sia per dare maggiore imponenza all’edificio qualora già non
ne avesse, ma soprattutto per superare - con sforzo tecnico eccellente - il
naturale dislivello del terreno, e giustificare la scarsa estensione del prato
a disposizione.


foto giugno 2009 facciata a nord facciata – ingresso ad
est
La
parte decorativa, porte, balaustre,
finimenti interni, e decorazioni varie, fu affidata a Gio Battista
Castello detto il Bergamasco (pittore -progettista di architettura e di
decorazioni a stucco-. Dopo soggiorno a Roma, associato al Perolli contrattò
con GB Grimaldi per varie opere tra cui la villa. Eccellenti sue pitture sono
in molti palazzi e chiese cittadine; sculture definite “di non basso carattere”
compreso una in marmo, stucchi e ornamenti come nei palazzi degli Imperiali, e
opere meravigliose lasciate nell’ Escoriale di Spagna; sono documentate alcune
forniture decorative, tipo porte e balaustre, fornite nel 1565 su disegno
dell’artista) che si fece aiutare da altri maestri antelami, e dal marzo 1566
da Battista Perolli (dapprima con lavori
marginali tipo la decorazione della facciata, un poggiolo ed un busto marmoreo
del committente; poi definitivamente nel 1567 con la partenza del Bergamasco
per la Spagna).
Nel 1565 (oppure 1567, o 1580), morto lo Spazio, fu portata a
termine da G.B.Castello, ancora attivo nella casa in altri lavori (qualche
altro: Poleggi, Parma e Sagep76 -dicono Giovanni Ponzello, in quegli anni
presente nella vicina Bellezza, e che
nella nostra villa sicuramente intervenne nel 1567 per lavori di sistemazione
del terreno).
Il suddetto GB Grimaldi, committente della villa sampierdarenese, con testamento del 4 giugno 1580 la lasciò al
secondogenito figlio Pasquale (al primogenito GioFrancesco, lasciò
quella in piazza della Meridiana).
Simonetta Valenziano scrive sul Secolo
che Vincenzo fu ospite di Battino Grimaldi.
Boccardo, in L’età di Rubens pag. 27, scrive che chi ospitò il duca
nella villa di SPdA furono Carlo Grimaldi con la moglie Battina Centurione
Grimaldi (forse perché la prima edizione del libro del Rubens è dedicata a lui
che era il nipote di Giulia).
Il 12 lug.1607 Pasquale, e sua
moglie Giulia Grimaldi (non corrispondono su
Battilana), ospitarono Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, detto pure
Vincenzo I (Pastorino&Vigliero dicono 1706. Baldacci riporta un annale su cui è scritto
“6 luglio 1607.... è venuto qua per farsi alla marina alcuni bagni per un
ginocchio che ha offeso di catarri...., starà a Sampiedarena ove per la sua
persona è stato apparecchiato il Palazzo del s.r Pasquale Grimaldo, et certi
altri per la sua corte...”.

V.Gonzaga opera di Franz Pourbus Jr
Galleria
Rizzi
Vincenzo Gonzaga nel 1606 aveva progettato un
viaggio nelle Fiandre, ma rinunciò e decise trascorrere l’estate a San Pier
d’Arena. Presumibile che –nel frattempo- o aveva ricevuto un invito specifico-
oppure –più probabile- era pressato dall’incombente bisogno di denaro da
richiedere ai banchieri (già
intenso era il carteggio con Nicolò Pallavicino e suo cugino Domenico, con i
quali aveva scambi di regali e con i quali già c’era una cordialissima
corrispondenza preferenziale da tanto tempo, con reciproco scambio di oggetti
vari, nonché aggiornamenti politici e di informazione: gioielli (in uso gli argenti portati da un giardiniere
genovese mandato a lavorare a Mantova, e le perle di cui non sempre c’era la
disponibilità (per cui il duca fu invitato ad accontentarsi ‘quali sono possuti
riuscire’: una dama mantovana aveva
visto il ritratto di Veronica Spinola Doria e voleva per sé un eguale
‘giro di perle’), giardinaggio (“alberi citronetti, gelsomini di Napoli,
lemoncelli e naranci; siepi di mortella”), abbigliamento (vestiari, con grande
arrovellamento di Nicolò, perché ignorava le misure opportune) come guanti,
“camixie”, polsi a latuche, collari lavorati in oro ed argento, ‘rocchetti’ di
tela di Cambrai (destinati a Ferdinando Gonzaga, figlio di Vincenzo e prossimo
cardinale (1607); perfino un ben definito busto da donna che, non trovandolo
sul mercato, fu inviato a Mantova ‘prelevandolo’ ad una parente ed inviandolo
‘di buona fattura ma usato’); animali da allevamento (cavalli di razza tipo ‘i
Barbari’, cani mastini inglesi, una volta anche un ‘cammello novello per il
bestiario del duca’, tutto accompagnato da descrizioni tecniche di un esperto d’animali),
oggetti di tenore di vita (in genere, aggiornamento delle corti europee; per
rimanere al passo con la moda); cibi (come formaggi locali e dolciumi))-
Un mulo, era arrivato a
Genova da Mantova (‘dal collo pienotto ma con un bel portamento’), inviato al
marchese Antonio da Passano; delle perle se ne era interessato anche Giulio
Spinola (che fu rimproverato perché la collana era ‘troppa rada’).
Arrivò a Genova (scendendo dai monti lungo
la via Postumia, a Pontedecimo fu incontrato dalla maggior parte della nobiltà
genovese, in un giorno piovoso “che bagnò tutti ben bene” per cui fu d’uopo
accorciare le cerimonie e la consegna di doni od omaggi ufficiali),
ufficialmente sia per prescrizione medica di sabbiature ed aria marina, essendo
sofferente di podagra ad un ginocchio (dapprima, per questa
malattia dai medici era stato indirizzato alle terme di Spa), sia per diletto, ovvero
come riportato dai cerimoniali “attendendo a giuocare et a darsi buon tempo”
specificando che “fu da molti ill.mi ss.ri privatamente invitato”. Preferì
venire in Liguria in realtà perché oberato dalle spese (necessarie
per rendere sempre più splendida la sua reggia
e per la costruzione della cittadella di Casale) per le quali non trovò
altro sistema che ricorrere al prestito di un banchiere genovese (come già
facevano i sovrani spagnoli ed il papa stesso): in fondo era già in relazione
economica con i Serra, gli Spinola, i DaPassano, e tra tutti, maggiore fu il rapporto con Nicolò Pallavicino.
Comunque, per questa visita “non vuole cerimonie,
ne complimenti, professando solo di voler conversatione di Giovani per rispetto
del Gioco, e di Dame per recreatione dell’animo, essendo in età d’anni 42 ha
seco una bellissima corte di molti Gentilhuomini a se affetionati”. Quindi, con
questo spirito, partecipò ‘solo’ a parecchie feste
(perché gli davano l’occasione di conoscere genovesi ricchi ai quali tutti
chiedere soldi (il nobile Ansaldo Cebà, preferì regalargli un poema intitolato
a suo nome “il Gonzaga”)), ad una battuta di caccia al cervo (nel bosco di Madonna del
Monte, gliene portarorono al tiro ben tre capi, le cui carni –fatti prosciutti-
furono inviati a Mantova), a vari incontri al gioco
del ‘rapé’ (d’azzardo e proibito dalle leggi locali; molti
nobili –sapendo questa sua debolezza- lo ‘spennavano’ di ingenti somme,
costringendolo a chiedere ‘rifornimenti’ a Mantova, finché non gi giunse una
lettera dalla moglie che gli indicava “se il signor duca si volesse sbrigare
sarebbe cosa molto utile alla sua borsa ma molto più alla sua reputazione”).
Vi rimase sino al 24 luglio
(Baldacci riporta un brano dai cerimoniali sui quali è scritto “et avendo
passato quasi tutto il mese di Agosto, se ne tornò al suo Stato, senza essersi
mai più trattato di visita pubblica”).
Col duca -(già venuto a Genova nel 1592, ed allora
alloggiato in piazza Fontane Marose dopo sorteggio dal “bussolo”, da Francesco
Pallavicino; ora però giudicato un po' lontano dal mare e quindi scomodo; ed
anche il 25 ottobre 1600 di ritorno da Firenze dove aveva fatto visita alla
cognata, regina di Francia. In quest’ultima occasione fu ospitato da Barnaba
Centurione preferendolo all’invito di andare ospite in palazzo Doria “onde
schiffar” l’incontro col conte Diara figlio del Contestabile di Castiglia e
Grande di Spagna)-
si accompagnarono sessanta persone suddivisi in tre diversi palazzi: uno per i
duca ed i suoi pochi intimi; uno per “i
signori che accompagneranno Sua Altezza e che non saranno compresi nella lista
della sua compagnia e del suo seguito”; un terzo per la servitù, mulattieri e
guardie. Tra i primi, ospitati nel nostro borgo ci fu anche un figlio (anche
lui già ospite dall’ott.1606 di Nicolò Pallavicino, accolto all’arrivo con una
grandiosa festa -con dame riccamente abbigliate -protrattasi fino alle tarde
ore della notte);
il segretario del duca, chiamato Chieppio; il famoso compositore-cantante-poeta
Francesco Rasi (1574-1621) giunto alla corte dei Gonzaga dopo
lungo soggiorno fiorentino, e che alcuni mesi prima della partenza aveva
impersonato il protagonista nell’ Orfeo di C.Monteverdi; l’artista PietroPaolo Rubens (di ritorno da una
missione in Spagna per incarico di VincenzoI Gonzaga (cantato da Verdi nel
Rigoletto). Dall’anno 1600 era al seguito del duca: si erano incontrati
occasionalmente presso un orefice di
Venezia ove il duca era andato per comperare una scimmietta d’oro in equilibrio
su una altalena, da regalare a sua figlia Eleonora (scimmietta, che il Rubens
incluse nel ritratto della bimba che aveva due anni, e che lei indosserà anche
quando diverrà imperatrice d’Austria).
Era già stato a Genova
nel 1604; in quell’occasione aveva dipinto -appena trentenne- la tela della
‘Circoncisione’, da affiggere sull’altare maggiore nella chiesa del Gesù nel
1607-per i fratelli Pallavicino: Giulio (1559-1635. Primogenito di Agostino
q.Francesco. Il suo ritratto vedi L’Età di Rubens pag. 63), Marcello (sacerdote, prefetto della casa
Professa dei gesuiti) e Nicolò (finanziere del Gonzaga da cui nel 1602 aveva
acquistato il titolo marchionale per il feudo di Mornese, e che allora doveva
rimborsare le spese sostenute nella missione in Spagna; diverrà padrino del
terzogenito del Rubens)-.
Evidentemente però il
trentenne pittore, seppur protetto dal duca, doveva essere una figura ancora
poco considerata, di accompagnamento minore e non di fama neanche tra i suoi
colleghi: infatti dai numerosi carteggi di questa visita ducale mai emerge il
nome del Rubens (sia i ‘cerimoniali’ genovesi, sia quelli mantovani, sia le
lettere del Chiabrera ad un altro pittore Bernardo Castello, e quindi
interessato).
Nel 1606 Rubens era a
Roma, ed assai malvolentieri doveva tornare a Mantova dal Gonzaga suo datore di
lavoro; questi non solo con cronica mancanza di puntualità nel pagare lo
stipendio ma anche maldestro nell’affidargli
incarichi poco graditi come acquistare tele di altri e rifiutare le sue
adducendo essere in bolletta. Molta è la corrispondenza ritrovata
negll’archivio mantovano, con Gerolamo Serra, Ambrogio Spinola, Giulio Spinoila
Da Roma che venne qui da
noi –non si sa se direttamente da Roma o da Mantova; e pare che da qui tornò
direttamente a Roma Quando si trovò a
SanPierd’Arena, comunque -approfittando del tempo libero non impegnato dagli
uffici di corte- usò questo secondo soggiorno per aggiornarsi in architettura, e riproporre in disegni ed incisioni (non è chiarito se da solo o più
probabile con l’aiuto di uno o più ‘geometra’ diligente e scrupoloso) -con la
pianta e le strutture- tante tra le migliori ville genovesi: la Fortezza è stata riconosciuta in un disegno
della prima edizione, denominato “Palazzo D”,
documentata con nove tavole, più di qualsiasi altra villa genovese, e
con una sezione staccata e specifica alla tav. 71 per il bagno; è su essi che
si evidenzia pure l’esistenza di un affresco decorativo della facciata
d’ingresso -attribuito a Perolli- e che in seguito scomparve. La prima edizione
del libro con disegni ed incisioni, intitolato “palazzi di Genova” uscì a spese
del pittore, nella prima metà di giugno del 1622, con lettera dedicatoria a Carlo
Grimaldo, uno dei nipoti della padrona Giulia). Il “Palazzo C” corrisponde alla vicina villa Spinola, in
quel tempo di PaoloAgostino. Non appare descritto il terzo palazzo ospitante,
di Nicolò Pallavicino** (dal Rubens chiamato ‘Pravecino’). Oggi gli originali
–non completi- sono ospitati nella biblioteca del Royal Institute of British
Architects. Sappiamo che il Rubens a metà settembre era a Roma, quindi non
seguì il duca nel ritorno, ma da qui andò verso sud (Roma), da solo, a cavallo.
L’arrivo del duca di
Mantova non fu quindi solo per sua salute e
svago (da buon donnaiolo, aveva
lasciato a casa la duchessa; nei ‘cerimoniali’, ricorrono frequente frasi tipo
‘festini di dame’, ‘moltitudine di dame’, ‘gentil donne all’intorno della puppa
(poppa) della galera’), e come già detto per rafforzare bilateralmente la già
efficiente rete di relazioni finanziarie, -il tutto sottolineato da frequenti
scambi di doni specialmente con il carissimo amico Nicolò Pallavicino.
Mentre le giornate trascorrevano in conversazioni
(tra cavalieri e membri del numeroso seguito, dame, sacerdoti), oppure in giochi
(carte: a Pegli, dopo un banchetto, giocò contro il cardinale, vincendo in
coppia 1700 scudi d’oro), banchetti, musica (il Rasi, accompagnandosi col suono i arpe
e col canto; è assai probabile abbia proposto l’ascolto dell’opera di
Monteverdi accompagnandosi con l’arpa, cercando di stupire i genovesi con le
sue “miracolose” capacità di produrre effetti sonori sfruttando la tecnica
dell’eco, naturale nella sala della cappella. I musici, secondo l’affresco
dell’Ansaldo, erano sistemati sui ballatoi nei pressi del cornicione del
salone); gite (in città, la neo eretta -dai Pallavicino- chiesa di
s.Ambrogio o del Gesù visitata con Nicolò ed accompagnato da un solo paggio;
nei nostri dintorni invece la villa Pavese -ora Franzoniane, o la villa Doria a
Pegli); ed il 25 luglio, festa di san Giacomo, grande euforia per il “barcheggio” (partenza per una gita in
barca di tutto il giorno, con mangiare sulle spiagge, tra suoni e canti; otto
galee trasportarono il doge, senatori, gentiluomini e dame, da Carignano a
Sturla; da lì a Sestri P e ritorno); il Duca pare non partecipò, ma assistette
alla sosta fatta nel pomeriggio presso l’approdo alla marina della villa, dove
fu fatta festa e spettacolo con ‘lanci’ di salami e di frutta dalle galee
-raccolta dai marinai che la ripescavano per rioffrirla alle dame- e grande
accorrere di leudi e di paesani “divertiti ed interessati alle copiose ed
abbondanti ‘confettioni’ che piovessero dalle navi”; ed alla sera, in cappella o nella chiesa
vicina, messe cantate, preghiere o cori
(una “compieta” eseguita a tre voci accompagnate con tromboni, flauti, “corneti
ed altri istrumenti”; una volta un giovane putto cantò il “nunc dimittis” ed un
“magnificat”, accompagnato dall’organo e da un basso, “con tanta armonia che
pareva una melodia celeste”) .
Di tutte questi avvenimenti clamorosi, ne scrisse
pure Gabriello Chiabrera il 4 sett.1607, in una lettera indirizzata al pittore
Bernardo Castello.
Nel 1745 (6 giugno) alloggiò nella villa Francesco III, duca di Modena. Il regnante già era
venuto a Genova come turista; e 25 anni prima la moglie, Carlotta d’Orleans, fu alloggiata a S.P.d’Arena
con 600 persone al seguito, in villa Lomellini. Stavolta lui era in armi,
generalissimo delle armate spagnole di S.M.Cattolica. Proveniente dal levante, accompagnato
da 10 cavalieri e 40 fucilieri a cavallo, raggirò la città passando per la
strada di Pino, e da Campomorone scese a S.P.d’Arena dove fu alloggiato nel
palazzo del mag.co Agostino Grimaldi q.
Silvestri. Qui giunto andò a cena e solo il giorno dopo ricevette una
delegazione del Senato (sei patrizi, tra cui lo stesso padrone di casa a capo)
che arrivati in carrozza gli portava ‘i complimenti’ della serenissima
Repubblica. Per altri quattro anni il Duca personalmente fu alleato dei
genovesi contro le Armate Austro-tedesche; ma l’anno dopo il Governo genovese
abbandonato dagli alleati francesi e spagnoli, dovette cedere agli austriaci
senza opporre resistenza, maturando però l’episodio del Balilla.
Nel 1757, sulla carta del Vinzoni, è ancora
documentata l’appartenenza alla famiglia Grimaldi, non specificato il nome,
compresi i terreni al di là a levante della crosa Larga.
Nel 1800, i francesi assediati dagli
austriaci, ancora comandavano la piazza di San Pier d’Arena usata come fascia
protettiva per evitare eventuale assedio sotto le mura; nei continui scontri a
fuoco, moltissimi erano i feriti: la municipalità locale dovette provvedere in
stato di totale sudditanza a reperire due “ospedali per le truppe”: la Fortezza divenne in quegli anni l’”ospedale dei francesi” creandosi epidemie locali (un
dottor Capponi descrive “febbri biliose, putride o nervose” anche tra i civili,
causa le nulle capacità igieniche, talché quasi tutti i soldati ed un ottavo
dei cittadini colpiti, soccombeva. Ovviamente inutili le rimostranze degli
abitanti: le autorità avevano ben altro da pensare, visto che le cose volgevano
in negativo: il 20 apr. di quell’anno, mentre le navi inglesi bombardavano
indisturbate il borgo, le truppe austriache comandate dal gen. Melas -attestato
a Sestri-, erano giunte tra i vigneti
del Polcevera, costringendo i francesi a “barricare tutte le strade ... conservando solo una piccola apertura
allo sbocco del ponte con ostacoli pronti ad essere messi in opera
immediatamente”).
Dopo
questi fatti, negli anni attorno alla metà
del 1800, fu acquistata dal conte Agostino
Scassi figlio di Onofrio.
Un
chirografo del 27 ott.1849, dimostra che la villa fu poi affittata dal conte
Agostino Scassi proprietario, al cav. Giuseppe
Antonio Castelli con un contratto di 5 anni. Prossimi alla scadenza, il
9 ago.1854, fu affittata all’Azienda delle Strade Ferrate con un contratto di
sei anni (in un precontratto di locazione
si legge: “l’anno del Signore mille ottocento cinquanta tre ed alli quattordici
del mese di maggio nella città di Genova:- Si premette che per la costruzione
della stazione a servizio della strada ferrata in questa città essendo stati
designati i locali denominati quartieri dell’Annona e di San Paolo ora
servienti (sic) di Caserma alle Truppe di presidio in Genova si rese necessario di procurare altri
locali per l’aquartieramento (sic) delle
Truppe ed a la fine essendo stati prescelti alcuni palazzi nell’abitato di San
Pier d’Arena fra essi si comprese quello di spettanza degli eredi del fu Conte
Onofrio Scassi : Che....”), per alloggiarvi temporaneamente parte delle truppe
del presidio di Genova, comandate dal gen. Alfonso La Marmora (l’arch. Matteo Leoncini andò per conto loro
a controllare lo stato di conservazione dell’edificio, giudicandolo
positivamente; risulta anche che il
conte, approfittando della scarsezza di alternative di locazione in San Pier
d’Arena, abbia giocato al rialzo del prezzo con l’amministrazione militare
imponendo un affitto di 9 lire al mese; questa dovette accettare
giocoforza, dopo aver sentito il parere
dell’ Intendente Generale di Genova ritenendo la cifra esorbitante, avendo
pensato anche ad una espropriazione per utilità pubblica, ma rinunciando a
rivalse pur di ‘non dividere e sub dividere’ le truppe in molte più piccole
residenze. Pare anche che fu in questa occasione che avvenne la distruzione del
bagno ottagonale, anche se la villa in generale non ebbe a subire altri gravi
danni strutturali (parte del giardino, verso il mare, appare in
quell’epoca di proprietà di un
Dellepiane, ed un magazzino già affittato a Tommaso Traverso). Nella relazione si rileva
che la attuale via N.Daste ancora non aveva nome, e viene chiamata
genericamente “strada interna”, mentre viene regolarmente citata la “strada
Larga”. Comunque la villa viene considerata posta a termine della via DeMarini;
anche la sovrastruttura della ferrovia, previde un sottopasso di m.6 per la
‘st.com.Larga’.
In seguito,
lo Scassi la utilizzò consentendo la trasformazione in fabbrica
di conserve; e così la vide nel 1875 l’Alizeri nella sua visita “A
chieder l’ingresso, vedremmo nel pian terreno e officine e caldaie a bollire
conserve alimentari, e nelle ampie sale un ingombro di casse e di scatole a
chiuderle e suggellarle. Così volle l’avvicendarsi dei secoli....”.
Divenne
poi proprietà di Nasturzio (in via
J.Ruffini), (si presume sia Silvestro, fabbricante di conserve alimentari negli anni attorno al 1900, dapprima come
affittuario poi proprietario).
Ancora
nel 1922 circa, DeLandolina scrive
“ora v’à una fabbrica di salse. Quello che fu un ricetto agli svaghi ed a’
riposi estivi patrizi risuona ora di tutto il fervore del lavoro”.
Dal 1923 è posta sotto tutela e vincolo
della Soprintendenza alle Belle Arti; (e dal 1934 anche la cappella, chiamata impropriamente dalla
Soprintendenza ‘Abbazia
dei Grimaldi prospiciente al giardino di Villa Scassi’; a meno che una abbazia già esistesse, e sul suo sedime fu costruoito il
palazzo).
Nel 1924, il Comune
di San Pier d’Arena, propone un mutuo di 1.400mila lire, per l’acquisto del palazzo
con case e terreni annessi; con
l’impegno di porre restauri per dedicare decorosi locali per gli uffici pubblici
allora albergati in ambienti inadeguati (si prevedevano la regia Pretura, l’ufficio di conciliazione,
il commissariato di P.S., ecc.; progettando anche di utilizzare il terreno
annesso per costruire un grandioso mercato all’ingrosso di frutta e verdura :
mercato che dovrà essere circondato da doppia fila di case ad uso abitazione
civile, di cui tanto difettava la città), nonché liberandolo dalle casupole che
-in lungo volgere di tempo- si erano “abbarbicate ai fianchi della villa”.
Questa
convenientemente restaurata nei serramenti, rifatti alcuni pavimenti, ritoccati
e ripararti i portali di ardesia, riprenderà l’antico splendore e la sua mole
quadrata, in degno riscontro alla leggiadria delle vicine.
Da
allora, è di proprietà del Comune, oggi di Genova. Per sfruttare le aree, e
sistemare adeguatamente la viabilità, si
previde dall’amministrazione fascista del 1926, comperare anche la proprietà
Sauli (5370 mq, per altre 1milione250mila lire), così da allargare via Larga a
10 m. ed aprirne un’altra altrettanto larga parallela a ponente di fronte a
villa Scassi e, nel centro, aprirvi il mercato. Non tutto fu realizzato come
previsto, perché si era all’atto di entrare nella Grande Genova.
Il 4
giu.1944, un’incursione aerea,
determinò rotture parziali del tetto, con crollo di alcuni soffitti, e guasti
alla facciata.
Nel 1950 ospitava l’istituto scolastico
comunale “scuola tecnica e di avviamento
professionale a tipo industriale maschile di San Pier d’Arena”
Nel 1961 era sede della scuola tecnica e di
avviamento professionale a tipo industriale
maschile, dedicata a G.Garibaldi; e dell’istituto serale per macchinisti
navale C.Colombo.
Sede della scuola media Nicolò Barabino fu
abbandonata perché giudicato pericolosa sia per certe strutture instabili sia
per la presenza eccessiva di topi.
I lavori di ristrutturazione, altalenanti per
problemi di economia, iniziati nel 1989 circa portarono all’utilizzo per
le scuole “Casaregis” -con sede centrale in via Daste- utilizzando un solo
piano (le classi 4.a e 5.a , più responsabili), pur sempre costretti a
dividersi in succursali più o meno comode.
Nel 2002 il salone ha ospitato un ritrovo
per il carnevale mascherato; dopo i
carri allegorici sfilati in via Cantore,
nel pomeriggio riunione dei bambini con pentolaccia ed in serata gran
ballo in maschera.
Nel 2003, vista la scadenza dell’obbligo
della messa in opera dei servizi di sicurezza per una scuola, giudicata
eccessivamente alta di costo, si inizia a prevedere un uso diverso dello
stabile: da scuola a museo
Nel
febbraio 2004 nel gran salone fu
organizzato il ‘martedi grasso’ con un ballo in maschera. A fine anno si scrive
del previsto –per fine 2006- abbandono della ‘scuola Casaregis’; per divenire
–concesso in comodato gratuito- centro della ‘Direzione Didattica Regionale’
(già chiamato Provveditorato agli studi). Il trasloco dei 300 ragazzi negli
edifici di pza Sopranis, ha creato rimostranze e cortei.


L’ esterno: di aspetto esterno severo e povero, ha
proporzioni rigorose; ma la utilizzazione degli spazi interni e la loro altimetria,
dimostrano una geniale capacità e risoluzione
che erano tipiche nell’Alessi (riscontrabile per esempio, con le dovute varianti, ma pur sempre
‘autoritarie’, nel rapporto loggia -ricca di stucchi- e salone come nella villa
Cambiaso a Genova) che ha fatto mantenere così a lungo l’equivoco
dell’architetto disegnatore).


Sulla
facciata è andata definitivamente perduta la decorazione del GB Perolli. Sulle altre
facciate le rare decorazioni mettono in risalto le due logge: una è posta sulla
facciata nord, con balconcino, a tre fornici ampissimi, relativa ad una sala
del piano nobile; l’altra è aperta sul lato a levante, a piano terra, a
costituire l’ingresso. Questo, -che appare sopraelevato rispetto il piano
stradale- e raggiungibile con una scala, che ancora a metà del 1800 era a due
rampe di una diecina di scalini cadauna, di pietra di Finale, con ovvi
“muriccioli di sponda”; oggi, anche per favorire l’uso scolastico, tali rampe
non esistono più e lo sbalzo di altezza è superato da una scala a raggiera con
scalini bassi, lunghi e leggermente pendenti-. Portano ad un loggiato centrale
a tre fornici, a cui corrispondono sopra
le finestre e mezzanini dei piani elevati; ai due lati lievemente aggettanti
rispetto la parte centrale della facciata, ai tempi del Rubens, c’era una
decorazione con colonne corinzie sino
alle due estremità mentre al piano nobile corrispondevano a delle lesene
decorate; furono eliminate in un restauro successivo, lasciando a nudo la parete
e munendo il finestrone posto ai due lati della loggia con solida inferriata
con sopra le finestre e mezzanini dei piani superiori. Il tutto venne distribuito in modo da non togliere il
serioso senso di saldezza delle strutture,
anzi evidenziando in modo migliore la sua struttura “maschia”, e
risultando “più fortezza”.(come già detto, sopra l’ingresso, la facciata fu fatta decorare da Battista Grimaldi
con un affresco -disegnato, e prodotto con la tecnica del chiaro e
scuro, da Battista Perolli; doveva conferire un aspetto più leggiadro e meno
arcigno, alla visuale d’ingresso; però il tempo ha distrutto tutto).



Rubens pianta piano terra sezione verticale 1 verticale2



sezione verticale 3 sezione verticale 4 sezione verticale5
La
struttura interna: nei
fondi troviamo vari ambienti, già usati come cucina e refettori, con acqua
attingibile dalla cisterna con pompa a mano, ed un cesso e cantina. Il piano terra è tutto orientato est-ovest: dopo il loggiato
dell’ingresso, c’è un ampio ballatoio col pavimento di ottagoni d’ardesia
alternati a quadrelle di marmo; è separato dal vestibolo, da tre arcate chiuse
da tramezze in mattoni (erette dal Castelli; come pure egli aprì due nicchioni
ai lati nord-sud, ove prima erano due sedili in stucco).

Rubens - il bagno ottagonale
Nel
centro del lato ovest, vi era un bagno ottagonale (allora chiamato
‘stufe’a dimostrazione della maggiore attenzione ad esse per l’acqua calda che
alla funzione), ripreso da quello
dell’Alessi per la villa di famiglia al Bisagno, e documentato dal Rubens,
rappresentava la più nota caratteristica della villa per il tocco particolare della raffinatezza e
dello sfarzo che si voleva raggiungere (
era composto da un vano ottagonale centrale e con la vasca , circondato
da più ambienti tra loro collegati e comprendenti spogliatoio, tiepidario con
la stufa, altrove spesso decorati con
affreschi o mattonelle); purtroppo è stato manomesso in modo irreparabile, ed è
quindi giocoforza prendere solo atto che esisteva.



quattro immagini della loggia

Lo scalone
disegnato dallo Spazio, è centrale e con una rotazione a 90° verso nord
all’apice da accesso al piano nobile: per primo alla bellissima loggia
dalla quale si spaziava verso i monti e le altre ville. Appena finito il
palazzo, nel 1565 la volta a botte del loggiato doveva essere decorata da due
maestri della stuccatura, Antonio Lugano e GioPietro del Lago di Lugano (non
nominati in AA.VV.-Scultura a Genova.vol.I); ma qualcosa successe perché il
lavoro dopo due anni fu invece
degnissimamente eseguito da Battista da
Carona (il fratello Andrea non appare citato) di cui esiste la bolla di
commissione del lavoro datata 1567, per
un lavoro di suddivisione in cassettoni di stucco bianco snelliti da due
riquadri a lunetta -compiuto entro il 1570-1, quando il Carona partì per la
Spagna- (Carona è un paese nei dintorni del lago di Como; si sa che è proprio
dalla regione del comasco -e Canton Ticino- che provengono in questi tempi i
migliori artisti del marmo e della pietra : scultori, architetti,
lapicidi, “pichapetra” rivestono in
Genova un ruolo primario quali progettisti, costruttori, ristrutturatori,
decoratori). Sulla lunetta era stata
fabbricata sempre a stucco una “historieta di relevo da maestro Luchetto
Cambiaso” (di cui rappresentano uno dei rari studi non ad uso pittorico ed
eseguita per contratto personalmente dal “maestro Lucheto Camblaxio”). Le
immagini in altorilievo rappresentano delle “divinità marine in convito ” (qualcuno vi legge le “Nozze di
Peleo e Teti”: Peleo era un re, condannato ad esilio perché
divenuto assassino; dopo molte peripezie, morta la prima moglie, si risposò
con Teti, così bella che Giove l’aveva
eletta a dea: fu quindi l’unico mortale a sposarsi con una divinità; e dal
matrimonio nacque il famoso Achille che morì nell’assedio di Troia), ed “il
carro di Nettuno” (qualche critico -come anche M.Labò- dice che il
bassorilievo rappresenta il “Quos ego” corrispondenti alle parole scritte
sull’Eneide di Virgilio e profferite da Nettuno contro i venti, scatenati
dall’ira di Giunone contro Enea; tema riproposto dal Cambiaso in palazzo
Giustiniano in Posta Vecchia).
M.Labo
dice che collaborò anche il fratello Andrea da Carona (pure lui però non citato
nel libro di scultura su detto vol..I: un omonimo compare nell’elenco fornito
dai Consoli dell’arte, all’ufficio dei Padri del comune -dei 104 maestri
-”magistri antelami” - presenti a Genova nel 1486 (impossibile sia lui
quindi); TuvoCampagnol dice Antonio, ma
poco probabile visto che era già attivo nel 1510-).
Due
panchette di ardesia -ai lati della finestra- permettevano intrattenimenti e
conversazioni in luogo con vista amena.
Un
ampio salone, rivolto a sud verso il mare, è lungo 18 m. ed era il più
grande fatto a Genova di quell’epoca; si impone per la solenne serietà
dell’insieme, non arricchito da decorazioni né dipinti, in perfetto accordo tra
il committente che desiderava qualcosa di imponente e l’artista che crea una
solenne ma semplice struttura: spiccano così solo i portali, perché ornati da
pietra nera d’ardesia. Battista Grimaldi, aveva previsto anche l’arrivo di
mobili, conosciamo prodotte da un Passano due credenze, (chiamato “Passiano”,
fu progenitore di una vasta famiglia di ebanisti, divenuti famosi
per i lavori di intaglio del legno e perfezione degli oggetti
fabbricati).


Nel
feb.1996 il salone ha rivissuto i costumi e le usanze degli antichi
proprietari, rievocati in una festa carnevalesca in costume.
I pochi
soffitti affrescati (da G.B.Castello (1509-1569);
o da Lazzaro e/o Pantaleo Calvi secondo E.Parma) riguardano alcune stanze poste attorno al
salone ed a cui si aprono, oggi aule scolastiche; hanno immagini a carattere
mitologico e guerresco con presumibili riferimenti riguardanti le imprese della famiglia committente (di
queste:-


il ratto di Elena la
vittoria
-nella 1ª
sala a sud, le “imprese di Scipione”
sono le meglio conservate (nel riquadro centrale: continenza di Scipione,
ovvero il rifiuto dei doni offertigli in cambio della liberazione della
fanciulla; nei laterali: Scipione nominato console; quando incontra Annibale
prima della battaglia di Zama; scena della battaglia di Zama; scena di assedio
(di Cartagena?).
-nella 2ª
sala a sud il riquadro centrale raffigura un re in trono attorniata da
riquadri minori di scene di battaglia: sono tutti i pessime condizioni e di
difficile lettura ed interpretazione.
Nella 3ª
sala a sud -ove attualmente è la
segreteria a fianco della loggia- tutti dipinti ispirati alla storia troiana,
di levatura tecnica giudicata mediocre, attribuibili a B.Perolli e
collaboratori sotto la guida -e qualche ritocco- di G.B.Castello; invece a
Lazzaro e/o Pantaleo Calvi ed aiuti, secondo E.Parma: sul riquadro centrale racchiuso da una
cornice a finto stucco come sorretta da otto grandi putti di finto marmo, posti
su una mensola col capo coperto da un vaso della volta a padiglione c’è il
“giudizio di Paride”, mentre dei riquadri poligonali si leggono “il ratto di Elena”, “una scena di
sacrificio (Ifigenia?)”, “la presa di Troia”, “la fuga di Enea da Troia in
fiamme con Ascanio ed il padre Anchise sulle spalle”. Agli angoli delle
semplici grottesche e sulle pareti un paesaggio con ruderi.
Nella 1ª
saletta del piano nobile posta a nord-est sul soffitto si vede “la vittoria
(o la fama) che incorona due personaggi” (un guerriero con la punta della
lancia rivolta a terra ed un vecchio): il dipinto fu realizzato forse da
Lazzaro Calvi che negli anni 1570 avevano bottega con la
numerosa famiglia di artisti; attorno, circondati da grottesche, tondi con
delle divinità mitologiche di Giove, Nettuno, Plutone, Saturno; ed agli angoli
finte nicchie con figure allegoriche nude su sfondo dorato.
Nella 2ª
sala a nord il riquadro centrale rappresenta la “Sibilla che mostra ad
Augusto la Madonna col Bambino”, circondata da riquadri minori raffiguranti “Augusto
in trono col piede sul mondo ed attorno i popoli sottomessi e inginocchiati”; “scena
di battaglia”; “giuramento dei triunviri
sul mondo”; “una battaglia navale”. Circondati a loro volta da grottesche ed agli angoli da figure allegoriche, di cui due
avvolte da un drappo, e due seminude.
Nella 3ª
sala a nord, il riquadro principale propone la storia di “Orazio Coclite
sul ponte Sublicio contro gli Etruschi”; i quattro minori rappresentano “Marco
Curzio si getta nella voragine” (la leggenda vuole che si precipitò nella
voragine apertasi nel Foro, dopo la sentenza degli àuguri che essa non si
sarebbe richiusa finché Roma non vi avesse gettato dentro quello che più era a
lei caro); “due condottieri nei pressi di un accampamento, di cui uno traccia
un cerchio per terra”; “un sacrificio o condanna di un giovane guerriero
davanti ad un re anziano seduto in trono”; “supplizio di Attilio Regolo”.
Agli
angoli semplici grottesche e candelabri .
Nella
sala centrale posta a nord, vi è una loggia a tre fornici, con eguale
terrazzino (a cui oggi manca una colonnina ed il buco è coperto con un cartone). Labò dice che c’è
un’unica loggia a sud, con la vista del mare***
Il giardino, in origine
arrivava sino al mare; ancora a metà del 1800 era cintato con addossati 128
sedili; a sud della villa c’era la cisterna con “attingitoio”. Attualmente è
limitato al piazzale antistante l’ingresso, purtroppo cementificato, asfaltato
per utilizzo a posteggio, con delle colonnine delimitanti verso via Daste in
condizioni disastrose e vergognosamente indecorose.
Il teatro: a partire soprattutto
dal 1750 circa, ebbe un notevole incremento non solo con spettacoli di musica e
lirica, ma anche con commedie, melodrammi e
comico. Iniziato nelle case patrizie, quando anche i tempi non erano del
tutto sereni (assieme al gioco del biribis ed al cicisbeismo che a Genova
trovarono il massimo della loro applicazione (ne hanno parlato il Parini,
Stendhal, l’Alfieri, affermando che a Genova ‘spettava lo scettro della
galanteria italiana’), si allargò in molti oratori, chiese, palazzi, e
baracconi, ove si iniziò a fare
spettacoli sempre più di attrattiva, con la richiesta partecipazione di valenti
professionisti (di cui si facevano
mecenati i più ricchi cittadini, e con i quali collaborano i rampolli delle
famiglie stesse). Così venivano rappresentati testi di Racine, Voltaire,
Molière, Goldoni, Paisiello, Cimarosa, e di tanti altri allora in voga (per
esempio divenne famoso nel 1750 e seguito, il DeFranchi quale produttore lui
stesso di commedie ed anche traduttore dal francese e in genovese (ricordata
“la locandiera” di Goldoni, divenuta “la locandiera de Sampé d’Aren-na”)) .
Del teatrino
di palazzo Grimaldi, si ha notizie sin dal 1749: venivano offerti spettacoli spesso richiesti dagli
abitanti stessi; quindi è probabile che
più frequenti fossero l’attività lirica ed il teatro comico (questo organizzato
da dilettanti o anche da compagnie
girovaghe)
Sono
del 1779 (2 gennaio), gli avvisi riguardanti il “Teatro della crosa Larga” (in
alcuni testi viene chiamato
semplicemente “ Teatro di San Pier d’Arena” come se fosse l’unico negli anni dal 1779 al 1827; c’era invece
anche quello della “Loggia”): “lunedi scorso in San Pier d’Arena da una società
di quelli abitanti si è dato principio a proprio trattenimento ad alcune
rappresentazioni teatrali nel Palazzo della ecc.ma ed ill.ma Famiglia Grimalda
. Eglino si propongono di procurarsi quella sì onesta e lodevole ricreazione in
tutte le feste fino a Quadragesima, e
più in un’altro (sic) giorno della settimana. É desiderabile che la loro
istituzione sia incoraggiata dal pubblico gradimento e che serva d’esempio
ovunque domina l’oziosità “. E’ scritto chiaro quindi che fosse ospitato in
questa villa, considerato che già vi era
un teatrino di intrattenimento, ma -di
contro- c’è la difficoltà di concepire un vasto spazio per il pubblico ovvio
gli spettacoli fossero dapprima rivolti solamente alla classe dirigente ed
all’aristocrazia con un fasto ed eleganza da non avere eguali in tutta la
riviera, e quindi eseguiti dentro la villa (probabile sia qui, quanto riferito
da Belgrano circa una rappresentazione in San Pier d’Arena di una commedia titolata ‘li comici schiavi’ scritta da Gio
Gabrielle Anton Lusino –pseudonimo di Anton Giulio Brignole Sale-, stampata a
Cuneo nel 1666 da Strabella ed a spese di Giuseppe Bottari di Genova); ma
quando lo spettacolo iniziò a coinvolgere la cittadinanza ha più logica concepire il teatro come “vicino” alla villa,
pur sempre nel terreno di proprietà, quindi allestito in qualche baracca o capannone -destinato
anche a feste popolane- ad imitazione
di quello interno limitato “per i
signori”; qualcuno altro non si sbilancia accettando ambedue le
ipotesi )
Però
ogni tanto doveva prendere la mano agli organizzatori, se nel 1791 si protesta
contro “l’indecenza... sfacciataggine...corrutela del costume”; episodi
“disdicevoli” accadono nei palchetti: insomma per taluni, il teatro è sede di
perdizione: “ in San Pier d’Arena ... mescolano l’indecenza del popolo genovese
e la sfacciataggine del farastiere colla prostituzione della Nobiltà dei due
sessi. Teatri e casino che hanno saputo portare la corrutela del costume sino
nelle capanne già innocenti dei vicini pastori i quali ora ripeton solo le
ariette de’ musici lor famigliari e si addomestican tranquillamente a
seguitarne i suggerimenti più scandalosi”. E non parliamo della paura di
eventuali incendi considerata la necessità di usare candele in abbondanza. E’
ovvia la necessità di continue delibere da parte delle autorità, per
regolamentare l’attività di questi teatri, specie quelli pubblici: sono noti dei documenti datati 3 ago.1779 di
autorizzazione da parte del Comune di San Pier d’Arena al capo di una compagnia, Lorenzo Ergento “di poter lavorare
purché le prime quattro rappresentazioni siano “Giovanni e denari”, “ Roberto, ossia l’uomo virtuoso” , “ la
locandiera” , “l’assassino di Scozia” ).
Ed
altro del 01 giu.1800 -in pieno assedio-
“si permette al cittadino francese Florentin Montignani di aprire in San Pier
d’Arena, mediante la gratificazione convenuta di lire due a sera, a vantaggio
dell’Ospedale, con l’obbligo di presentare anticipatamente l’opera che si dovrà
recitare”; e del 14 gentile.1803: ”si permette ai cittadini Onorato Tubino e
Giuseppe Caffani, a nome della società dei dilettanti dare onesto divertimento
di sceniche rappresentazioni per il corso del presente Carnevale, nel Teatro
della Crosa Larga”; del 26 giu.1819, il sindaco consente “al sig. Antonio
Morassi di poter dare un pubblico divertimento di bussolotti nel Teatro della
Crosa Larga, purché osservi le regole del buon costume, tanto nell’agire che
nel parlare, e si prenda almeno un gendarme per invigilare il buon ordine e non
permettere che si fumino pipe o sigari né nel teatro né nelle scale...”
Rimase
in attività fino al 1827 (probabilmente fino a quando si decise di affittare la
villa).
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Guida illustrativa per la città di Ge.-Sambolino.1875-pg.326.645
-Archivio
Storico Comunale-Ferrovie
-Archivio
Storico.Comunale.Toponomastica - scheda 3247
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.426—ed./02-pag.463
-AA.VV.-
Galeazzo Alessi (mostra)- Sagep.1974-pag.63
-AA.VV.-Il
don Bosco nella storia urbana-DonBosco.1997-pag. 32disegni
-AA.VV.-Rubens a Genova-mostra
1978-pag.95.127-30.147 palazzoD
-AA.VV.-SPd’A nella sua
amministraz.fascista-Reale.1926-pag.52
-AA.VV.-Scultura a Genova e in Liguria-Carige-vol.I-pag.259
-Baldacci C.-la danza a
Genova-DeFeraari.2004-pag.88
-Battilana-genealogie
delle famiglie nobili di G.-vol.II.pag15 della famiglia
-Boccardo&DiFabio-El siglo de
los genoveses-Electra.1999-pag.125
-Bologna M.-Archivio della
fam.Sauli-SLSPatria-v.114.f.II-pag-670.571
-Bottaro&Paternostro-St.del
teatro a Ge.-Esagraph.82-v.I-pag.
57.154.1643 e 4
-Cappellini
A.-Dizionario biografico di genovesi illustri e notab.-Stianti.1932-pag.80
-Casanova&Dolcino-La
Liguria nella pittura-RGA.1970-pag.79
-Castagna&Masini-Genova,
guida storico artistica-Masini.1929-pag.450
-DeLandolina
GC.- Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.16
-DiNegro
GF B-l’araldica a Genova-Liguria.1983-pag. 84
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.16
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
S . - 9/87.5 +
9/89.3 + 2/90.5
+ 3/91.9 +3/96.3
+
4/96.9
-Genova,
rivista municipale : 10/31.892
+ 9/32.896 +
10/38.36 +
-Grosso
O.-All’ombra della Lanterna-1946- pag.152-3
-Il
Secolo XIX del 07.02.02 + 11.09.02 +
10.5.03 + 23.2.4
-Labò
M.-I palazzi di Genova di PP Rubens-Tolozzi.1970-pagg 58 e 129.
-Lamponi
M.-Sampierdarena-EllePiù.2002-pag.72
-Levati
PL-Regnanti a Ge.nel sec.XVIII-Gioventù.1910-pag. 33
-Lunario
genovese del sig. Regina 1889-pag.541
-Magnani
L.-Il tempio di Venere-Sagep.1987-pag. 92n12.139n.6.215n9
-Moretti
AM-Musica e costume a Ge.-Pirella.1990-pag. 55.205n44+52
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.12.18)
-Pagano
ed/1933-pag.576; /1950-pag. 219.514;
-Parma
E-Il cinquecento-CARIGE.1999-pag.220.326
-Pastorino&Vigliero-Dizion.
de. strade di Gen.-Tolozzi.1985-pag.1188.1363
-Poleggi
E.-Genova, una civiltà di palazzi-Silvana.2002- pag. 39
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.51
-Podestà&Augurio&Musella-I
Serra-Test&Immagine.1999-pag187
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.170.176
-Roscelli
D.-Nicolò Barbino maestro..-soc.Universale.1982-pag.153
-Sagep-Guide
di Ge-n°76.tutto
-Scorza
A.MG.-Le famiglie nobili genovesi-Frilli.2003-pag.110
-Soprani.Ratti-Vite
de’ pittori, scultori e …-Tolozzi.1965-v..I-pag.402
-Stringa
P.-La Valpolcevera-Agis.1980-pag..93
-TCI/1997
Ville e giardini d’Italia –
-Tuvo&Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.79
-Vitale
V.-Breviario della storia di Genova-SLSP.1955-vol.I-pag.432
PALESTRO via
Palestro
Oggi non più a San Pier
d’Arena; corrisponde all’attuale via Santo Bertelli.
Fu nell’anno 1900 che fu
proposto alle autorità il nome di ‘ via Palestro’, al
vicolo posto tra -allora erano- via Vittorio Emanuele e via san Martino, e le case n° 34A di proprietà Galezzo, 34B
di Rovegno e 34 C di Pittaluga e C..
La proposta fu accettata
e la prima targa in marmo fu applicata nel genn.1901 (quando
contemporaneamente via san Martino era
divenuta via A.Saffi).
Nel Pagano 1902 unico
compare al civ. 34 c’era una delle tre fabbriche di fiammiferi in legno, quella
di Ferrero Giovanni (c’è
ancora nel 1912, non compare più nel Pagano/19).
Nell’elenco delle strade
di San Pier d’Arena pubblicato nel 1910, la via appare delimitata da via
Umberto I (v P.Reti) e via A.Saffi (v.C.Rolando) con civv. sino al 5.
In quello del 1927, relativo alle strade della grande Genova
appena unificata, appare in SPd’Arena di 4a categoria, ma – assieme a quella
omonima di Rivarolo - candidate prossime alla variazione a favore di quella del
Centro.
Nulla appare realizzato
ancora nel 1933, sempre di 4.a categoria e con civv. sino al 5 (quando via
P.Reti era divenuto via Milite Ignoto, e via C.Rolando era ancora via A.Saffi).
Fu con delibera finale del
podestà del 19 agosto 1935 che fu cambiato la titolazione con l’attuale.
DEDICATA alla battaglia
combattuta durante la seconda guerra di Indipendenza, nei pressi del comune
pavese (posto a 121 m slm. Nella pianura lomellina, a levante del fiume Sesia,
più vicino a Vercelli -12 km- che al capoluogo -58 km) il 30-31 magg.1859.
Per due giorni si
scontrarono gli austriaci del VII corpo d’armata, guidati dal gen. Zobel, contro i franco-piemontesi,
guidati dal gen. E.Cialdini.
Assisteva le operazioni
personalmente anche il re Vittorio Emanuele II.
Dopo un iniziale
ripiegamento, gli austriaci - forti del numero: 30mila contro 15mila- sferrarono
un imponente contrattacco minacciando di scompigliare seriamente e
definitivamente le linee italiane;
allora il re Vittorio postosi al comando del II reggimento di zuavi francesi
assieme al loro comandante col. De Chabron, andò con essi ad un disperato
attacco, rigenerando i fanti italiani e costringendo il nemico alla ritirata
verso Novara. Ben 31 cannoni furono conquistati in assalti alla baionetta.
Così, sconfitte, le
truppe austrianche dovettero, anche per il complesso delle successive
operazioni, ritirarsi ulteriormente
oltre il Sesia fino al Ticino per riorganizzarsi, anche perché in contemporanea
falliva un altro attacco austriaco - comandato da Gyulai - a Confienza;
permettendo all’esercito francese di Napoleone III di puntare su Milano.
Il re -per il valore
dimostrato e lo sprezzo del pericolo- si
meritò sul campo da parte francese la nomina di “nostro caporale”.
Nella zona fu costruito
un ennesimo ossario per i Caduti, ed un monumento al Soldato italiano.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale
-Archivio Storico
Comunale Toponomastica - scheda 3253-
-DeLandolina GC.- Sampierdarena-Rinascenza
.1922-pag.50
-Enciclpedia Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.18)
-Pagano/1908-pag.875---/1933-pag.247
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1365
-Pescio A.-I nomi delle
strade di Genova-Forni.1986-pag.259
PALMETTA piazza Palmetta
TARGA: piazza Palmetta


QUARTIERE ANTICO: san Martino
N°
INFORMATICO: 2819 CATEGORIA: 3
 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 45100
UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
 da google Earth, 2007
da google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: la piazza è posta a ponente di via Walter
Fillak, e comunica con essa tramite via
G. Salinero; è chiusa ad altri sbocchi, e possiede un transito veicolare
rotatorio con senso antiorario (generalmente impossibile completarlo per le
auto in sosta).
É
servita da ambedue gli acquedotti, DeFerrari Galliera e Nicolay.
CIVICI Neri= da 1 a 7 (esclusi 3 e 5); e da 2 a 4
Rossi= da 1r a 19r (compresi
9ab e 17a); e da 2r a 10r
===civv.1
e 3 neocostruiti nel 1953; quest’ultimo da abitazione fu trasformato in
magazzino nel ’77.
STORIA
IL TOPONIMO
Il toponimo non ha un etimo preciso, e varie
sono le interpretazioni, nessuna documentata e sicura.
A mio avviso, sicuramente quello stradale si
sovrappone a quello più antico della fine del 1700, riguardante la località.
==1==non un
quartiere, ma tutta una ampissima fascia di terreno che in sezione est-ovest
viene delimitata dal crinale del Belvedere sino al Polcevera. Mentre per la
limitazione nord-sud vede due versioni -quali più frequenti adottate dagli
storici-: 1A= comprendente il territorio tra
Certosa e l’ attuale via A.Caveri. A conferma di questa ipotesi, a mie mani
alcune carte: la prima, del 1757 (ma preparata molto prima), di Matteo Vinzoni, non cita questo nome perché probabilmente ancora
con esisteva; la seconda, dell’ ing. arch. Brusco, del 1781 (vedi sotto)
pone il nome Palmetta a nord, ovvero
dopo, la chiesa di s.Martino – seguendo la strada, su quello che nella carta
del Vinzoni era terreno dei Cicala; la terza, sempre del capitano Brusco
ma del 1790, ove scrive “Principio della strada della Palmetta” in corrispondenza dell’inizio dell’attuale
via Vicenza.

a monte
della chiesa di s.Martino, la scritta ‘La Palmetta’
dic. 1781
- G.Brusco-Progetto per allargare la Strada del Mercato di San Pierdarena fino
alla Palmetta -.
ASG.Raccolta
cartogr. Busta 18 n.900 – particolare.
1B= versione molto più
allargata, che - sempre dai confini nord del borgo, con Certosa - va a sud fino
ad una ipotetica linea che passa per via GB Monti. Ambedue le interpretazioni,
a fondo valle comprendono i quartieri di
san Martino (che iniziava dal quartiere
Mercato) e del Campasso (che a sua volta comprendeva la piana di piazza d’Armi). (vedere ‘vico Governolo’)
==2==l’idea dell’esistenza di un
palmeto nella zona, o singola e maestosa come ora in piazza Montano ed allora
preciso punto di riferimento più della villa che la ospitava, ha una sua
logica, vista la longevità di simili piante; anche se non è stata dimostrata
una precisa localizzazione di simile
ornamento non spontaneo nella zona. In questa direzione interpreta DeLandolina,
scrivendo che fu proprio nei giardini della villa Currò esisteva un palmeto
“che nella dolcezza del suo clima vi giungono a fioritura”.
==3==Altra interpretazione è legata - come
la frazione Palmaro a Pegli - alla cerimonia religiosa della domenica delle
palme (quarta di Quaresima, iniziale della settimana santa culminante nella
Pasqua, celebrata in memoria della trionfale entrata di Gesù in Gerusalemme Per
la cerimonia religiosa si tagliavano dei rami da una palma che se esistente
nella zona, la fece divenire punto di riferimento popolare; fino a che, morta
la pianta, rimase il nome, mentre la cerimonia senza il materiale primo, fu sostituita
gradatamente con la benedizione dell’ ulivo), eseguita per 600 anni nel
piazzale dell’unica parrocchia esistente nel borgo. Unendo le due ultime
interpretazioni, si può pensare che per la cerimonia religiosa si traessero i
rami da una o più palme esistenti nella zona, divenuta così punto di
riferimento popolare; fino a che, morta la pianta, rimase il nome, mentre la
cerimonia senza il materiale primo fu sostituita gradatamente con la
benedizione dell’ ulivo.
==4==Meno probabile un’ altra origine
relativa alla parte di poppa di una nave in gergo chiamata palmetta (posta
dietro al timone, e nelle navi a motore, sovrastante il tunnel dell’elica; zona
riservata allo stivaggio della mercanzia delicata, fragile o di valore; un
proprietario (Currò) che faceva corrispondere le preziosità della stiva alla
sua villa).
LA LOCALITA’
Come già detto ne ‘il toponimo’,
non potendo definire una posizione precisa, è divenuto uso la dizione “alla
Palmetta” per indicare genericamente la
zona del Campasso, rione san Martino (dove
era l’antica parrocchiale).
A conferma, Tuvo riferisce che il 1 giugno 1825, «nello stradone di Polcevera, in località Palmetta, avviene lo storico
incontro tra i re Carlo Felice e la regina Cristina con l’Imperatore d’Austria
Francesco I. Con lui c’è il cancelliere dell’Impero principe di Metternich, il
vicerè del Lombardo Veneto arciduca Ranieri e la viceregina; il corteo reale
imperiale sfila lentamnente tra la folla plaudente seguito da un largo seguito
di carrozze e cavalieri, mentre un cordone di truppe è schierato lungo la
strada che conduce a San Pier d’Arena, sino a Genova. In piazza della Lanterna
le truppe sono passate in rivista dai Sovrani. Indi il corteo
raggiunge...(Genova, ove tutti saranno ospitati nelle lussuose residenze)...Nei
giorni seguenti furono effettuate delle regate alle quali parteciparono
equipaggi sampierdarenesi»
LA STRADA
antica
Il nome – in un progetto del Brusco del 1790 –
mirante ad allargare la attuale via Rolando (limando le proprietà e lasciando
ristretto dove i palazzi) e ad aprire uno “stradone
che passa fino à Rivarolo” indicava invece - in corrispondenza dell’attuale via
Vicenza - “Principio della strada della Palmetta”.
Nel regio decreto del 1857 la sovrappone a
via W.Fillak: infatti la via a fondo valle che dalla porta Lanterna andava
verso Pontedecimo, viene chiamata strada nuova Provinciale, e – nel tratto
dell’attiuale zona di san Martino - anche “stradone della Palmetta”. A
conferma, nel luglio 1861 un atto
notarile riguardante una casa venduta a Certosa, conferma che essa è posta “in capo al regio stradale, detto della
Palmetta”.
Negli ultimi decenni del 1800,
l’amministrazione comunale decise di dare il nome di via Vittorio Emanuele a
tutta la strada che dalla porta Lanterna arrivava sino a Rivarolo ed oltre. Nel
1902 c.a, via V.Emanuele venne a sua
volta frazionata, e questo pezzo fu dedicato al re assassinato diventando via
Umberto I. Ed è da questa strada, che il Novella nei primi decenni del 1900
descrive esistere una “via Palmetta” (quindi potrebbe essere qualsiasi di esse,
tra le attuali via A.Caveri e via
G.Salinero).
LA PIAZZA
attuale: I primi palazzi che
delimitarono una piazzetta, distaccandola così dalla strada principale, furono
eretti nel 1888 per iniziativa di
imprenditori come i fratelli Rusca (proprietari delle cave di monte
Gazzo) e soprattutti di Vignolo Agostino (giudicato “speculatore” perché dopo
varie operazioni azzardate andò in fallimento, cosa estremamente grave sempre,
ma a quei tempi assolutamente
dequalificante): in quegli anni, seppur in un momento di grave crisi,
l’industria già insediatasi nella zona, aveva chiamato tanta manovalanza dalle
regioni vicine, il più spesso poveri ed analfabeti, comunque tutti senza una
abitazione decente e con gravi difficoltà a pagare una pigione adeguata.
L’operazione fu resa possibile dalla lottizzazione dei terreni sia da parte
delle ferrovie (che l’avevano ricevuto dal Demanio) sia da parte della Carrena
stessa che aveva comperato più terreno di quanto gliene occorresse e così se ne
disfaceva capitalizzandolo.
Appare in uno studio comunale anteriore
all’anno 1900, una piantina in cui si propone al Comune il toponimo di Palmetta
ad una piazza allora senza nome, posta ad ovest di via Vittorio Emanuele
(allora, tale via andava dalla Lanterna a Rivarolo ed oltre; ma qui si
riferisce allo specifico punto corrispondente a via W Fillak), e creatasi tra i
civici (di allora, 51 e 53: quelli delimitanti la piazza oggi); nel dic.1900
viene riproposta alla giunta, col nome di “piazza della Palmetta”, confermando il nome popolare antico.
Il desiderio di non cancellare dalla memoria un nome storico,
non significa che la palma –ammesso sia esistita nell’antichità- fosse ubicata
nel posto. La titolazione stradale quindi, diviene puramente simbolica,
come via della Coscia.
Una fonte dice che ospitò la prima pista per gare da ciclismo, negli anni inizi
1900; la stessa cartina comunale di
sopra, segnala un “vico della Pista” in una zona poco più a sud, tra via Miani
e via Bezzecca: si presume quindi che in verità la pista fu eretta in quella
zona vicina.
Nel 1910, sulla pubblicazione edita dal
Comune, la piazza è descritta ‘da via Volturno verso il Polcevera’, ed aveva
civici sino al 5 e 6.
Nella piazza, prima di essere riassettata, vengono ricordati negli anni 1920-30 dei trogoli (posti all’estremità sud, ove le massaie
andavano a lavare i panni, e ricordati anche da E.Morasso per i pettegolezzi
che sopperivano ai giornali ed ai bollettini locali; evidentemente in quegli
anni nelle case popolari non esisteva ancora il servizio dell’acquedotto nei
singoli appartamenti: le chiacchiere tra comari, favorirono e diedero corpo ad
una strana leggenda di fantasmi locali, che la
scarsa illuminazione e la fantasia alimentarono fino a divenire un fatto
di interesse generale, dividendo i timorosi da spavalde ronde munite di nodosi
randelli; finché non fu chiarito trattarsi di un amante notturno di una
sconsolata moglie, di operaio che lavorava nei turni di notte) e l’entrata di servizio delle corderie (poi
della Feltrinelli. L’ingresso principale era in via UmbertoI a livello del civ.
44; vantavano la presenza di 200 operai -maggiormente donne-).
Nel 1926, momento della unificazione di
SPd’Arena con Genova, era l’unica piazza con questa titolazione e quindi non subì variazioni.
Riconfermata nel 1933, viene descritta di 5.a categoria, ma con civv. fino al 4 e 7.
Nel Pagano/40, descritta “da
via G.Salineri verso il Polcevera” non ha civv. neri ed ha un solo civico
rosso: 4r=Tinelli M. carbonaio.
STORIA Molto anticamente, erano comunque terreni
poco abitati, insalubri nella parte più a nord, praticamente fuori del paese e
lontani dal centro organizzato e su terreno scosceso. La carta del Vinzoni, e
quindi ancora nel 1757, è significativa perché finisce quando descrive la antica abbazia di sanMartino: oltre, più nulla eccetto che
erano terreni dei Cicala.
Lamentandosi
già i paesani sampierdarenesi dell’eccessiva lontananza della chiesa
parrocchiale, questi terreni a maggior ragione erano considerati campagna brulla, acquitrinosa se pioveva e
quindi poco produttiva e disabitata (considerando che tutti gli abitanti a San
Pier d’Arena nel 1815 erano in 5345); spesso i radi abitanti si dovevano
confrontare con i soldati, sia quelli che passavano andando a difendere i
confini sia quelli delle guerre d’invasione: ambedue che razziavano tutto
quello che trovavano, come bottino e paga, e che spesso per ottenerlo
uccidevano e devastavano (difficile doveva essere -e rimanere- fedeli a “mamma
Genova” con lei lontana e ben racchiusa nelle sue mura, quando a questi
contadini toccava rimanere lì a subire
le angherie e violenze degli armati in gruppo; o -in alternativa- perdere tutti
i beni se non anche la vita. Questo perché a fine di ogni guerra, tornavano i
soldati genovesi per punire non solo chi avesse favorito o inneggiato alla loro
presenza, ma anche chi era stato obbligato a collaborare).
Per la comunità, il primo punto di
riferimento, ovviamente era il parroco di san Martino.
La zona fu travagliata nell’apr.1747:
l’ingegnere francese Sicre, maresciallo di campo, applicando quanto già auspicato dal collega Jean-Ubalde de Pène,
fece tagliare il territorio, dal torrente Polcevera al Belvedere, con articolati trinceramenti
tutti collegati, alternati da ridotte e postazioni di artiglieria rinforzati da
muretti a secco: torneranno utili quando a metà maggio, 70 battaglioni
austriaci e 12 piemontesi (60mila, contro 20mila genovesi aiutati da forze
gallispani) arrivarono in zona e tra il 12 e 13 giugno attaccarono da tutti i
lati Genova. I trinceramenti ed i forti ressero l’urto dei primi attacchi
smorzando le prime velleità del nemico, che allora pose assedio da lontano;
quando ormai la situazione era giunta agli estremi sopportabili, l’esercito
nemico dovette improvvisamente e miracolosamente allontanarsi perché richiamato
verso il Monginevro, attaccato da ingenti truppe francesi.
Nel 1757
esce il libro del Vinzoni con la carta “dell’acquedotti” e relative proprietà: si vede bene che mentre la fascia
lungo la strada (via C.Rolando) è distribuita ad una decina di proprietari, la
fascia sotto il Belvedere appartiene – da sud - ai magnifici: Lorenzo
Lomellini, fratelli Pinelli, fratelli Grimaldi (GioGiacomo e GioBatta con le
loro ville lungo la strada), Giuseppe Lagomarzino con la villa di via Caveri;
signori Morci (illustri sconosciuti), magnifici Cicala e Sebastiano Pallavicini. Non passa inosservato che tutta la fascia del crinale da
salita Millelire a Certosa non è
descritta nei confini di proprietà personali. Ancora più scarna, limitata a
nord sino all’abbazia di san Martino e senza nomi, la carta dell’’Atlante del
«Dominio della Serenissima...» del 1773.
Nel 1781
l’ingegnere militare Giacomo Brusco su proposta delle Autorità locali,
tentò risolvere la viabilità del centro del borgo, già allora ‘congestionato’.
Propose un rettifilo -poi non realizzato- che si sovrappone all’attuale via
C.Rolando e che superata la chiesa di san Gaetano, percorre un ulteriore tratto
di duecento metri circa (con a ponente della strada la proprietà dei sig.
Ghezzi, poi altri 200 di proprietà
‘delli mag.ci Rovereti’) sino
all’abbazia di san Martino; oltre la quale, “al principio dello stradone di
Rivarolo c’è una zona chiamata ‘la Palmetta’”.
Un’altra
relazione di un architetto (Claudio Steracca?) del luglio 1790, che proseguì i
progetti del Col. Cap. Ing.re
Brusco, relativa sia all’eliminazione di
tutti i torrentelli e canali d’acqua che attraversavano la via (oggi
v.C.Rolando), sia al suo allargamento, scrive “la strada nuova slargata che
dalla Piazza del Mercato di S.Pier d’Arena, passa à S.Martino, ed alla
Palmetta...”. Ambedue puntualizzano essere punto focale della Palmetta,
l’attuale piazza R.Masnata (anzi, la seconda relazione, scrive all’altezza
dell’attuale via Vicenza ‘Principio della strada della Palmetta’)
Ancora nel 1850 la zona era praticamente
tutta campagna con qualche rara casa di
contadini, sparsa nei prati con orti e vigneti, tagliata da numerosi
torrentelli scarsamente arginati, asciutti od impetuosi a seconda del
tempo; i più grossi prima che sfociassero nel Polcevera erano usati per alimentare dei mulini,
anche lui senza argini, a volte in secca ed altre in devastante espansione;
solo vicino ai ruderi della abbazia di san Martino, un maggiore agglomerato con
le solite osterie. Il passaggio della
ferrovia a metà secolo, aumentò la popolazione locale e conseguentemente la
lenta ma inesorabile presenza umana anche nella zona da bonificare; in
quell’epoca di metà 1800 nacquero così lungo la strada rade casupole di
artigiani e poi le prime industrie (dei
Maclaren & Wilson; in SPd’A si contavano allora circa 13mila anime;
c’era tra le rade case un palazzotto che
Thomas Robertson (uno dei primi industriali del ferro ed acciaio) prese in
affitto dal marchese Negrotto Cambiaso (proprietario della maggior parte dei
terreni della Palmetta); scrivendosi che era aperto sulla strada tramite un
giardino, potrebbe essere la palazzina Tuo, al civ. di via W.Fillak). Ovviamente niente illuminazione,
niente acqua in casa, niente scuole, tanta miseria e semplicità; la vita media
non superava i 40 anni, essendo altissima la mortalità infantile.
Alcune carte di fine ottocento-primo 1900,
relative all’istituto don Bosco e purtroppo non vaste da allargare sopra via Cristofoli fino al crinale; descrivono proprietari dei terreni (ad
est): 1876-92 a mare i Durazzo-Pallavicini ed a monte i Montano-Negrotto (i
primi furono discendenti di due famiglie importantissime e di origini
antichissime feudali: per i Durazzo in quegli anni era MarcelloIV
-1821.1904- che andò sposo –1847- a
Teresa Pallavicini –1829.1914- figlia del grande Ignazio proprietario della
casa di via Balbi e della villa a Pegli. I due ebbero un figlio, GiacomoFilippo
che assunse ambedue i nomi –1848.1921- e che sposò in prime nozze Masetti Giulia ed in seconde Matilde
Giustiniani senza mai avere figli. Matilde quando restò vedova, sposò Pierino
Negrotto Cambiaso); 1890-1907, a mare sempre i Durazzo Pallavicini ed a monte i
Moro
Dal
1900 in poi, ci fu un crescere disordinato di modeste fabbrichette (turaccioli,
candele, sapone, mulini, cordame), e- con esse- le case per gli operai,
magazzini, depositi, capannoni; e via via essendo zona di estrema periferia,
tra gli onesti e timorati lavoratori, la massa dei più tristi: disoccupati,
avventurieri, beoni, attaccabrighe, ladri, sfaccendati e contrabbandieri
(allora c’era il dazio da pagare!).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda
3267
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.426—ed./02-pag.463
-AA.VV.-Il
palazzo DurazzoPallavicini-NuovaAlfaEditor.1995-pag.19
-Castruccio
A&C-Ge. e paesi circostanti come eravamo-Mondani1983-
-Ciliento
B-Gli scozzesi in piazza d’Armi-DeFerrari.’95-p.46car.50.60.69
-DeLandolina
GC– Sampierdarena -Rinascenza.1922-pag,50
-Forti
LC-Le fortificazioni di Genova-Mondani.1975-pag.99
-Gazzettino
Sampierdarenese : 1/79.5
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.140
-Lamponi
M-Valpolcevera come eravamo-Mondani.1993-pag.2.5
-Morasso
E.-I racconti del nonno***
-Novella
P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.berio.1900-pag.18.32
-Pagano/1933-pag.247;
/40-pag.362
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1377
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.9
-Schiaffino
P-Parlar camallo-Il Lavoro-Genova parla-pag.38
-Stradario
del Comune di Genova edito 1953-pag.131
-Stringa
P.La Valpolcevera-Agis.1980-pag. 87 .96carta
PANCALDO via Leone Pancaldo
TARGHE: via – Leone Pancaldo

angolo con via G.Buranello


angolo
con via G.Giovanetti
QUARTIERE ANTICO: Mercato
N° IMMATRICOLAZIONE: 2820
CATEGORIA: 3
 da
Google Earth, 2007.
da
Google Earth, 2007.
In verde, ipotetico tracciato
della via; con in fucsia,
via GGiovanetti e giallo, via
della Cella.
 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE
INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 45160
UNITÀ
URBANISTICA: 26 – SAMPIERDARENA
 da
Google Earth, 2007
da
Google Earth, 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STORIA:
Dall’amministrazione
comunale nella seduta del 22 ago.1907,
fu attribuito - inizialmente come
vicolo - il nome del condottiero alla neoformata strada delimitata dalla costruzione dell’attuale
lungo fabbricato con tre portoni eretto dai fratelli Girardo, perpendicolare
alla ferrovia ed aperto in via A.Doria e
via Vittorio Emanuele.
Il
terrapieno della linea ferroviaria, con un cavalcavia specifico, passa sopra
l’inizio della strada.
Lungimirantemente,
l’obbligo era di iniziare le costruzioni tenendosi lontano 20m dalla ferrovia:
questo permise in un secondo tempo l’allargamento della strada ferrata da due a
quattro binari.
Nel 1910 si trova scritto nell’elenco delle
strade cittadine come “vico Leon Pancaldo”, situato “da via V.Emanuele verso
nord a fianco della via A.Doria, con numero civico estremo: 5”.
E sempre
‘vico’ era nel 1926, all’atto della
unificazione comunale di SPd’Arena con Genova; classificato di 5a categoria.
Da
Venezia, negli anni 1925-30 venne ad
abitarvi al civ. 5 la famiglia di Giacomo Buranello (una lapide vicino al
portone, ricorda il personaggio. Vedi a ‘Buranello’).

Nel 1933 era divenuta ‘via’, seppur sempre
di 5.a categoria e con tre civici neri.
CIVICI:
2007= NERI= da 1 a 5
ROSSI= da 1r
a 15r (manca 11r; in più= 1Ar, 3Ar, 9Ar)
da 2r a 6r
La
strada inizia da via Buranello, sottopassando la ferrovia; prosegue carrabile
comunale, senso unico viario diritta sino in fondo, laddove è chiusa. Strutturata
a ┤, dall’altezza del civico 3 (a
metà percorso circa) può sfociare in via Giovanetti – ove sbuca sottopassando
un collegamento a terrazza tra due palazzi di quest’ultima strada. Lunga
m.103,24 e larga 2,4, con due marciapiedi.
Nel
Pagano/40 il vico, che dipartiva da via
II Fascio d’Italia a via G.Giovanetti, aveva civv. neri 1,3,5 ed un solo rosso:
7r fruttivendolo
DEDICATA
al
navigatore savonese, che, in terra natia, ovviamente sarà stato chiamato Leone;
ma buona parte della bibliografia lo
chiama Leon, per eutonìa o dal portoghese.
Incerta
e non documentata la data di nascita: in un censimento del 1531 è dato cinquantenne,
quindi nato nel 1481; ma, desunto
dall’età da lui dichiarata alla Commissione di Valladolid, risulterebbe nel 1482;
lo
studioso Belloro ha calcolato dovrebbe essere nel 1490.
Da antica casata ligure, fu figlio unico maschio di agiato artigiano di
stoffa e tessitore: Manfrino, sposo di
Battistina di Repusseno (o Repossano).
Dovette seguire i corsi scolastici del tempo:
grammatica, logica, retorica, ed anche scuola di vela – indirizzato dal padre, per
andare a procacciarsi la lana in Spagna o Sardegna e per divenire infine
maestro nella Corporazione dei ss.Gervaso e Protasio.
Preferì la via del mare alle fiorenti
attività familiari (Baldassarre scrive che LP “diè all’acqua una nave con
felice presagio detta Vittoria”; e riporta da AM de’Monti, che Leon Pancaldo
era “nocchiere, e Padrone della nave Vittoria del 1522”) e tale fu
l’entusiasmo, da divenire rapidamente un esperto e stimato marinaio, ricercato
tra la gente di mare per armare navi e spedizioni.
Nel 1514 sposò in Savona la giovane Selvaggia
Romana, anche lei figlia di un Antonio, accimatore di panni e socio del padre.
Insieme abitarono nel quartiere di sant’Elmo, nei pressi della fortezza di
Priamar.
Ma 5 anni
dopo, appena seppe che in Portogallo si approntava la spedizione di Magellano
(Magaglianes), partì ad arruolarsi quale marinaio semplice assieme ad una
ventina di altri italiani (su 230-265 marinai; Spotorno e Verzellino dicono
sulla nave Vittoria, di 85 t., quarta per grossezza dopo la ‘sant’Antonio’ di 120 t.; la ‘Trinidad’ di
110 t.; la ‘Concepcion’ di 90t) per il primo viaggio di circumnavigazione ed
alla ricerca del passaggio verso il favoloso oriente (vedi Magellano).
Imbarcato invece sull’ammiraglia Trinidad
(=Trinità), una delle 5 navi della flottiglia, salpò il 20 settembre 1519
(Lamponi scrive 10 agosto) dal porto di Sanlucar (o san Luccar) de Barrameda
(vicino a Siviglia), dopo aver consultato gli astri. Il 3 ottobre furono a
Tenerife; da lì verso l’America del sud
a cercare il passaggio al Pacifico (così poi battezzato da Magellano per le
bonacce), che fu trovato dopo tanti tentativi percorrendo ogni insenatura, con
solo tre navi al seguito, nel novembre dell’anno dopo: il passaggio
dall’Atlantico al Pacifico non viene descritto nei particolari perché – presumo
io - non consapevoli di questa ‘uscita’, dopo averne cercato a migliaia in ogni
rientranza della Terra del Fuoco. Si data nell’agosto 1520 il passaggio attraverso
lo “stetto di Magellano”.
Lamponi descrive un inedito episodio: lui navigante
in acque dell’America, sogna un fuoco di sant’Elmo (alone luminoso visibile di
notte in corrispondenza di punte; causato da aumento del campo elettrico in
corrispondenza di forti variazioni atmosferiche tipo temporali) -
temutissimo quale cattivo presagio per la nave dai marinai - mentre il reale
fuoco si era avviluppato nella casa a Savona con la moglie salvata in extremis
da un marinaio che – seppure autore dell’incendio - doveva riconoscenza ai
Pancaldo.
La vastità del Pacifico fu superiore alle
aspettative ed alle scorte di acqua ed alimenti. Allo stremo, solo a marzo del
1521 avvistarono terra: erano le isole Molucche (attuali Filippine), ove il 27
aprile Magellano perdette la vita in combattimento.
A questo punto le navi superstiti erano rimaste due;
di esse la Victoria, comandata da Sebastiano El Cano, ritornò in patria
attraverso il Capo di Buona Speranza. Mentre invece sulla Trinidad - rimasta indietro per una falla ed
assottigliandosi l’equipaggio - il Pancaldo via via divenne dapprima timoniere,
poi nocchiero, fino ad essere il personaggio più eminente sulla nave.
Si scrive che,
ancora presso le Molucche, fu catturato dai portoghesi arrivati provenendo
dall’occidente, che lo trattennero prigioniero causa i pessimi rapporti con gli
spagnoli, e trasportato in India da dove riuscì a fuggire assieme ad un altro
marinaio ligure Juan Bautista e solo nel 1526 (altri scrive il 6 settembre
1522) tornare in terra europea (dopo
1084 giorni, cioè dieci anni di lontananza, con 18 uomini su 74; e quando gli
altri erano già tornati con la nave Vittoria (il comandante Elcano si era preso
tutti gli onori e premi, compreso uno stemma gentilizio arricchito con un globo
ed il motto ”primus circumdedisti me”. Solo la relazione del vicentino
Pigafetta, che era sulla sua nave, riuscì a far conoscere ridimensionare
l’usurpatore e dar lustro alla figura di Magellano ed all’impresa di Leon
Pancaldo).
Nel 1527 fu a Valladolid in Spagna, per partecipare
ad un interrogatorio dove accennò a dei libri da lui scritti sulla navigazione
fatta a dimostrazione delle sue capacità non solo marinare ma anche letterarie
(pare che l’opera, non andò stampata e, lasciata in mani inesperte, perduta).
Seppur allettato dal re francese perché ritentasse
la strada dell’oriente, a dicembre dell’anno 1531 arrivò a Savona; con duemila
ducati ricevuti dal re portoghese Giovanni III per l’impegno d’onore di non
passare al servizio di altra corona, né dare carte, né istruire altri
navigatori.
Così
decise fermarsi a terra nella sua villa chiamata ‘la Pancalda’ in località
Lavagnola (alla confluenza tra il Lavanestro col Letimbro). Questa casa era
munita di torre di avvistamento; posta vicino ad un pozzo; poco discosta dal
Duomo in zona Scarzeria e dalla casa della famiglia Crema; sulla facciata fece dipingere un affresco con
il suo ritratto con uno astrolabio in mano, circondato da simboli marinari dall’immagine delle isole vedute, e da una
scritta sotto riportata).
Nel
1534 (altri dicono nel 1535, ed altri nel 1537), legalmente sciolta la promessa
fatta al re portoghese, riprese il mare per una nuova spedizione usando una
galea, la Santa Maria, forse di sua proprietà (assieme ad un galeone del genovese Pietro Vivaldi, con merci
genovesi) diretto in Perù; purtroppo fallì prima ancora di arrivare allo
stretto di Magellano causa una tempesta che lo fece tornare verso il Rio de la
Plata; qui, sbarcato per andare alla ricerca di fasciame per riparare la nave,
fu assalito da indigeni selvaggi, ed ucciso
(un’altra versione - essendo fragili o nulle le testimonianze dei pochi
sopravvissuti - sostiene che nel tentativo di raggiungere la riva prima su una
scialuppa e poi a nuoto, morì annegato. Baldassarre, che sostiene questa
seconda versione, aggiunge che la nave tornò a Savona e passò agli eredi;
mentre invece la casa (posta in un terreno vicino al pozzo, e poi incorporata
nel palazzo dei signori Vercellini) fu divisa -per pio legato- tra i padri
Minori (o Minimi) Conventuali e l’oratorio di s.Catterina).
Morì
quindi nei vasti mari attorno al Rio de la Plata, nel 1538-40.
A
Savona, la torre trecentesca affacciata
sul porto, fu intitolata a lui (eretta per vedetta ed a difesa dai saraceni,
detta pure ‘dei piloti’ (perché stazione del servizio fisso di pilotaggio
portuale) ed attuale simbolo cittadino.
Sulla torre ci sono due scritte, una sopra
lo stipite della porta «in mare irato, in subita procella, invoco te, nostra
benigna stella» che si legge e scrive in italiano e parimenti in latino,
dettata dal savonese Gabriello Chiabrera.
Invece su una targa serbata nell’atrio del palazzo degli Anziani si
riportano le parole che lo Spotorno dice fossero fatte scrivere dallo stesso
Pancaldo sulla facciata di casa sua:
«io son
Leon Pancaldo Savonese, // ch’il mondo tutto rivoltai a tondo: // le grand’Isole incognite, e il paese //
d’Antipodi già vidi, e ancor giocondo // pensava rivederlo, ma comprese //
l’invitto Re di Portugal che al mondo // di ciò lume darìa, perciò con patti, // ch’io non torni mi diè
duo mil ducatti».
Si attribuisce al Pancaldo anche una
discreta vena letteraria. A parte il libro del memoriale della navigazione con
Magellano (detto ‘roteiro’), andato perduto, ed a parte la conoscenza delle
discipline nautiche e geografiche, pare fu anche un rozzo poeta come dimostrato
dai versi scritti (una ottava) sulla facciata della casa, e poi riportati
all’Anziana’ quando la casa di via Scarzeria fu demolita.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale in palazzo Ducale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda
3271
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi di Genova-ediz/94.426—/02.463
-Baldassarre&Bruno-Schedario
degli uomini illustri in Savona-1981
-DeLandolina GC-Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.50
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Enciclopedia
dei liguri illustri- vol.I-ERGA
-Il
Secolo XIX quotidiano.- 17.06.06 +
-Lamponi
M.-Sampierdarena-Libro Più.2002-pag.72
-Lamponi
M.-Leggende, miti e arcani di Liguria-LibroPiù.2004-pag.127
-Miscosi
G.- Genova e i suoi dintorni-Fabris 1937-pag.159
-Novella
P.-Le strade di Genova-manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.18)
-Pagano/33-pag.247;
Pagano/40-pag.362
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.1384
-Poleggi
E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.34
-Spotorno G.-storia letteraria
della Liguria-1826-vol.IV-pag.170
-Tuvo&Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.100
PANTERA via
della Pantera
Unica segnalazione è sul Dizionario delle
Strade di Genova, quale nome antico di via F.Anzani.
Senz’altro è un nome non legalizzato dal
municipio cittadino, come anche “via Airone”.
Quindi è un termine popolare per designare la
località, con riferimento a qualche avvenimento che era accaduto nella zona: in
questo caso, presumibilmente, o un gruppo di saltimbanchi nomadi installatosi
nei prati ancora non edificati, o -più probabile- al possesso degli Spinola di
una simile bestia, regalata loro da qualche stravagante collega, con il
quale intercorrevano rapporti di
traffico marittimo nelle terre esotiche. Tra i nobili signori, sono noti scambi
di cani, asini, cavalli, scimmie; può non stupire che qualcuno volesse distinguersi con un animale simile.
Il problema poteva essere dove tenerlo; e dove meglio se non in campagna?
Non si ha conforto di nessun’altra fonte.
Via F.Anzani, prima di essere così intestata,
era stata ufficialmente chiamata “via A.Cattaneo”.
Una via e salita omonime sono a Genova,
ufficialmente riconosciute nel 1927 in zona san Fruttuoso; laddove però
abbondano strade intitolate ad animali da zoo: via dell’Orso, vico Leone, ed
anche via del Pavone, e del Castoro.
BIBLIOGRAFIA
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.59
Non
c’è sul Novella
PAPA
via del Papa
 È una
strada che dalla zona Fiumara (prima della demolizione degli stabilimenti
Ansaldo) sbucava in zona aeroporto, usufruendo di un ponte proprio -da allora
anche lui chiamato ‘ponte del Papa’- e passando
all’interno delle acciaierie, delle quali è proprietà.
È una
strada che dalla zona Fiumara (prima della demolizione degli stabilimenti
Ansaldo) sbucava in zona aeroporto, usufruendo di un ponte proprio -da allora
anche lui chiamato ‘ponte del Papa’- e passando
all’interno delle acciaierie, delle quali è proprietà.
Ovviamente non è un nome ufficiale
riconosciuto dalla toponomastica, ma fu così chiamata perché su suggerimento
dell’arcivescovo mons. Siri fu usata nel 1985 solo per due giorni, il 21 e 22
settembre, per accompagnare papa Giovanni Paolo II, appena sceso dall’aereo,
nell’interno dell’Italsider in crisi, fino ai capannoni del laminatoio a freddo
dove parlò di fronte a tremila operai; e poi (credo però proseguendo via mare) per arrivare
a Genova
Venne riutilizzata nel 1994 quando si diede
il via alla ristrutturazione del ponte di Cornigliano mentre era in atto anche
il ‘restyling’ del ponte dell’autostrada. Si dovette far ricorso a questo
percorso, in orario 11-15, per i camion (oltre 400 giornalieri) che uscivano
dal porto e dall’autostrada stessa.


Tutta l’area stradale venne promessa essere
venduta entro il 1999 alla città; venne così ‘requisita’ dalla Prefettura che
la affidò in gestione al Comune per disciplinare il traffico (intersezione con
la via ferrata, con cavi ad alta tensione e condutture dell’acqua e
del gas) valutandola di urgente realizzazione essendo fondamentale per snellire
il traffico –non solo quello pesante- da via Molteni e via Cornigliano, realizzando la ‘nuova strada a mare’
(suddivisa in quattro lotti, così suddivisi: il 1° che sarà il tunnel sottomarino; 2° la
zona dell’elicoidale; 3° Lungomare Canepa con viadotto sul Polcevera; 4° dal
torrente all’aeroporto, attraverso le acciaierie (già finanziato con 80milioni
per 2°-3°-4°, di cui metà dell’Anas che attende per affidare gli appalti appena
il prefetto ed il tribunale decideranno in merito al ricorso); 5° dalle
acciaierie a Multedo.
A bloccare i lavori è stato un ricorso
dell’Ilva di Cornigliano al Tar nei primi mesi del 2003, poiché il lembo di
terreno necessario è di loro proprietà (dal punto di partenza del ponte sulla
riva destra).
Il ponte ferroviario sul torrente (eretto
negli anni ’30), è stato demolito in due tempi; il secondo, messo in atto il 27
sett. 08 con 32 cariche esplosive (=18
kg di esplosivo) collocate sui pilastri di supporto, scoppiate alle 13,50.
L’operazione è stata diretta dall’esperto Danilo Coppe coadiuvato da
specialisti della brigata paracadutisti della Folgore su richiesta della
Prefettura. Per evitare schegge ed onda d’urto, la zona di esplosione è stata
‘fasciata’ da materassi e bolle d’acqua specifici.

A fine 2009, solo su il
Cittadino si legge che il presidente della Regione Burlando ha promesso che
questa strada verrà riattata entro il 2012 (nel 2007 si parlava entro
2011) essendo i lavori principali nel
tratto dopo il torrente, ove a Cornigliano erano gli elettrofiltri delle
acciaierie (ora demoliti) e la bonifica del terreno. Il nuovo ponte, ad unica campata, sarà alla fine e
prolungamento di lungomare Canepa.
BIBLIOGRAFIA
-Il Cittadino 27.12.09
-Il Secolo XIX- del agosto (?)1994 + 22.6.03 + 28.09.08
-La Repubblica - del 19.1.04
PARODI via Rosetta Parodi
TARGA: via – privata – Rosetta Parodi

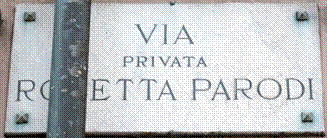
angolo
con via W.Fillak
QUARTIERE
MEDIEVALE: san Martino
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2821 CATEGORIA: 3
 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8
CODICE
INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 45880
UNITÀ
URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
 da
Google Earth 2007. In giallo, via Vicenza; fucsia, via Campasso
da
Google Earth 2007. In giallo, via Vicenza; fucsia, via Campasso
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: doppio senso veicolare, da via W.Fillak
verso levante, chiusa all’apice.
È
strada privata.
Nel
1999 fu ristrutturato l’edificio con i
civv. 2, 4, 6 rossi.
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
CIVICI: neri=
da 1 a 9
rossi= da 1r a 27r e 6r (mancano 2r e 4r)
===civ.
4r Nel
Pagano/33 era l’officina di riparazione
motori elettrici di Bressan Domenico.
===civ. 9r La trattoria ha radici antiche di
tipo osteria-tavola calda per gli operai: osteria Barbieri (1930). Nel Pagano
1950 è descritta osteria di Albanese
Giovanni; divenuta poi ‘da Piera’ (Bonfigli, fino al 1979), ‘i 2 G’ dopo allora,
e forse cambiando gestore, l’ultimo nome
è rimasto.
Nella scheda toponomastica si segnala solo
una ristrutturazione del 1999 per cui i civv. 2, 4, 6 rossi furono cancellati.
Nel
Pagano/40, la via che si staccava da via delle corporazioni e finiva chiusa,
aveva solo numeri rossi: 3r=rip.calzat.; 7r carbone; 9r osteria Barbieri.
STORIA: tal
sig. Parodi Gerolamo iniziò nei primi anni del 1900 a costruire dei palazzi che
dalla via principale via Umberto I
formarono inizialmente un semplice distacco.
Nel
1910 la strada non era ancora inclusa nelle via ufficiali del Comune. Ma come
‘vico’ viene aggiunto a penna negli anni immediatamente posteriori, con
itinerario compreso tra via Umberto I e la proprietà Tuo; e con civv. sino al 7
Nel 1912, il costruttore pose al Comune di San Pier d’Arena domanda
ufficiale di qusta titolazione. La proposta, è evidente, fu accettata.
Così
comparendo unica nell’elenco delle vie della Grande Genova (1926), non subì variazioni nella unificazione dei
nomi.
Nel
1933 era di 5ª categoria e con civici
neri sino al 7.
DEDICATA Per la strada che si era formata, il
costruttore pensò dare il nome della defunta moglie Rosetta, ricordata in vita
per azioni filantropiche da lui stesso sostenute e continuate, e che volle meritassero di essere tenute in
considerazione per pubblica riconoscenza.
Per avvalorare il patteggiamento, ed
affinché l’Amministrazione comunale si
impegnasse al riconoscimento indefinito in avvenire, aggiunse generosamente la
allora considerevole somma di lire mille, quale oblazione a favore della
Congregazione di Carità. Tale scelta non poté essere contraddetta
dall’Amministrazione pubblica (anche appunto perché strada privata), ma non fu riconosciuta
via, quanto solo “vico”.
DeLandolina/1922
scrive che fu “gentile pittrice genovese, sposata in Moro, vivente” (potrebbe
allora essere stata una moglie dei Moro che avevano la villa nei terreni sopra,
da via Caveri, e quindi -anche questo terreno- era loro). Vigliero dice, credo
erroneamente ma possibile: che era la madre.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale in
palazzo Ducale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 3320
-AA.VV.Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.427---ed./02-pag.464
-DeLandolina
GC- Sampierdarena –Rinascenza.1922-pag. 50
-Lamponi M.-Sampierdarena-
LibroPiù.2002-pag. 141
-Novella P.-Guida di
Genova-Manoscritto bibl.Berio-1930circa-(pag.18)
-Pagano/1933-pag.247; /40- pag.
364; /50-pag.394
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1402
-Poleggi E. &C-Atlante di
Genova-Marsilio.1995-tav.9
PASCOLI via
Giovanni Pascoli
TARGHE: via – Giovanni Pascoli
strada privata


in angolo con via G.Balbi Piovera


in
angolo con scalinata Beccaria
QUARTIERE ANTICO: limite tra Coscia e
Mercato
 da
MVinzoni, 1757. Ipotetico tracciato della via (con giallo, corso O.Scassi;
celeste via GBPiovera) a ponente sul terreno del principe di Francavici, ed a
levante del duca Spinola.
da
MVinzoni, 1757. Ipotetico tracciato della via (con giallo, corso O.Scassi;
celeste via GBPiovera) a ponente sul terreno del principe di Francavici, ed a
levante del duca Spinola.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2822, CATEGORIA: 3
 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 45940
UNITÀ URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO
 da
Google Earth, 2007. In giallo via GBPiovera.
da
Google Earth, 2007. In giallo via GBPiovera.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie
STRUTTURA: da via G. Balbi Piovera, a scalinata
C.Beccaria; senso viario unico, opposto alla numerazione, da ponente a levante.
===civ
5a: fu assegnato a nuova apertura nel 1975
Pochissimi gli insediamenti artigianali, nessuno
commerciale.
Nel dic.03 ed ancora ago.04 si legge sul
Secolo che la via è stata inclusa nell’elenco di quelle ‘private di interesse
pubblico’ con programma di divenire municipalizzata (ovvero accorpamento
comunale gratuito in cambio di manutenzione e servizi quali illuminazione,
fognature, cassonetti spazzatura, asfaltatura, ecc.).
STORIA: La
strada, neoformatasi con la costruzione dei caseggiati nella proprietà
Piccardo, come traversa dell’asse principale indirizzato verso il costruendo
ospedale (allora via E.De Amicis), ebbe dalla Giunta sampierdarenese ufficiale
titolazione dopo scelta e delibera del
Comune il 16 set.1914, riconosciuta con itinerario ‘parallelo a corso Roma - in
basso -‘.
Il Pagano/1925 vi colloca al 2-3 Repossi
Emilio che – ancora nel 1933 - si interessa di medicinali (presumo un grossista
o rappresentante)
Nel 1926, all’atto della unificazione della
capacità comunali delle delegazioni nella Grande Genova, risultando unica
dedicata al poeta, rimase immodificata.
Nel 1933 era di 5ª categoria e con civici
sino al 6 e 7 ed, allora, era privata.
Nel 1958 il Comune preparò il terreno per la
posa dell’asfalto, però non addivenendo ad un accordo, abbandonò il fondo in
modo inagibile perfino al traffico pedonale.
 foto anni
60 Gazzettino Sampierdarenese
foto anni
60 Gazzettino Sampierdarenese
Il passaggio a strada comunale è avvenuto
alla fine degli anni 1990.
CIVICI
2007=
NERI =da 1→7 e da 2→6
ROSSI =da 3r→19r (manca 1r; aggiungere 5Ar, 13Br)
il 6r
(mancano 2r, 4r)
La strada è in pieno centro cittadino, ma
l’essere stata autonoma per lungo tempo ha favorito, come in tutte le vie
popolari in cui manca la spettacolarità della monumentalità, quei legami
affettivi tra gli abitanti, che creano sentimenti comuni, paralleli a quelli
descritti dal poeta a cui è intitolata.
Nel Pagano/40, limitata come oggi, civv.
neri da 1 a 7 e da 2 a 6; rossi 5r commestib.; 7r carbone; 9r fruttiv.; 11r
macellaio; 13r bottiglieria; 17r latteria
Nel Pagano/50 l’unico bar è al 17r., di
Parodi M.
DEDICATA al grande poeta italiano nato a san Mauro di
Romagna (Forlì) il 31 dic. 1855 (dal 1932 il paese si chiama san Mauro
Pascoli).
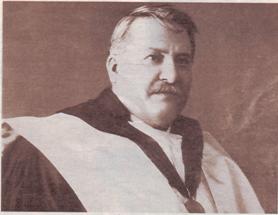
Trascorse
l’infanzia alla Torre, nella tenuta del principe Torlonia, essendone il padre
l’amministratore (quindi piccola borghesia rurale).
Iscritto
presso gli Scolopi, quando raggiunse i 12 anni gli fu ucciso il genitore senza
una motivazione conosciuta, e l’omicida rimasto poi impunito: al ragazzo
vennero a mancare così i mezzi diretti per progredire negli studi ginnasiali.
Fu indirizzato e vinse una borsa di studi con
la quale potè finire il liceo ed iscriversi all’Università di Bologna dove fu
allievo del Carducci.
Però la
famiglia trascorse anni difficilissimi: non solo inizialmente fu privata del
sostegno economico, ma poi anche sottoposta a tragiche pene che conseguirono in
successione: per primo, costretti ad abbandonare la casa a favore del nuovo
amministratore; poi la morte di quattro fratelli e della madre - e
conseguentemente il peso della gestione dei 4 fratelli rimasti (conosciamo i
nomi: Maria- chiamata Mariù è quella che rimase con lui più a lungo; Ida che,
morì di pochi mesi e non viene contata se non perché rinominata nell’ultima;
Margherita, Giacomo, Luigi, Raffaele, Giuseppe, Carolina).
Questi avvenimenti
pesanti, seppur frequenti in quell’epoca senza assistenza, cambiarono
decisamente il carattere del giovane, rendendolo molto sensibile e permeato di sfumatamente
malinconiche.
Iniziò
a scrivere sonetti e poemi anche in
latino, riuscendo con facilità ad esprimere
con parole belle e dolci, i sentimenti comuni.
A 21
anni, frequentando A.Costa, si iscrisse all’Internazionale Socialista dei
lavoratori, iniziando a scrivere articoli sul loro giornale “il Martello”:
quando l’associazione fu sciolta per legge, la sua ostinazione a difenderla –
accusato di ‘grida sovversive’ - gli valse due mesi di carcere (1879), anche se
poi fu assolto per inesistenza di reato.
Dopo
questa parentesi politica solo
simpatizzò per i nazionalisti.
Riprese
gli studi e si laureò (1882 -36 dice nel 1891) in lettere, divenendo professore
di latino e greco nei licei di Matera, poi di Massa, Livorno, Roma.
Vincendo
il premio internazionale di poesia latina, istituito dall’accademia di
Amsterdam, divenne noto e riconosciuto anche lodevole narratore: fu così ricercato da atenei universitari,
promosso professore a Bologna (1895), e poi a Messina (1897), Pisa (1903) e - succedendo
al Carducci, di nuovo a Bologna (1905).
Con i
sudati risparmi e la vendita di alcune medaglie d’oro vinte nei concorsi
poetici, riuscì a comprarsi una casa in Toscana, a Castevecchio di Barga, dove
visse con le sorelle Ida e Maria; e dove tutt’ora è sepolto pur essendo mancato
a Bologna il 6 apr.1912.
Ampio
lo scrigno dei suoi scritti: da libri per la scuola, ad antologie, studi
danteschi, composizioni latine, articoli per giornali e patriottici, poesie:
tutto pervaso da uno stile basato sulla dolcezza e semplicità, sulle piccole
cose della vita comuni a tutti ma
espresse con desiderio del bene, con voce umile e spontanea, con forte serenità
nel dolore e di fronte ai grossi sacrifici compreso la morte; riuscendo così ad
descrivere quasi musicalmente, questi sentimenti interpretati e vissuti da
tutti.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
storico Comunale di palazzo Ducale
-Archivio
Storico Comunale -Toponomastica, scheda 3324
-AA.VV.-Annuario,
guida archidiocesi-ed.1994-pag.427; ed.200-pag.464
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino Sampierdarenese
: 9/73.12
-Il Secolo XIX : 25.11.03 +
23.08.04
-Lamponi M:- Sampierdarena –
Libro Più.2002- pag. 199
-Novella P.- Guida di Genova-
manoscritto bibl.Berio.1930 c.a.-(pag.17)
-Pagano -Annuario
genovese-ed.1933-pag.248; /40-pag. 364; /61-pag.324
-Pastorino-Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1403
-Poleggi E. &C-Atlante di
Genova-Marsilio.1995-tav. 35
PASTRENGO via Pastrengo
Attualmente non più a San
Pier d’Arena, ma in Castelletto. Corrisponde all’attuale via Dattilo.
Da una carta del 1790, si chiamava “vico dei Disperati”:
nel dicembre dell’anno 1900, il regio Commissario straordinario propose alla
Giunta comunale il cambio, col nome di vico Pastrengo, e fu accettato.
Iniziava da via A.Saffi (via
C.Rolando), parallela a via Carlo Rota; portava alla zona chiamata “Fornace” così
popolarmente detta per l’esistenza nel posto di un largo appezzamento
argilloso, materiale necessario per
la fabbrica di mattoni; e si
fermava chiusa, presumo al confine ovest
della proprietà con villa seicentesca Lomellini -poi Bocci, oggi distrutta – (localizzata
dove ora è il civ. 20 di via G.B.Monti), e di cui era la strada
di uscita verso l’asse principale di via Mercato (oggi via
C.Rolando).
Prospiciente, ancora nel 1904 c’era in quell’epoca il convitto-collegio Dogliani, ospitato in un palazzotto
settecentesco che ora non esiste più.

il collegio Dogliani è la villa bianca al centro della
foto subito sotto gli alberi
Nel 1910 è classificata sempre “vico
Pastrengo” con numeri civici solo pari sino all’8 e, sempre da via A.Saffi,
portava genericamente “verso la collina”.
Il Pagano/25 segnala al 5r la tipografia ‘la
Poligrafica, telef. 41-478, esistente ancora nel 1933; --- e Calderoni Primo & C. che riproducono
disegni--- al 13r una seconda tipografia, di Riva Giovanni;--- al 20-22r
Bagnasco Cairoli si interessavano fino ancora nel 1933 di macchine e
trasmissioni;--- al 28r della ‘via’,
l’impresa edilizia del costruttore Capello Filippo,
ancora attivo dopo la guerra;--- al 6-10 una fabbrica modelli e puleggie (sic)
in legno di Almonte &.C. che vive ancora nel 1933 (nel 1919-20 erano
Almonte e Pizzocolo in via P.Cristofoli);--- Non precisato il civico: negozio
di giuocattoli (sic) di Paoloni Giuseppe anche lui attivo ancora nel 33.
Nel 1927 venne pubblicato l’elenco delle
strade delle delegazioni tutte unite allora nella grande Genova: SPd’Arena si
trovò a confronto di una omonima dedica in Centro, e per questa ’via’ si
dovette programmare il cambio.
Nel 1933 appare ormai ufficialmente
classificata “via”; ed anche i limiti sono ben definiti arrivando dall’attuale
via C.Rolando ‘a via P.Cristofoli ed a via G.B.Monti’; era di 4ª categoria ed
aveva civici sino al 5 e 14. Al civ. 5 c’era un “Circolo ritrovo sociale”, ed
all’8 una sede dell’ist.Palazzi.
Per il Pagano/33: al 5r quello di riproduzione disegni, di
Calderoni Primo & C (da molto tempo ed attualmente il via A.Cantore) in
coesistenza con la tipografia “La Poligrafica¨”.
Nel 1935 la delibera del podestà datata 19
agosto 1935 decretava la sostituzione con il nome ‘via E .Rayper’ poi limitato al tratto che da
via L.C.Farini sfocia con una scalinata
di raccordo in via G.B.Monti.
Durante il periodo bellico, viene ricordato
l’episodio di alcuni partigiani che nel sett.1943, con una carretta
trasportavano armi e munizioni: nella strada c’era una caserma della G.N.R. di
Salò (ovvero Guardia Nazionale Repubblicana), dove ora ha una sede locale la
Telecom; riuscirono a passare senza destare sospetti alla guardia, e non essere
così controllati, guadagnando un altro
nascondiglio in via T.Grossi.
DEDICATA alla località
veronese dove il 30 aprile 1848 avvenne una battaglia riguardante la prima
guerra di Indipendenza.
Iniziò subito dopo le 5
giornate di Milano, in virtù di un
rapido avanzamento delle truppe di re Carlo Alberto verso il Mincio (messo in
atto per eliminare sul fianco sinistro la minaccia degli austriaci, guidati dal
maresciallo J.J. Radetzky, attestati appunto in Pastrengo). Lo stesso re, il giorno
30, guidando all’assalto le truppe piemontesi, e favorito da un risoluto
intervento di uno squadrone di carabinieri a cavallo - accorsi a difenderlo -
costrinse il nemico a ritirarsi oltre l’Adige.
Già le terre erano state terreno di battaglia
nel 1799 con i francesi vincitori sugli austriaci
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale Toponomastica - scheda 3340
-AA.VV.-Contributo di SPd’Arena
alla Resistenza-PCGG.1997-pag.36
-DeLandolina
GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag. 50
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.18)
-Pagano/1925-pag.1809;
/1933-pag.248.1694
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1408
-Pescio A.-I nomi delle
strade di Genova-Forni.1986-pag.264
-Tuvo T.-Sampierdarena
come eravamo-Mondani.1983-pag.79
PAVANELLO
giardini Camillo Pavanello
TARGA: San
Pier d’Arena – giardini – Camillo Pavanello – primo olimpionico d’Italia –
20.10.1879-7.7.1951


 da MVinzoni, 1757. In giallo, via
CRolando; fucsia via Currò, celeste, chiesa di sGiovanni Decollato (don Bosco).
da MVinzoni, 1757. In giallo, via
CRolando; fucsia via Currò, celeste, chiesa di sGiovanni Decollato (don Bosco).


da Pagano. 1961 da Google Earth, 2007
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA – n°: 46290
UNITÁ URBANISTICA:
25 – SAN GAETANO
STRUTTURA: vasto
rettangolo di verde alberato (agli estremi nord-sud sono lecci, nel centro sono
platani) racchiuso tra via P.Reti, via B.Agnese, via D.Storace. Questo
giardino, confrontabile con foto vecchie, appare più volte ristrutturato, sia
nella disposizione delle aiuole che nella qualità, quantità e distribuzione
degli alberi.
Da mare a monte, e solo a levante, nei
giardini si aprono: un cancelletto secondario che da adito alla “scuola materna
statale N.Bacigalupo”; un altro cancello offre l’ingresso all’ “Istituto
Magistrale Statale Piero Gobetti”, alla “scuola elementare di stato A.Cantore”, alla “direzione didattica n°3
di Sampierdarena II” . Nel centro il cippo militare.
CIVICI
UU25 =
non ne ha. Viene indicato 0 e X.
===Civ.
25 di via P.Reti: Un cancello è l’entrata del “liceo classico G.Mazzini” statale
(vedi
in via P.Reti).
===Un
penultimo cancello, il più a nord porta alla “scuola civica vespertina” (sorte
come volontariato in città nella seconda metà del 1800 trovò maggiore solidità
ed organizzazione con l’interesse della duchessa di Galliera che nel 1897
destinò un congruo lascito al fine di una ristrutturazione più qualificata. In
SPd’Arena, favorite da amministratori lungimiranti come P.Chiesa, si
moltiplicarono grandemente fino ad avere centinaia di insegnanti per fornire
alle giovani elementi utili alla vita quotidiana in orario pomeridiano non
scolastico), ad un “patronato ACLI” ed alla locale “associazione nazionale
carabinieri sez. Mario Tosa. MOVC” che nel 2010 si è trasferita in locali della
Croce d’Oro. L’ultimo all’estremo
nord porta all’asilo nido comunale “le
Mongolfiere“.
STORIA:
-Dalla
carta del Vinzoni, del 1757, il
terreno faceva parte della grossa proprietà del Magistrato degli Incurabili (vedi in Abba).
-Nel 1863 il terreno era divenuto di
proprietà del sig. Badano Pietro. Per la somma di L.45mila, questi lo vendette
in quell’anno al Comune locale.
-Pocvhi
anni attorno al 1900 (1891-1908):
doveva essere solo una piana a terra battuta ed erba, che veniva genericamente
chiamata “vecchio giardino pubblico in via Vittorio Emanuele (san Martino) con
entrostante alberatura”; esisteva dentro l’area una casa comunale
d’abitazione.
La
Cooperativa di Produzione e Consumo, in un capannone eretto al limite della
proprietà, delimitava la nascente via B.Agnese e, nel dicembre 1903, godette
del diritto di prospetto sull’uso del giardino: viene descritta la erezione in quegli anni di una vera pista ciclabile (lo sport del ciclismo o meglio le
‘corse velocipedistiche’ erano ancora agli inizi ma già attiravano sempre più
folla di spettatori in un’epoca in cui non esistevano praticamente distrazioni
pubbliche ed era necessità di tutti uscire di casa per vivere insieme i giorni
festivi); qui trasferita dal Campasso
(vedi via san Fermo), e prima di essere riedificata all’altezza del civ. 47 di
via A.Cantore (vedi).
In
quello stesso anno fu dato appalto al sig. Carnevale Paolo per la costruzione
dell’edificio scolastico.
Lamponi descrive una prima gara ciclistica
avvenuta a fine secolo, nel largo prato non ancora delimitato dalla scuola
(precisa 31 maggio 1885, ma poi scrive che fu effettuata in via UmbertoI strada
che ebbe quel nome dopo la morte del re avvenuta nell’anno 1900, e promossa
dall’Universale a favore del monumento a Garibaldi che sarà innalzato nel
1905); comunque è invece importante la descrizione della festa: per la gente
finalmente qualcosa di diverso dalle solite sfide marinare: dal passo
della Lanterna un corteo sempre più
folto e festoso, con bandiere, gonfaloni, banda, sindaco con giunta, accompagnò i dieci atleti sino allo spiazzo
ove era stata aperta una pista e per tifare il
casalingo Tortarolo (poi primo professionista ligure) o il forte Giorgio
Davidson (scozzese venuto a Genova per vendere rifiniture marittime) o il
milanese Loretz (primo campione d’Italia); il pranzo era all’aperto o dalla
Gina, le selezioni diedero ragione ai più forti come Davidson e Cesare Buttalo;
il premio fu probabilmente un umile alloro.


il monumento, posto davanti alla scuola
-Anno 1905, sindaco N.Ronco. Venne
inaugurata la scuola N.Barabino, in severo
stile neoclassico, con due entrate raggiungibili ciascuna da doppia scalinata
esterna; a voce si dice che dapprima fu intitolata a P.Chiesa (più probabile a
N.Barabino, morto pochi anni prima); il giardino fu arricchito, il 30 ottobre,
col monumento al pittore N.Barabino (poi, ed ormai da
molto tempo, fu spostato nella piazza omonima): era
intervenuto personalmente il re d’Italia Vittorio Emanuele III con la regina
Elena, preceduti da una quadriglia di carabinieri a cavallo e con un seguito di
una quarantina di carrozze, dopo il benvenuto del sindaco Nino Ronco, in un’ala
di folla urlante “viva il re” arrivarono
ai giardini ove con bandiere e vessilli erano presenti tutte le associazioni e
migliaia di cittadini; la banda del Risorgimento suonò l’inno reale e fu fatto
cadere il telo che copriva la statua; visitarono la nuova scuola e si
intrattennero con alcune persone (la bimba Rina Benedetto recitò una poesia; i
membri della Croce d’Oro furono passati
in rassegna con le loro attrezzature; i ginnasti della Sampierdarenese -
col presidente prof. Sckulteky – primario
chirurgo nell’ospedale locale - fecero
alcuni esercizi).


Non esistonoancora i palazzi
civ.2 e 4 di via B.Agnese; troneggia la
torre dei Pallini
Il re
era giunto in città soprattutto per la posa della prima pietra del
prolungamento del porto ed inaugurare la stazione di Brignole.
In
quell’anno, negli uffici pubblici cittadini, si installavano i primi telefoni.
-Anno 1923 (24 maggio): Fu l’anno quello, in
cui anche a Genova, il desiderio di risuscitare l’orgoglio nazionale attraverso
il richiamo quotidiano di un simbolo, stimolò l’erezione di molti monumenti ai
caduti e di parchi della Rimembranza.
Il
primo parco fu inaugurato a Firenze nel febbraio di quell’anno; l’idea di
onorare i Caduti dedicando loro un albero fu raccolta e copiata in tutta
Italia; a Genova, essendo stati i morti in guerra più di 5mila, la maggiore
difficoltà si ebbe nel cercare un’area vasta abbastanza; i quotidiani
raccolsero l’idea di una specie di plebiscito popolare e di raccolta fondi; in
contemporanea si iniziò a progettare il più grandioso monumento ai Caduti di
piazza ora della Vittoria, allora chiamata piazza di Francia.
San Pier d’Arena era ancora comune autonomo;
prospiciente alla strada -divenuta via Milite Ignoto (via P.Reti)- venne
ufficialmente chiamato “parco della Rimembranza”, per portare onore ai
concittadini caduti in guerra; ad alcuni di essi (non si sa con quale scelta;
ancora nel dicembre dopo, in san Gaetano fu celebrato solennemente il ritorno
delle salme di sei militari parrocchiani), fu dedicato un albero (il nome e
cognome fu scritto su una piastrina di metallo da applicarsi dagli alunni delle
scuole su ogni pianta interrata durante una solenne cerimonia. Per l’occasione, l’ edificio venne imbiancato, e ribattezzato - intitolandolo “scuola Antonio Cantore”. Anche la palestra,
in quell’anno, fu riattata.


cerimonie anni 1920-30


inaugurazione bandiera del
sindacato ferrovieri. C’è scritto militi della Croce d’Oro degli anni ‘50
1929, ma se c’è ancora il
monumento, è di molto prima
Si
progettò anche per l’erezione di un monumento ai Caduti ed al generale Cantore
in particolare (già dal 1917, esponenti locali della Croce Rossa italiana (GB Botteri fra essi - vedi) avevano avanzato
l’idea di meglio onorare la figura del generale; un primo concorso del 1 febb.1923 fu
annullato perché i bozzetti non apparvero degni della scelta ; un secondo
concorso, indetto il 14 mag.1923 proponeva di base un monumento alto 9 metri :
vinse lo scultore Guglielmo Gemignani che si impegnò per 200mila lire ad
erigere nel “campo della Rimembranza” il monumento -alto 12 m, con basamento in
travertino e la parte scultorea in bronzo - da porsi in atto entro il 27
mag.1927. L’assorbimento di San Pier d’Arena nella Grande Genova, seppur il
comune fosse in attivo e quindi capace di spendere tale cifra, fu determinante
di sospensione dell’incarico, che finì nel nulla).

In attesa di realizzare il monumento, al
centro fu posto il cippo che doveva essere temporaneo e che invece si vede
ancor ora: fatto di pietra rosa tenue di Cortina d’Ampezzo (capoluogo del
“monti pallidi”) porta la scritta “a secolare ricordanza dei nostri umili eroi-
XXIV-V-MCMXXIII” (come detto, la pietra dei “monti pallidi” è di un meraviglioso ed inconfondibile rosa
marezzato, che un qualche bischero negli anni 1995 coprì di vernice bianca per
renderla – a suo ignorante avviso - più evidente: e più assurdo fu che nessuno
si promosse per eliminare lo scempio di cui si ravvedono ancora nel 2003 le
tracce.) è sormontato dall’urna bronzea
con la fiamma, opera dello scultore Lavezzari a cui era stato dato l’incarico
il 13 aprile. In un periodo politicamente incline a rivalutare enfaticamente il
grande sacrificio compiuto da moltissimi per l’unità d‘Italia fu posto in onore
dei “caduti della guerra 1915-18” e del nostro più grande concittadino il
generale Antonio Cantore: molto semplicemente vi fu inciso “a secolare
ricordanza dei nostri umili eroi XXIV-V
MCMXXIII (una targhetta affissa
da “i combattenti”, ricorda genericamente anche “i caduti della guerra
1940-1945”).
Anche il medaglione con l’effige in bronzo
del generale fu affidato allo stesso scultore Lavezzari con l’intenzione di
porlo in una nicchia nel centro della facciata della scuola (nell’enfasi, non
fu forse spiegato che il generale mai portò il berretto da alpino perché
essendo alto ufficiale dell’esercito aveva in dotazione, per uso ufficiale che
ordinario, un berretto con visiera tipo cheppì: quello che fu ovviamente perforato
dalla pallottola che lo uccise).
Le
parole ‘San Pier d’arena – al primo dei suoi caduti – Antonio Cantore –
MDCCCLVI-MCMXV-MCMXXIII’
Nell’aiuolina alla base, arredata dal
guerresco simbolo di 4 ogive, residui probabilmente della prima guerra mondiale,
giace un grosso sasso, qui portato dai
monti della Forcella dove fu colpito a morte il generale; su esso c’è scolpita
una frase
RICORDO . SACRO
. DOLOMITICO .
TINTO . VERMIGLIO .
SANGUE . CANTORE .
GRUPPO . A. N.A. .
CORTINA . D’AMPEZZO .
ALLA . SEZIONE
. DI . GENOVA .
FRATERNAMENTE . OFFRE .
15 . IV . 1931 . IX
il
tempo ha reso illeggibili queste parole, salvo – forse per strana fatalità - il nome
“Cantore”; per i politici è una fortuna
che sia scomparsa la parola “sacro”.

È stato
arduo a trovare il testo neppure all’Assoc. Reduci di via Giovanetti
sanno alcunché; ed abbiamo constatato
come apaticamente non è stata promossa nessuna ricerca sulla storia, né di
essa, né della cerimonia di inaugurazione, né delle ultime disposizioni
postbelliche.
Dietro al cippo invece, una grossa nicchia
(di grezzo cemento eretta nel secondo dopoguerra quando fu anche rifatta la
scuola poiché prima del 1945 i marmi erano appoggiati ai muri esterni) con al
centro un marmo contenente in altorilievo bronzeo il busto del generale,
circondato da sei alte stele anch’esse di
marmo con incisa la lunga sequela di nomi dei nostri soldati caduti
nelle due ultime guerre mondiali, molto ipocritamente … a memoria: in realtà
morti due volte. Diventano tre volte se si include anche il Pagano ed i vari
libri su Sampierdarena che neanche citano il complesso (del monumento, targhe a
ricordo dei Caduti delle due Grandi Guerre, e lapidi varie; non da tutti, viene
menzionata solo la cappella del cimitero).
In
fondo, sono stati degli illusi. E pertanto… non degni di memoria osannata.
Infatti sono morti, sacrificati con l’illusione di togliere un potere e così
salvare la Mamma, la Famiglia, la Patria!; e non accorgersi di farne instaurare
un altro a cui delle tre Femmine, gliene importa nulla. I governanti, una volta in poltrona,
scarsamente mirano a riformarsi a vantaggio di altri -come i cittadini stessi-,
comunque mai a fare leggi che potrebbero indebolire la loro posizione o intaccare la loro sostanza. Per questo sono
occorse orribili guerre distruttive o ribellioni altrettanto violente,
necessarie per scalzare un potere; ma ahinoi, per lasciarne instaurare uno
nuovo diverso ed in genere sempre più autocratico comunque non riformabile se
non con un’altra guerra. A spirale perversa.


---I giardini vennero allora racchiusi da alta
cancellata (ricuperata quale ferro utile, nell’imminenza della seconda guerra
mondiale come quella che racchiudeva villa Scassi sul davanti).
---Nel
1938, al limite nord dei giardini, fu approvato costruire in via Martiri
Fascisti una “Casa della madre e del bambino”; aperta sui giardini della
Rimembranza, su terreno donato dal Comune alla federazione provinciale
dell’ONMI ( opera nazionale maternità ed infanzia; il progetto, dell’ing.
Camillo Nardi Greco e dell’arch.Lorenzo Castello , prevedeva un edificio in
stile fascista, definito semplice,
razionale e senza conferire l’aspetto di un ospedale). Fu inaugurata il
28 ott.1940 (celebrativo della marcia su Roma). Nella guida del 1961 è ancora
chiamato OMNI. La palazzina, ristrutturata completamente nell’’87 dopo 5
anni di lavori , ora viene chiamato
‘asilo nido la Mongolfiera’ tutt’ora è
attiva per ospitare con attrezzature moderne i bambini delle donne che
lavorano; come tale appare vincolata e tutelata dalla Soprintendenza per i beni
architettonici della Liguria. Nei vani sul dietro vengono ospitati vari servizi
sociali; vi hanno sede anche gli ‘Amici
della montagna’: tutti però si aprono in via Battista Agnese.
Negli anni subito postbellici, la parte a
mare, spesso era occupata da un giostraio; ma già in tempi antichi sia
“Fagiolino” o “Padella” allietavano con le loro battute le serate (con seggiole a pagamento) o i giochi dei
bambini (“al vostro buon cuore”).
Fagiolino,
al secolo Giovanni Peironi, decedette all’ospedale di Bolzaneto nel marzo 1976;
nei tempi d’oro del mondo del tendone
divenne un clown famosissimo nel circo Palmieri, musicista assurdo, originale
pagliaccio, il clown capace di far ridere chicchessia. Ritiratosi dal circo,
scelse diventare Fagiolino e richiamare il pubblico nelle piazze cittadine (qui
nei giardini o vicino al Baraccone del sale
o in piazza Palmetta).
Anche Padella, al secolo Mario Bensi, lavorò da giovane nel circo Palmieri, decise
formare una sua ’arena’ personalizzata dedicando la sua vita a fare il clown
per quello definito “ teatro per i poveri”: per tutto il periodo bellico e
dopo, riuscì a far ridere i bambini e sorridere o distrarre chi era rimasto in
città, prima che la TV non costringesse la cittadinanza al ‘tutti comodamente a
casa’. Portava la paglietta con nastro tricolore e tutti i vari discorsi (tra i
quali viene rammentata la storia e prodezze della sua cavallina, finivano con
una solenne “gnaera”. La sua bonaria
semplicità, lo rese figura caratteristica cittadina. Morì sessantenne, dopo
lunga malattia, nel 1972”
---Nei
primi anni 60, le vecchie scuole in pesante stile neoclassico furono abbattute
perché insicure -seppur non direttamente danneggiate dai bombardamenti-;
molti alberi sostituiti (da tutti lecci, i più divennero platani); il
monumento “arricchito” da stele marmoree con i nomi dei soldati caduti
nell’ultimo conflitto ( dall’etica
antica del “pulcrum est mori pro patria”
, si passò -fino alla seconda guerra mondiale- ad un reverenziale rispetto per
chi diede la vita per l’Italia : e fino ad allora queste stele avevano per i
giovani una logica di ammirazione e di monito ; da dopo gli anni settanta,
abbandonata quella che si chiamava
‘educazione civica’ ovvero del rispetto altrui e delle cose comunitarie,
lasciando le nuove leve al libero arbitrio rappresentato soprattutto dal
concesso soddisfacimento di ogni personale interesse fino al prevalente egoismo
, menefreghismo, ed insensibilità , si è reso questi elenchi
di morti neanche fastidiosi -sarebbe sempre una reazione- ma solo delle fredde
ed inutili pietre : i valori dei
sacrifici si sono spostati altrove . Qualcuno -probabilmente vecchio e ormai citrullo- per cercare di rinverdirne il
lustro, alcuni anni fa coprì stoltamente la pietra del monumento e del sasso
con vernice bianca, occultando il rosa pallido e delicato della roccia
naturale, segno che anche chi ha ancora rispetto di queste cose, non capisce più niente); le aiuole rifatte in forma diversa
e- a parte quelle centrali arredate con arbusti sempreverde- genericamente poco
curate, viali asfaltati. Nel 1964 fu inaugurato il nuovo edificio, nel quale è
ospitato nella parte a nord anche il liceo classicoG.Mazzini qui spostato dalla
villa Serra-Masnata di via Cantore.
---I
giardini furono dedicati dalla Giunta Comunale all’atleta Pavanello con
delibera del maggio 1993, essendo stato
proposto alcuni anni prima, al compimento dei 100 anni della società
Sampierdarenese.
---Nel
1994, onde limitare lo smog da scarichi di marmitte e l’inquinamento acustico
specie dalla vicina via P.Reti, fu racchiuso ai tre lati da una apposita
barriera metallo-plastificata, che tuttora resiste anche alle scritte, con
discreto risultato.
---Nell’anno 2000 si procedette all’ultimo ed
innovativo ‘restyling’ dei giardini eseguendo un completo ridisegno strutturale
per una spesa di 900milioni circa (arch. Stefano Ortale; appaltatrice la soc.
EsoStrade). Tagliando circa una ventina – dei 35 esistenti - di grossi alberi
di platano, si è dato spazio ad una pista ciclabile ed una di pattinaggio
lievemente sopraelevate con aiuola attorno; sono state messe a terra numerose
piantine di sempreverde e promessi qualche alto fusto come una canfora ed altri
lecci; e nel lato a mare sono stati installati dei servizi igienici chiusi
autopulenti, nel lato a monte castellature di giochi per bambini con
pavimentazione di gomma ad assorbimento d’urto.


quattro
fotografie dell’anno 2000


Fu inaugurato il 5 giugno 2001.

 2001
2001
Nel 2006 una impresa ha progettato la possibilità
di costruire interrati dei box per auto. Il progetto, seppur bocciato dal
CdCircoscrizione, viene riproposto nel 2007 e ribocciato.



anno
2000 e 2006
Attualmente è uno dei pochi giardini aperti
anche di notte e quindi genericamente “abbandonati” all’educazione dei singoli
(ahinoi!); rimane posto ideale per i
bambini che escono sciamando in sicurezza da scuola, per i giovani che si
ritrovano tra loro, e per portare a spasso i cani (paletta e sacchetto
obbligatori, anche se il cartello intima che i cani vanno portati al guinzaglio
e con museruola se mordaci; a parte qualche fatto sporadico ed individuale
mugugno “sembrano una discarica” ...le cartacce delle merendine non le buttano
i cani..., si può dire che la
cittadinanza è soddisfatta. Nel 2002 si segnalarono frequentazioni notturne
pericolose, sporcizia, siringhe e bottiglie vuote.. ed ovviamente non si
propone affrontare il problema –non facile d’accordo- ma solo chiudere, come
salita GB Millelire). Il monumenmto è affiato alla cura della Associazione
Nazionale Alpini di via Giovanetti
Nell’estate 2009 avviene la decisione di chiuderli, alla
sera.

DEDICATA
all’atleta della società ginnastica Sampierdarenese, che partecipò alla prima
olimpiade -nel 1900 a Parigi- unico italiano: allora la ginnastica comprendeva
oltre gli esercizi artistici, anche l’equilibrismo e l’acrobatismo.
Nato a
Terni il 20 ott.1879 ove ad 11 anni era già iscritto ad una palestra, venne nel
1899 a San Pier d’Arena in via Rayper al 14.11b, per entrare come operaio
meccanico alle acciaierie Ansaldo di Cornigliano.
Nel
tempo libero, iscrittosi alla palestra, (che in quegli anni era ospitata -chi
dice in stanze della scuola elementare in piazza san Martino , usando il
piazzale antistante per gli esercizi...all’aperto; chi in via Manin e successivamente in via
della Cella , in un grande locale, forse
una stalla, attiguo alla sede della Croce d’Oro); divenne rapidamente così bravo, tanto da
essere candidato da Enrico DeAmicis, presidente della società, al concorso
internazionale di ginnastica artistica che si sarebbe svolto a Parigi dal 29
lug.1900; (a tutti gli altri componenti della squadra venne ritirata dalla
Federazione Nazionale l’iscrizione prima della partenza, perché il programma
appariva troppo difficile e mirato a mettere in inferiorità i ginnasti
nostrani) per cui per caparbietà ed a proprie spese della Sampierdarenese, fu l’unico a raggiungere il terreno di gara
davanti alla giuria internazionale (composta da 30 membri francesi, 18
stranieri di cui nessuno italiano). Vinsero i primi 27 posti, tutti atleti
francesi; lui -che su sei diversi esercizi (liberi ed obbligatori ai 4 grandi
attrezzi: cavallo-anelli-barra-parallele, nonché corpo libero, salto in alto ed
in lungo, salto in lungo del cavallo, salita alla fune, sollevamento di pesi:
una pietra di 50 kg. da terra in alto per 10 volte) era arrivato primo in
quello a corpo libero ma era caduto in quello delle parallele -la motivazione
fu data alla sbarra, bagnata e resa scivolosa dalla pioggia- si classificò 28°,
primo di tutti gli stranieri. Ricevette una corona di alloro, una medaglia
d’oro, una targhetta di platino e due ceramiche di Sèvres per la società (che
tutt’ora possiede).

La
delusione arrivò al ritorno in patria, ufficialmente in lutto nazionale per la
morte di re Umberto I; ma l’evento ginnico venne onorato dai colleghi locali e
di Cornigliano, con una cena alla
trattoria della Gina del Campasso; ma soprattutto perché la Federazione rifiutò
di giudicare quella gara come l’Olimpiade; solo 50 anni dopo, dopo tanta ed
amara indifferenza dei responsabili, il Comitato Internazionale Olimpico nella
persona del segretario generale Otto Mayer, confermò che il concorso parigino
era parte integrante della seconda Olimpiade moderna (la prima era stata tenuta
ad Atene nel 1896, per iniziativa del famoso barone DeCoubertin): così anche il
CONI nello stesso anno confermò all’atleta il titolo di olimpionico d’Italia
(col numero 306 e non uno come sarebbe stato di diritto). Dopo il successo
parigino, proseguì l’attività agonistica, diventando poi direttore tecnico
della sua società negli anni di massimo splendore con le olimpiadi di Anversa
del 1920. Fu poi anche giudice di gara e giurato nazionale.
Morì
nel 1956.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica ,
scheda 3343/a
-Autore
sconosciuto-Dattiloscritto chiesa s.Gaetano&Bosco-vol.I-pag.206
-AA.VV.-SpdA nella sua amministr.
fascista-Reale.1926-p.15modelli monumento
-Gazzettino
Sampierdarenese : 2/72.2 + 4/76.9 + 5/78.19 + 3/80.3 + 9/85.11+ 4/86.8 + 6/87.11 + 5/89.8 + 8/91.7foto +
7/94.7 + 8/94.14 + 07/02.9 + 07/03.6 + 09/03.8 +
-Genova
Rivista del Comune: 4/23.365 +9/32.901foto +11/38.80 +11/40.95
-Il
Secolo XIX 24.07.09 p.25 +
-Lamponi
M.- Sampierdarena- Libro più.2002- pag.153
-Novella
P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio 1930circa-(pg.8.14.20)
-Parpodi-1891-1991
cento anni di storia SGC Sampierdarenese. 10.17 +
-Pagano/1950-
pag.36; /1961-pag.560.575.577
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio. 1995-tav.21
-Secolo
XIX: 19.01.99 +23.6.00 +5.7.00 +6.6.01 +10.05.02pag. 29 +14.3.03
-Tuvo T.-Sampierdaena come
eravamo-Mondani.1983-pag. 67foto
-Tuvo.Campagnol-Storia
di S.P.d’A-D’Amore.75-p. 37.290foto di Pavanello. 293 non citato EMotta;
Esonzogno; Oltre un secolo di Li.SecoloXIX;
PEDEMONTE via Giacomo
Pedemonte
TARGHE
San Pier d’Arena – via – Giacomo Pedemonte – musicista-compositore –
1894-1963

 via L.Dottesio
via L.Dottesio

 angolo via A.Cantore
angolo via A.Cantore
QUARTIERE ANTICO: Coscia
 da
MVinzoni, 1757. In giallo, via LDottesio (via Demarini); celeste, via
GBCarpaneto (via Fossato sBartolomeo), verde, a levante villa GB.Negrone; a
ponente proprietà Nicolò Pallavicini con, in rosso, villa.
da
MVinzoni, 1757. In giallo, via LDottesio (via Demarini); celeste, via
GBCarpaneto (via Fossato sBartolomeo), verde, a levante villa GB.Negrone; a
ponente proprietà Nicolò Pallavicini con, in rosso, villa.
N° IMMATRICOLAZIONE: posteriore
 da
Pagano 1967-8. L’area ancora occupata dall’oleificio
da
Pagano 1967-8. L’area ancora occupata dall’oleificio
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 46430
UNITÀ URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO
 da
Google earth, 2007. In giallo via di francia; fucsia via LDottesio
da
Google earth, 2007. In giallo via di francia; fucsia via LDottesio
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie
STRUTTURA: senso
unico viario in discesa, all’opposto della progressione dei civici che va da
via L.Dottesio a via A.Cantore.
Nel
SecoloXIX di nov.03 ed ago.04 si legge che la strada è inclusa nell’elenco
delle ‘vie private ad interesse pubblico’ e quindi programmate a divenire municipalizzate
con acquisto gratuito in cambio di manutenzione ed inserimento nei servizi
comunali (illuminazione, cassonetti spazzatura, fognature, asfalto, ecc.).


da monte a mare da mare a monte
CIVICI non ci
sono rossi
2007=
NERI = da 1→7 e da 2→32 (compreso 24C)

Modello in compensato degli
alunni delle scuole medie.
===al civ.
3, la villa Negrone - Moro.
L’elenco
dei palazzi vincolati e protetti dalle Belle Arti (oggi ‘Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio della Liguria’) fa leggere la tutela dal 1964 al civ. 1 di
via Dottesio (civ.3 di v.Pedemonte), chiamato “Palazzo ex Piccardo Rovereto”. In effetti
in questa costruzione (alla fine del 1800, al civ. 25 di allora quando quel tratto di strada era
ancora via DeMarini (vedi)) abitarono: la sig.ra Piccardo ved. Rovereto (e
dovrebbe corrispondere a questa villa, se in contemporanea ai civv 26-27
seguenti, abitava il marchese Pallavicini); poi, nel 1908, l’industriale Moro
Tomaso e Figli. (invece, sempre a fine 1800 un altro ‘cav. Piccardo Giovanni’ (forse fratello della precedente) abitava ai
civv. dal 28-29 di via DeMarini: qui era il cancello che tramite un viale
faceva arrivare alla villa che era più in
alto, in zona Montegalletto, ove ora è la ‘torre’ detta dell’ospedale).
Non si
conoscono data di costruzione né
committente, né architetto progettatore; posta sull’asse principale stradale,
dalla struttura cubica e dalla loggia angolare si può arguire un’origine della
metà del cinquecento, in epoca para-pre alessiana. Dall’antica
planimetria vinzoniana del 1757, allora, apparteneva a Gio Batta Negroni.
Il
palazzo aveva due ingressi, e fu considerato principale quello aperto sul retro
rispetto la strada principale (oggi in via G.Pedemonte); -come per villa Scassi- si presume sia
effetto di una ristrutturazione posteriore della porta che dava adito ai
giardini; comunque in seguito a questa decisione il portone, recante il civ. 1
di via Dottesio, venne chiuso addirittura murando la porta ed il civico fu soppresso nel 1973.
A
ponente della facciata a mare si nota un
ampio corpo basso, a terrazzo, (che ospitava la cappella gentilizia come si
deduce dalla cartina settecentesca del Vinzoni)
che la collegava con la seguente
affiancata villa dei Pallavicino poi Moro (oggi il terrazzo, e quest’ultima
villa sono stati demoliti lasciando di essa solo la facciata col portone:
aprendosi in via Dottesio è descritta a quella via). Il giardino, in origine stretto,
irregolare e di scarsa estensione, era orientato verso nord-est alla collina
(ed il suo lato a levante, costeggiava
la salita san Bartolomeo allora non ancora “del Fossato” ed oggi via
Carpaneto); oggi se ne conserva una piccola parte, rappresentata dalla piazzetta sita davanti all’ingresso nord,
divenuto il principale: ripristinato assieme alla villa, è caratterizzato dalla presenza di un
saggiamente ben conservato
Comprendeva
nella parte finale in alto una torre, anch’essa cinquecentesca, con aspetto
caratteristico ottagonale e con eleganti archetti pensili su peducci e aperture
centinate; oggi inglobata in edifici ottocenteschi in via GB Carpaneto. ciottolato
a mosaico bianco e nero alla genovese.
La
facciata a mare, dalle ampie finestre appare tripartita ( 3 al centro con
terrazzo e due ai lati, caratteristica
distribuzione dettata poi come
imperativa dall’Alessi).



All’interno,
il piano terra è caratterizzato da due atri centrali contigui, relativi ai due
ingressi (sulla strada e sul giardino); al piano superiore nobile, la scala
-con piani in ardesia- sfocia in una loggia nell’angolo sud est visibile
dall’esterno di via Carpaneto per i grandi fornici separati da una colonna
ionica centrale e per il balcone sorretto da plastici mensoloni cinquecenteschi
che nell’insieme creano un piacevole aspetto della facciata; il salone, posto a
monte e contornato dalle sale più piccole, non ha più alcuna decorazione
dipinta. I pavimenti sono ad ottagoni di
ardesia mentre appaiono di grossi riquadri in marmo quelli dei
pianerottoli.



oleificio Moro con torre ottagonale
piazzetta anni 1970
Nella
seconda metà dell’ottocento, la villa subì il declassamento ad uso industriale,
essendo stata acquisita dall’oleificio Moro che nei terreni retrostanti costruì la grossa
fabbrica e raffineria.
Il
palazzo, riacquistato in tempi più recenti dalla società
di Navigazione C.I.M.A.srl, fu ripristinato ad uso uffici, senza che
fossero alterati i caratteri architettonici e decorativi: nell’insieme, ha
molte affinità architettoniche con la villa vicina Pallavicino-Gardino.
Negli
anni 90(?) fu occupata dalla EdiSoftware,
società a responsabilità limitata, gestita da tre ingegneri (Marco Abergo,
Enrico Pedemonte, Massimo Ferrari)
STORIA: Siamo ancora dentro il quartiere della
Coscia. Prima che lo stabilimento Moro Tommaso e figli - che si apriva in via
Bottego al civ.1 - di raffineria e produzione (inscatolamento in recipienti di
latta lavorata e litografata) di olio d’oliva, olio di semi, e sapone occupasse
tutto il terreno che oggi ospita questa strada, c’erano orti coltivati a vigna,
frutteti ed ortaggi.
Solo
con la demolizione dello stabilimento e successiva bonifica del terreno, fu
aperta dopo il 1970 questa nuova strada che praticamente passa in
corrispondenza dell’interno dell’ex stabilimento.
Il 12
marzo 1973 una delibera comunale stabilì il nome attuale; una parte di civici
rossi passarono da via A.Cantore alla nuova via e da allora i numeri civici
sono in successione continua senza distinzione del colore; nel ’74 furono
assegnati a nuova costruzione il civ. 16 ed
il 1-3-5.
DEDICATA al
musicista nato a Pontedecimo il 12 nov.1894, e morto a Genova il 7 genn.1963.
Essendo
stato già indirizzato dal padre Giovanni – organista nella chiesa parrocchiale
di san Giacomo - alle nozioni musicali da quando aveva sei anni, dopo aver
finito degli studi tecnici decise di iscriversi al liceo musicale N.Paganini,
ove si diplomò nel 1913. Si trasferì a Milano, per perfezionarsi al
conservatorio G.Verdi.
Tornato a Genova, occupò
l’incarico di organista nella chiesa di sant’Ambrogio; di professore della
cattedra di organo allo stesso liceo Paganini; e - dal 1936, anno in cui fu
approntato l’organo nella Cattedrale – collaudatore, concertista ed organista
contitolare.
Compose numerose opere musicali
per cori religiosi e non, per orchestre e soprattutto per organo; vengono
ricordati nel dic.51 concerto nella sala
del Maggior Consiglio del palazzo Ducale e,
postumo nel 1964 un polifonico vocale all’auditorium della Fiera del
Mare.

BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica , scheda 3355
-AA.VV.-Annuario,
guida archidiocesi-ed.1994-pag.428; ed.2002-pag.465
-AA.VV.-Catalogo
delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag.147
-AA.VV.-Le
ville del genovesato-Valenti.1984-vol.IV-pag.23
-Frassoni
E.-2 secoli di lirica a Ge.-CARIGE- vol.II-pag.481
-Il
Secolo XIX : del 25.11.03 + 23.08.04
-Internet-
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.28
-Pagano
–Annuario genovese- ed.1961.pag.1566
-PastorinoVigliero-Dizionario
delle strade di Ge,-Tolozzi.1985-pag.1413
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio 1995-tav.51
non
citato da
Enc.Sonzogno
Enc.
Motta
AAVV-oltre
un secolo di Li
Arte
organaria in Liguria
Giazotto-la
musica a Genova
PELLEGRINI via Antonio
Pellegrini
TARGA: via – Antonio Pellegrini


angolo con via del Campasso
QUARTIERE ANTICO: Campasso
 da
MVinzoni, 1757. In celeste via Vicenza-Campasso; in verde ipotetico tracciato
di via APellegrini nei terreni Cicala.
da
MVinzoni, 1757. In celeste via Vicenza-Campasso; in verde ipotetico tracciato
di via APellegrini nei terreni Cicala.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2823. CATEGORIA: 2
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 46540
UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO


da Pagano 1961
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: Sacro Cuore di Gesù
STORIA: Compare già così titolata nel 1926 all’atto
della unificazione del comune di SPd’Arena con quello genovese, e classificata
di 4a categoria. In quel tempo omonima dedica esisteva per una strada di
Cornigliano, che fu obbligata a cambiare.
Il
Pagano 1919 colloca al civ.2 l’unico veterinario cittadino, dr. Briccola Luigi
attivo ancora nel Pagano/25.
STRUTTURA: rettilineo di circa trecento metri, praticamente diviso in due tronchi: il primo,
è senso unico viario -dall’altezza della chiesa e via Campasso, sino a metà
percorso- quando si innesta da ponente via S.Spaventa nella quale il maggior
traffico stradale prosegue - sempre come senso unico. Il secondo tronco,
continua il òprecedente verso monte, è chiuso in fondo ed è doppio senso viario.
La
ripida pendice della collina di Belvedere tagliata orizzontalmente
dall’autostrada, fa da sfondo verde ed un po’ selvaggio al paesaggio.


A lato nord della chiesa, in una iniziale vasca -collettrice (studiata dal geom.
Lastrico del Comune) posta alla confluenza del rio Belvedere con il rio detto Pellegrini-, inizia un torrentello anonimo, che corre lo stesso
itinerario naturale interrato sotto la strada
di via Campasso; attraversa via Fillak e percorrendo via Chiusone (vedi), sfocia nel Polcevera.
Attualmente in parte si unisce alla tubatura delle acque bianche della zona,
così inviate al torrente tramite il collettore di via Capello e via Porro. Spesso i due rivi, nelle giornate piovose, entrano in
piena; e prima -quando esisteva solo una
iniziale camera sotterranea, troppo spesso si intasava di detriti determinando
lo straripamento ed arrivando ad allagare l’intera zona, favorita dall’’effetto
imbuto’ della obsoleta tubatura finale di via Chiusone maggiormente ristretta;
in questo vano, dopo l’8 settembre vi si rifugiarono 13 ex militari che
cercavano sfuggire ai tedeschi e fascisti.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.
Nello stesso spiazzo a lato della chiesa, vi
sono quattro cancelli: uno, il più a
ponente, chiuso ed arrugginito, aggiustato nell’anno 2001, si apriva nel vico
del Diavolo (vedi) che portava ad una villa signorile, detta “o cason”, distrutta per la
costruzione del ponte autostradale, e che all’interno era decorata con dipinti
sui soffitti. A fianco, il secondo
cancello apre ad un viottolo di recente fattura, che salendo lungo il
fianco del colle - forma dei giardinetti (e pertanto vengono chiusi da un
vigile urbano alla sera); arriva sino a Belvedere 2, alle case di via Baden
Powell.
Terzo, è quello della villa Torre. Il quarto, a mare della casa , è il civico 1A



in basso, i primi tre cancelli il percorso che sale verso via Baden P. civ. 1A
CIVICI neri= da 1 a 19 (compresi 1ab, 3a, 9a, 11a); e da 2
a 8 (escluso 4)
rossi= da 1r a 17r e da 6r a 12r (compreso 6abe, ed 8b)
Nel
Pagano/40 la strada andava ‘da via S.Spaventa a v. Campasso ai monti” sono
citati solo i civv. rossi: 3n Macelleria; 5n latter.fruttiv; 7n Asilo
infantile del Campasso; 11 calzol.; 13n coop C Rota vend. n.13; 13 Dopolavoro
«Pietro Avellini».
 civ. 1
civ. 1
==== civ. 1: Il terzo cancello, dà adito
alla antichissima “villa dei Torre”, col
termine villa inteso come casa di campagna; ancora nel 2003 abitata dalla fantastica
Eleonora
Torre (da giovane fu partigiana, chiamata ‘Ivonne’ delle
SAP cittadine, ed ora semplicemente ma con fermezza ‘la Nora del Campasso’
perché decisa ed agguerrita nella difesa del rione e degli interessi dei più
deboli. Il padre, fu ucciso dai fascisti in maniera subdola e col
giustizialismo tipico degli impuniti di allora. Personaggio caratteristico
della zona appunto per il carattere ‘dolcemente impetuoso’ che la portava a
contatto con i dirigenti sociali –specie politici- presso i quali difendeva gli
interessi degli abitanti in genere e delle persone che si erano rivolte a lei
in particolare).


villa
Torre dalla piazzetta d’ingresso la fossa di raccolta dei due torrenti
La casa
è intesa come ‘villa alla genovese’, ovvero casa di coloni-pastori-contadini;
viene descritta vecchia di oltre 3-400 anni, e forse anche di più. Alle spalle ha due o tre fasce coltivate ad
orto; poi il pendio sale piuttosto rapidamente verso Belvedere concedendo
piccole fasce in alto (una con pollaio).
Il
terreno è tagliato da un torrentello: esso passa di fianco ed a mare
della casa –laddove è profondo circa un metro e più, scavalcato da un
ponticello ‘artigianale’, il cui alveo
in certi casi di piogge pesanti è insufficiente e lo faceva straripare
allagando anche la piazzetta davanti alla chiesa ed oltre-.


il torrentello, che ancora
‘tiene’
2ª / Zona Mil / M . 500
Anche
sul muro di questa casa, come altre disseminate nella città (una vicina, è
anche in via del Campasso) è una targhetta della “Zona Militare m. 500”
relativa alla distanza dal forte e quindi – forse - limite demaniale.
===civ 1A
appare di recente costruzione
===1r, assieme al 3r, posti nell’angolo da
cui inizia la strada, porta sullo stipite l’incisione “macelleria” e “spaccio
municipale” relativi all’uso di case popolari con relativi servizi. Forse fu
qui che lavorò nel periodo attorno alla guerra del ‘45 il macellaio Borghi del Campasso (un grosso e pesante
omone, attivo atleticamente nelle gare
di ciclismo ma con la caratteristica di cercare di arrivare ultimo, e vincere
così più numerosi premi di consolazione; come poi, più famoso perché in gare di
più alto livello, il famoso Malabrocca).



civ. 1r-3r-5r-
===civ 2:
l’ex macello civico.


anno 1920 circa
Borghi
Su
questo terreno, nel primo 1800 si
ergeva uno stabilimento che produceva glucosio (vedi via del Glucosio- dava nome omonimo alla strada che da li, arrivava al via Umberto I
(attuale via W.Fillak); strada che fu annullata, sepolta sotto il terrapieno
della ferrovia; un passaggio a voltino viene segnalato essere esistito sino
alla fine del 1900, ma in via Campasso, 200metri più a nord della strada ).
Nel 1901-2,
in occasione di un riscontro di alcuni casi di vaiolo in cittadini immigrati
dal napoletano, e nel dubbio di una epidemia, si pensò aprirvi un lazzaretto affinché fosse un po’ meglio isolato ma
anche attrezzato, rispetto un altro provvisorio aperto a Promontorio e
dimostratosi inefficiente.
Fu nel 1907
che la civica amministrazione deliberò aprire
un edificio adibito a macello civico unico per la città di San Pier
d’Arena. Prima di allora non è chiaro come avvenissero le macellazioni-
alimentando le varie interpretazioni relative alla ‘crosa dei buoi’: se alla
marina c’era già un qualcosa di attrezzato, o avvenissero autonomamente a
livello di singolo macellaio, come si può pensare in tutto l’800 quando gli
abitanti del borgo erano appena qualche migliaio; il problema nacque evidentemente con la moltiplicazione esponenziale dei residenti-.


anno 1980
anno 2000
Una assai anziana signora, nel 1998
ricordava nel posto un laghetto e vicino una
casa tipo colonico con orti.
All’inizio l’edificio fu chiamato in gergo popolare
“ammazzatoio” e come tale compare nel Pagano/1921 telefono 41008 (nel Pagano/20 non c’è; nel P/1925 c’è la
fabbr. ghiaccio chiamata S.A.I.F. Soc.An.Industrie Frigorigene); in forma
ufficiale fu titolato ‘Macello civico’
(e così fu scritto ai lati di un grosso stemma cittadino sampierdarenese, con
grosse lettere sopra il portone centrale dell’edificio a due piani, e con
architettura di stile tipico classicheggiante di primo 900). La costruzione, aveva annessa una ciminiera,
perché autorizzata a bruciare le carogne di bestie non sane, specie di muli e
cavalli usati allora come normale mezzo di traino cittadino.
Dal 1 genn.1923 il mattatoio fu in gestione alla soc.an. Industrie
Frigorifere, società privata con una convenzione stipulata dal comune
locale (era previsto nel contratto una gestione per 25 anni); nel 1933 il comune di Genova disdisse il
contratto perché ritenne lesivo ai
propri interessi che un privato gestisse uno stabilimento di proprietà civica,
in concorrenza con quelli propri e gestiti direttamente, ed in più percependo
delle somme per questa attività.



cinque foto dell’anno 2007


Negli stessi anni, tutta questa attività
venne spostata e concentrata in unico stabilimento in val Bisagno, cosicché
l’edificio sampierdarenese fu trasformato in deposito per i servizi funebri
comunali (carri e cavalli).
Dopo la guerra. lo stemma fu poi distrutto
(forse era accompagnato da simboli fascisti), e fu mutato con un altro più piccolo
di Genova assieme alla scritta ‘mercato uova e pollame’. Infatti l’edificio,
rammodernato con una spesa di oltre 32milioni, fu destinato al ‘nuovo mercato
all’ingrosso delle uova e pollame’: fu inaugurato il 20 febbraio 1955 dal sindaco Pertusio e giunta con
assessori; comprendeva 23 posti auto per i commercianti, una sala per
contrattazioni uso borsa merci, locali per il veterinario, per la direzione,
per lo scannatoio del pollame, per la cottura del mangime, un ufficio dazio, la
banca BNL e vari box di 65mq per i venditori . Era previsto anche un raccordo
con la linea ferroviaria vicina, costruendo una rampa di accesso verso il
parco, programmato quale allora il maggiore e più attrezzato mercato specifico
in Italia. Come ‘ex Mercato ovoavicolo
del Campasso’, l’edificio è tutelato e vincolato dalla Soprintendenza per i
beni architettonici della Liguria.
L’attività
e licenza relativa al pollame, era stata dapprima gestita dall’Annona comunale,
poi passato in gestione a privati. Nel
1982
una petizione del ‘Comitato ambiente del Campasso’, preoccupato per i
rumori dovuti al carico e scarico merci nelle ore notturne, e per gli odori cattivi, determinò un ordine
del giorno del Consiglio comunale che sfrattava le strutture invitandole a
sgomberare i locali al più presto, e prospettando una destinazione delle
strutture a uso sociale (parcheggio o casa protetta per anziani; o cedere a
privati. Venne escluso la destinazione a posteggio dei nomadi). Da allora
comunque, appare chiuso ed inutilizzato.
 foto 2011
foto 2011

interno, visto dalla saracinesca
d’entrata. Foto 2011
===civ. 3a:
chiesa
cattolica parrocchiale , dedicata al “sacro Cuore di Gesù al Campasso”:
nel marzo 1930-XV, un regio decreto autorizza la Chiesa parrocchiale di Certosa
di acquistare il terreno, per quello scopo. Il 4 dic.1939 il card. Boetto
Pietro , arcivescovo di Genova, emise un decreto di costruzione di una Vicaria
autonoma nella località del Campasso, resasi necessaria per la cura spirituale
di un centro che -già allora- superava i tremila abitanti, abbastanza lontani
da una propria chiesa parrocchiale. Quindi, la erigenda chiesa, allora aveva già il terreno
necessario (una parte del demanio; un’altra più piccola parte comprata dalla
famiglia Marchese che lo teneva a prato; ed una terza parte già di proprietà
della curia ricevuta in lascito. La Curia ed i Marchese, si scambiarono
reciprocamente in accomodato un tratto di terreno, concedendo l’uno dove ora è
il campanile e ricevendo dove ora è il cancello per proprietà privata).


Nell’attesa, fu aperta una Vicaria autonoma
e provvisoria (decreto arciv. Del 4 dic. 1939 con vigore dopo 17 dic.) ma
decorosa cappella da iniziare il culto dove è il civ. 7 al piano terra, e
provvista degli arredi necessari, compreso un conveniente appartamento per
l’abitazione del sacerdote.
Il tutto rimase però inattivo, sino al 31
mag.1940 (giorno festivo del Sacro Cuore di Gesù), quando l’Arcivescovo riprese
il decreto e lo firmò l’8 giu.1940 (due giorni dopo, alle ore 18, Mussolini
dichiarò guerra alla Francia ed alla Gran Bretagna) dopo aver constatato che
presso la Curia esisteva un deposito di lire capace di provvedere alla dote del
nuovo beneficio parrocchiale .
Si aggiunse che il decreto sarebbe entrato
in vigore il 16 giugno, sancendo così per quel giorno, l’erezione della nuova parrocchia e
prevostura, denominata Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Campasso, con un
nucleo di assistibili di 1600 abianti. Fu tolto allo scopo una parte di territorio alla parrocchia di
san Gaetano ed una parte alla parrocchia della Certosa di Rivarolo. Fu dato
l’incarico a don Bartolomeo Tubino (poi trasferito a Certosa), seguito da don
Natale Traversa (bolzanetese di nascita
-8.8.1914-, divenne sacerdotge nel 1938 e fu inviato come cappellano militare a
seguito del corpo di spedizione di truppe alpine in Russia, ove nel 1941 meritò
un medaglia d’argento ed una Croce di Guerra, al VM. ed il grado di tenente. Al rientro in patria, scrisse un libro di questa drammatica
esperienza, titolato ‘Croce sul petto’; e divenne prima parroco nella natia
Bolzaneto (dove –aiutando i partigiani- fu individuato dalle forze nazifasciste
e costretto alla latitanza-) e poi prevosto al S.Cuore del Campasso quando la
chiesa era ancora da costruire; rimase sino al 1955 quando passò a Voltri. Morì
nel 1999).
Da
allora, il parroco dovette ricorrere a
varie sedi provvisorie nei dintorni, compreso l’uso dei locali ove ora è
l’asilo in via Pellegrini 7pt (e qui la
segnala il Pagano /1961); e dove poi si
aprì un negozio di piastrelle al 17r (la
ditta Edilcentro di Carcare).
La prima pietra fu posta nel 1950. La chiesa
fu eretta in un anno su disegni dell’ing. Senise, dall’impresa Sfondrini. Fu
consacrata il 17 marzo 1951 alla presenza di mons. Siri , allora arcivescovo di
Genova, lo stesso che pochi mesi dopo (17 giugno) benedisse il nuovo altare
maggiore.
E’ ad una sola navata, delle dimensioni di
m.12x8 (Lamponi dice 12x18+4 di abside); con un solo altare principale. Tipico
il campanile, eretto ad L e con le campane poste in finestrelle.
Possiede un marmoreo bassorilievo posto
sopra il portale; una tela del sampierdarenese Traverso dedicata al sacro Cuore
di Gesù, ed una statua lignea della Madonna della Guardia, scolpita ad Ortisei. Pregevole anche il battistero. La parrocchia è la più piccola (1380 anime)
delle nove del Vicariato sampierdarenese; il prevosto attuale, dal 1979, è don Antonio Pietro Picollo (incaricato dalla Curia arcivescovile dell’ Ufficio per la disciplina
dei Sacramenti -matrimoni-. Nel 2007 nominato monsignore).
===5r
è il negozio che pospetta a nord dentro la lunga
aia dei 5 civici sudescritti. Sullo stipite ha inciso “consorzio agrario”.
Naturalmente oggi non è più adibito a questa funzione anzi, come i civici rossi
precedenti appare chiuso da molti anni.
=== civv. 3-5-7-9-11. L’ing. Adriano Cuneo studiò i
progetti di utilizzo delle aree, dando inizio nel 1921 alla costruzione del
grande edificio, posto a monte dei
macelli; l’impresa edile fu il Consorzio
Ligure delle Cooperative (che poi nel 1930 si fuse per formare lo IACP - oggi
si chiama ARTE: il presidente ing.Sirtori dovette in quegli anni affrontare la
grave crisi degli alloggi, legata all’accrescimento abnorme della popolazione,
in seguito all’immigrazione straordinaria dovuta allo sviluppo industriale:
alla sua fondazione, il Comune cedette all’Ente una casa già costruita in via
Pellegrini ed un’altra in via Spaventa, nonché 500mila lire ed alcuni lotti di
terreno per 53mila mq , già edificabili da molto tempo ma non messi in atto per
difficoltà economiche). Il grosso complesso in cemento armato, copre un’area di
1150 mq., con 6 scale, a sette piani, 107 alloggi (per 414 vani).
 civ. 7
civ. 7
===civ.6,
progettato nel ‘38 dall’ing. Braccialini, realizzato nel ‘40, eretto in
muratura dall’impresa SAF.Liberti, copre un’area di 647 mq, ha due scale, un
cortile, 6 piani, 47 appartamenti. (132 vani). Fu inizialmente utilizzato per
accasare degli emigrati francesi, dei quali ancor nel 2001 rimangono alcuni
degli eredi.
===civ. 7
Durante la guerra, nelle cantine ospitarono un rifugio rinforzato. Nel 2007 (ma
da oltre un decennio), al piano terra (int.1 e 2) si trova l’ asilo materno
comunale, chiamato “scuola dell’infanzia G.Govi” del Campasso. Ebbe
inizio dal 1922 un servizio per l’infanzia -dapprima nei fondi del civ. 3
(sotto il negozio con la scritta ‘macellaio’), poi al 13-. Il calo demografico
già nel 1998 minacciò la chiusura (come avvenuto per la scuola elementare). Nel
giardino, un ciliegio -forse selvatico- fiorisce a primavera con intenso colore
rosato meraviglioso.


===civ. 8
fu edificato nuovo nel 1959
===civ.9 e 11 furono riparati nel 1945.
===civ. 7r: anteguerra, vi aveva sede uno dei vari spacci della cooperativa di consumo C.Rota
(nel 1933 erano in via A.Doria 37r e
79r, corso D.Alighieri, 42r, v.GB.Monti 14r, via DeMarini 1, e via UmbertoI al
147r).
Tra
questo civico ed il 9r c’è la colonnina
funzionante di una fontanella, ancora antica
con la pigna in vetta. Raccoglie acqua potabile dalle falde soprastanti che già
anticamente (quando non esistevano i palazzi) era sorgiva.
===civ. 8r: il circolo ricreativo “Pietro Avellini”.
Nato
col nome di “ club amici del Campasso”
nel 1919, in una sede vicina all’attuale: sempre in via Pellegrini ma al
civ. 15, che rimase sinistrato durante un bombardamento aeronavale all’inizio
del conflitto 40-45 e quindi qui trasferito subito dopo.


In data
21 genn.1925 fu sciolto dall’autorità di pubblica sicurezza (fiduciario di zona
era un certo Lucchesi), applicando un
decreto prefettizio che imponeva la liquidazione di tutti i debiti e
crediti, e di cessare tutte le attività consegnando tutte le iniziative e beni
a qualsiasi altra istituzione locale purché sempre e solo con scopi di
ricreazione. Risorto nel 1937 nei
locali attuali (che sono dello IACP-Arte),
ai soci rifondatori fu imposto di cambiare colore della bandiera sociale
(che era rossa) ed il nome da dare : “circolo ricreativo Pietro Avellini” (un
non bene conosciuto caporale alpino tanto che in alcuni testi è chiamato
Avellino, nativo di Pegli; morto valorosamente
combattendo tanto da guadagnarsi la Croce di guerra alla memoria negli
anni 1935-7 nell’ A.O.I. (Africa Orientale Italiana): evidentemente in Etiopia
(la conquista di queste terre in quegli anni, associate alle colonie dell’Eritrea,
Somalia ed Oltregiuba per circa 6 anni fino al 1941 costituirono l’Impero
coloniale italiano, con capitale ad Addis Abeba). Stranamente e paradossalmente
risultò poi che fosse di ideologie politiche
assolutamente non affini al
regime fascista).
Il
circolo, che prima era aderente all’ ENAL, successivamente al 4 dic.1971 aderì
all’ ARCI; all’art.1 del proprio statuto, riconosce voler essere “strumento di
lotta per la crescita democratica del Paese e per la affermazione culturale e
politica e sociale del lavoratore e del cittadino attraverso una effettiva
pluralità di partecipazione alle decisioni e alla conduzione della società
civile. ... ecc”.
In
seguito, in seno al circolo, si è formato anche un attivo “club
Sampdoria”. Subito dopo il cancello
d’ingresso, una lapide ricorda i soci caduti in guerra.
===
civ. 10r
posto sotto la scuola fu costruito dalla famiglia Laffi, ad uso
lavorazione di materiale elettrico, con otto operai. Negli anni 1954 fu
rilevato dai fratelli Garobbio, Cosimo e Giuseppe, ex fabbri in carpenteria che
lavoravano (per l’Italsider, per la Fulgor Cavi) materiale come macchinari e
presse per la lavorazione dell’acciaio,
arrivando ad avere oltre 30 dipendenti. Dopo essi, dal 1957 vi ebbe sede
l’officina di Francesco Gallo & Figli,
piemontese genovesizzato dal 1935, specializzata nella costruzione ed
installazione di arredamenti di bordo, e per l’edilizia pubblica e privata .
(dalle porte o vetrine corazzate, a divisori, cabine vetrate o metalliche e
stands fieristici), producendo materiale che andava anche all’estero (Germania,
Arabia); i due figli negli anni ’80 aprirono una officina in altra sede.
Attualmente è adibito a deposito cartaceo della banca Popolare di Novara e
della banca d’Italia .
Attualmente vi ha un deposito-archivio cartaceo di una, o forse più, grandi banche.
===civ.13-15r nel 1933
c’era un club “Amici Campasso”
===civ. 15:
nel febb.1917 esisteva solo questa casa
popolare, di proprietà comunale; in questa data, la casa ed il terreno attorno
fu ceduto all’ EACP ( ente autonomo case popolari) già ben diviso in lotti edificabili. Lamponi vi
segnala la sede di un ‘circolo la Ricreazione’ negli anni 1930 non segnalato
dal Pagano/33.
Distrutto da una bomba durante la guerra, fu
edificato nuovo nel 1954.
Proveniente da salita Angeli, per lunghi anni vi abitò il
pittore-scultore, nonché poeta e scrittore Galotti Francesco, espressivamente forte e
caratteristico, poco conosciuto nella sua stessa zona perché persona schiva,
mite ed introversa (nativo di Fermo, AP, il 5 apr.1921, venne a Genova
nel 1936 per diventare ansaldino e nel tempo libero allievo alla scuola di
disegno e modellato in legno. Durante il periodo bellico, fu soldato del regio
esercito e poi partigiano sui monti di Montemarzo (AT) con nome di battaglia
‘iena’, e (forse) prigioniero. Dalla
guerra tornò gravemente malato ed invalidato da non poter riprendere l’attività
operaia: seppur disoccupato iniziò a produrre significativamente, e tentò la
via del professionismo artistico esponendo in molte rassegne e mostre ottenendo
riconoscimenti e premi. Insegnò bozzetto grafico ed ornato nell’Istituto don
Bosco ed al Vivaldi di Genova. Nel 1952 aprì il ’cenacolo artistico
dell’Acquasola’ quale sala riunioni, mostre e conferenze per artisti, e dal quale
emersero tante firme autorevoli nel campo dell’arte –come Giannetto Fieschi-.
Malgrado lavorasse nella cupa miseria non ottenne alcun finanziamento dal
potere civico, proprio per quella umiltà dignitosa, generosa e non invadente
che lo caratterizzava. Non amava il soldo se non come elemento di sopravvivenza
ed era sempre pronto e primo ad aiutare con presentazioni, mostre gratuite gli
artisti nullatenenti). Morì il 9 dic.1984).
===civ. 17,
fu progettato uguale al 6 e realizzato in contemporanea, anche se appare abbia
45 appartamenti (125 vani). Fu anch’esso utilizzato per ospitarvi degli
sfollati, già residenti nella zona della Centrale del latte; ma anch’esso ebbe
l’ala di nord-ovest distrutta nei bombardamenti.
===civ. 19, raggiungibile solo salendo
un’erta scaletta, fu assegnato ad una nuova costruzione nel 1965, adibita a
scuola elementare, succursale dapprima della Cantore e poi della industriale
Ludovico Ariosto di Certosa. Dismessa, fu occupata nella primavera del 1994 dal
Centro Civico Zapata, la cui liberazione avvenne solo con l’uso della forza
pubblica. È stata giudicata non agibile con continuità causa la presenza di
amianto nelle strutture; è quindi stata offerta in gestione ad un circolo ARCI
Musicale di Pegli che la ha usata saltuariamente. Nel 2008 si parla di vendere
o abbattere, essendo inagibile ed irrecuperabile (costoso e complicato) da
parte del Comune, proprietario-.

STORIA: la strada già esisteva prima dell’anno 1900 .
Alla data del 1910 già la titolazione era
stata ufficializzata: lil nome compare nell’elenco delle strade pubblicato in
quell’anno dal Comune, con civici sino al 4 e 7 (ma in pochi anni a seguire
divennero civv. sino a 2 e 19) nel percorso ‘da via G. Bruno (via Campasso)
alle nuove case popolari’ . In altro documento si precisa: “strada che da via
G.Bruno corre tra il mattatoio e le case popolari”.
Notevole fu il contributo dei campassini
alla resistenza negli ultimi anni del conflitto mondiale, ed il tributo di
sangue sia sotto i bombardamenti che nelle azioni belliche o ‘trasferiti’ in
Germania.
DEDICATA all’illustre politico avvocato, nato il 16 mar.1843 da Didaco ed Anna
Di Negro, a Costantinopoli (oggi Istàmbul; nacque così lontano perché il padre
-avvocato pure lui, genovese del sestriere di Prè, era là in fuga in quanto –escluso
dall’amnistia- era stato condannato a morte a Genova per aver partecipato
attivamente ai moti dell’aprile 1849, assieme a G. Avezzana, C. Reta, G. Morchio; tutti poi
graziati da altra amnistia).
Tornato
in Italia dopo la morte del padre, completò gli studi a Pisa, esercitò la prima
avvocatura a Costantinopoli e, dopo il 1870 tornò definitivamente a Genova, ove ben presto si fece amare,
ammirare, ricercare.

Di una magrezza spettrale, con occhietti
penetranti come punte d’acciaio, geniale e generoso, di carattere bizzarro e
singolare, con uno stile originale sia nel parlare, sia nel comportamento, sia
nel vestiario (sceglieva abiti in forma perennemente austera ed altrettanto
sempre con la tuba in testa -una delle ultime in città, e la più celebre
assieme a quella di Nicolò Garaventa, narrano che non se la levava neppure
a letto-; e che tenesse due sigari
accesi contemporaneamente per poterli afferrare di qua o di là a seconda della
mano occupata nel momento).
Come avvocato penalista, quando discuteva le
cause, creava e regalava emozioni a non
finire perché era un ottimo oratore, pieno di impeto e di spirito critico
arguto; le sue arringhe facevano affollare le aule per ascoltare i suoi detti,
ricchi di sarcasmo, battute salaci e bei motti
(oggi si chiama humour: la raccolta di essi, chiamata “Pellegriniana”,
ne ricorda alcuni: notando l’età dei
deputati al senato, disse che “il Senato è la camera di moribondi”; “a Milano
non c’è nebbia ma solo fumo di risotti”; oggi forse sciocche, ma a quei tempi
come sempre ancor oggi, certe battute
salaci creavano una curiosa sete di
anticonformismo e di disprezzo
delle rigide regole dei bigotti e benpensanti) .
Come politico, era favorevole ai
repubblicani, ma aperto alla collaborazione con i socialisti, si schierò sempre
a favore del popolo e degli scioperanti nei periodi iniziali di rivendicazioni
umanitarie dapprima, sindacali dopo con i diritti dei lavoratori; difese
Stefano Canzio nel processo il 10 mar.1878 ritorcendo sulla polizia il contegno
scorretto verso il corteo che si avviava a commemorare Mazzini a Staglieno; per
lunghi anni non ci fu adunata popolare -anche a San Pier d’Arena- a cui non
fosse invitato per essere ascoltato; nell’anno
1900, dopo il regicidio a Monza, vennero stretti i freni libertari e
sciolta la camera del lavoro: assieme a Pietro Chiesa ed al sindaco Bettinotti
fu alla testa degli scioperanti per recarsi dal prefetto ed ottenere con
sagacia e fermezza un successo all’imponente movimento operaio. Candidato nel 1882 nel 1° collegio di Genova, nella lista dei
Repubblicani-radicali contro il candidato governativo (quando faceva parte del
Comitato democratico radicale (assieme a F.Campanella, V.Armirotti e
F.Gattorno) ed al governo era Depretis),
ebbe 5000 scelte ma non vinse. Fu
invece vincitore della campagna elettorale a deputato per la Camera nel magg.1886 (16ª legislatura) la vittoria politica dei
repubblicani fu schiacciante, risultando primi in due collegi di Genova - di
cui uno al Pellegrini (abitante in via
s.Lorenzo), uno a Lazzaro Gagliardo –ed in
quello di San Pier d’Arena con Valentino Armirotti-.
Il 19 dicembre 1900 il Prefetto riscioglieva
le organizzazioni camerali di Genova e di Sestri
Ponente, le leghe dei lavoratori del Porto e quelle metallurgiche-navali. La
risposta operaia non si fece attendere. Il 20 mattina entravano in sciopero 7
mila portuali; e nella stessa giornata la sospensione del lavoro si allargava a
macchia d’olio ai cantieri, alle fabbriche, ai servizi, ai trasporti urbani; si
estendeva agli stabilimenti metalmeccanici di Sampierdarena, Cornigliano,
Sestri e Prà; e coinvolgeva oltre 25 mila lavoratori, provocando l’arresto di
tutte le attività economiche. Dinanzi alla paralisi completa della città e
della zona, le autorità dovevano ammettere la loro impotenza. Il 22, il governo
si trovava costretto a intervenire per sconfessare l’operato del prefetto: e il
giorno seguente, le organizzazioni disciolte si ricostituivano in un’atmosfera
di trionfo. A Genova, intanto, gli operai procedevano alla rielezione dei
membri della disciolta commissione esecutiva della Camera del Lavoro. Il
seggio, stabilito nell’ex-oratorio di San Filippo, era presieduto da Pietro
Chiesa; dieci tavole con altrettante urne erano state disposte nella sala. Le
operazioni di voto, cominciato per alcune urne già alle 17, continuò fino
all’una dopo mezzanotte, alla luce di poche candele, non essendovi
nell’oratorio né luce elettrica, né gas. La scena, all’indomani, fu descritta
dal Corriere Mercantile con queste significative parole: chi entrava in quella
semioscurità, rischiarata da poche fiammelle giallognole e vedeva quel via vai
di operai seri e composti che si recavano alle urne riceveva l’impressione tale
che difficilmente potrà dimenticare. Pareva un episodio grandioso, per la sua
imponenza, della Rivoluzione francese. Al banco stettero quasi sempre l’On.
Chiesa e l’Avv. Pellegrini, quest’ultimo dominante la folla con il suo
cilindro, in abito rigorosamente nero e guanti, che al mattino forse erano
stati bianchi, ma che alla sera non avevano più un colore definibile. I votanti
furono 9.200 circa e pochissime furono le schede bianche o nulle. Tutti i
candidati presentati dai dirigenti delle leghe furono eletti con votazione
plebiscitaria e con scarti di voti insignificanti, risultato questo, che
dimostrò, più che la disciplina e la compattezza dei lavoratori, la loro
consapevolezza del valore di quelle elezioni:
Nel 1901 (21ª legislatura) nel secondo collegio di Genova, anche perché animatore del grande
sciopero del porto dell’anno prima, vinse
senza dover ricorrere al ballottaggio,
su Luigi Arnaldo Vassallo, grande direttore del giornale “Il secolo
XIX”, designato dai monarchici).
Caduto nelle elezioni del 1904, tornò alla Camera nel 1905 (22ª legislatura) eletto nel collegio di Pesaro.
Abitava a Genova, in via san Lorenzo.
Si spense a sant’Ilario in una modesta villa, ove una lapide lo ricorda amico del popolo.
Preparandosi a commemorare il centenario della nascita di Mazzini, il 20 aprile 1905 fu trovato
morto a letto: stava annotando una frase su diritto e privilegio, da un libro
di Rousseau: “l’uno viene dalla natura,
l’altro dalla violenza o dalla frode; l’uno è istrumento di vita per tutti,
l’altro è per pochi istrumento di sopraffazione e di prepotenza: il diritto è
l’eguaglianza; il privilegio è un uomo
in piedi fra cento inginocchiati”.
La diagnosi postuma dei medici fu di “malattia di cuore e conseguente
paralisi cardiaca”.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica scheda 3362
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.428—ed.02/pag.465
-AA.VV.-Avvocati
di Ge- Ordine Avvocati -unico.2000-pag.31
-AA.VV.-1933-1983
Liceo Classico «G.Mazzini»-DonBosco.1983
-AA.VV.-1886.1996
oltre un secolo di Liguria-Il SecoloXIX-pag.95
-Balletti&Giontoni-Una
città fra due guerre-DeFerrari.1990-p.151. 152pianta
-Benelli
& coll.-La donna nella Resistenza-LaNuovaItalia.1979-pag.210
-Costa
E.-Valentino Armirotti-soc.OperaiaUniversale.2001- pag.206
-DeLandolina
GC.– Sampierdarena -Rinascenza.1922- pag. 50
-Enciclopedia
Sonzogno
-Galotti
F-Pittura e scultura d’oggi in Liguria-EAR.1970-pag.-144
-Gazzettino
Sampierdarenese: 5/73.4 +
6/73.5 + 7/95.8
+ 6/76.4 +
3/82.3 + 3/89.2
+ 6/89.11 + 5/90.5
+ 3/90.13 +
7/92.7 +
-Genova, rivista
comunale: 1/33.31 + 7/42.37
+ 3/55.47.62
-Google-SamuniE.-la
FIOM a Genova, nascita e sviluppo di un sindacato...
-IC –Il
Cittadino-settimanale, del 07.10.97
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.141
-Macaggi
G.-Antonio Pellegrini-Casa Ed.Italiana-
-Miscio
A.-La seconda Valdocco-Elledici.2002-vol.II-pag.89.122.
-Novella
P.-Strade di Ge-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag. 16)
-Pagano/1933-pag.248;
/40-pag.366; /1961-pag.873-1298
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade...-Tolozzi.1985-p.1417-1420foto
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10
-Raimondi
O.-Il sec. XX, Riv.popol.illustrata-SEI-anno XIII/1914-.595foto
-Roberto
F.-L’edilizia residenziale pubblica-C.Librai-1999-.143
-Tuvo&Campagnol.Storia
di Sampierdatrena-D’Amore.1975-pag.272.
-non
citato Enciclopedia Motta
PENSA via Romolo
Pensa
TARGHE:
San Pier d’Arena – via – Romolo
Pensa – caduto per la Libertà – 1899-1943


angolo con via G.Buranello

 angolo piazza Treponti
angolo piazza Treponti
QUARTIERE ANTICO: Coscia
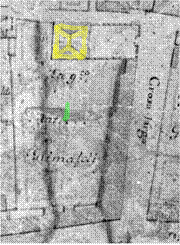 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
Ipotetico tracciato di via RPensa.
In giallo, villa Grimaldi la Fortezza.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2824
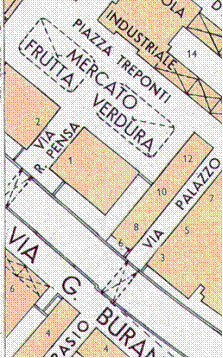 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 46840
UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth, 2007.
da Google Earth, 2007.
CAP: 16149
PARROCCHIA:
s.Maria della Cella
STRUTTURA: strada comunale carrabile,
senso unico viario da piazza Tre Ponti a via G.Buranello, lunga m.29,8 e larga
m.8. Ai lati, i marciapiedi sono larghi m. 1,30, però nel tratto sotto la
ferrovia non ci sono. È zona di mercato
con bancarelle all’aperto.
È stato presentato un progetto di trasformazione totale della zona
mercato; nel 2010 non è ancora in atto.
STORIA: Nei primi anni del 1900, la strada era
delimitata da uno stabilimento descritto ‘deposito ferri’, e nel sottopasso vi
transitavano su un binario dei treni
provenienti da un raccordo a mare (ed attraversante un cortile - posto di
fronte in via Buranello - di proprietà dei figli di Enrico
Forni, legnami).
Il piccolo tratto di strada fu intestato al
Pensa dopo l’ultima guerra mondiale con delibera della Giunta Comunale del 29
settembre 1946; precedentemente non
aveva nome ed era un tratto facente parte prima di tutto di via Vittorio
Emanuele, poi della piazza Treponti (denominata il 23.2.34) a cui ha sottratto
i due civici prospicienti.
Negli
anni 2000 esisteva un’altra targa, poi sostituita non so quando, nella quale
non c’era il nome della delegazione mentre era estesa la data della morte: via
– Romolo Pensa – caduto per la Libertà – 1899-30.9.1943.
CIVICI:
2007=
NERI = 1 e 2
ROSSI= da 1r a 7r (compresi 1Ar ed 1Br)
da 2r a 8r (compresi 2Ar e
2Br)
DEDICATA al
barista con esercizio in piazza N.Barabino, nato a San Pier d’Arena il 14
sett.1899, di carattere generoso e gioviale, da sempre di idee antifasciste e
mazziniane. Dopo il 25 luglio 1943 alla caduta del fascismo ed all’occupazione
nazista, fu tra i primi a concepire e mettere in atto il concetto della
necessità di una ribellione armata.
Troppo il divario organizzativo ovviamente;
così solo accettò di nascondere delle armi nei fondi del suo bar “san Pietro”.
Probabilmente una delazione o il fatto
di essere già segnalato perchè ingenuamente aperto nell’espressione delle sue
idee e sentimenti, determinò il 30
sett.1943 un organizzato accerchiamento notturno di tutto il quartiere con
perquisizione sistematica di tutti i caseggiati, cercando armi abbandonate dai
militari in sfacelo organizzativo dopo l’armistizio, e prelevando così anche
tutti i sospetti (una ventina di persone). Quando giunsero al bar, il
proprietario fu obbligato ad aprire per il controllo e, nelle cantine fu
ritrovato il materiale bellico nascosto.
Qualcuno
dice che seduta stante il Pensa fu fucilato: non credibile perché sarebbe stato
più vantaggioso una dimostrazione più plateale e legale, intimidatoria e atta
a scoraggiare i più deboli; perché
sarebbe stato più utile raccogliere informazioni; ed infine anche perché - ma
non so - sino a che punto l’ufficiale tedesco avesse possibilità di decisione di fucilare seduta
stante: in quei tempi tutto era possibile.
Un’altra
versione vuole che il Pensa abbia tentato una reazione di opposizione alla
perquisizione o di fuga o di esasperazione, scatenando il fuoco dei
mitragliatori tedeschi della Wermacht.
Fatto
fu che, colpito alla colonna vertebrale, dette ai presenti l’impressione di
essere spezzato in due cadendo piegato all’indietro fulminato.
È così
considerato la prima vittima partigiana di San Pier d’Arena.
Intanto
in città si perfezionava l’attività della resistenza: sia continuando a
ricuperare armi e nascondendole per un prossimo futuro; sia reclutando gli
sbandati ex militari (favoriti da una legge che voleva per loro un nuovo
reclutamento nelle file nazifasciste -pena la deportazione-), e favorendo il
ricongiungimento sui monti con formazioni militarizzate; sia organizzando le
fila del servizio , con la costituzione dei primi comitati (il CLN -cioè
Comitato di liberazione nazionale -
nacque in via XX Settembre il 9 sett.43;
i GAP -ovvero Gruppi di azione patriottica- , nati a cavallo tra la fine
del ‘43 e l’inizio del ‘44; ed i
SAP -Squadre di azione patriottica-,
comparse nel giu.44).

BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Ferrovie
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica , scheda 3384
-AA.VV.-.Annuario
guida Archidiocesi- ed/94-pag.428; ed/02-pag.465
-AA.VV.-Contributo
di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1977-pag.32-5
-AA.VV.-35°
SPd’A
-Gazzettino
Sampierdarenese : 4/93.5
-Gimelli
G.Cronache militari della resistenza…-Carige.1985-vol.I-pag.51
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 72
-Pagano/1961-pag.446
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1426
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.51
-Stradario
del Comune di Genova-ediz./1953-pag.135
PERASSO vico G.B. Perasso
Era il nome dell’attuale via Nicolò Bruno,
traversa posta all’inizio della via
Sampierdarena , fatta ad angolo retto che da verso monte si apre infine in via A.Prasio.
Nel febbr.1914 fu proposto all’approvazione
del Sindaco l’annullamento della precedente titolazione di “vico
Francesco Domenico Guerrazzi”, da sostituirsi
con “vico Pittamulo” oppure “vico Balilla”: evidentemente prevalse il
secondo col nome completo, visto che anche il Novella lo segnala come “vico
Giovanni Perasso Balilla, da via Cristoforo Colombo“, a via J.Ruffini.
Ancora esisteva nel 1926 quando il comune di
SPd’Arena fu unificato con quello genovese; allora era classificato di 5a
categoria
Ancora esisteva nel 1933, da via C.Colombo a
via J.Ruffini.
Con delibera del podestà del 19 agosto 1935,
onde evitare omonimie con Genova centro, fu sostituito con il nome attuale
(che, dal ‘35 fino al ‘46 sbucò in via Palazzo della Fortezza).
DEDICATA (vedi anche a Balilla) al giovane quindicenne
che in Portoria il 5 dic.1746 dette il via - col suo gesto- alla ribellione
popolare contro l’oppressore: divenne il simbolo di una fierezza e dell’amore
all’autonomia che sempre ha contraddistinto la storia genovese.
Lo storico Accinelli, vissuto in
quell’epoca, descrisse il tentativo dei soldati di Maria Teresa d’Austria di farsi
aiutare dai presenti a rimuovere un cannone presumibilmente diretto verso la
Provenza -prelevato molto probabilmente alla batteria della Cava ed infossatosi
nel terreno fangoso davanti all’antica chiesa di santa Caterina Adorno in
Portoria (se era uno di quei cannoni posizionati alla Cava, era per difesa
della città dal mare; su essi –come consuetudine per protezione divina- era
stato inciso come dedica il nome di un santo; pare che quello che scatenò la
rivolta fosse dedicato a santa Caterina: una strana doppia coincidenza, e ben
chiaro messaggio per chi era presente)-.
Il ragazzo, o meglio ‘un figgieu de
stradda, un battuso’, afferrato un
sasso, gridò la famosa frase ‘che l’inse’ accendendo l’insurrezione che
evidentemente covava da tempo ed aspettava solo l’innesco (VEPetrucci scrive: ’son segùo comme l’òu, che quande o l’è
arrivou a casa, s’ò l’ha contòu da prïonâ, so mamma a gh’ha daeto de segùo un
lerfon”).
Si accetta e non si discute più che - quale
scintilla esplosiva - avvenne il gesto
del sasso, per testimonianze vicine al fatto come tempo, (l’ambasciatore
veneziano a Genova il 1747, ed un’opera storica del patrizio GFrancesco Doria
del 1748; Pasolini scrive che la sassata provenne dalla rabbia per il sequestro
di un cesto di mele che lui stava cercando di vendere e che sfogò poi su quelli del cannone).
Ma si è ancor oggi
perplessi su molteplici fatti concernenti, storicamente non ben definiti:
--- “Che l’inse!” Si è perplessi della frase di rabbia che
accompagnò il sasso: corrisponde a: ‘ e che!
incominciamo!’. Primo a farne accenno, fu il francese Bastide, nella sua
‘storia della Repubblica di Genova’ del 1795.
--- Per il nome del ragazzo, esiste
l’assoluta inesistenza di prova certa.
Già il problema sorse a
metà del secolo del 1800 e nel 1865 sotto forma di polemica tanto che il Consiglio
municipale più volte si trovò a doversi pronunciare in merito. Ma in seguito,
approfondite ricerche fatte fare dal governo Mussolini, portarono ad una
commissione di alte personalità della cultura locale (Ernesto Codignola (uno
dei maggiori pedagogisti italiani - 1865-1965); Volpicella; Nurra; Morando;
don Gioachino Ridella;
cap. A.Burlando
e don Rebora
(rispettivamente podestà ed arciprete di Montoggio); nonché altri 26 studiosi;
in tutto 33) che si impegnarono a fondo negli archivi e rifecero il punto dei
ritrovamenti; ma non riuscirono ad
apportare nulla di nuovo:
=il ritrovamento di un libretto anonimo (scritto in latino
maccheronico ed intitolato ‘bellum genuense’, probabilmente scritto da un prete
che partecipò all’insurrezione, quindi testimone dei fatti quantomeno in genere
di quei giorni, e che anche rimase ferito vicino a porta san Tommaso), nel quale il sacerdote
scrisse che il ragazzo era soprannominato “Mangiamerda”(sappiamo
da altre fonti come a quell’epoca questi - a volte terribili - soprannomi erano
in uso per tutti gli uomini della plebe, e facevano carico di una scelta fatta
quando il bimbo era appena nato e quindi nell’impossibilità di scegliersi
qualcosa di diverso). Ovvio che il Duce, quando apprese questa chiarificazione storica,
impose il silenzio e la non diffusione facendo perdurare il ‘falso’ mito
storico, in quanto aveva bisogno di una figura giovanile che esaltasse le virtù
militari insite nell’animo e nei geni della “stirpe” italica.
=il nomignolo Balilla
compare per la prima volta nel 1755 in una libera traduzione dialettale della
Gerusalemme Liberata, scritta da Agostino Gastaldi: ’si parla di due personaggi
del popolo che hanno mostrato coraggio nella guerra del 1746’; tale Alessandro
Gioppo (una nota precisa: pescivendolo che in quei giorni fece parte del Quartier Generale del Popolo)
e tale Balilla (senza alcuna nota né spiegazione)’.
=solo nel 1845 Michele G.
Canale scrisse sull’almanacco ligure ’Omnibus’, che il Balilla si chiamava
Perasso. E l’anno dopo, un opuscolo, precisò il nome di Giovanni Battista. Orlando Grosso fece
rilevare che Balilla era un usuale diminutivo di GB, e che era anche il grado
minore dei confratelli delle casacce, tipo ‘baciccia’, ‘ballin’ e
‘balletta’, ancor oggi in uso per
indicare affettivamente un piccolo.
=nel 1845 Mameli usò per
la prima volta il nome Balilla in un suo componimento; e lo ripropose nel 1847
nell’Inno d’Italia“…i bimbi d’Italia si chiaman Balilla…”.
=definito ed accettato
che si chiamasse Perasso GianBattista, le ricerche trovarono due GB Perasso,
quasi coetanei:
-- un giovane originario
di Montoggio nato l’8 aprile 1729 (fu
trovato all’Archivio Storico anche un altro simil-omonimo, Gio.Batta Perrazo,
contadino, pure lui ‘della villa di Montoggio’ che nel 1753 fu processato e condannato a 2 anni di remo,
catena al piede, per contrabbando di 3 libbre di sale effettuato l’anno prima.
Il padre perorò la causa del figlio adducendo precedente buona condotta e che
raramente aveva abbandonato il paese d’origine). Questa dato anagrafico
venne confermato nel 1851 da don Giuseppe Olivieri che precisò aver chiarito
che - sia il prete che il ragazzo erano
di Montoggio, frazione Pratolongo (non Porto-lungo come
suggerisce DeLandolina); -che questi era figlio di Marc’Antonio e di Gerolama (o Geronima) ed
all’epoca del gesto avrebbe avuto poco più di
17½anni (una nipote di questo, fu cameriera di C.Cabella e
gli donò una attestazione manoscritta del nonno), -e che il giovane era in Portoria per apprendere
l’arte del tintore.
--L’altro, in seguito ad
altra ricerca compiuta nel 1865 nei registri della parrocchia di s.Stefano, nato
il 26 ottobre 1735 (il SecoloXIX scrive 1736), alle ore 9 da MariaAntonia Prodi (Parodi) e
da un popolano, Antonio, in vico dell’Olivella, ma all’epoca dei fatti abitante
in vico Capriata di Piccapietra; e quindi all’epoca del fatto, di 11 anni (ulteriore
documento accerta che questi morì a quasi 46 anni).
--Il SecoloXIX ne propone
un terzo, nobile o almeno di lignaggio,
emerso agli archivi di san Lorenzo, figlio di AntonioMaria (console dei
Tintori della seta a Genova) e da Antonia Maria Parodi (omonima della
popolana!).
--Al Museo del
Risorgimento è conservata una prova di identità, risultata falsa, nelle
ricerche effettuate dalla Soc.Lig.St.Patria nel 1927. Porta scritto una descrizione dei fatti che
sarebbe di pugno del giovane. Pieno di strafalcioni e dialettalità, porta
scritto «Io peraso deto u balila o incunminciatoa tirare un sascu e mi
rispusero andiamo avanti i mio sio mi dise a speta un pocu che vengo mia no
portato una bandiera lo presa in mano mi sono miso a gridare andiamo avanti
altra nun dico che il popolo lu sa a dio a tuti». Nicoletta Perasso (a servizio
di Edoardo Cabella figlio del senatore Cesare) donò al padrone questa
carta;questi la donò al Comune nel 160° dell’insurrezione; ma la carta su cui è
scritto questo documento autoapologetico è stato appurato era stata prodotta
nel 1832.
DeLandolina nel 1922 scrisse –senza
specificare da dove traeva tale notizia- che nacque ”a Porto-lungo (Genova)”.
Pasolini invece scrive che il paese è Montobbio, vicino a Torriglia ed al lago
Val Noci: ma ciò appare errato per ambedue.
Intanto Vittorio Emanuele
Bravetta (scrittore di numerosi libri)
musicava per l’ONB (opera nazionale balilla), si scrive in occasione del primo
centenario della ribellione, una canzone molto orecchiabile e facile che divenne
l’inno fascista:
Fischia il sasso, il nome squilla
del ragazzo di Portoria Fiero l'occhio, svelto il
passo,
e l'intrepido Balilla
chiaro il grido del valore:
sta gigante nella storia
ai nemici in fronte il sasso
Era bronzo quel mortaio...
agli amici, tutto il cor
che nel fango sprofondò,
ma il ragazzo fu d'acciaio
e la madre liberò
La doccia fredda proviene da due lati: uno,
da subito il dopoguerra; dopo il periodo
del regime fascista, durante il quale il monello era stato ricuperato
con aulica ed esagerata raffigurazione, al fine di proporre un ideale
fortemente di parte, anche se storicamente dubbio: l’uso di questo soprannome
durante il ventennio per inquadrare i più giovani in divisa in tutta Italia, ne
ha dopo offuscato la limpidezza reale e prettamente genovese.
Scrive Dolcino che sulla
base del suo monumento, quando i tedeschi nell’ultimo conflitto mondiale
occuparono Genova, mano ignota scrisse “chinn-a zù, che son tòrna chi”. Ancor ai tempi attuali a distanza di quasi
sessant’anni è prevalente l’interpretazione del simbolo vissuto in quel
ventennio; e se ne ha ancora soggezione: è quindi ancora troppo recente. Nel popolo ed a ‘palazzo’ viene vissuto con
una non poca avversione; alle celebrazioni del 5 dicembre, il Comune depone una
corona di alloro, ma il Sindaco di persona non è mai venuto. Anche se Genova,
come popolo ribelle mantiene un record nazionale, e lo ha sempre dimostrato anche nelle annuali
lotte sindacali e recentemente nelle
dimostrazioni del G8, il mal uso di quei tempi ne frena anche il solo parlarne.
D’altro lato, anche gli storici moderni,
freddi e disincantati come Paolo Lingua scrivono che l’insurrezione fu genericamente di popolo
e non legata ad una particolare scintilla; il mito del Balilla fu inventato nel
periodo risorgimentale quando politicamente era necessario fomentare l’opinione
collettiva contro l’Austria.
Cosicché è un nome bifronte, di quelli che
sono legati a fatti storici dimostrati, ma fu deformato due volte, e solo a
vantaggio di parte; cosicché meno se ne parla e meglio è (come l’”inno a
Roma”), o quantomeno, non se ne inneggia.
Ma se ciò è accettabile per l’Italia in genere, favorire questo equivoco
è a svantaggio della nostra migliore
tradizione di indipendenza, ardore impetuoso e ribelle ai soprusi, di qualsiasi
colore.
Dolcino scrisse giusto: non importa chi
fu: è un simbolo. Non quello proposto da Mussolini, ma quello del carattere del
genovese, insofferente del sopruso del più forte chiunque esso sia, ribelle
alla perdita della libertà intesa come bene primario ed assoluto della vita
dell’uomo
La storia è impietosa, ma sicuramente si
riprenderà la dimensione veritiera. L’unico vero pericolo è che, dello spirito e
della fierezza popolare degli antichi genovesi poco importa ai moderni
abitanti, ormai sufficientemente
“imbastarditi” dall’immigrazione selvaggia (prima nostrana, poi foresta). Un
emigrato, nel dic.2006 dal Brasile chiede al Secolo chi fu, perché “oggi
purtroppo quasi nessuno si ricorda chi fu Giovanni Battista Perasso, abbreviato
Balilla. Credo addirittura che qualcuno pensi che fu un personaggio dell’era
fascista”. La risposta di Maggiani è stata «era un ragazzino (o forse no?) abbastanza
sconsiderato da fare quello che nessuno tra i genovesi aveva ancora avuto il
coraggio di fare o di dire: mandare al diavolo gli odiati e odiosi occupanti
austrotedeschi. …Che il Balilla sia esistito davvero…significa in fondo ben
poco…così è stato arruolato per fare il suo dovere di simbolo…Poi, …poi è
scomparso, almeno per questi tempi così poco propensi alla rivolta, alla
sconsideratezza, all’eroismo»
Quindi - secondo me - a conclusione delle
considerazioni su scritte, ne viene che alla lunga, soffocare le tradizioni,
anche se bifronti, è un danno più grosso di quello che si vuole parare.
BIBLIOGRAFIA
-A Compagna-Bollettino
per i soci- : 6/96.tutto + 2/97.5
-Agosto A.-La
questione del balilla...-Atti
SLSP.1979.fasc.I-pag.301-
-Arichivio Storico
Comunale in palazzo Ducale
-Archivio Storico
Comunale - Toponomastica scheda 3395
-DeLandolima GC
-Sampierdarena- .1923-pag.29 (chiama: ‘via Balilla’)
-Dolcino M.-Storie di
Genova-Frilli.2003-pag. 80
-Gazzettino
Sampierdarenese 06/03.2
-Genova, rivista
municipale : 1/34.10
-Il SecoloXIX quotidiano- del 8.12.04 + 16.12.06
-Lingua P.-Breve storia
dei genovesi-Laterza.2001-pag.194
-Morgavi G.-Rievocazioni
genovesi-Bozzi.1961-pag.147
-Novella P-Strade di
Genova-manoscritto bibl.Berio.1930ca-(pag. 17)
-Pagano/1933-pag.248
-Pasolini A.-Semmo da
taera de Colombo-NEG.1990- pag.51
-Pescio A.-I nomi delle
strade di Genova- Forni.1986-pag.43
-Sisinni F-
Atti-SocLiStPatria.1980.II-pag.14
-Volpicella
L.-relazione-Soc.Lig.StoriaPatria.1930-vol.LVII-pag296
PERLASCA via
Giorgio Perlasca
TARGHE:
via –
Giorgio Perlasca – salvò ebrei deportati – 1910 – 15-8-1992
via –
Giorgio Perlasca




angolo ovest con Ponte di
Cornigliano angolo est con
via R.Pieragostini


lato ovest con Ponte di
Cornigliano
 Da Google Earth 2007.
Da Google Earth 2007.
In giallo via R.Pieragostini
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA – N°: 47030
UNITÁ URBANISTICA: 24 – CAMPASSO
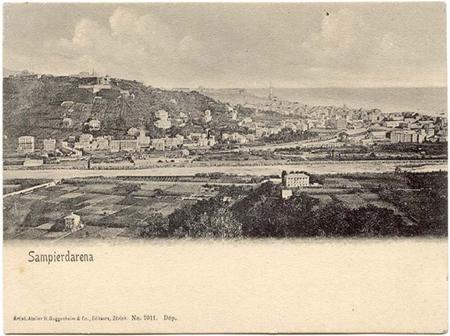
il
percorso, da antica cartolina
STRUTTURA: Inizia subito prima del Ponte di Cornigliano,
ed è estesa lungo in fianco sinistro del Polcevera, fino a Rivarolo ed oltre.
È
stata così titolata agli inizi del 2005,
senza particolari cerimonie, al punto che praticamente nessuno sa - ancora dopo
un anno - di tale denominazione, sulla scia di emozioni televisive,
cinematografiche e di mai troppo tardivi riconoscimenti (nel suo piccolo, anche
il nostro parroco del Fossato ha allora corso gli stessi rischi ed ha ottenuto
medesimo risonoscimento, senza – ovviamente - rinomanza nazionale).
Per un tratto di circa 500 metri, si affianca, a
ponente, a via Argine del Polcevera, dalla quale è separato dal guard rail e da
una rete metallica che si interrompe in corrispondenza di via Campi.
È
quindi strada solo di percorrimento veicolare, mirata a snellire il traffico
verso l’entroterra (che, fino ad allora, passava solo per via W.Fillak, nell’interno tra le case).


L’imbocco
iniziale dovrà essere allacciato a Lungomare Canepa in modo da sbloccare
l’ingorgo asfittico di via Molteni e Pieragostini. L’operazione non era
fattibile senza prima liberare l’area di Cornigliano (avvenuta a fine 2006).
Oltre
il ‘confine’ di nostra pertinenza (in linea con il centro di via Campi), un
tratto di strada è formato a conca, per un sottopassaggio: quando piove
intensamente esso è soggetto ad allagarsi, necessitando di pompe idrovore per
il prosciugamento che funzionano se c’è corrente.
CIVICI nel nostro territorio, non ha civici
DEDICATA a
Giorgio Perlasca, che nacque a
Como il 31 gennaio 1910. Dopo qualche mese dalla sua nascita, per motivi di
lavoro avendo funzione di segretario comunale, il padre Carlo trasferì la
famiglia a Maserà (Padova).
Negli anni liceali, animato da
spirito nazionalista ed idealizzando questa idea nella versione dannunziana e
nazionalista, arrivò a litigare con un suo professore che aveva condannato
l’impresa di Fiume, facendosi espellere per un anno da tutte le scuole del
Regno.
Nel 1935 aderì al fascismo. Coerente,
partì volontario prima per l’Africa Orientale (Abissinia. Guerra italo-etiopica
del 35-36) e poi per la Spagna, dove combattè come artigliere al fianco delle
truppe del generale Françisco Franco.
Tornato in Italia nel 1939, entrò in crisi con
il fascismo per due motivi: l’alleanza con la Germania (asse Roma-Berlino del
36; patto d’acciaio del 39, e contro la quale l’Italia aveva combattuto solo
vent’anni prima); e le leggi razziali (entrate in vigore nel 1938 che sancivano
la discriminazione degli ebrei italiani).

Smise così di essere praticante fascista, senza però mai diventare un
antifascista.
Impiegato in una azienda triestina che trattava importazione di carne dai
Balcani, scoppiata la seconda guerra mondiale, dal governo italiano fu inviato
nei paesi dell’Est come incaricato d’affari con lo status di
diplomatico per comprare
bestiame per l’Esercito italiano. A Belgrado nel 1941, vide le prime colonne di deportati
(ebrei e zingari), rimanendo fortemente scosso. L’armistizio (8 settembre 1943) lo colse a
Budapest (Ungheria, allora alleata ai nazisti, ma
ancora comandata –dal 1920- dal dittatore Miklos Horthy von
Nagybanya-1868-1957 già comandante della flotta austro ungarica nel 1918).
Provando maggiore responsabilità verso il giuramento di fedeltà al Re,
rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana: fu così internato per
alcuni mesi in un castello riservato ai diplomatici. In contemporanea, a metà ottobre 1944, gli ungheresi
– sino a quel momento ancora guidati dal su detto reggente, ammiraglio Horthy- firmarono
un armistizio con l’Unione Sovietica, il governo venne rioccupato dai nazisti ed
il dittatore arrestato e internato in Baviera; i tedeschi ripresero potere affidando
il comando ad un loro collaborazionista fascista di nome F.Szalasi, capo dei
nazisti ungheresi chiamati “Croci Frecciate”. Come da dettame centrale, egli
iniziò le persecuzioni, violenze e deportazioni verso i cittadini di religione
ebraica.
In
corrispondenza, si prospettò per il Perlasca il trasferimento in Germania;
così, approfittando di un permesso per visita medica, fuggì nascondendosi presso conoscenti e poi presso
l’ambasciata spagnola, usando un
documento che aveva ricevuto in Spagna al momento del congedo (questo, recitava:
"Caro camerata, in qualunque parte del mondo ti troverai, potrai
rivolgerti alle Ambasciate spagnole"). In quella sede, fu aiutato trasformandolo cittadino spagnolo, con un
regolare passaporto intestato a Jorge Perlasca collaboratore dell’ambasciatore Sanz Briz, il quale – come già facevano altre potenze
neutrali: Svezia, Portogallo, Svizzera, Città del Vaticano - rilasciava
salvacondotti per proteggere i cittadini ungheresi di fede ebrea, ricoverandoli
momentaneamente in ‘case protette diplomaticamente’ (si rileva che queste
operazioni non sempre erano disinteressate: alcuni funzionari vendevano a caro prezzo questi
salvacondotti e non sempre poi avevano la forza né la volontà di pretenderne il
rispetto).
A fine novembre Sanz
Briz dovette lasciare l’Ungheria, portandosi a Berna per comunicare più
facilmente con Madrid (ma soprattutto per non riconoscere de jure il governo
filo nazista di Szalasi, che chiedeva lo spostamento della sede diplomatica da
Budapest a Sopron, vicino al confine con l’Austria).
Il giorno dopo, il
Ministero degli Interni nazista - venuto a conoscenza della partenza di Sanz
Briz - ordinò di sgomberare le case protette. Fu allora che Perlasca,
ricoverato nella sede dell’ambasciata spagnola di Budapest rimasta
momentaneamente senza il capo responsabile, si ribellò e prese la decisione.
Trovandosi ‘alle corde’ dalla necessità e sfruttando il caos governativo del
pre-disfatta, assunse ‘motu proprio’ la responsabilità di autonominarsi
sostituto-capo della sede, presentando credenziali, carte intestate dell’Ambasciata e timbri autentici facendo esistere una precisa – ma falsa -
nota di Sanz Briz che lo nominava suo sostituto per il periodo della sua
assenza (favorito dal conoscere bene l’ambiente della diplomazia,
frequantandola da anni); ed ingiungendo ai nazisti di chiarire tale situazione
presso il loro Ministero degli Esteri,
giocando sulle estreme difficoltà dei normali contatti internazionali.
Con tali
credenziali, e con l’aiuto-consenso di altri ambasciatori, degli impiegati e
del legale dell’ambasciata (l’avvocato Farkas, di origine ebrea. Questi riuscì
a sfuggiire ai nazisti, ma non alle truppe sovietiche, che lo uccisero quando
subentrarono in Budapest nel gennaio 1945) ordinò ai nazisti di sospendere ogni loro
iniziativa; fu creduto e nel
clima confuso legato alla ormai prossima disfatta, ed in assenza di
comunicazioni precise, il bluff funzionò. Usò questo potere, per fornire agli
ebrei un certificato personale attestante che la persona era “cercata ed attesa
in Spagna da parenti diretti; che il trasferimento verso la penisola iberica
era stato interrotto da impossibilità di viaggiare; e che nell’attesa era sotto
protezione dello stato spagnolo”
Le operazioni di
sabotaggio (incendio del ghetto e trasferimento verso i campi di sterminio) contro gli ebrei (rinchiusi in
cinque casermoni posti sulle sponde del Danubio in località di fronte all’isola
Margherita) furono fermate. Non solo li salvò burocraticamente, ma intervenne
anche pagando i funzionari affinché fossero riforniti di cibo; organizzando fra
loro un abbozzo di resistenza militare;
girando la città su una Buik diplomatica in una città piena di macerie,
cecchini e freddo invernale; andando alla stazione ferroviaria a ricuperare i
‘viaggiatori’ diretti ai campi; trattando col governo nazista e le autorità di
occupazione per evitare incursioni da parte dei ‘nylas’.
Così, giocando con il tempo che i nazisti
chiarissero l’inghippo; con il caos di quei giorni e con lunghi tempi burocratici,
tra il dicembre 1944 e gennaio 1945 salvò
dalla fame e dal trasferimento più di 5000 ebrei ungheresi mettendoli in attesa
di emigrare in Spagna.
Fu
fortunato, perché prima di essere scoperto avvenne l’entrata in Budapest
dell’Armata Rossa. Perlasca fu arrestato
dai russi, ma chiarite le sue generalità, fu fatto rientrare finalmente in
patria –passando attraverso i Balcani-, e tornando ad essere cittadino italiano
qualunque, e soprattutto non raccontando a nessuno la sua storia.
Solo alla fine degli anni ’80, furono
alcune donne ebree ungheresi, ragazzine all’epoca delle persecuzioni, che
iniziarono chiedersi chi fu quel diplomatico spagnolo che le aveva salvate. Le
testimonianze si sovrapposero e divennero così numerose che Giorgio Perlasca
non potè nascondersi ulteriormente nel suo silenzio. Fu così cercato e ‘scovato’: tra
essi vengono citati i coniugi Eva e Pal Lang, ambedue sopravvissuti a quei
terribili giorni, che promossero in Italia un viaggio collettivo, con meta
Padova e la pubblicazione del rischio gratuito del bluff.
Israele lo
proclamò Giusto tra le Nazioni e, invitandolo a Gerusalemme -ove piantò un
albero sulla collina dei Giusti- gli riconobbe la cittadinanza onoraria.
A ruota seguirono gli altri Paesi: in Italia
la vicenda venne fatta conoscere al grande pubblico da Enrico Deaglio con la
trasmissione televisiva Mixer e pubblicando il libro "La banalità del
bene". Dallo Stato gli fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile ed il
titolo di Grande Ufficiale della Repubblica. In Ungheria, a Budapest una scuola
alberghiera porta il suo nome ed il governo, dopo una apposita sessione del
parlamento, gli concesse la Stella al Merito, massima onorificenza nazionale.
La Spagna gli concesse l’onorificenza di Isabella la Cattolica. Gli Stati Uniti
lo accolsero come un eroe. Alla domanda
di un giornalistia sulle motivazioni e
sul perché lo aveva fatto, rispondeva : "Lei cosa avrebbe fatto al mio
posto, vedendo migliaia di persone sterminate senza un motivo, solo per odio
razziale e religioso, ed avendo la possibilità di fare qualcosa per
aiutarli?". E ad un altro che gli chiedeva "Lo ha fatto perché
cattolico?", lui credente anche se non praticante, rispose: "No.
Perché sono un uomo".
Morì il 15 agosto del 1992. È stato sepolto nella terra nel cimitero di Maserà a pochi chilometri da Padova; sulla lapide, a
fianco delle date, un’unica frase in ebraico: “Giusto tra le Nazioni”.
Innumerevoli i
riconoscimenti, di associazioni e di fondazioni private; in moltissime città europee
vi sono vie e piazze che portano il suo nome. Dicembre 1944 – Gennaio 1945: i 45 giorni di Jorge Perlasca.
Da Internet si riassume: “nelle vesti di diplomatico
regge pressoché da solo l’Ambasciata spagnola, organizzando l’incredibile
“impostura” che lo porta a proteggere, salvare e sfamare giorno dopo giorno
migliaia di ungheresi di religione ebraica ammassati in ‘case protette’ lungo
il Danubio. Li tutela dalle incursioni delle Croci Frecciate, si reca con
Wallenberg, l’incaricato personale del Re di Svezia, alla stazione per cercare
di recuperare i protetti, tratta ogni giorno con il Governo ungherese e le autorità tedesche di
occupazione, rilascia salvacondotti che recitano “parenti spagnoli hanno
richiesto la sua presenza in Spagna; sino a che le comunicazioni non verranno
ristabilite ed il viaggio possibile, Lei resterà qui sotto la protezione del
governo spagnolo. Li rilascia utilizzando una legge promossa nel 1924 da Miguel
Primo de Rivera che riconosceva la cittadinanza spagnola a tutti gli ebrei di
ascendenza sefardita (di antica origine spagnola, cacciati alcune centinaia di
anni addietro dalla Regina Isabella la Cattolica) sparsi nel mondo. La legge
Rivera fu dunque la base legale dell’intera operazione organizzata da Perlasca,
che gli permette di portare in salvo 5218 ebrei ungheresi”. Dopo l’entrata in
Budapest dell’Armata Rossa, Giorgio Perlasca viene fatto prigioniero, liberato
dopo qualche giorno, e dopo un lungo e avventuroso viaggio per i Balcani e la
Turchia rientra finalmente in Italia.
Da eroe solitario diventa un “uomo qualunque”: conduce una vita normalissima e
chiuso nella sua riservatezza non racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, la
sua storia di coraggio, altruismo e solidarietà. Negli anni Ottanta: la
scoperta di un uomo Giusto. Grazie ad alcune donne ebree ungheresi, ragazzine
all’epoca delle persecuzioni, che attraverso il giornale della comunità ebraica
di Budapest ricercano notizie del diplomatico spagnolo che durante la seconda
guerra mondiale le aveva salvate, la vicenda di Giorgio Perlasca esce dal
silenzio.
Le testimonianze dei salvati sono numerose, arrivano i giornali, le
televisioni, i libri, e lo stesso Perlasca deve recarsi perfino nelle scuole
per raccontare quel che aveva compiuto. Non certo per protagonismo, ma proprio
perché ritiene necessario rivolgersi alle giovani generazioni affinché tali
follie non abbiano mai più a ripetersi”.
BIBLIOGRAFIA
-Brizi.Cirnigliaro-Percorsi
‘resistenti’ in val Polcevera-Brigati.06-pag.89
-Il
Secolo XIX di : 12.9.05
-Internet-Google
PESCATORI piazza Pescatori
PESCHERIA piazza Pescheria
Non è facile
localizzarle - essendo descritte
genericamente “a lato mare della via Cristoforo Colombo” (via San Pier d’Arena).
Non chiariscono la posizione, i documenti ritrovati:
- Il 27 dicembre 1900 il regio Commissario
straordinario A. DeBenedetti, propose alla giunta comunale il nome di
“piazza Pescatori” per quella piazzetta
da via C.Colombo, detta popolarmente “delle cucine economiche”; e di “piazza
della Pescheria” allo slargo popolarmente conosciuto anche come “largo della
Pescheria”.
- Il 26 genn.1901, il cittadino Grosso
Francesco protesta in Comune opponendosi alla targa di ‘piazza Pescheria’ ad un
terreno posto vicino alla pescheria comunale, ma - a suo dire - di sua
proprietà.
- Nel 1910 vengono citate
ancora entrambi le piazze, segno che
esistevano e quindi di non assenso al ricorso fatto. Piazza Pescatori aveva un numero civico;
piazza Pescheria aveva l’1 ed il 2;
ambedue erano ‘da via C.Colombo al mare’.
- A conferma, De
Landolina scrive che nel 1919 il sindaco Bettinotti Mario (che fu il sindaco
più giovane, da poco tornato dalla grande guerra) in piazza Pescheria aveva
fatto costruire in riva al mare «una piccolissima saletta con un certo gusto
architettonico per la vendita del pesce, che mai, al contrario, vi si è visto»:
probabilmente, la su citata “pescheria comunale”.
- Ancora DeLandolina 1923 scrive che la piazza
Pescatori era il punto di partenza ed arrivo per «lanciare le reti per la pesca per ammainarle al ritorno».
- Nell’elenco delle strade stilato nel 1927
subito dopo l’unificazione dei comuni nella Grande Genova, compaiono esistere
ambedue le nostre piazze (classificate di 5a categoria) ma ambedue soggette ad
essere variate essendovene una corrispondente omonima nel Centro.
- Nel 1933, Novella ed il Pagano, confermano
ancora la presenza di ambedue, logicamente sempre da via C.Colombo verso il
mare; era di 5.a categoria con un civico la prima e tre la seconda.
- Il Pagano cita al 5r di piazza Peschiera (che però non esiste da noi,
presumo sia stata Pescheria) di un altrettanto non meglio specificato club “cooperativa Pescatori ed amici”; ed al
civ. 8 la tipografia di Reale Federico
(vedi anche in via P.Cristofoli); e il calderaio Casazza del 1921
Non
c’è accordo:
a)--- Lamponi propone decisamente essere
stata titolazione della piazzetta dei Minolli; a mie mani ho nulla per
smentirlo se non la deduzione fatta prima e che in quegli anni essa aveva già
un nome: piazza Savoia.
b)
considerato che in un documento d’archivio datato inizi 1900, la pescheria
municipale era al civ. 50 (di allora), e che il teatro Ristori era –sempre per
la numerazione di allora - al civ. 26; il palazzo municipale al 56-58-59, e
quello del sale al 61, che il Grosso (di cui sotto) aveva case al 39 e 42-3-6:
si può localizzare quindi, subito prima a levante del palazzo comunale, in
corrispondenza ove ora dove c’è il
palazzotto della Salvamento.
c)---Nel Pagano/1921 compare al civ. 1 di piazza Pescheria, l’officina meccanica di Casazza Angelo
& figlio – lo stesso sarà nel Pagano/1933 - lavorazione in rame
ed altri metalli.
L’officina dei calderai
Casazza, sappiamo era in fondo a via Colombo, sul fianco ad est del palazzo con
attuale civico 52, allora tutto di proprietà del Casazza Angelo: e quindi potrebbe
essere in questo tratto la Nostra piazza – ancor oggi senza nome proprio,
facente parte di via SPdA, posizionata meno di cento metri prima che finisca e
di fronte ad ove sfocia via Pacinotti.
Nel Pagano 1933 è sempre
Casazza Angelo e figlio; ma in Piazza Pescatori 1 di SPdArena; telefono 41-124.
Vedere foto specifiche.
Forse lo stesso Casazza Angelo – ma non credo – e
quindi un omonimo, che in questa data ha stampato un opuscolo –numero unico- per la chiesa
della Cella, ove si dichiara «Arti grafiche Sampierdarena - soc. an. –
stabilimento cromo-lito-tipografico – stampati di Lusso e Commerciali /
Forniture complete per Uffici / Cataloghi illustrati – Opuscoli / tricromie –
Etichette in rilievo; impianto speciale per la Lavorazione di Scatole—Fornitori
delle Scatole per lo Zucchero di Stato. Telef 49.25».




proprietà della Civica Biblioteca Gallino


tubo di ferro sagomato, lungo 7 metri
Queste due denominazioni, in epoca sconosciuta furono soppresse e le
piazzette furono incorporate con via C.Colombo.
DEDICATA a: San Pier d’Arena, fin dal più antico, è sempre stata terra di abitazione di
pescatori, dai tempi della cappella votiva a san Pietro -poi divenuta di sant’Agostino alla Cella - quando la spiaggia
era praticamente deserta, alla creazione
del porto che ha distrutto in pochi mesi più di mille anni di storia.
Regolamentazioni più precise si hanno da
dopo il 1100 con la conservazione
dei documenti: è di allora il nome del
lastrone piatto e levigato generalmente
di lavagna, tipica dei monti liguri su cui i pescatori poggiavano la merce
(valeva anche per il grano, l’olio ed altre merci), detto “clapa o ciappa” e,
da lì “chiappa” per indicare poi genericamente e tipicamente la pescheria (a Genova abbiamo la zona della Chiappella,
vico e porta delle Chiappe, salita Chiappa e Chiapparolo ,piazza Chiappazzo
e via Chiappeto e Chiassaiuola).
Come vi venivano battuti
i pesci venduti ancora vivi, era divenuto oggetto di berlina e quindi di
punizione far battere più volte il sedere su un lastrone similare: le
cosiddette “patte in ciappa“ (nato per i pescatori che non si attenevano alle
regole, si estese anche per i debitori comuni, i falliti, i ladruncoli, i servi
infedeli o che comunque non stavano al loro posto -maschi e femmine-: dal
mercato ittico un lastrone fu portato a Banchi e negli altri mercati, affinché
le punizioni di sculacciata passiva fossero di pubblica visione).
Già nel 1200
e fino oltre il 1400 i pescatori
erano dotati di strumenti come “canne, scandagli, bilance, nasse, tramagli,
rezzagli, palamiti (o palangari), sardare (o sardellare), sciabiche e tonnare;
ma soprattutto di reti che costituivano un bene patrimoniale soggetto a
vebndite, eredità o affitti alla pari di case e terreni”.
Più fitte e precise le leggi dai primi anni
del cinquecento, soprattutto al fine di proteggere la popolazione dall’abuso
della vendita di prodotto non fresco; così, appena sbarcati, per vie obbligate
e senza intrattenersi per vendere a privati, dovevano raggiungere le pescherie,
pena sanzioni e sequestro; non potevano
farsi sostituire sul mercato da altri rivenditori se non dopo un certo orario;
dovevano mantenere un contegno senza schiamazzi; potevano alzare i prezzi solo
nei giorni comandati di magro; i pesci “posi” del giorno prima dovevano essere
segnalati; punizioni varie erano previste per gli inadempienti , come dapprima
multa, poi raddoppiata, poi tratti di corda, ed infine addirittura galera.
È del
1692 una ‘grida’ del Magistrato dei
provisori delle Galere, da leggersi “ne luoghi soliti e consueti, e
particolarmente anco in la Chiappa doue si sogliono vendere i Pesci, nella
Piazza del Guastato, nelle spiagge della Foce e di San Pier d’Arena…”: nel foglio vengono stabilite le pene contro i
trasgressori delle disposizioni, e contro i frodatori della gabella sui pesci:
da 5 anni di bando o ‘relegatione’ a 2 anni di carcere o ‘galea’.
Secondo tradizione,
furono i pescatori di San Pier d’Arena
che soccorrendo una nave in tempesta, oltre ai naufraghi salvarono una
statua della Madonna che portarono in chiesa
(pare proveniente dall’oriente, fuggita dalla furia distruttrice -già iniziata nell’VIII secolo- degli Iconoclasti;
ma gli esperti la fanno risalire ad arte del seicento). Per tre volte la sacra
effige scomparve dal sito, e fu ritrovata su un castagno a Coronata:
interpretando la volontà divina, fu
lasciata nel santuario.
Dello studioso Armando Di Raimondo il
ritrovamento di un esposto fatto scrivere nel 1778 dai pescatori del borgo, contro De Marini G.B., Magistrato
della Polcevera, residente a Rivarolo; nel loro esposto, segnalano che pretendeva
quotidianamente per sé, famigli e collaboratori, approvvigionamento di pesce
fresco a prezzo così stralciato da non essere conveniente se non per dovere di sudditanza.
La questione andò al Senato che chiamò il Magistrato: egli si difese in modo
arrogante e – da nobile intoccabile – negando ogni abuso e disprezzando
ironicamente i poveri sudditi.
Ma è da un nostro concittadino, Rebora, e dai suoi studi che si
sente smentire che la pesca era l’alimentazione preferita dai sampierdarenesi;
essendo invece preferenziale come alimentazione, la pastorizia e gli animali da
cortile.
Nella Pieve di s.Martino
esisteva un altare apposito e gestito da loro con i proventi del lavoro
domenicale (è descritto nella guida del CentroOvest-Remedi).
Già dal 1925
sull’arenile di Prà, si organizzò un Palio marinaro tra cittadine e paesi
limitrofi, laddove i pescatori esercitavano la loro valenzia e forza muscolare:
la passione per queste sfide era molto sentita, e rappresentavano l’attrazione
più forte. Cosicché dopo la guerra, nel 1955, il Comune di Genova istituì il “Palio di san
Pietro” (oggi Palio di Genova) nell’ambito di una più vasta
manifestazione “Vita all’aria aperta”. Allo scopo si dotarono i
12 singoli concorrenti (Voltri=verde; Prà=rosso; Pegli/Multedo=bianco.granata;
Sestri=bianco.nero; Cornigliano, SPd’Arena=bianco verde; Foce/sGiuliano=rosso
blu; Boccadasse=, Sturla/Vernazzola=giallo; Quinto=blu; Nerv=arancio; sIlario)Capolungo=viola),
di un gozzo da regata (a 22 palmi; in legno di mogano e cedro;
costruiti tutti eguali in un cantiere di s.Margherit; lunghi m.6,5; pesanti 300
kg;). La prima
domenica di giugno, 4 vogatori locali (di
punta) ed un timoniere (alla guida di
scia ovvero vogante in piedi col volto in avanti); da
davanti alla chiesa di s.Pietro (patrono e protettore dei marinai (escluso
1996 a PortoAntico; 1997 e 2000 a calata Zingari; 1998 alla Foce;1999 a Nervi;
2000° Prà) vogano per
un miglio marino (= tre giri di boa) per infine arenarsi
per far salire il ‘mozzo d’arrampicata’ scaòlando la corda ad infilare la
bandierina nell’apposto vaso posto alla sommità di un rialzo di 4-5 m. Nel 1986
i gozzi in legno furono sostituiti da quelli in vetroresina, lunghi 5,65 e
pesanti 195 kg. Ed eliminata la ‘scia’. Il vincitore, per un anno tiene il “Batacchio
bronzeo” del XVI secolo – scuola del Cellini- che ornava il portone nord del Palazzo
del Principe e regalato dagli eredi


la zona fotografata testimonia la teoria c)
come localizzazione


malgrado l’intestazione della cartolina, metto la presenza a distanza del pontile di
Giunsella
in
discussione sia la nostra spiaggia per quel testimonierebbe giusta la
localizzazione c)
pontile in mare che non abbiamo mai avuto


BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale palazzo Xducale
-Archivio Storico Comunale
- Toponomastica schede 3411 e 3417
-Benozzi.Caminata-L’Oratorio
di Coronata-Inchiostri Ass..1999-pag.48
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.51
-DiRaimondo A.-La
Podestaria di Pol.-Bollettino ACompagna-1/2010-p.5
-Lamponi M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag. 68
-Maira Niri M-La tipografia a Genova…-Olschki.1998 -
pag.471
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto
bibl.Berio.1930circa-(pag.18)
-Pagano/1933-pag.248.873
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di
ge.-Tolozzi.1985-pag.1437
-Pescio A.-I nomi delle
strade di Genova-Forni.1990-pag. 92.268-9
-Raimondi P.-Proverbi
liguri-ed. LaStampa1992-pag. 9
PESCE via
Pierino Pesce
TARGHE
via – Pierino Pesce – caduto per
la Libertà – privata - 1898-1.5.1923




QUARTIERE ANTICO: Canto
N° IMMATRICOLAZIONE: 2825
CATEGORIA. 2
 Da
Pagano 1961
Da
Pagano 1961
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 47200
UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007. In giallo via TMamiani
da Google Earth 2007. In giallo via TMamiani
CAP:
16149 (primitivamente era 16151)
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STRUTTURA: senso unico stradale, da via T.Mamiani a via
F.Avio.
Strada comunale carrabile, lunga
48m e larga m.8,90, con due marciapiedi larghi m. 1,22.
Nel novembre 03 la strada si
legge nell’elenco delle ‘vie private di interesse pubblico’ e quindi in
programma di municipalizzazione gratuita per, in cambio, manutenzione e servizi
vari come l’illuminazione, cassonetti della spazzatura, fognatura. L’elenco fu
ripubblicato nel 2004; ma nel 2011 ancora tutto appare fermo.
STORIA:
La strada nacque nell’area prima occupata da capannoni industriali dell’impresa
di GB Carpaneto; è quindi praticamente presente, dai tempi della formazione e
nascita di via F.Avio (vedi), ma evidentemente rimase senza un nome finché la
Giunta comunale deliberò la denominazione attuale il 26 aprile 1946.
CIVICI:
2007= da 1 a 13 e da 2
a 20
essendo la numerazione senza distinzione tra neri e
rossi, e non esistendo portoni di abitazione, tutti i civici vanno intesi come
rossi.
===civ. 5
: Dal 23 maggio 1980, inaugurata dall’allora sindaco Fulvio Cerofolini, ha
ospitato la sede dell’archivio storico dell’Ansaldo - poi trasferito a Fegino
di Cornigliano nell’apposita villa Cattaneo-Dell’Olmo- con tutti documenti
sulle attività dell’industria, e che hanno
fatto oggetto di una annuale pubblicazione di un libro storico
specifico.
===civ.6
il bar, che nel 1950 era di Pizzorno G.
===civv 1-3-5-7 furono assegnati a nuova costruzione del 1975
===civv
7-9-11 erano le porte di uscita di sicurezza del cinema-teatro Politeama
Sampierdarenese eretto dove ora è il grosso moderno edificio a levante della
strada che si apre in via Avio; furono soppresse nel 1972.
I nuovi 9-11 furono assegnati
a porte prima senza numero, nel 1988.
===civ.16r nel 1961 era il bar Colombia; quando poco vicino c’era un chiosco
vendita-rifornimento di benzina BP.
DEDICATA
all’operaio nato a Visone (AL) nel 1898, da anni residente ed operaio, noto in
città e soprattutto a Cornigliano quale attivo organizzatore comunista delle rivendicazioni operaie. Fu uno dei
primi martiri comunisti, contrapposto ai martiri fascisti creatisi negli
scontri di strada provocati dalle squadracce nere, forti del numero, dell’arroganza
e della protezione ‘in alto’: vincere intimorendo l’avversario con la violenza
era uno dei sistemi per sradicare l’avversario (distruggere i centri di
organizzazione incendiando-saccheggiando le sedi; seminando violenza, e quindi,
spesso, la morte).
Il primo maggio del 1923, festa dei
lavoratori, a Coronata avvenne uno scontro con i fascisti, emergenti per
violenza e numero: riconosciuto, fu isolato, catturato, percosso (e forse
torturato per strappargli informazioni), sino alla morte.
Tale
esecrabile avvenimento, passò quindi nel silenzio perché le autorità cittadine
erano già schierate contro gli antagonisti del regime fascista; per cui ovvie
le già in atto proibizioni di pubbliche attività da parte di qualsiasi
organizzazione, e chiusura delle varie associazioni cattoliche, operaie e
ricreative; arresti per i militanti dei partiti avversi e dei -per loro-
sovversivi; nonché scioglimento dei Consigli comunali (anche a Sampierdarena
avvennero delle dimissioni “spontanee”,
giustificate con la “inutile presenza di elementi socialisti che essendo
contrari alle istituzioni, non tornano a vantaggio del Comune...e darebbero
esca a violenze inutili...(seduta del 23 sett.1922)”.
In
questo clima, di autorizzazione ad aggredire tutto ciò che non era “orbace”, il
fatto che nel giorno della festa dei lavoratori un noto attivista rosso fosse
sopraffatto e picchiato a morte rientrava in una volontà di normalità che - per
chi dirigeva- neanche meritò un’inchiesta giudiziaria.
Gli iscritti al partito fascista, forti di
questa protezione, iniziarono a “regolare i conti in sospeso” con azioni di
squadra, mirate ad imporre il volere
emergente ed eliminare sia i simboli che il nemico stesso : così divenne cronaca
quotidiana “ scacciare e mettere al
bando tutti gli avversari che osano resistere”.
Nella ‘cronaca genovese’ del bollettino
municipale ‘il Comune di Genova’ si riporta : “martedì 1° maggio – sulla
collina di Coronata, in seguito a violento alterco fra due comitive di
giovinotti, rimane ucciso da un colpo di rivoltella il ventiquattrenne Pietro
Pesce, comunista.” .
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 3414
-AA.VV.-Annuario,
guida Archidiocesi-ed.1994-pag.429;ed.2002-pag.466
-AA.VV.-40°
Anniversario della Repubblica-ATA.1986-pag.148
-AA.VV.-53°
Spd’A
-Genova-
bollettino municipale- 6/23.714
-Gazzettino
Sampierdarenese 5/82.2
-Il
Secolo XIX del 25.11.03 + 23.08.04
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag. 110
-Pagano
–Annuario genovese/ed.1961-pag. 329.446
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.1436
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav. 33
-non
citato su Ragazzi
Corallo-Chiavari-pag.227
AAVV-contributo di SPd’A
PICCARDO via privata Piccardo
Il nome, non ufficiale comunale, fu
popolarmente accettato per indicare l’accesso (nell’attuale via L.Dottesio)
alla proprietà del Piccardo, a cui si risaliva tramite l’attuale via
Malinverni-via G.Balbi Piovera, e che oltre alla villa, portava anche alle
suore di Carità.
Il Piccardo fu un
imprenditore divenuto assai benestante e proprietario di tutta la zona a monte
dell’attuale via Cantore, da via S.B.d.Fossato a via B.Piovera. In alto ove ora
è il grattacielo, aveva la villa.
L’imprenditore a fine
1800 decise regalare al Comune – forse
in cambio di altri privilegi non conosciuti - il terreno necessario per aprire
la strada oggi Balbi Piovera e poter così raggiungere l’ospedale altrimenti
inutilizzabile con agilità per le ambulanze trainate a mano (alternativa
sarebbe stata la ‘crosa Imperiale’ che, in linea diretta dal nosocomio a via
Daste (ove era un cancello per entrare nella proprietà)
comprendeva: via GB Botteri (senza i tornanti in alto)- angolo
a ponente di via BPiovera e di via Pittaluga-via Malinverni).
BIBLIOGRAFIA
-Genova -Rivista municipale
PIERAGOSTINI via Raffaele
Pieragostini
TARGHE:
via Raffaele Pieragostini –
caduto per la libertà – 1899 – 23-4-1945


a fine strada presso il Ponte


 inizio strada, angolo con Largo
Jursé
.
inizio strada, angolo con Largo
Jursé
.
QUARTIERE
ANTICO: Ponte
 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2826
CATEGORIA: 2
 da Pagano
1967-8
da Pagano
1967-8
CODICE
INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 48120
UNITÀ URBANISTICA:
24 – CAMPASSO
26 - SAMPIERDARENA
 Da Google Earth 2007
Da Google Earth 2007
-in fucsia, il ponte di Cornigliano; rosso, via Eridania
e giallo, via P.Mantovani; celeste, via T.Grossi;
marrone, largo Jursé.
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco (nel Pagano 67-8 è attribuita a fantomatica
s.Giacomo; in quello precedente è di s.Gaetano)
STRUTTURA: ampia
strada a cinque corsie (3+2), a doppio senso
veicolare, che congiunge largo E.Jursè (alla
Crociera), con il Ponte di Cornigliano (fino a metà, dalla Madonnina).


la strada da tetto del gratticielo – anno 2002
È
fornita dall’acquedotto Nicolay.
STORIA: Nelle
prime carte dalla seconda metà del settecento, la strada già esiste importante,
ma anonima; in quei metri era circondata da terreni ricchi d’acqua incanalata
da essere capace di muovere le pale dei molini, e coltivati a frutteti ed orti (tra i più fertili della regione: come la piana d’Albenga ora).
Dalla carta del Vinzoni, 1757, la strada ovviamente è anonima; appare
circondata dalle seguenti proprietà:
--a
nord, e dal ponte verso est- del sig. GB Grondona; + dei mag.ci fratelli
Veneroso (con casa sulla strada.
Non sappiamo chi furono; a Genova vengono descritti alcuni divenuti importanti:
un Hieronimo (Gerolamo) Veneroso, 1691-1726,
divenne doge -dei biennali, con berretta e corona regia- nel 1725; ma morì
l’anno dopo. Invece suo figlio, GioGiacomo, fu doge dal 11.6.1754-6: nato da
Giulia Rivarolo il 6.4.1701; ebbe un figlio Gerolamo anche lui; fu dapprima,
assieme al padre che era commissario, a sedare le rivolte della Corsica; poi
Magistrato della Mura, doge, di nuovo MdM progettò piazza Acquaverde, poi
MdGuerra; morì a Chiavari il 17.XI.1758. Non è scritto per nessuno dei tre, che
avessero dei fratelli) + parte di quella vasta proprietà -da arrivare sino a vCRolando-
dell’ecc.mo Domenico Spinola.

Nella
foto sopra, scattata nelle prime decadi del 1900, compare a sinistra una villa, (dalla
struttura seicentesca; sulla carta vinzoniana
compaiono, sulla strada: nel terreno dei Grondona, un molino (e quindi
non sarebbe); in quello dei Veneroso una casa di proprietà di R.do Ambroggi. Se
ne dedurrebbe che fosse dei Veneroso, visto la loro importanza, ma un ramo
collaterale di quelli su descritti. Si legge che dopo, divenne una proprietà
dei Serra, anche loro non specificati meglio (vedi sotto al civ.5)).
--a sud invece, la proprietà del rev. Stefano Ferrari, con sei case sulla strada: le
prime due di sua proprietà; la terza del mag.co Crosa;
quarta e quinta del mag.co Caste(llo), la
sesta dei Veneroso.
Come appare nel 1846 su una carta ora all’Archivio Storico Comunale, il pezzo dalla
Crociera al ponte, viene chiamato
genericamente “strada Provinciale
di Ponente”.
Il primo nome della via, in
origine di memoria fu ‘via san Cristoforo’ (vedi): per tutto il tratto dalla zona Mercato (dietro palazzo Carpaneto,
inizio di via C.Rolando) al ponte; a conferma, il
regio decreto del 1857, la cita (per
esso la strada della Marina arriva sino alla Crociera) con questo nome.
Nei primi anni dopo la prima grande guerra, 1918-9 circa, il Consiglio comunale di san Pier d’Arena
volle cambiare la titolazione in “via Cesare Battisti” (vedi), ancora tutta estesa dal ponte
alla villa Carpaneto.


da via Pacinotti, lo stabilimento
Molini Alta Italia foto
Pasteris 1911
in basso, un ingresso Ansaldo
Ma con l’avvento della Grande Genova, per
evitare doppioni con l’omonima del centro, la
lunga strada fu spezzettata in più parti ed il tratto corrispondente -con
delibera del podestà del 18 ago 1935- fu battezzato “via
Monte Corno” (vedi).
Sulla parte a mare sul ponte c’era la
costruzione del dazio, per la esazione della
tassa comunale (con peso pubblico per veicoli da carico); controllava anche lo scalo treni a monte (solo merci, ed a piccola velocità); cessò la sua
attività nel 1945 circa.


barriera del dazio
Nel punto di passaggio tra strada e ponte,
dove a monte ora si innesta la strada lungo il torrente (via Perlasca), fu
aperta una stazione ferroviaria (nel 1967,
civico nero) detta ‘scalo merci piccola
velocità’ (Nel 1933 la città vedeva
due stazioni merci, una questa: denominata PV e quella del Campasso, ove
arrivavano veicoli o merci in piccole partite senza vincolo di peso. Nel 1963 è
chiamata “di Genova-Campi (per merci)”).
Le merci arrivate per ferrovia vedevano il trasporto e la consegna in
città tramite società in possesso di camion; una di esse descritta nel Pagano è
la soc.an. Lanati E.& C. (con una sede
anche a Terralba. Forse la genitrice della più potente omonima casa di
spedizioni con sede negli anni ‘60 in via Balleydier, 50).


piazzale d’ingresso all’area lato verso il torrente



area scalo merci verso nord
In terreno della ferrovia, prospiciente
sulla strada a monte del ponte Cornigliano, c’era una palazzina a due piani,
eretta nel 1945 poggiando su grossi plinti poligonali essendo la base il
terreno sabbioso del torrente; in esse c’era un bar eufemisticamente chiamato bar 2000 (nel
1950 di proprietà di Albalustro P.), ma
che fu demolito alla fine del 1995 per lo sbocco della nuova strada.
Dopo la seconda guerra mondiale, con
delibera della Giunta comunale la via (5 luglio 1945) e lo slargo iniziale (24 apr.1956), furono dedicate ai partigiani Pieragostini e Jursé.
CIVICI
Nel
1965 fu adottata la numerazione continua, ma ancora negli anni 70 venivano
distinti i colori.
Nel
1969 fu assegnato il 61. Nel 65, a nuovi
edifici, dal 25 al 55.
2007=Uu24=
NERI = da 1 a 73 (compresi
65ab, 73c; esclusi 11,13,19,21,23).
ROSSI= nessuno
UU26=NERI = solo civ. 80
A mare si
apriva la vecchissima strada di ‘via al Ponte di
Cornigliano’ poi inglobata nello stabilimento
Ansaldo; di esso ora (giu/02) rimane solo il cosiddetto ‘palazzaccio’ che
ultimamente ha ospitato a lungo la ‘Ansaldo Industria’ a sua volta composta da
varie aziende che, iniziato nel 1997 lo smembramento, sono autonomamente
ciascuna in via di trasloco verso il WTC,
la Torre Shipping o altrove.


anno 1990 – la facciata su via
Pieragostini


anno luglio 2000 la facciata del
CCRT lungo via Pieragostini


anno dic. 2000, tutto demolito
2003 - unico rimasto
===prima
della demolizione di tutti gli stabili per fare il ‘complesso della
Fiumara’, sulla strada si affacciva il
lungo stabilimento della ‘CCRT Cavi’.
===rimane
il fianco del più vecchio – restaurato - palazzotto dell’Ansaldo STS, che si apre in via Mantovani.


===civ. è il penultimo nato nel complesso: il
grattacielo –fatto a schermo televisivo (vedi foto da google)- detto ‘Torre Selex
Comunications’. In alcuni piani si elaborano progetti di natura militare
e quindi soggetti al vincolo del segreto.
I civv. a mare furono soppressi nell’anno
2000 per demolizione.
A monte
Nella
pianta del Pagano/67, i civici 1 e 5 sono a est di via T.Grossi; e subito ad
ovest di essa c’è il 15
===civ. 5
fu eretto nel 1906. Ancora agli inizi del 1900, nel suo sedime esisteva un
‘palazzo Serra’, con le fattezze esterne della villa sei-settecentesca (aspetto
cuboide, con tetto di ardesie a cupola), non descritta in alcun libro e
visibile nella foto sopra. Non abbiamo trovato a quale Serra appartenne (erano
dei Serra quella poi Monticelli di via della Cella; e quella Doria
Serra-Masnata di via Cantore).
===civ. 1r il caffè Ligure.
Ancora presente nell’elenco SIP del 1971.
===civ. 5r nel 1950 c’era la
trattoria di Riccardi E.
===civ.
9r nel 1950 c’era il bar di Pesce R.
===civ.
15r nel 1967 lampadari e fonderia artistica
Vaccari Valerio
===civ.17r nel 1950 c’era la trattoria di Ricci V.
===civ.
67 ancora nel 71 c’era l’Istituto Nazionale Trasporti
===civ.
71 ancora nel 71, la cooperativa Nino Repetto
DEDICATA al partigiano nato a San Pier d’Arena il 5
mar.1899 (controversa è la data precisa: alcuni dicono 3 maggio) da Giuseppe
(operaio alla fonderia di Multedo, e residente in via Daste in una modesta
casetta al civ. dove ora è apposta una
lapide; militante socialista, indirizzò il figlio ai principi mazziniani
facendolo partecipare alle riunioni di partito) e
da Gatti Clotilde. Ebbe una sorella di nome
Colomba.
Col padre frequentava i circoli operai e si
imbeveva dei discorsi di PChiesa, di L.Calda, dell’Internazionale e dell’Inno
dei Lavoratori.
Instradato così politicamente dal genitore,
seppur molto attirato dagli studi, per ragioni economiche dovette andare a
lavorare nella bottega di artigiano di uno zio, fino a che arrivò all’epoca del
servizio militare –1917- che svolse come motorista dell’aeronautica, al
deposito aviatori di Torino, senza prendere impegno alcuno al di fuori di questa
attività. Solo dopo il congedo –1920- ed al rientro a Cornigliano, trovato
lavoro –1922- come operaio alla san Giorgio di Sestri Pon. si iscrisse al
Partito comunista, allora già
clandestino, partecipando attivamente e responsabilmente attivandosi in prima persona
(anno in cui il PNF iniziò la ‘legalizzazione’ del suo operato). Intanto si era
trasferito di casa a Cornigliano in via della Libertà.
Nel 1925 venne scelto come coordinatore del
congresso provinciale genovese (in preparazione di quello internazionale a
Lione) entrando a far parte della dirigenza del partito a cui dovette
dimostrare estrema fedeltà adoperandosi in mille impegni di media importanza
(incarichi cospirativi, università a Mosca e Spagna, centro estero a Parigi).
Raccolse così varie condanne dal Tribunale
Speciale, tra cui una di 5 anni di detenzione nel febb.1929 inflittagli a Roma
ed incarcerato a Padova il 21 luglio (conseguente ad un arresto avvenuto il 6
nov. 1927, accusato di aver ricostituito il partito comunista che già era stato
“schiantato” assieme agli anarchici dal nuovo regime con le leggi speciali del
1926). Ne scontò una parte, uscendo nel
nov.1932 per amnistia ai detenuti
politici, in corrispondenza del decennale fascista. Per 2 anni -1933-4-, visse a Genova, non riassunto dalla san Giorgio ed occupandosi in
una officina sampierdarenese.
Agli inizi
di sett./1935, su richiesta del partito, espatriò in Francia da dove a novembre
col nome di Gianni Licarini, da LeHavre partì per Mosca. Qui frequentò per tre
anni la scuola universitaria leninista (organizzata come un collegio, a gruppi
di 20, insegnava unità e continuità ideologica a tutti i fuoriusciti, futuri
dirigenti; studiavano la filosofia marxista, economia politica, leninismo,
storia operaia internazionale e locale, storia del pensiero, rivoluzione
francese e russa, il PCI e lingue); e poi frequentò l’accademia militare
Tolmaciov di Leningrado (corsi di teoria
militare). Lasciò l’URSS nel marzo 1938.
Intanto, nel gennaio/1938 il Tribunale
Speciale lo aveva ricondannato assieme ad altri 70 comunisti, in contumacia,
per l’attività e per aver firmato un articolo intitolato “per la salvezza
dell’Italia” pubblicato due anni prima su giornale francese.
Rientrato a Parigi, era considerato un
politico-militare di assoluta e provata fedeltà: pressoché subito andò a
militare (col nome di Gianni DiGiorgio; assieme a Togliatti) come combattente
volontario nelle file delle Brigate internazionali nella guerra di Spagna (il
partito fu dapprima reticente a concedergli l’autorizzazione, poi lo indicò – per un anno - quale addetto ai servizi radio di Barcellona,
e ad importanti missioni locali di partito (1936.39).
Tornato in Francia, lavorò in fabbrica; ma
nel gennaio1942 fu arrestato dai nazisti che curarono il trasferimento – 12
febb. 42 - a Roma, consegnandolo agli italiani: il Tribunale Speciale lo
ricondannò a 18 anni, di internamento: iniziò a scontare la pena a san
Gimignano, accusato sempre per reato politico, avendo continuato a mantenere
contatti con i movimenti comunisti internazionali soprattutto con quello russo
che lo aveva già ospitato.
Dopo poco più di un anno però, dopo i fatti
del 25 lug.1943 (arresto di Mussolini; governo passato a Badoglio. Si pensava
che a Roma, Badoglio ed il re sarebbero sicuramente rimasti, sotto controllo degli alleati; al contrario
il nord Italia, invaso dai tedeschi avrebbe richiesto una lotta contro essi. Il
30 ago da Regina Coeli rientrarono anche
Buranello, Fillak e tutti gli altri), fu scarcerato il 18 agosto.
Rientrò a Piòvera (AL) dove viveva la madre
sfollata; ma pochi giorni dopo era a Genova con l’investitura ufficiale già
decisa a Ventotene: di segretario della Federazione locale, ovvero di dirigere
i comunisti genovesi e savonesi. Fu il primo a dedicarsi alla reazione attiva,
alla ‘svolta militare’, mettendola in atto secondo i rigidi insegnamenti
ricevuti, di estrema osservanza alle direttive centrali. Dovette scalzare dal
comando gli operatori preesistenti (in particolare il dirigente Dellepiane, che
–non arrestato- aveva però ‘vivacchiato’ adattandosi e sopravvivendo nelle
estreme difficoltà locali senza un progranna né una visuale più vasta; definito
inopportuno ‘attesista e quindi opportunista ed indegno di militare nelle fila
del partito’, venne eliminato al vertice).
La prima
riunione per riorganizzare il partito fu il 24 ago 43 in una trattoria sulle
alture di SBdFossato (Promontorio?), fino alla sua elezione a segretario
politico del comitato federale genovese.
Il giorno
dopo l’8 settembre, nella confusione generale, la riunione fu al Campasso nel
retrobottega di Achille Marsanasco: l’epicentro storico dell’organizzazione comunista genovese fu in
piazza Masnata: qui conversero tutti i responsabili del partito e fu decisa
l’attività armata partigiana di scontro
sociale, militare, politico ad oltranza (non lavorare, sabotare la produzione
di guerra, interrompere ogni relazione tra operai e occupanti) contro i
tedeschi ed i fascisti di Salò, coordinando la nascita dei movimenti di
resistenza partigiani di montagna e cittadini (nacquero a fine ottobre i GAP
‘gruppi di azione patriottica’ (che nell’ottobre iniziarono uccidendo un
capomanipolo della milizia sestrese, ed a gennaio ’44 due ufficiali tedeschi
con conseguente fucilazione di 8 antifascisti incarcerati); ed i ‘comitati
clandestini di agitazione’). Si scrive che il 20 settembre 43 a villa Scassi si
incontrò con i proclamatori dello sciopero dei tranvieri, per coordinarli ed appoggiarli con atti
dinamitardi sulle rotaie; nella seconda metà di ottobre fu sostituito alla
dirigenza, da R.Scappini (che raccoglierà poi la firma di resa tedesca); a lui
viene assegnato la organizzazione del partito per tutta la provincia.
Nel giugno 1944 fu nominato Ispettore
regionale del T.I.I. (Triunvirato insurrezionale internazionale del PCI), con
l’incarico di difficilissime e sofferte decisioni (tipo quella di ordinale la
fucilazione per rappresaglia di cento prigionieri , 80 tedeschi e 20 fascisti:
i tedeschi avendo subito sette morti in una azione dei GAP genovesi, avevano
ordinato la fucilazione nel campo di concentramento di Fassoli di 70 detenuti),
e di abile sarto nel cucire le necessità della città (con una visione
‘nazionale’) e della montagna (con necessità più spicciole e locali).
Promosso al grado di tenente colonnello,
dal 1.7.44 il PCI elesse il gen. Rossi Cesare quale comandante e Pieragostini
fu vice comandante regionale della
sezione operativa in seno al Comando militare regionale (il CMR era composto da
7 membri, uno indipendente (il comandante, gen. Rossi) , e gli altri
corrispondenti ai vari partiti politici presenti: per i comunisti il nostro
(col grado di vice comandante), socialisti, partito d’azione, liberali,
repubblicani e democrazia cristiana. Designati dal CLN Ligure (comitato di
liberazione nazionale), divennero i coordinatori delle varie zone belliche
regionali: Pieragostini in particolare, riuniva periodicamente tutti i
comandanti operativi della zona (divisione Cichero, 58a brigata, 3a brigata,
brigata di manovra, 57a brigata, brigata
Giustizia e libertà , divisione Lombardia)).
Il 23 settembre 1944, lo vediamo presiedette
un convegno di tutti i comandanti di brigata al fine di dare ordine alla
‘guerra per bande’, ciascuna slegata alle altre dopo i rastrellamenti; fu costituita
la nuova ‘brigata Oreste’, il cui comando si stabilì a Rocchetta Ligure
Infatti il nemico reagiva alle stimolazioni
con i noti rastrellamenti sui monti, riaprendo una ferita organizzativa, non
ancora messa a fuoco: furono di nuovo necessarie intense consultazioni per
ricostituire l’organico. Girando tutto il territorio ligure, riuscì a dare
l’impronta militare a tutte le
formazioni partigiane, specie durante il rastrellamento nella zona di Gorreto
(ago-ott 44) dove personalmente ed attivamente partecipò alle fasi di
sganciamento, guadagnando la stima di tutti.
Col soprannome di Lorenzo Rossi, distinto
rappresentante di azienda manufatturiera sita oltre la linea gotica, può andare
ad appuntamenti vari senza destare sospetti; può interessarsi di relazionare su
tutte le iniziative politico militari -nazionali ed internazionali-; di
stabilire i compiti delle varie formazioni partigiane anche extra regionali
(dal 1 ott.43 al 30 giu.44 fu ufficialmente ‘capo servizi collegamenti’ di
2mila uomini); di preoccupandosi di riunire tutti i commissari del PCI (partito
comunista italiano). Lo scopo era di organizzare operazioni atte a creare nel
nemico permanente stato di allarme ed insicurezza; anche nei momenti terribili
dei rastrellamenti, cercò di favorire le situazioni di sganciamento e ricupero,
sottolineando delle capacità militari e dimostrandosi scrupoloso osservatore di
tutte le varie componenti di ciascuna operazione bellica -dal cibo ai
rifornimenti, dai sabotaggi alla costituzione di “squadre volanti” aventi il
principale scopo di colpire in aree cittadine, compresa la famosa “giornata
della spia” (30 nov.44).
Questa vita intensa, pericolosa e violenta,
ben poco gli concesse agli affetti personali quali il semplice manifestarsi
alla compagna della sua vita (Lina Fibbi, pure lei organizzatrice dei GAP):momenti fugaci,
rapiti ai bombardamenti ed al tipo di
vita di ambedue; da una sua lettera dal carcere, scrive di “aver cura del
nostro prossimo figlio...educalo alla scuola di suo padre e alla tua, e
chiamalo Gianni”.
Attivamente ricercato, fu fatalmente
catturato il 26 dic. 1944 (Pastine scrive a marzo del 1944; Antonini “a partire
dal 1° dicembre”) assieme a quasi tutta la direzione dell’antifascismo ligure:
tal Leopoldo Trotti, il generale Cesare Rossi, il col. Alfredo Amoroso ed il
Nostro (per aver commesso l’imprudenza di essersi recato a casa un compagno che
aveva mancato ad un appuntamento perché appena arrestato: la casa era
sorvegliata dagli agenti del commissario Veneziani). Furono incarcerati nella
sez. IV di Marassi e sottoposti a processo (che
Pastine giudica illegittimo perché i membri
giudicanti -essendo militari dipendenti dal legittimo governo regio, e
fedeli ancora per giuramento al re- avrebbero dovuto riconoscere lo stato di
prigioniero di guerra e non di morte come invece voleva la legge militare) che si concluse con diverse condanne a morte, eseguite con rapidità.
Pieragostini, marcato col n° 2959, giudicato
prigioniero ‘eccellente’ (ovvero utile per eventuali scambi nell’atto del
ripiegamento), fu intanto sottoposto quotidiamente -per 4 mesi- a torturanti interrogatori
nella ‘cella di rigore’ del primo piano della Casa dello studente a san Martino.
Tanto resistette e dovette subire, fino al
momento che il nemico nel pomeriggio del 23 aprile 45 e nella persona di Hengel
attuò la ritirata, in fuga verso il Brennero, con le SS tedesche ed italiani
-con famigli- al seguito. Allo scopo, fu usato come ostaggio assieme ad altri
25 detenuti (tra cui anche il gen. Ernesto Rossi; fra essi politici e membri di
missioni alleate, chiusi in una corriera partita da Marassi alle 15,30 del 23).
Seppur gravemente denutrito, tumefatto dai pestaggi, ferito e piagato,
rappresentava - come tutti gli altri - pur sempre una importante pedina di
scambio in caso di scontri con i partigiani.
Dopo pernottamento a Novi, il giorno dopo,
quando la colonna si trovò poco prima di Bornasco (PV) -una frazione di Vidigulfo nel
pavese- fu attaccata da aerei americani (o inglesi): fu colpita anche la corriera
con i detenuti uccidendo il gen.Rossi, mentre il Pieragostini benché
ammanettato ed incatenato con l’anarchico Ponte, tentò la fuga. Ma le SS
comandate dal serg. Lungman, riparate ai bordi della strada in un fossato,
uccisero entrambi a colpi di mitraglia. I sopravvissuti invece, portati a san
Vittore a Milano, furono liberati tre giorni dopo.
In vari documenti si parla di generica
‘morte per bombardamento’ (Gazzetta Ufficiale del 4 apr.1970 per medaglia
d’oro-vedi sotto); in altri di ‘morte per fucilazione’ (foglio matricolare e
carabinieri)
In data 24 apr.1945, ignari della sua morte,
il CLN Ligure lo designò prosindaco -assieme ad un esponente del PRI - nella
giunta comunale costituenda con la liberazione di Genova (sindaco fu nominato
Faralli Vannuccio del PSI) .
Fu insignito della medaglia d’oro al valor
militare «alla memoria» per attività partigiana: “PIERAGOSTINI Raffaele di
Giuseppe, classe 1899, da San Pier d’Arena. - Patriota di purissima fede, si
dedicava fin dall’inizio all’attività partigiana divenendo uno dei principali
comandanti e organizzatori delle più agguerrite unità della sua zona e
sostenendo alla loro testa asperrimi combattimenti che procuravano al nemico,
ingentissime perdite. Nel corso di un violento rastrellamento nemico, riusciva,
grazie alla sua intelligente capacità operativa ad organizzare una brillante
resistenza ed il successivo sganciamento riordinando con energia ed abilità le
formazioni sbandate. Ricercato attivamente veniva infine catturato e sottoposto
ad atroci torture per varie settimane perché rivelasse le importanti
informazioni in suo possesso. Il suo nobile animo resistette con stoicissimo
(sic) al dolore nulla rivelando sulle formazioni partigiane e sui commilitoni e
trovando la forza di confortare i compagni di prigionia ed infondere loro la
fede nei destini della Patria. Portato quale ostaggio dal nemico in
ripiegamento e gravemente debilitato dalle gravissime sevizie subite, trovava
la morte durante un bombardamento. Si spegneva così un nobile animo di patriota
e di combattente. Bornasco (Pavia), 24 aprile 1945”.
BIBLIOGRAFIA
-Albo
dei decorati al Valor Militare-Ist.Nastro Azzurro.1977- pag.166
-Antonini
S.-la «banda Spiotta» e la BrigataNera...-DeFerrari2007-p.83
-Antonini
S.-La Liguria di Salò-DeFerrari.2001-pag.493
-Archivio
Statistico Comunale Toponomastica - scheda 3486
-AA.VV.-Annuario
guida Archidiocesi-ed./94-pag.430—ed./02-pag.467
-AA.VV.-Contributo
di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1997-pag.133.139
-AA.VV.-40°
anniversario della Repubblica.ATA.1986-pag. 101
-AA.VV.-
35° Spd’A
-AA.VV.-Vecchia
SPd’Arena e Cornigliano-Valenti.1976-pag.36
-Biga.Conti.Paoletti-I
precursori della lotta...-ANPPIA.1994-pag.502
-Calegari
M-Comunisti e partigiani-Selene.2001. pag.98.143.242.295.tutto
-Castronuovo
V.-Storia dell’Ansaldo-çaterza.1994-vol.I-pag.104cartina
-Gazzettino
Sampierdarenese : 2/91.5 +
1/96.15
-Genova
Rivista comunale : 1/45.5 +
1/49.17dice che fu fucilato
+ 4/50.27
-Gimelli
G.-Cronache militari della Resistenza-Carige.85-v.II-pag.864.948
- “
v.III-pag. 318.401
-Medulla
M.-Sampierdarena-DeFerrari 2007-pag. 22
-Pastine G.-Fuoco sulle montagne
verdi-DeFerrari 2007- pag.129
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.1457
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.21.33
-Ragazzi.Corallo-Chiavari-Sagep.1982-pag.272
-Simonelli
N.-Raffaele Pieragostini-DelCielo.1974-
-Tuvo
T.-Sampierdarena come eravamo-Mondani.1983-pag.36
-Tuvo.Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore 1975-pag.112
.
PIETRA salita (della) Pietra
via della Pietra
vicolo
della Pietra
La toponomastica non prevede specificare che
con questo toponimo si sottintendono due caratteristiche ormai scomparse (il
quartiere e la salita) più altre due ancor oggi in atto (la via ed il
vico).
Pastorino dà per certo che l’etimo proviene da
“una pietra miliare romana, oggi scomparsa”.
Mentre per gli “s”torici (quelli con la ‘s’
minuscola) è facile intuire che in questo tratto ci fosse una pietra miliare romana, dalla cui presenza
ne è derivato il nome, essendo tale cippo, purtroppo, scomparso nel tempo, agli
“S”torici appare ovvio non tenerne conto.
Combacerebbe essere il 2° miglio romano (1 miglio romano =1480 metri
circa), componendo la distanza dal ‘mercato di san Giorgio’; posta sulla linea Aurelia-Postumia, cadrebbe poco
prima del bivio: passaggio del torrente
per Borzoli, e prosecuzione verso il confine nord-ovest del territorio (limite
poi anche della Curia di SPdArena).
==QUARTIERE: Prima
del 1900, era genericamente una vasta zona (rione, quartiere) misconosciuta a troppi “Storici” qualificati.
Viene citata e quindi intesa più come territorio, che come strada precisa.
Nelle varie divisioni locali in quartieri, mai ufficializzati e quindi lasciati
all’uso del popolo, è uno dei più ricorrenti ad essere citato.
Ancora nel 1953 era tutta nel
territorio di San Pier d’Arena (escluso il civ.2 che era a Rivarolo), e
lo era da novecento anni quale uno dei nostri tre ‘quartieri’ storici.
Attualmente appare
tutta attribuita a Rivarolo.
==SALITA: Corrisponde a salita V.Bersezio.
I vecchi sampierdarenesi la chiamavano “a möntâ da prîa”,
da Rivarolo al Belvedere - e forse anche agli Angeli.
Nel registro della Curia arcivescovile di
Genova, Belgrano riporta uno scritto in latino dell’anno 1074 riguardante terreni di proprietà della chiesa di s.Siro, da
‘locare’: “...et petimus in sancto petro
in arena in loco qui nominatur bruceto de superiore capite (cioè come confine
superiore) petra nadia...” (in questa frase ci sono alcune parole che
lasciano confusione: bruceto=avente; un Bruxeto, è a Molassana. Nadia è
intraducibile ed inspiegabile; forse nigra, per la pietra di Promontorio; comunque nadia
nell’indice del libro viene data per ‘salita della Pietra’).
In una nota spese datata 1789, si legge l’acquisto da parte del Municipio, a Savona, di
7mila mattoni detti da “carroggio”, per fare il fondo della salita Pietra.
Nel 1813
vengono segnalate due ville signorili, munite di cappella privata per le
funzioni religiose: di Davilli GB posta
nella salita della Pietra, e di Piuma Domenica (i
cui eredi vedi nell’elenco dopo, al civ. 8 e 14c; quest’ultima, nella carta del
Vinzoni appare essere nella ‘via’ e non nella ‘salita’ ). La famiglia patrizia dei Piuma, si scrive arrivò a Genova nel 1400
(non si specifica da dove venne). Si formarono due ceppi, dei quali uno
ascritto all’Albergo dei Promontorio ma che si estinse nel 1634; un altro che
aveva case in via Prè, fu ascritta all’albo doro della nobiltà nel 1759, ed
ebbe poi un Carlo Maria (1837-1912) insigne professore di matematica nel nostro
Ateneo.
La presenza di una strada col nome di Pietra, è ovviamente riconosciuta in San Pier d’ Arena anche nel
regio decreto del 1857. il quale per primo fissava le strade dei borghi e città, già
nominati ed ufficialmente da riconoscere.
Solo all’inizio del secolo 1900
divenne ufficialmente “salita Pietra” tutta la crosa che dall’incrocio
con via Giordano Bruno (via del Campasso) saliva sino al
quadrivio di Belvedere con forte Crocetta
(e nel 1901 fu estesa sino al
corso dei Colli: in questa data le fu imposta -con quel nome- la prima targa in
marmo, ed aveva civici- non corrispondenti agli attuali- sino al 2 e 31). Tutto
il terreno a monte della strada sino agli spalti di forte Crocetta in questi
anni apparteneva alla fam. Galleano (viene descritto esistere
nel 1813 una villa omonima, nella zona “da via S.Gaetano” possedente
nell’interno del fabbricato una signorile cappella religiosa privata.
Importante questo nome perché in alcune carte, la zona viene definita
“Galleano”); mentre nella parte a valle compaiono le case
coloniche – dal basso in su - dei Sibilla,
dei Bozzolo e dei Piazza.

Della stessa data, un elenco delle case
cita i proprietari: al n° 1, 3 e 12,
case Degola Matilde; 2, Monticelli GB; 4e 4a, Tubino Luca; 4a anche
Roncallo Domenico; 5 e 6, eredi di Eanrin; 7, Molinari Stefano; 7a-b Pizzorno e
C; 8 e 14c, Piuma; 9-10, Timone Santo;
14,14a-b,15 e 16 eredi Campoantico; 17, 18,19 avv.to Sibilla;
dal 20 al 23 fratelli Bozzolo; 24 e 25 Piazza Luigi; 26 eredi Frassinetti.
Pochi anni dopo, probabilmente assieme a
tante altre nel 1935, la titolazione della via fu annullata e
modificata denominandola al Bersezio.
Cento metri prima dell’apice –ove è il
quadrivio- c’è ancora una cappella dedicata
alla Madonna, descritta in salita V.Bersezio.
==VIA: è la continuazione verso nord, discendendo salita
V.Bersezio nella quale si innesta via del Campasso; ed arriva a via
B.Brin.
1757- Nella carta del Vinzoni, è descritta – poche decine
di metri dopo l’innesto di via del Campasso- la villa del M.co Dom.co Piuma (vedi sopra ma femmina, a ‘salita – 1813’)
Quando -subito dopo il 1910- la salita venne intestata a V.Bersezio, con l’antico nome
rimase solo il tratto in piano della ‘via’, ed il confine con Rivarolo era
determinato da via Bercilli,
posta in territorio di proprietà di Enrico Zella, che vi fece costruire nel periodo 1911-14 i
civv. dall’1 al 9.
Nell’elenco delle strade pubblicato dal
Comune nel 1910 appaiono ufficializzate sia “salita Pietra”, dalla via omonima
alla salita Forte Crocetta, con civv. fino al 2 e 31, e “via Pietra”, dall’incontro di salita Pietra e di via
G.Bruno fino al confine con Rivarolo Ligure, possedendo civici fino al 14 e 15.
Il Pagano 1911 segnala il forno per pane di Dellacasa Luigia al 12r, ancora
attivo nel 1921 (non più nel 1925) ; ed al 22r quello di Gualco Agostino ancora
attivo nel 1925.
Nel 1921,
venne aumentata una tassa comunale di
Sampierdarena alla ditta ‘Devoto A. (conserve alimentari’ esistente nella via.
Non presente nel Pagano 1912, viene
segnalata dal Pagano/19 e 20 (“Devoto A.&C. stabilimento conserve
alimentari, tel. 31-92 “presente anche alla voce “esportatore”), e non più dal
Pagano /21).
Nel Pagano 1925 si segnalano: senza
civico: i bottai Bozzano e Benedetti ancora presenti nel 1933 – e lo
stabilimento di Garibotti Marcello (industria e fabbrica di sacchi tel 41364, casella post.1671);
al civ.14 la fabbrica di turaccioli
di Jacquillon Giuseppe la cui carta intestata, la prima
in nostro possesso, porta la data del luglio 1907 ed era: “Grande
stabilimento // per la Fabbricazione di Turaccioli // a coltello ed a macchina
ed a smeriglio // Società anonima cooperativa // Sampierdarena, via della
Pietra, 14 – esportazione”. Nel 1909 una fattura diventa con nuova intestazione:
“(identico inizio; e solo “Cooperativa Turaccioli” + sovrapposte due dizioni
stampate in rosso “medaglia d’oro / esposizione internaz. Pisa 1907” ed a
fianco “Croce insigne e medaglia d’oro esposizione Roma 1908”). Nel 1910 compare il socio “De Caria
& Jacquillon / ditta Cooperativa Turaccioli”- come nella foto sotto (in Internet viene chiamato
Del Caria, ma la carta su detta è firmata a mano De Caria Enrico). Quindi
l’azienda dimostra essere già attiva almeno dal 1907 (tel. 49-70) e lo sarà
ancora nel 1933, tel.41170.
Problematico è localizzare la villa riprodotta: dal
disegno sembra imponente, seicentesca, con dietro ampio parco cintato e
ninfeo (attualmente via della Pietra è prosecuzione a nord di via del Campasso,
da dopo il bivio con salita Bersezio, anticamente ‘salita della Pietra’: ma i
palazzi che fiancheggiano a ponente –
dove i numeri pari - questo tratto di strada, oggi di competenza di Rivarolo,
non lasciano intravedere che lì ci fosse una villa di tali dimensioni).
Comunque nel Pagano/40 la ditta è riportata al civ. 10.


Nell’elenco del 1927, stilato subito dopo l’unificazione comunale, compaiono: una
‘via Pietra’ sampierdarenese ed una ‘via della Pietra’ rivarolese; ed il ‘vico
chiuso della Pietra’ sempre rivarolese; tutti e tre di 5a categoria.
E nel 1933
è invece precisato “via della Pietra”, a San Pier d’Arena, da via A.Ristori a via (sic) Bersezio ed a
via A.Saffi, con civici sino a 13 e 16, e di 5.a categoria. Vi si aprivano un
negozio di bottaio (di Bozzano e Benedetti);
al 9r una cartoleria (di Boccalero Giuseppe); al 14 la fabbrica di
turaccioli di Iacquillon Giuseppe.

foto 2011-civici pari a levante-area dove forse ci
fu la villa di Jacquillon; compreso dove il palazzo arancione in stile anni
1940; non combacia lo spazio tendenzialmente ripido
Nel Pagano/40 è assegnata a SPdA e va da via
Campasso e via B.Brin; civ. nero solo il 2
ed il 10 di Jacquillon G. Ditta di A.Mansueto fabbr. turaccioli. Dei
rossi: 2r sacchi, olii e ditta guastavino&DeGiovanni; 3r latteria; 7r
bottiglieria; 9r tabacchi; 12 parrucch. u&d; 13r fruttiv.; 18r commestib.;
22 carbome e legna; 24 commestib.
Dopo l’ultimo conflitto mondiale, 1945, eliminato il dazio, evidentemente i confini sono stati modificati, accorciati
per noi di un due-trecento metri (anche a ponente di via Fillak, il confine
attuale è dettato da via Campi, quando prima comprendeva anche parte di via
Frassinello), non si sa perché ma si suppone per motivi di numero degli abitanti.
Anche la Toponomastica include la via in ‘zona San Pier d’Arena –
Rivarolo Ligure, da via Campasso a Benedetto Brin’.
Nel Pagano 1950 al 5-7r c’era l’unico bar, allora di Gandolfo I.
Il civ.1 fu demolito e ricostruito nel ’63; civ. 4 eretto nel 1954;
civ. 7 costruito nel 1951;
civ. 8 demolito nell’’86; civ. 19
eretto nel 1952; civ. 11a nel 1954. Nelle schede della toponomastica con si
segnala la demolizione della villa di Jacquillon.
==Un VICO
omonimo, “vicolo detto della Pietra”, è descritto in documenti conservati
all’Archivio Storico Comunale, anteriori
al 1900. È descritto vagamente “da via Vittorio Emanuele (vFillak) verso
il Polcevera”, quando la lunga via andava dalla Lanterna a Rivarolo compresa.
Da una cartina allegata, sembrerebbe localizzabile poco più a nord dell’attuale
via Bezzecca, quindi dove era via san Fermo, ma non si hanno ulteriori
informazioni.
STORIA: Si
può pensare, che prima dei romani, le comunicazioni con l’interno fossero assai
scarse e che quindi la strada fosse solo un tracciato tipo sentiero-mulattiera.
Divenne strada – e come
tale sarebbe la più antica
di San Pier d’Arena-Certosa quando il percorso corrispose all’Aurelia
romana (vedi) la quale - proveniente dagli Angeli e costeggiando sino a
Belvedere, scendeva a Certosa per
raggiungere Rivarolo ( e da là o proseguire verso la Bocchetta o tagliare il
fiume con il ponte e, salendo a Borzoli
scendere a Sestri per proseguire verso ponente).
CONFINI: Come già detto, dopo l’ultimo conflitto
mondiale, evidentemente i confini sono
stati modificati, accorciati e, per noi notevolmente ridotti (vedi via del
Confine e via Frassinello).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale in palazzo Ducale
-Archivio St.Comunale
Toponomastica - scheda
3490
-DeLandolina GC-Sampierdarena-Rinascenza.1923-
pag.51
-Gazzettino S. :
9/82.9 + 9/92.3
+
-GrossiB&Poleggi-Una
città portuale del medioevo-Sagep l1980-pag. 30
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.44
+
-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1930ca-(pag.18)
-Pagano/1933-pag.248; /40-pag.371
-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di
Ge.-Tolozzi.1985-pag.1458
-Stradario del Comune di Genova edito 1953-pag.139
-Stringa P.-La Valpolcevera-Agis.1980-pag.
92cartina
-Vigliero BM-Dizionario delle strade di
Ge-Tolozzi-vol.IV- pag.1485
PIEVE vico Pieve di
san Martino
TARGHE : San Pier d’Arena – vico – Pieve di san Martino –




QUARTIERE ANTICO: San Martino
 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
In rosso la pieve di s.Martino vescovo;
fucsia, l’Oratorio; giallo via CRolando;
celeste, via ACaveri
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2828 CATEGORIA: 2
 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE
INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 48400
UNITÀ
URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
 da Google Earth 2007.
da Google Earth 2007.
in giallo via ACaveri; celeste CBazzi;
fucsia via Currò.
CAP: 16151
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: da via Carlo Bazzi a via Currò, con teorico
doppio senso veicolare: in realtà il vicolo è così stretto da creare problemi
al transito di una vettura di più grossa cilindrata; comunque quando l’uscita
in via Currò non è ostacolata da un posteggio scorretto, la via di accesso più frequente e facile è da via C.Bazzi per
alcuni fondi adibiti a box auto.
CIVICI neri=
da 1 a 5
rossi= da 1r a 29r e da 2r a 4r
Il Pagano/40 la limita come oggi; non cita
civv. neri; un solo rosso: 11 Solia pastif.
STORIA: dalla carta del Vinzoni si rileva come la
‘Parrochia di san Martino Vescovo’ confinasse a monte (a est) con la sua casa
parrocchiale ed il suo Oratorio (disposti a L); e fosse ai piedi della collina
- sul cui apice scorre la salita a Belvedere - e il fianco collinare occupato
dai vasti possedimenti privati riguardanti: la zona di via Currò (di proprietà “già dell’ecc.mo
generale GioLuca Pallavicini, ora Rovereti”); quella di via Caveri (del mag.co Giuseppe Lagomarsino, con villa che
corrisponderebbe al civ. 11 di detta via);
seguite a nord dall’ ampio possedimento dei Cicala (iniziante poco prima di via Vicenza).
A ponente della strada
principale (via san Martino, oggi
CRolando), via GTavani -nella carta del Vinzoni- separava i terreni (che precedentemente erano
del mag.co Giacomo DiNegri) del mag.co Stefano Lomellini q.Carlo (lato
a mare - vedi Daste 103) da quelli della mg.ca
Lomellini Giovanna (a nord).
La stessa carta evidenzia come
- per chi arrivava dal mare seguendo la via san Martino (via C.Rolando) - poco prima della chiesa si staccasse un’altra strada
che dapprima tagliando tra i prati e poi
passando dietro ad una casa (posta nell’angolo con vico
Cicala –via A.Caveri), portasse diretti
alla antica abbazia parrocchiale (che
andrà distrutta -e totalmente scomparsa- da dopo la fine del 1700).
Le case che si aprono nel vicolo sono assai
vecchie e quindi antecedenti a quel lungo caseggiato che si apre davanti a loro in via Rolando ed
il cui stile è degli anni 1910 circa. Restò e si confermò così praticabile il retro della via principale, e
chiamato solo “vico san Martino”, da via Currò a via Marsala (via C.Bazzi), con civici sino al 5,
per continuare ad accedere al pur lui antico Oratorio di san Martino.
Nel
1933 persistevano ancora queste denominazioni. Solo il 19 agosto del 1935 il
podestà deliberò fosse chiamata come oggi.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale palazzo Ducale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica scheda
3504
-AA.VV.-Annuario
guida Archidiocesi-ed./94-pag.430; ed./02-pag.467
-Lamponi
M.-Sampierdarena- Libro Più.2002- pag.142
-Novella
P.-strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio 1930circa-(pag.19)
-Pagano/1933-pag.247;
/40-pag.372; /1961-pag.335.pianta72
PIGAFETTA via Antonio
Pigafetta
Non descritta da nessun altro testo; solo il
Dizionario delle strade di Genova segnala l’esistenza di tale via a San Pier
d’Arena, posta da corso Magellano: forse è un nome che fu proposto e non
accettato, per esempio forse a quel lungo emiciclo comprendente i vari palazzi
tutti col civ 1. In sintonia, nella zona, con gli altri circumnavigatori.
DEDICATA al vicentino del
1491 che partecipò volontario, addetto alla persona del capitano, alla
spedizione di Magellano. Patì con quel ruolo tutte le vicende della spedizione
e della circumnavigazione fino al momento della morte del comandante. Fu ferito
nell’isola di Natan (laddove Magellano fu ucciso); e, solo nel 1522, poté tornare con i 17
compagni superstiti.
Solo
per merito della sua relazione, a Magellano furono riconosciuti i meriti della prima circumnavigazione, che – altrimenti
- altri superstiti non avevano rivelato, anzi avevano aggiudicato a se stessi.
Lasciò dettagliata narrazione scritta
dell’impresa ed anche dei luoghi, popoli, flora, fauna, metereologia
incontrate, usando un linguaggio misto
italo-veneto-spagnolo.
Fu fatto Cavaliere di
Rodi.
Morì giovane, nel 1524
BIBLIOGRAFIA
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag.1464
la strada non viene citata da:
ArchivioCom.Top..
Elenco comunale vie del
1910;
Novella;
Pagano1933;
Pescio A.;
Tuttocittà;
Stradario Comunale/1953
e /VVUU;
PIRLONE via
Dario Pirlone
TARGHE:-
San Pier d’Arena – via – Dario Pirlone – medaglia d’oro al V.M. –
1914-1942




QUARTIERE ANTICO: confine
tra Castello e Coscia
N° IMMATRICOLAZIONE: la strada è successiva alla
applicazione


da MVinzoni, 1757 Dal Pagano/1961 (ancora
anonima)
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA -n°: 48850
UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
 da Google Earth 2007.
da Google Earth 2007. 
la strada, è a ponente della villa Fortezza.
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STRUTTURA: senso
unico viario da via N.Daste alla piazza (del mercato di) Treponti.
La dedica, fu decisa in Consiglio Comunale il 26 ott.1970. A seguito
della nuova denominazione, il civ. 1 della piazza divenne civ. 1 della via.
CIVICI
2007= neri= 1 e 2
DEDICATA
al giovane sampierdarenese nato nel 1914 e morto
eroicamente nei combattimenti di El Alamein, il 24 ott.1942.
Sergente maggiore del 185° artiglieria, effettivo
della divisione Folgore, fu incaricato di una batteria anticarro.

La motivazione alla medaglia
d’oro dice durante questa battaglia:
“comandante di un pezzo anticarro impegnato da forte formazione di carri
armati nemica, riusciva, dopo strenua lotta, ad infliggere al nemico sensibili
perdite, catturando con ardita mossa l’equipaggio di un carro colpito.
Successivamente, avuto immobilizzato il pezzo, feriti tutti serventi, ferito
egli stesso gravemente alle gambe, incitava i dipendenti a non perdersi d’animo
e continuare a combattere con le bombe a mano ed i pugnali. Sopraffatto dal
nemico, irrompente nella postazione, vincendo lo strazio del suo corpo
martoriato, sorreggendosi con sforzo supremo sulle gambe maciullate, scaricava
la pistola sul nemico gridando: ’voi non mi avrete vivo. Viva l’Italia’. Cadeva
da prode”.
Fu
insignito di medaglia d’oro, al Valore Militare alla memoria.
LA FOLGORE: A Tarquinia dall’azione del colonnello
pilota Giuseppe Baudoin nei primi anni di guerra nacque una nuova divisione,
idea che andava diffondendosi nell’ambiente para-aereo (i fallschirmjäger
tedeschi), ovvero una forza di fanti-paracadutisti. Iniziando con 60 volontari,
che sarebbero divenuti istruttori, e dopo tentativi -anche tragicamente finiti-
di organizzare il lancio in gruppi, furono ben presto inviati –inizio 1941-
alcuni a Cefalonia dove però non combatterono per immediata resa delle truppe
greche; ed un altro gruppo in Cirenaica per proteggere la ritirata della X
armata. A fine 1941 il gruppo ebbe
battesimo di “Folgore” e, via mare fu inviata in Africa ove dovette cambiare
nome in ‘divisione cacciatori d’Africa’, togliendosi i fregi dei paracadutisti
dalla manica e lasciando nei depositi paracadute e tutto l’armamentario
specializzato. Rommel provvide a
schierare subito il reparto nel deserto, quale ‘unità d’assalto’.
Erwin Rommel, attaccando dalla Libia verso est, via
via travolse le linee inglesi; e dietro al nemico in rotta che scappava, lo
inseguì tanto che si allontanò troppo dai rifornimenti (che non potevano più
venire direttamente, essendo cielo e mare praticamente in mano al nemico);
mentre gli inglesi arretrando si avvicinavano al loro continuamente ben rifornito.
Per esaurimento di mezzi, dovette fermarsi su una linea frontale che aveva
inizio presso il piccolo centro chiamato El Elamein
La
guerra. Agli occhi di oggi, la guerra combattuta dai nostri
soldati appare spregevole perché di
aggressione, a fianco di un alleato che non disdegnava la sopraffazione
violenta e gratuita (e moralmente perversa, visto i lager e le discriminazioni
razziali), solo per testimoniare a se stessa le sue capacità di potere. Al
punto che il commentatore televisivo si è espresso dicendo”è stata una fortuna
che l’Italia abbia perso, se no chissà cosa poteva succedere...”.
A spiegazione, Maggiani scrive che là i soldati ci
si trovarono volenti o nolenti, facendo il loro dovere e perché non c’era altro
da fare se non sacrificarsi fino alla morte.
Questi ragazzi si trovarono a vestire il
grigioverde –nella mentalità postbellica di quelli che si sono arrogantemente
autoconvinti di averla vinta loro la guerra- per combattere la guerra di
Mussolini (non della Patria); e quindi ben sta se hanno perduto, e se sono votati all’oblio e al disinteresse
dei giovani di oggi, venendo ricordati solo quelli.
E’ vero che molti soldati avrebbero preferito
starsene a casa e vivere in pace; ma -mio pensiero- è altrettanto vero che quei giovani erano là
perché –se non loro, ma sicuro i loro genitori- prima di partire avevano
inneggiato chi prometteva quelle conquiste. La colpa –se di colpe si deve
parlare- non fu solo di chi decise, ma anche di chi consentì ed applaudì che
quella decisione fosse presa. E per un verso o per altro, erano la maggior
parte degli italiani, ivi compresi molti partigiani dopo o quantomeno i loro
genitori. Questo, non per giustificare
il fascismo, ma perché la Storia deve essere obiettiva, e non di parte: è
troppo comodo oggi scrivere –o lasciare intendere- che fu colpa di tizio e di
caio: fu colpa nostra, di noi italiani...quasi tutti, ma...democraticamente...
la maggioranza..
Mutismo e indifferenza, c’è ancora adesso, dopo 60
anni di tempo, in attesa di ridimensionamento
El
Alamein è una località sulla costa della Cirenaica (Libia),
120 km a ovest di Alessandria e del Nilo. Il fronte iniziava dalla fascia
litoranea e di approfondiva per 65 km all’interno- si arriva a MarsaMatruh, ove
c’è una ampia zona collinosa nel deserto che prende il nome dall’arabo ‘Tel el
alamein” ovvero ‘colline dalle vette
gemelle’.
PREMESSE:
Rommel (per l’occasione nominato ‘la Volpe del deserto’) alla
guida dell’esercito italo-tedesco e forte di solo 96mila soldati -dei
quali 56m italiani-, 600 carri armati, 500 aeroplani- iniziò
l’offensiva il 21 genn.1941 e fece arretrare l’esecito alleato guidato dal gen.
Claude Auchinleck (forte
di 150mila uomini, 1200 carri e 1500
aerei) fino a quel punto della fascia costiera. Ma, la
quasi totale assenza di rifornimenti (sia di rincalzi che di
mezzi –soprattutto carri, benzina ed aerei) lo costrinse ad
arrestare la marcia –che sembrava trionfale e prossima ad occupare il canale di
Suez- a 105 km da Alessandria.
Gli inglesi, anche loro disfatti ed usurati, approfittarono
però di questa sosta per abbondantemente approvigionarsi, mentre W.Churchill
affidava l’incarico al gen. Gott (ma questi perse la vita mentre veniva
ad assumere il comando); fu sostituito dal gen. Bernard Montgomery.
Rommel tentò approfittare, e (30 ago) tentò un
improvviso attacco con carri armati, che –mancando di supporto- fu respinto; dovette così andare a Berlino –ufficialmente
per ragioni di salute- ma in sostanza per rendere conto della situazione,
lasciando il comando al vice, gen. Georg Stumme –che morì di
infarto il giorno dell’attacco, mentre ispezionava le linee-.
Il comando fu temporaneamente assunto dal gen. Von Thoma.
Furono gli inglesi che resisi consci della
situazione degli avversari, iniziarono attacchi aereonavali alle basi, tra
tutte Tobruk. Ma la reazione italotedesca li fece desistere.
Si stabilì quindi una linea di fronte -di truppe
contrapposte ed in stallo- perpendicolare alla costa, che si addentrava per 50
km fino ad arrivare alla depressione di
El Quattara (che garantiva l’intransitabilità dei mezzi e quindi
–reciprocamente- l’accerchiamento). Il fronte italotedesco
vedeva: sulla costa un reggimento di bersaglieri, seguito in successione -dalla
164° divisione tedesca; div. Trento; div. Bologna; mezza brig.parà Ramcke; div.
Brescia; altra mezza Ramcke; div. Folgore all’apice dell’interno. Di rincalzo, nelle retrovie
stavamno -a salire dal mare- la 70a div.tedesca, seguita dalla
div.motor.Trieste, div. Littorio, 21a div. corazz. tedesca, div. Ariete e –dietro alla Folgore- la div.
Pavia (che insieme alla Brescia e la Ramcke, formavano il X corpo d’Armata).
La 185° divisione fanteria Folgore era comandata
dal gen. Frattini, ed era composta dal 186° e 187° regg. paracadutisti
associati al 185° rgt artiglieria-paracadutisti.
 frecce di attacco e
-in nero- zone da loro conquistate il 24 ottobre
frecce di attacco e
-in nero- zone da loro conquistate il 24 ottobre
LA BATTAGLIA Furono
5mila uomini, contro 15-20mila; cannoni di piccolo calibro, contro 300 mezzi
corazzati....
Iniziò il 23
ottobre 1942, alle 20,42: gli inglesi, rinforzati in tutti i settori- e guidati
dal generale inglese Bernard Law Montgomery, iniziarono a sorpresa una controffensiva
(chiamata Lightfoot), contando su molteplici situazioni di vantaggio non ultima
l’assenza di Rommel, rientrato d’urganza il
25 ott.. Ma già il 26 ott. la situazione delle truppe italotedesche era divenuta
drammatica. L’aviazione alletata troncava tutte le iniziative.
Lo scopo era un tentativo di sgretolare le difese
italo tedesche mediante bombardamento serrato aereo-navale e
terrestre, contando di 973 aerei contro i 340 dell’Asse; 3171 cannoni contro
2433, incuneamento di pattuglie nei campi minati, simulati sbarchi alle
spalle tenendo l’avversario costantemente allertato e
facendogli sprecare rifornimenti già al limite e senza prospettiva di reintegro.
Lo squilibrio di forze era
modificato in peggio per noi: 196mila
uomini contro 104; 435 autoblindo contro 119;
1029 carri armati contro 490 (di cui 279 M13 italiani inefficaci contro
le corazze nemiche e con munizioni che appena scalfivano la corazza dei Grant e
Sherman, mentre i Tigre tedeschi furono da Hitler concentrati verso la Russia.
Da
quell’inizio, si combatté una grande battaglia che –in parallelo a Leningrado- praticamente
decisero le sorti del conflitto in genere: in Africa, furono 10 giorni che
iniziarono lo sconvolgimento ed infine il ribaltamento della sorte della
seconda guerra mondiale; per tanti motivi sommati, ma soprattutto
organizzativi, le forze dell’Asse dopo mesi di continue vittorie su tutti i
campi di guerra dovettero ripiegare -seppur dopo strenua e logorante lotta-
sopraffatti dal nemico più ben organizzato (d’altra parte Hitler stesso aveva
sottovalutato l’impegno in Africa, concentrando mezzi e forze sul fronte russo, dove perdendo, subì la
seconda fatale debacle che lo costrinse a difendersi, sino alla disfatta
totale).
Luserna-Dominioni scrivono, in una sorta di diario,
che “...Gli italiani del 1942, ad El Alamein, posseggono una sola superiorità,
ma essenziale: nelle truppe sono rimasti soltanto i soldati veri e gli altri se
la sono tempestivamente squagliata..” ; ”....il giorno 24, con la luna piena
“si scatena «l’ultima battaglia». L’inglese attacca a sud e a nord, ovunque con
massiccia superiorità di mezzi. “...Le 4.30. Il tiro (inglese) anziché
diminuire aumenta di intensità...Le 5.20. Il tiro avversario è durato
esattamente un’ora...sta venendo avanti su due colonne, il nemico...falcidiati
dalle (nostre) raffiche cerca riparo e lancia due razzi rossi...chiamano in
soccorso i carri...eccoli, sono del General Lee...ma gli artiglieri
vigilano...i pachidermi tentennano...poi ripegano a precipizio...tre volte i
carri tentano l’attacco e tre volte vengono arrestati...in una uadi giacciono
stravaccati tre o quattrocento inglesi, logorati dalla fatica e dalla sconfitta...chi
siete? Credevamo che nessun uomo potesse resistere ad un attacco come il
nostro”. Doronzo,
dei parà, nel suo libro non cita il Nostro; scrive una sua relazione, di quel
24 ottobre. Inizia il diario con un capitano artigliere che al suo quesito circa i proiettili di
troppo piccolo calibro e pericolosamente accatastati vicino al pezzo, gli
risponde: «si, hai ragione, ma vedi qui
da noi valgono il doppio». E subito dopo “…gli artiglieri penso siano i più
sacrificati perché…debbono vivere con quello che passa la sussistenza e,
diciamolo pure, nella migliore delle ipotesi è sempre troppo poco. Aggiungiamo
che i pezzi e il munizionamento se lo son dovuti portare fin qui a spalla e si
parla di quintali trascinati su terreno sabbioso e irregolare… All’improvviso
il cielo a est si accende come se lungo tutta la linea ci fossero cannoni che
sparano simultaneamente…ci siamo di nuovo…passa un bel quarto d’ora e quelli
non la piantano per niente…i colpi arrivano a migliaia…solo quando si
schiarisce il cielo a est… lo spettacolo è terrificante, quello che era il
terreno che noi conoscevamo non ha più nulla di terrestre, letteralmente
coperto di buche come piccoli crateri dai bordi imbiancati dalle
esplosioni…come posso essermi salvato?”;
e davanti innumerevoli carri armati colpiti (ne
conta 11, ma poi ne vede uno qua vicino ’assai grande’, due che stanno bruciando; e –più lontano- quattro di quelli
grandi; e 15 di mezzi più piccoli, camionette...).Infatti la battaglia pare che
si sia sviluppata ai fianchi, non coinvolgendo direttamente la sua postazione
messa in mezzo tra i colpi inglesi e quelli italiani
Il
nemico comunque è stato respinto. Pirlone
è morto.
Dopo la
battaglia del 23-24, a fine mese, gli inglesi iniziarono a tentare di sfondare
sulla costa; poiché a sud –nell’entroterra- ha devuto rinunciare a combattere
contro la Folgore alla quale era stata offerta la resa con l’onore delle armi,
ovviamente rifiutata.
E poi,
“dal 28 ottobre il settore della «Folgore» è tornato tranquillo: paracadutisti
e guastatori rafforzano le posizioni sconvolte, nell’euforia della rude
vittoria: le falle sono turate. A nord le cose vanno male, ma essi lo
ignorano...Ignorano la consumata decisione di sacrificare le truppe italiane
del centro e dell’ala destra, pur di lasciare alle truppe tedesche dell’ala
sinistra la libertà di ripiegare... A sud (il nemico) è ribattuto dalla «Folgore»: «Interfectus est» direbbe Giulio
Cesare, è fatto a pezzi. Allora concentra tutto il peso a nord e dopo dodici
giorni riesce a sfondare.
La «Folgore»,
sino ad allora vittoriosa, è aggirata e condannata.
Il 2 novembre Montgomery ordinò l’operazione
sfondamento ‘supercharge’.
Due giorni dopo, il 4 novembre, la Folgore, che da
5mila uomini ne contava 272 e 32 ufficiali, fu travolta.
LA FINE : Rommel ebbe
l’ordine di disimpegnare prima le truppe tedesche e per ultime quelle italiane.
Il 23 genn.43 le truppe italiane abbandonarono Tripoli; (agli inizi di febbraio
von Paulus si arrenderà a Stalingrado); il 13 maggio le forze dell’Asse rimaste
in Tunisia, si arresero.
Gli italo tedeschi persero 12mila uomini
(morti+feriti+dispesi) e subirono 25 mila prigionieri; gli Alleati perdettero
23.500 uomini.
Uniti
nella lotta (artiglieri, bersaglieri, carristi, piloti d’aereo), tutti fanno
parte delle memorabile battaglia; da allora ed anche per loro merito, in
particolare la Folgore (ai cui superstiti fu riconosciuto l’onore delle armi)
il nome El Alamein è parola simbolo del coraggio. L’epitaffio, scritto su una
lapide nel cimitero, recita ‘mancò la
fortuna, non il valore’.
La
divisione Folgore ebbe quattro medaglie d’oro collettive -una per i singoli
reggimenti- e 16 individuali; tra queste ultime, quella per il nostro sergente
maggiore.
Quota 33 Sul colle più alto, sulle mappe
segnato con quel nome, c’è un cimitero in piena zona dove erano nascoste oltre
un milione di mine.



il
sacrario
francobollo 1998






i
nomi degli sconosciuti “ignoti
a noi, noti a Dio” i loculi
Eretto ad opera
del conte arch. ten.col.Paolo Caccia Dominioni (alpino già comandante del 31
batt. Guastatori); questi, –riprendendo una iniziativa inglese già in atto
durante il conflitto- dal 1959 (altrove si scrive 1949) assieme al serg.magg.
Chiodini Renato, dedicò gli ultimi anni della vita al ricupero e riconoscimento
dei caduti e per questo insignito di medaglia d’oro. Nel vasto cimitero di
guerra italiano riposano 4814 soldati italiani (inj internet si scrive 4634) dei
quali 1300 ‘ignoti a noi, noti a Dio’, e molti africani nostri coloniali (228,
si precisa), che furono sconfitti, ma che diedero fulgido esempio di come si
affrontano le responsabilità, anche se subite, e spesso non condivise (i
tedeschi persero 10mila soldati, gli alleati 13.500).
Il Col., anche architetto,
fece costruire il torrione nel quale riportare le salme -quali ormai ossario-.
Vennero ricomposte nei locali attorno ad un salone centrale (ove è l’altare, ed
ora il busto del colonnello) dopo aver smantellato il cimitero terreno
(aumentando giorno per giorno, era diventata una inquietante e struggente
distesa di croci); attorno, un recinto che fu completato con un ingresso con
corte d’onore; nell’interno servizi, sala museo di cimeli, sala proiezione ed
una sala allegata che ospita i resti di un centinaio di scalpellini pugliesi
morti durante la costruzione della diga di Assuan nel 1903 (nel 1960-73 fu
costruita -a monte delle cataratte- quella ‘alta’).
Nel lungo elenco
compare il nome di una donna, la “inf. Maria”; che è presumibile sia nome e
professione inventate, non conoscendo la
persona. I resti di questa donna furono ritrovati – vicino a quelli di due
militi - durante la ricerca delle spoglie, nel deserto di el Qattara. Nessuno
conosce perché fosse lì, né chi fu; comunque – raccolte le spoglie (operazione
di ricupero delle salme già iniziata dagli inglesi a mezzo di nostri
prigionieri) per non lasciare la tomba anonima le fu dato il nome inventato di
“Maria“; e collocata assieme agli altri. Esistevano in servizio delle
infermiere –monache: può essere; non crocerossine ufficiali, perché non c’erano;
oppure la compagna di qualche ufficiale.
Nel 2002, il
presidente della Repubblica Ciampi, considerato che dopo la vittoria in terra
d’Africa gli Alleati riuscirono da là a sbarcare in Italia e decretare la fine
del fascismo, ha espresso il suo apparentemente ambiguo ‘grazie italiani, per aver perso’.
Nel 2008 si ha
notizia che l’Egitto ha ceduto all’Italia l’area del cimitero-sacrario di
‘Quota 33’: nel deserto.
Il
fratello risulta aderente all’associazione del Nastro Azzurro.
BIBLIOGRAFIA
-Albo
dei decorati al Valor Militare-Ist.del Nastro Azzurro.1977- pag.167
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica , scheda 3536
-AA.VV.-Annuario.guida
dell’archidiocesi-ed/94-pag.430—ed/02-pag.467
-Doronzo
R.-Folgore! E si moriva-Mursia.1978-pag.97
-Gazzettino
Sampierdarenese : 1/75.4
-Il
Giornale : 6.12.99 +
-Il
Secolo XIX : 20 e 21.10.2002 + 17.06.06 + 10.04.08
-L’Alpino-rivista
mensile dell’ANA- n.1/2008-pag.14
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag. 72
-Luserna.Dominioni-I
ragazzi della Folgore-Longanesi1972-pag.136.184
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Genova-Tolozzi.’85-p.1480
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35.51
-- non citato Enciclopedia Sonzogno e Motta.
PISACANE scalinata
Carlo Pisacane
Il Novella segnala la scalinata, dipartente “da via
G.B.Monti” (ma poi divenuta, e lo segnala tra parentesi senza dire quando,
“scalinata Gaetano Filangeri”).
Nel 1910 non era ancora
ufficializzata; lo divenne (aggiunta dopo a penna sull’elenco delle vie) come
“scalinata Carlo Pisacane, da via G.B.Monti verso la proprietà Palau”, con
civici sino al 3.
Nel 1927 fu pubblicato
l’elenco delle strade di tutte le delegazioni entrate a far parte della grande
Genova: la scalinata è presente (classificata di 5ª categoria, con omonime
dedicate a Sestri, Voltri ed in Centro): ma la titolazione fu lasciata solo in
Centro per una strada più importante, posta tra viale B.Bisagno e piazza
Palermo.
Ma nel 1933 sul Pagano è
ancora segnalata tra le nostre strade, la “salita Carlo Pisacane”; come sempre,
da via G.B.Monti, chiusa, di 5ª categoria, ma con civici sino al 7.
Fu con delibera del
podestà datata 19 agosto 1935 che divenne “scalinata Filangeri” ( da vedere per
i dettagli).
DEDICATA: allo scrittore e patriota napoletano nato il
22 agosto 1818.
Di carattere amabile,
delicato e fiero; deciso come soldato; inquieto e irascibile nei sentimenti. Di
nobili origini – cadetto dei duchi di san Giovanni- dopo i primi insegnamenti
in collegio preferì arruolarsi – 1839,
divenendo - come il fratello

Filippo fedele al re di
Napoli - tenente del genio nell’esercito borbonico.
Usò questa carica
militare per poter insinuare negli alti gradi dell’esercito borbonico il
concetto ed il desiderio dell’Italia unita e - determinatamente mazziniana.
Ciò gli valse che – in
piena carriera – nel 1847 dovette
fuggire via da Napoli (divenendo disertore). Riuscì
ad allontanarsi, accompagnato dalla donna amata (era Enrichetta Di Lorenzo in Lazzari,
moglie di un cugino e madre di tre figli; corteggiata da quando lui era appena dodicenne
e dichiarati tra loro nel 1845); assoggettandosi assieme a complicate
peripezie.
Scapparono insieme a
Londra (ove fu
raggiunto da richiesta di estradizione, rifiutata dal governo inglese), poi
a Parigi (arrestati
per falso passaporto; lei incinta). Infine a Marsiglia ove
lui (senza
lavoro, accettò un comando nella Legione Straniera francese che lo portò in
Africa ma senza combattere, essendosi arresi i momentanei nemici algerini; e
quindi rientrato ben presto) e lei (che partorirà Carolina, bimba che i parenti non
accettavano e ponevano come condizione per rientrare a Napoli che la affidasse
ad un orfanatrofio; ma che troppo presto morirà a metà febbraio 1848).

Nel 1848 scesero insieme in Lombardia - raggiunti da notizie di moti e sommosse: Palermo,
Napoli, Torino, Milano, (non viene citata Genova) – avendo avuto
nomina di ufficiale nell’esercito Sardo
e partecipare alla prima guerra di
indipendenza ove fu sconfitto l’esercito piemontese; lui già si era ritirato
perché in battaglia era stato ferito. Rifugiarono in Svizzera.
L’anno dopo lo troviamo –
quale colonnello, capo di stato maggiore, a guidare la difesa della Repubblica di Roma chiamato
personalmente da Mazzini a far parte della Commissione di guerra (mentre lei assisteva i
feriti nei punti di assistenza); sconfitto anche qui, dal gen N.Oudinot, fu
da lui arrestato e imprigionato in Castel Sant’Angelo; liberato, fu ricostretto
all’esilio a Lugano. Nel libro “La guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49”, edito nel 1851,
stigmatizza le cause del fallimento: mancanza di una politica sociale popolare,
che coinvolgesse le masse (coerentemente, nel frontespizio di un suo libro, riportò la frase di
Giordano Bruno “non temete nuotare contro il torrente; è d’una anima sordida
pensare come il volgo, perché il volgo è in maggioranza”).
Da Lugano, nel 1852 arrivò a Genova con Enrichetta, ove
rimase per tre anni vivendo con l’insegnamento della matematica; accolto nel
salotto di casa Benedettini, vagheggiava un rientro a Napoli; scrisse per
giornali cospirando contro i Borboni: collaborò con ‘l’Italia del Popolo’ di
Losanna (1849-50) con toni spesso assai polemici; dove l’affetto dell’adorata
ma fragile Enrichetta divenne instabile seppur anno di nascita (28 nov. 1852) di una
seconda bimba, battezzata Silvia; approfittò per compilare
anche saggi e libri, scrivendo “Saggi storico-politico-militari sull’Italia”,
in quattro volumi,
i primi due dei quali (uno di 102 pagine e l’altro 179) pubblicati a Genova
dallo ‘stabilimento Tipogafico Nazionale Antonio De Barbieri’, nel 1858 (gli altri due, a Milano con aggiunto il
‘Testamento politico’ scritto prima di partire per l’impresa); si scrive che – specie i primi due – erano
fortemente polemici, ed osteggiati quindi sia dai monarchici che temevano le
mozioni a casa Savoia, e sia dai repubblicani per i toni socialistizzanti e
critici di Mazzini – anche se ogni gesto e parola erano improntati di vera
amicizia e unità di intenti col Mazzini (primario ideatore di Sapri), sino
all’estremo sacrificio di se stessi.
Nel 1857 preparò (Mazzini e l’ambiente di Carlotta Benettini già l’avevano progettato)
e comandò la cosiddetta “spedizione di Sapri”.
Enrichetta, presagendo il dramma cercò invano di dissuaderlo. Si imbarcò come
passeggero sul piroscafo ‘Cagliari’ e, al largo, appoggiato da Giuseppe Daneri,
se ne impadronì facendo rotta su Ponza ove liberò i prigionieri politici ed i
galeotti; con essi, sbarcò a Sapri ma, in località Sanza, fu assalito e
annientato dallo stesso popolo che voleva liberare.
Nel partecipare alla progettazione
della quale, commise l’errore che aveva criticato per Roma: l’appoggio della
popolazione. La realizzò il 29 giugno
1857, impadronendosi con un gruppo di amici della nave postale “Cagliari”
mirando a sollevare il napoletano dal regime borbonico; lo sbarco a Sapri prevedeva
una accoglienza positiva da parte della popolazione e spontaneo rafforzamento
delle sue truppe da parte di volontari locali e prigionieri politici liberati a
Ponza.
Finì invece ben presto in un massacro, causa il
mancato appoggio degli insorti locali e la non collaborazione del popolo,
sommati ad una energica ed inaspettata reazione delle truppe borboniche.
Con pochi superstiti
cercò di sfuggire puntando sul Cilento
ma pochi giorni dopo (il 2 luglio) furono accerchiati a Sansa: nello scontro
molti morirono, altri si arresero (vedi Carlo Rota); lui fu ferito e non
volendo essere fatto prigioniero sapendo che riconosciutolo lo avrebbero
trattato da disertore e traditore, preferì suicidarsi con un colpo di pistola (qualcuno
dice che invece fu catturato e fucilato).
“Eran trecento giovani e
forti...” così inizia la poesia di Luigi Mercantini del 1857, intitolata “la
spigolatrice di Sapri” a memoria dell’impresa che seppur fallita, destò una
maggiore attenzione e sensibilità al tema dell’unità nazionale, che fu utile
nelle imprese successive.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale
-Archivio Storico
Comunale Toponomastica - scheda 3538
-DeLandolina
GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.51
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Fabbri L.-L’opera più
rara di Carlo Pisacane-il Mese, 1944- pag. 446
-Genova, rivista comunale – 3/57.16foto
-Marasco G.- Carlo Pisacane, Enrichetta...-La
Casana- 3/85-pag.35
-Novella P.-Strade di Ge-Manoscritto
bibl.Berio.1900-pag.17
-Pagano/1933-pag.248
-Pastorino&Vigliero-Dizionario delle strade di
Ge.-Tolozzi.1985-pag.1482
-Pescio A.-I nomi delle strade di
Genpova-Forni.1986-pag.77
PISTA
vico della Pista
Non è un nome ufficiale del Comune, però è
scritto in alcune mappe comunali della
fine del 1800 disegnate con lo scopo di censire e designare i nomi alle strade
della città. Fa riferimento quindi ad un
toponimo popolare, usato probabilmente
per indicare il luogo ove fu eretta nel posto la prima pista ciclabile genovese
(prima di essere trasferita ai giardini ora Pavanello e poi ancora dove ora è
via A.Cantore).
Dalla mappa su detta si può localizzare a
lato Polcevera di via W.Fillak;
- o all’altezza e quindi corrispondere alla
rientranza, poco prima di via Bezzecca - lasciando così pensare che la pista
occupava lo spazio occupato poi ed ora da un meccanico;
- o all’altezza di via
san Fermo, cinquanta metri dopo via
Bezzecca, dove allora avrebbe occupato lo spazio ove ora è
il civv. 11 di questa strada e dove -prima di esso- era uno stabilimento
siderurgico e fonderia.
Comunque in quella zona, sull’onda del
grande entusiasmo per i velocipedi (poi divenuti bicicli ed infine biciclette),
fu organizzata una primitiva pista, probabilmente in legno, di cui se ne conserva
il ricordo.
I primi gruppi dediti a questa attività
sportiva, nati a San Pier d’Arena,
pressochè coetanei essendo sorti agli inizi del 1890, furono in seno alla
Società ginnastica Sampierdarenese” ed alla “Raffaele Rubattino” (che poi nel
1894 si fuse con il “Trionfo genovese”) ambedue orientate prevalentemente verso
l’atletica e la ginnastica, ma aperte a tutte le iniziative.
La prima specifica società ciclistica a Sn Pier
d’Arena fu la “sezione velocipedisti” della “soc. Barabino”, nata nel 1897.
La prima serie di gare con carattere
interregionale, avvenne nel 1885: queste società, con l’aiuto dell’onnipresente
“società operaia Universale” e dell’Amministrazione comunale, organizzarono
la manifestazione intitolata “San Pier d’Arena pro-monumento a Garibaldi“ nei giardini ora Pavanello.
Da allora, il velocipede,
da mezzo di distinzione per cittadini all’avanguardia e per attività di
divertimenti, iniziò a divenire mezzo di trasporto per i meno abbienti e di lavoro.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale palazzo Ducale
-Lamponi M.-Genova in
bicicletta-Valenti 1977-pag..45
PITTALUGA via Gerolamo
Pittaluga
TARGHE:
-via - Gerolamo Pittaluga –
scultore – sec.XVIII
-2 – 2829 – via – Gerolamo
Pittaluga – scultore – sec. XVIII


angolo con via
A.Cantore-ovest


angolo con via
G.Balbi Piovera


angolo via
A.Cantore est su questa targa non si
legge più la scritta “Già via E.Mazzucco”
QUARTIERE
ANTICO: Canto
 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
Ipotetici tracciati: in verde, della via;
giallo, via BPiovera; e rosso
via ACantore.
N° IMMATRICOLAZIONE: 2829 CATEGORIA: 3
 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8
CODICE
INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 48940
UNITÀ
URBANISTICA: 27 – BELVEDERE
28 –
s.BARTOLOMEO
 da
Google Earth 2007
da
Google Earth 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: NS delle Grazie
STRUTTURA:
senso
unico veicolare verso ponente; dagli inizi di via A.Cantore ritorna in via A.Cantore - scorrendo parallela
ad essa, a monte - prima dei giardini di villa Scassi. Tagliata a metà e
incrociata, dall’inizio di via G.Balbi
Piovera.
È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

la strada vista da ponente a levante
CIVICI: vanno
in crescendo da levante a ponente. I numeri neri, quelli dispari -posti a monte
della strada- sono tutti nella mezza strada a levante.
I pari
-posti a mare della strada- ambedue solo nella metà a ponente
2007=
UU27 = solo il 47r
=UU28= neri = da 1→
9 (mancano 3, 5; aggiungere 5A),
da 2→ 4
rossi = da 1r→ 45r (manca
31r)
da 2r→ 20r (manca 16r)
===civv. 1
e 3 divennero tali nel 1954 quando
in quell’anno fu cambiato l’assetto della strada: prima erano l’ 11A e l’ 11B
di via A.Cantore. Furono ambedue demoliti nel 1957 e sul loro sedime l’anno
dopo fu costruito un unico palazzo a cui fu assegnato il civ.1, posto a metà
della scalinata che a levante la unisce a via B.Piovera (cosicché il civ. 3 non
esiste più).
Il Pagano ancora nel 1961 scrive che al tempo i
numeri neri erano dal 2 al 4-dall’1 al 9.
===civ.2:
preesisteva a tutte le variazioni legate alla costruenda nuova strada, perché
eretto nel 1908 (come scritto sul frontale del portone). Il portone è, dei due
a mare della strada, quello più a levante, in senso giusto per la viabilità
odierna, ma in senso opposto per quella all’origine (giustificata però dal
fatto che allora era l’unico).
===civ.
2r il Pagano/61 pone la ditta Alemagna panettoni
===civ. 4:
posto sul lato a mare, è il più a ponente di tutti i caseggiati. Il portone ha
la caratteristica di occupare –nella facciata - il più a ovest di due riquadri (ciascuno
incorniciato da una mezza colonna ai due lati) ambedue uniti con un unico
capitello frontale alla sommità (nel riquadro a levante, c’è una finestra). Questa
scelta architettonica, di per sé inutile, lascia pensare che in origine –prima
di ammodernamenti- ci fossero due porte, e forse per due scale
===civ.5:
fu eretto nel 1955. È posto sulla scalinata, di fronte all’1. Al 5r, nel 1961 c’era una officina
meccanica di Medica I.
===civv. 7
e 9 ebbero questa assegnazione nel
54; prima erano l’ 1 e 3 della via.
===civ. eretto nel 1936 (XIV)
===civ.13r nel 1961- L’autorimessa
Sampierdarena
===civ
37r
nel 1961- L’autotr. ParodiP
Alcuni insediamenti
artigianali hanno sede solo nella metà strada a levante come alcune officine
meccaniche per auto, un salone d’auto, la civ ===5Ar la soc. Multilastic; ed una palestra di insegnamento
professionale della danza, appunto chiamato “Spazio-Danza” (è una associazione sportivo
culturale nata nel 1991, e maturata in
scuola ufficialmente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione.
E’ divenuta negli anni un centro didattico territoriale di primaria importanza
nell’insegnamento della danza in tutte le sue qualità, dalla classica al
flamenco e liscio, dalla ‘danza del ventre’ al jazz, al ‘tiptap’, a quella
‘afro’, al ‘funky’, alla ‘latinoamericana’, ed a qualsiasi espressione in
merito che l’uomo abbia inventato. Nel marzo 2004 l’aumento degli allievi ha indotto aprire una
2a.sede in via AdBozzolo 1, in angolo con via E.Degola, utilizzando uno stabile
da tempo rinnovato esternamente ma abbandonato nella funzione commerciale).
STORIA: La parte a levante è distinta in due
diverse componenti: una, la ripida scala diritta verso il monte; la strada
carrozzabile vera e propria, con senso viario parallelo a via A.Cantore.
La
prima (e piccola parte della seconda), in origine erano parte del parco della sottostante villa Spinola. Rimane traccia
del giardino, in una nicchia a ninfeo visibile non appena salita la
prima rampa di scale che unisce la nostra strada a quella che scorre superiore,
via G.Balbi Piovera.

Questo piccolo ninfeo, che ha più di cinquecento anni, è
stato assurdamente coperto anteponendogli, nel mezzo, una colonna in cemento
che sorregge la cancellata
delimitante la proprietà del
piano terra del civ. 1 Appare un orribile compromesso salomonico: sottintende
che l’architetto che ha costruito l’edificio non potendolo distruggere perché
difeso presumo dalle Belle Arti e non
potendolo neanche inglobare nel giardino
privato, piuttosto che lasciarlo fuori di esso al piacere visuale e storico dei
passanti, ha con dubbia intelligenza inventato questa mostruosità
architettonica: che i beni privati
abbiano priorità sui beni comuni e di rilevanza storica, mi appare strano).
La
scalinata, prima di essere inclusa nella strada in oggetto, faceva parte di un
erto viottolo o scalinata a sua volta, che saliva a Promontorio, e che
popolarmente veniva chiamata ‘via Montegalletto’ (vedi).
La
seconda, ha -a metà percorso- un micro rilievo a dosso da superare; probabile
naturale asperità del terreno, non affrontato spianandolo, nei tempi in cui si
lavorava senza ruspe meccaniche.


la metà a levante, vista
dall’incrocio con v.BPiovera verso
ponente con i civv. 2 e 4
La
parte a ponente, ha anch’essa due
caratteristiche ma diverse dalla prima,
anche se con sembianze speculari.
Una
infatti, speculare alla scalinata della parte a levante, posta nella parte
finale della strada, corrisponde ad un trattino di quella strada che nel 1800
era tutto un sentiero diritto, che
dall’attuale via NDaste saliva sino a
Promontorio (si chiamava vico Imperiale (vedi)
ed era un tutt’uno delle attuali via
Damiano Chiesa-via GB Botteri-(non via MFanti) via Carrea; costeggiava a
levante i muri di cinta della villa Scassi –già della famiglia Imperiale-. Con
l’edificazione di tutta la collina e l’apertura di via Cantore e dell’ospedale,
l’erta salita venne frantumata in tanti pezzetti e con titolazioni diverse).
L’altra
è la strada vera e propria che nel
tratto di nostro interesse cambiò
ripetutamente nome a seconda delle ideologie politiche della giunta municipale:
dopo vico Imperiale divenne via Jaurès; poi via Egidio Mazzucco (così era nel 1933; poi questa titolazione fu trasferita con delibera del podestà del 19 ago.1935
nella attuale v.C.Rolando); infine -e finalmente per fortuna senza
faziosità- via G.Pittaluga. Quando sul colle (1915) fu eretto il nuovo
ospedale, per chi voleva raggiungerlo dal basso, la salita Imperiale era la via
di elezione: bisognava passare per l’attuale tratto a ponente della strada, e
continuare salendo fiancheggiando sempre la villa Scassi. Solo dopo la cessione
al municipio del terreno di proprietà Piccardo, che permise si aprisse la
strada, divenne agibile alle carrozze seguendo i tornanti dell’attuale via
G.Balbi Piovera.
Il
palazzo ha i due portoni, aperti su questa facciata, appunto perché antecedenti
all’apertura di via Cantore. Anche la attuale farmacia Cantore, si apriva su
via Pittaluga (quindi nel retro rispetto ora; ma questo ingresso, dopo essere divenuto
secondario, fu eliminato negli anni 70-80 circa).
Incastonato dentro il muro che
sostiene la via BPiovera in ascesa, c’è uno dei vespasiani ancora in funzione e
relativamente decente.

DEDICATA allo scultore del legno più famoso del nostro
borgo, essendo nato a San Pier d’Arena il 21 magg. 1689 (altri scrivono 1691 circa). Di genitori di condizione economica modesta, essendo istintivamente portato al disegno e poi a
modellare il legno, fu indicato a Pietro Ciurlo (allievo di A.M.Maragliano e
che pure lui viveva nel borgo-vedi); ne divenne allievo e per innata bravura
riuscì poi a divenire superiore al maestro. Infatti, staccandosi dalla bottega
del maestro, ne aprì una propria ed iniziò ad assumere direttamente commissioni
da privati e da congregazioni religiose.

Ci ha
lasciato a testimonianza della sua bravura un “Crocifisso” (nella chiesa della Cella), ed un gruppo “crocifisso
con Madonna e san Giovanni Evangelista” eseguita per la chiesa di santa Sabina (antichissima
del IV secolo, fu rifatta due volte: dopo l’incursione araba del 936 e nel 1547
rinnovata architettonicamente e negli arredi; affrescata nel 1846, fu poi
sconsacrata nel 1931, demolita nel 1939, al suo posto eretto un cinema. Però per fortuna ricostruita ex novo in via Donghi, ove si conservano
tutt’ora queste opere d’arte), ambedue unici della sua
produzione conosciuta scolpiti in grandezza naturale.
Ed
altrettanto unico esistente in patria, è un bassorilievo in legno lavorato
con avorio (nel tabernacolo sull’altare maggiore della chiesa cappuccina della
SS.Concezione: decorò le formelle in legno, scolpendo con tecnica finissima ed
a bassorilievo la resurrezione di Gesù).
Conosciamo
finiti all’estero: un altro bassorilievo (tratto da un disegno di Luca
Cambiaso, già di proprietà di Stefano Passano: alla sua morte, fu venduto a
collezionisti inglesi); un tabernacolo per la chiesa dei cappuccini di Lisbona
(trattasi di un bassorilievo con episodi dei sacri Libri, tratto da disegno
dell’abate Lorenzo De Ferrari); una
statuina di sant’Antonio (in origine per
l’omonima chiesa di San Pier d’Arena); ed altri bassorilievi.
Purtroppo l’artigianato dell’intagliatore del legno
ha lasciato traccia storica labilissima, né attendibile né documentata,
limitandosi la storiografia –solo il Soprani in pratica, e poi il Ratti- ad
intagliatori per le chiese (il coro o pulpito), ma assai imprecisa nei riguardi
del lavoro per statuine del presepio. In questo campo, pare che il Pittaluga
iniziò ed acquisì fama scolpendo statuine tendenzialmente grandi ed in
particolare quelle degli animali al punto che per definizione, viene
riconosciuto come l’animalista del
presepio genovese.
Seguendo
la moda che faceva divenire tradizione
il presepio nelle case dei nobili, poi predilesse eseguire prevalentemente i
“lavori in piccolo”, che lui vivente, gli diedero maggior guadagno ma che più
facilmente si sono disperse. Di sua produzione vengono citate quelle conservate
al museo civico di Villetta Di Negro, ed in poche chiese di Genova.
Caratteristica divenuta innovativa a
quei tempi, era di modellare e rendere
mobili le parti del corpo scoperte, lasciando invece fisso e da rivestire di
abiti il manichino centrale: questo permetteva di far assumere alle statuine i
gesti e l’atteggiamento più consoni alla posizione fatta assumere nello scenario
e nello stesso tempo concedere alle signorine nobili, usando ritagli di stoffe
per i loro vestiti, esercitarsi nell’arte del cucito modellando gli abiti per i
personaggi, gareggiando in maestria e fantasia.
A
quarant’anni di età, fu colto da una grave malattia degli occhi, che
offuscandogli la vista, compromise seriamente la sua attività. Di carattere
mite e religioso, sopportò con rassegnazione per tre lunghi anni questo
martirio, finché le intense cure di un valente oculista, gli permisero di tornare
alla sua arte. Marito esemplare, rimase
uomo pio e mite: pensando di essere ignorante in tutto, appariva sottomettersi
a tutti cercando di non contraddire i sentimenti altrui; fu ottimo padre per i
suoi sette figli (il Soprani dice che
non ne ebbe alcuno) che allevò seguendo i principi di rettitudine e religiosità
che ispirarono la sua vita.
Si
spense nel nostro borgo, il 14 mag.1741
(altri come il Soprani scrivono: “per violenta malattia, nel 1743, al
cinquantesimosecondo del viver suo”) a poco meno di 53
anni.
Già da molti secoli prima, dai tempi delle
Crociate, essendo la spiaggia di San Pier d’Arena rinomato cantiere di navi di
tutte le stazze, ed essendo in uso abbellire gli scafi con sempre più pregiati
intagli e sculture, la scuola locale di questi artisti del legno fu sempre
all’avanguardia ed assai ricercata: il Novella ricorda altri due valenti
artisti intagliatori: Giuseppe Forlano e Filippo Santacroce (quest’ultimo fu
incaricato di abbellire la poppa della galea capitana della Repubblica, scolpendovi
l’arrivo a Genova delle ceneri di san Giovanni Battista)
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 3546
-AA.VV.-Annuario
guida Archidiocesi- ed./94-pag.431; ed./02-pag.467
-AA.VV.-Scultura
a Genova e in Liguria-Carige-vol.II-pag.287
-Gazzettino
Sampierdarenese: 6/88.9
-Galassi
MC.-Venite adoremus- Tormena.1993. pag. 39.57
-Genova, Rivista municipale: aprile/37.33
-Grosso&Bonzi&Marcenaro-Le
casacce e la scultura lignea-Goffi.’39-p.25
-Il
Secolo XIX del 31.1.04 +
-Lamponi
M.- Sampierdarena – Libro Più.2002 – pag.199
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio 1930circa-(pag.7.11)
-Soprani&Ratti-Vite
de’ pittori, scultori e…-Tolozzi.1965-vol.II-pag.289
-Pagano/1933-pag.247;
/1961-pag.338
-Pastorino&Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag.1484
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35
-Rosselli
B&E-Santa Sabina restituita alla città-LaCasana 1/1985-pag 39
-Stradario
del Comune di Genova ediz.1953-pag.141
-non
citato su Enciclopedia Motta e Sonzogno + Paolo Novella +
PITTAMULI vico Pittamuli
Il 2 febbraio 1914, al sindaco venne
sottoposto la necessità di cambiare nome al vicolo, già denominato’Guerrazzi’,
oggi dedicato a Nicolò Bruno.
Allo scopo vennero
proposti due nomi a scegliere: vico Balilla oppure vico Pittamuli. Fu scelto il
primo, e del secondo non ci appaiono altre alternative nella toponomastica di
San Pier d’Arena.
Citato anche dall’
Accinelli, partecipe all’insurrezione e quindi testimone diretto, Pittamuli è il soprannome di un altro eroico
ragazzo di dieci anni (undici scrive Quinto)
che, anche lui, compì un significativo gesto di ribellione alle truppe
austriache e che coronò l’ insurrezione di massa, in altra parte della città:
due giorni dopo l’episodio del Balilla, mentre in città sempre più lievitava la
ribellione all’invasore, per ordine del Botta un corpo di trecento soldati (stanziati
dal Bisagno) aggirando le mura tentarono riunirsi al generale (attestato
a SanPierd’Arena); ma gli abitanti di san Vincenzo, accorti della
manovra iniziarono a bersagliare i granatieri costringendoli a tornare indietro
fino al ponte di sant’Agata ove si riunirono con altri che sloggiavano la zona
di santa Chiara. Nel proseguire la ritirata, lasciarono asserragliati in una
osteria vicino al ponte un distaccamento di cinquanta soldati a retroguardia.
La folla pose assedio da lontano a quella posizione difensiva, e stazionava
finché il ragazzo partì per primo scaricando una pistola (a dieci anni?) e con
una fiaccola atta a incendiare le
masserizie ricuperate dai soldati e messe a difesa del posto. Così presi tra il
fuoco interno e la folla urlante, la guarnigione preferì arrendersi ai
Bisagnini.
Evidentemente a corto di soldati, nei
disegni del Botta era attendere i rinforzi, chiamati dalle riviere e da Novi;
tentò di comandare il Senato affinché provvedesse lui a disperdere i rivoltosi, ma questi non cadde
nell’errore di proteggere l’odioso ed inviso invasore; ed il popolo ormai in armi e con sorprendente
compostezza militare gestita da pochi ma validi capipopolo, riuscì a sloggiare
gli invasori da tutti i punti ove erano attestati e farli fuggire fuori delle
mura, spedendoceli a SanPierd’Arena in rovinosa e rabbiosa fuga. Da qui
asserragliato, non però raggiunto da truppe sufficienti, anzi perdute anche
le molte che in città si erano arrese,
dovette ritirarsi verso la Bocchetta,
lasciando orribili segni del furore e della rabbia
BIBLIOGRAFIA
-Bargellini M. -Storia
popolare di Genova-Monni.1870.vol.II-pag.487
-Pastorino.Vigliero-Dizion. Delle strade di
Ge.-Tolozzi 1985-pag.1484
-Quinto GB.-Le targhe delle
strade-Pagano.1979-pag.176
POLCEVERA via
Polcevera
 carta del Vinzoni del 1757
carta del Vinzoni del 1757
Primitivo
ed antico nome dell’attuale via Giuditta Tavani.
In
una ‘laus’ dell’anno 1144,
firmata dai Consoli per richiesta dell’arcivescovo di Genova, venne
riconosciuto che fino al torrente tutte le terre di fronte alla proprietà
dell’arcivescovato (l’abbazia di san Martino) erano di proprietà della Chiesa.
Fu probabilmente in questo terreno che si aprì il primo cimitero, in riva al torrente ed in zona circondata da pioppi
(’albera’) e non cipressi; i ricchi venivano sepolti in chiesa; solo i poveri
finivano nella terra e – probabilmente – in fosse comuni non esistendo ancora
la cultura cimiteriale impostamolto più tardi, da editti napoleonici.
Nella
carta del 1757,
compaiono i nomi dell’allora proprietari: a monte della strada il mag.ca Lomellini
Giovanna con una casa, ed a mare Lomellini
Stefano q.Carlo con due case sulla strada principale.
Nella
carta dello stesso Vinzoni del 1773
ma nell’Atlante del ‘Dominio della Serenissima...’, ripropone il tracciato
della strada, che arriva perpendicolare al torrente dove piega per costeggiarlo sino al ponte di Cornigliano
(qui era un molino; e la strada proseguiva sino al mare con il tracciato chiamato
‘della crosa del ponte’ di Cornigliano.
Esistendo
nella strada a metà del 1800
tre abitazioni di un Daste (al 4b, 4d, 4e della numerazione di allora), e
sempre in considerazione dell’uso di definire una strada in rapporto al punto
pìù noto di riferimento -non esistendo ancora i nomi comunali-, era d’uso
chiamare “vico Daste”(vedi) anche quel tratto
vicino (è scritto: “ a notte di via Polcevera”), che poi dopo fu ufficialmente
chiamato via Calatafimi ed oggi via C.Orgiero. Invece negli anni vicino alla fine del
1800 i proprietari delle case furono: al
civ. 1 Ballestrero, Bisio e C; 2, Bruno, Gardella, Roncallo e C; 4 e 4a Parodi
Andrea e C; civ. 4b Somano; 4c e 4d Bianchi e C.
Sarà
in quegli anni che – costruendo la ferrovia – la via fu soprapassata dalla
strada ferrata, lasciando uno stretto
percorso a tunnel che probabilmente ripropone
la dimensione della strada originale.
Nel
dic. 1900 il regio
Commissario straordinario propose alla Giunta comunale la conferma del nome di
“via Polcevera”: evidentemente fu ottenuta, perché è del genn.1901 l’apposizione della prima targa in marmo,
eseguita da una impresa locale (Barabino-Calvi-Rebora) e, come dice il
documento, posta nella strada “da via
Vittorio Emanuele (via W.Fillak) a via Garibaldi (via
Pacinotti+Spataro)”: quindi era compreso anche il voltino sotto la
ferrovia.


Nel
Pagano 1902 unico
esercizio è quello di Oneto Domenico che ha una delle tre fabbriche locali di
fiammiferi in legno.
Nel
1910 era ancora via
Polcevera, “da via Umberto I verso la Ferrovia”, con civici sino a 3 e 4, ufficialmente
riconosciuta dall’Ufficio di Anagrafe e
statistica del Comune.
Il
Pagano 1911-12 vi
segnala(ambedue non presenti dal 1919), una fabbrica di fiammiferi in legno, di
Oneto Domenico---; ed il forno di Bunioli Giuseppe.
Negli
anni subito a seguire (1914
circa), tale denominazione fu annullata a favore direttamente di Giuditta Tavani.
Ma,
come sappiamo il Pagano/20-25
ancora vi include –non specificato il
civico- la rivendita n.6 di sale e tabacchi di Porcile Maria.
Per
il Polcevera torrente, e la Tavola del Polcevera, vedi “Argine”.



BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale in palazzo Ducale
-Belgrano LT-il registro
della Curia arcivescovile-Soc.LigStP-vol.II-p.71
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manosritto bibl.Berio.1930ca-(pag.17)
-Pagano/1925
-Vinzoni M-Il Dominio della serenissima Repubblica
di Genova-1773-
PONTE crosa del Ponte

Se la strada romana per
le riviere saltava completamente le spiagge di San Pier d’Arena e Cornigliano, passando nell’entroterra, via
Rivarolo-Begato-Sestri; e se pure i traffici di ogni genere tra i vari borghi
rivieraschi, anche per questi brevissimi tragitti, erano sempre favoriti via
mare, è innegabile che fin dagli anni prima del 1000 si sentì il bisogno di
comunicare anche via terra, essendo il borgo già ben strutturato (nel 1039 - è
documentato - aveva anche un servizio di guardia).
Tre strade confluivano al
Ponte: quella centrale più antica e diritta; quella dalla
parocchia proveniente, da nord, costeggiante il torrente ed usata pressoché
solo per le funzioni ecclesiali da parte di chi abitava nella zona della foce; e
quella proveniente dalla marina:
quest’ultima,parallela al mare, poco prima del torrente, tagliava verso
l’interno e attraverso prati, orti, frutteti, rigagnoli con molini, si
congiungeva – con un percorso a scalino - alla prima.
È quest’ultimo tratto che
prese il nome di “crosa del Ponte”,
Nei primi anni
dell’ottocento, divenne “strada comunale del Ponte”, affiancata dalle proprietà
di Dufour Lorenzo, Rolla
Francesco e Pratolongo Rocci
(quest’ultimo nella sua villa possedeva una cappella religiosa privata,
sinonimo di nobiltà e distinzione sociale), e segnando il tracciato di quella
che poi, dopo lo sconvolgimento del territorio per le fonderie Taylor-Prandi
(poi Ansaldo), diventerà nel 1901 via Bombrini: in quella data fu infatti
proposto il cambio del nome, “da vico Ponte di Cornigliano a via
Bombrini, per tutta la strada che da via Cristoforo Colombo va all’ingresso
principale dello stabilimento Ansaldo e, attraversando via Operai
fiancheggiando lo stabilimento suddetto, prosegue fino sotto al Ponte di
Cornigliano”.
L’ampliamento progressivo
della fonderia, successivamente ingloberà ed accorcerà la strada, sino al
totale sconvolgimento con il programma attuato alla Fiumara nel 2000.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale
-Castronovo V.-Storia dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag. 107cartina
-Gazzettino
Sampierdarenese : 9/92.3
-Novella P.-strade di Genova-manoscritto bibl.Berio
.1930-pag.16
POPOLO via Popolo d’
Italia
La strada corrisponde
alla attuale via A.Carzino.
Fu così intitolata, nel
periodo dell’era fascista (durato dal 1919 al 1943-5) eliminando il nome di
Goffredo Mameli per decisione del podestà espressa con delibera il 19 agosto
1935, secondaria alla necessità di unificare tutti i nomi della Grande Genova.
Con successiva delibera
della Giunta comunale del 19 lug.1945
anche questa titolazione fu cambiata, con la dedica attuale ad Alfredo Carzino.
DEDICATA: corrisponde al
nome del giornale quotidiano del partito fascista: era stato fondato a
Milano e diretto da Benito Mussolini,
portavoce ufficiale del nuovo partito nato dopo la marcia su Roma.
Ma aveva iniziato la tiratura
molti anni prima, dal 15 novembre 1914, con articoli interventisti nella
previsione del prossimo conflitto mondiale: anche per questo, dieci giorni dopo,
Mussolini fu espulso dal partito socialista. Le due citazioni
(tratte la prima da Napoleone e l’altra da Auguste Blanqui) che corredavano il
frontespizio, erano eloquenti sulle intenzioni : «La rivoluzione
è un'idea che ha trovato delle baionette» e «Chi ha del ferro, ha del pane».
Il giornale,
come detto, nacque come quotidiano con lo scopo di supportare la minoranza
interventista del Partito Socialista italiano. Oppositori erano i neutralisti del Partito
Socialista Italiano, ed i pacifisti (tra
questi ultimi la Chiesa, guidata da Benedetto XV,
ovviamente attaccati sulle pagine del giornale e tacciati quali ‘conigli’;
l'arcivescovo di Milano condannò vietando la lettura del quotidiano ai fedeli,
mentre il Vaticano condannava lo Stato Italiano per omessa censura arrivando a
suscitare quasi un caso diplomatico).
È altresì noto
che per far uscire le pagine, Mussolini accettò non piccoli finanziamenti da industriali
interessati all’entrata in guerra: sia italiani (alcune documentazioni
attestano il versamento di contributi provenienti da industriali italiani, tra
i quali spicca il nome di Filippo Naldi, direttore del Resto Del Carlino, il
quale permise la realizzazione del giornale in sole due settimane procurando sia mezzo milione di lire per le
prime spese; garantendo la distribuzione tramite le Messaggerie Italiane e cedendo due dei
suoi redattori. Nonché di alri interessati all'aumento delle spese militari per
lo sperato ingresso in guerra dell'Italia; fra questi i gruppi Agnelli
e Ansaldo), che francesi e inglesi (già
dal 1917 arrivavano 100 sterline a settimana, per l'impegno di boicottare
eventuali manifestazioni pacifiste in Italia).
Conclusa la guerra, il 3
ago.1918 venne inaugurata in via Palestro la redazione genovese del giornale,
presente lo stesso Mussolini, intorno al quale si erano ormai concentrate le
varie forze militari che, nel gennaio succesivo si organizzarono nei “fasci di
azione rivoluzionaria”.
Nel contempo, finiti i
finanziamenti, si dovette procedere ad una riconversione sia di scopi che
economica (tornavano reduci, soldati ed ufficiali; c’erano i morti da onorare;
ma soprattutto tanti i mutilati; ma poveri loro, con le finanze statali vuote; si
stava creando il caos governativo; non sottacendo una sempre maggiore influenza
delle idee comuniste. Il giornale scelse cavalcare la tigre dei rimpatriati, prponendo
una riorganizzazione del lavoro (i sindacati erano sul piede di guerra: specie
quando l’Ansaldo, da parecchie decine di migliaia di operai, dovette
licenziarne molti per ‘diminuzione di richiesta’) e, di
conseguenza, una nuova struttura dello Stato
Nel 1922 si creò il
partito, ed il giornale divenne portavoce ufficiale del PNF Partito Nazionale
Fascista e dell’opera politica di Benito Mussolini.
A fine anno (1
nov.1922) a Benito succedette alla direzione il fratello Arnaldo (vedi);
e dopo la sua prematura morte nel dicembre 1931, la direzione toccò a Vito Mussolini (figlio di Arnaldo – e
quindi nipote di Benito; carica prevalentemente onorifica perché quasi mai
presente, poco attento alle necessità del giornale ed anche poco prolifico come
giornalista, al punto che nel 1945 fu processato ma assolto).
I luoghi della Redazione
e Direzione, sia quello centrale milanese che quelli periferici, vennero
chiamati "il covo" per il fatto che inizialmente erano ospitati
in cantine di normali stabili cittadini
ove gli ex Arditi,
legati a Mussolini,
proteggevano il giornale da attacchi politici nemici.
Il quotidiano divenne,
per tiratura,
il terzo a livello nazionale.
Cessò la pubblicazione il
25 lug.1943 (altri scrivono il 26 luglio), per volontà dello stesso B.Mussolini,
dopo che il Gran Consiglio si era pronunciato contro di lui, costringendolo
alle dimissioni.
Nel 1998 venne richiesta da Giuseppe Martorana (segretario e fondatore del
movimento Nuovo Ordine Nazionale) al
tribunale di Milano
la riapertura del giornale. Nel 1999 con identico nome, venne rifondato ma quale periodico
mensile, sempre con sede a Milano.
Era il giornale di
partito, quindi con ideologia unilaterale – come tutti i giornali dei dittatori
- ovvia opera di propaganda usata a
larga mano dal potere per suggestionare, incrementare ed esaltare il concetto
di ottimale: delle scelte di vita,
superiorità dell’idea fascista,
forza e compattezza nazionale, ecc.. Altrettanto erano usati la radio, le scritte murali, i
raduni, ed ovviamente le targhe stradali.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale - Toponomastica , scheda
3636
-AA.VV.-1886-1996 oltre
un sec. di Lig.-SecoloXIX-pag. 173.201.205.354
-Enciclopedia Sonzogno
-Pastorino.Vigliero-Dizion.
Delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag. 369
PORRO via
Enrico Porro
TARGHE: via -
Enrico Porro – Privata
S.Pier d’Arena – via – Enrico
Porro – 1859-1931


inizio strada a sud, angolo con
via V.Capello


a metà strada


fine della strada a nord, angolo
con via W.Fillak
QUARTIERE ANTICO: san Martino
N° IMMATRICOLAZIONE: 2830
CATEGORIA: 2
 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 50280
UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
 da
Google Earth 2007. in fucsia, via VCapello.
da
Google Earth 2007. in fucsia, via VCapello.
CAP: 16151
PARROCCHIA: san Bartolomeo della Certosa
STRUTTURA: da via V.Capello a via W.Fillak. Scorre
parallela a quest’ultima con doppio senso viario.
Strada
di proprietà privata.
Fiancheggiata
da palazzi da abitazione ritmicamente uguali, allo scopo di albergare le
famiglie dei ferrovieri (da ciò, il nome di “villaggio dei ferrovieri”).
Le
case, solo sul retro, ovvero sulla facciata esposta alla strada principale,
possiedono accennati elementi geometrici e decorazioni floreali tipo liberty,
assai semplici trattandosi di case
popolari per il personale delle Ferrovie, a contorno delle finestre, con
disegno diverso nei vari edifici.
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera e Nicolay


da dare a monte incombente struttura
CIVICI
Nel
2007, dalla toponomastica di corso Torino:
NERI=
da 1 a 11 e da 2 a 16 (compresi 2a, 6a, 10ab)
ROSSI= 20r (mancano da
2 a 18).
Nel Pagano/0 è citata, limitata da via
V.Capello e via delle Corporazioni. Segnala solo civv. neri 1, 3, 5.
===civ.
___ si apre la palestra del dopolavoro ferroviario (con corsi di danza classica
e moderna, ginnastica artistica dall’asilo all’agonistica, ginnastica della
terza età ed esotiche orientali).
===civv.
2a-6-6a: assegnati a nuove costruzioni nel 1967
===civ.
4 assegnato a nuova costruzione nel 1968
===civ. 8 assegnato
a nuova costruzione nel 1962
===civv.10-12-14-16
assegnati a costruzioni del 1960
STORIA: Iniziati i lavori tra il primo e terzo decennio
del 1900, ancora nel 1932 si erigevano
dei palazzi per conto delle Ferrovie dello Stato, non si conosce per opera di
quale architetto. Occuparono gli ultimi prati residui rimasti liberi
dell’antica “piazza d’Armi” il cui terreno probabilmente era già proprietà
delle FF.SS..
La
strada è racchiusa ai lati tra via W.Fillak ed un muraglione delle
ferrovie, che in fondo -a nord- diramano
un binario per collegarsi col parco del Campasso tramite un ponte in ferro che
chiude la nostra strada e poi passa sopra via principale (Fillak) e anticamente
segnava uno dei confini tra San Pier d’Arena e Certosa.
Nel
1933 era collocata: “da via V.Capello”, chiusa, con i soli civici 1 e 3.
Con la
costruzione (1961-7) dell’autostrada (vedi in ‘Camionale’) la strada non solo fu sormontata dal ponte
Morandi, ma i piloni –studiati per salvaguardare lo scorrimento della
via Fillak furono ‘quasi appoggiati’ alle case creando – nei poveri possessori
degli appartamenti - un incombente muraglione di cemento eliminando ogni altra
visuale.
Come
scritto sopra, molti sono stati rifatti nel dopoguerra.
Fa
ancora parte del quartiere del Campasso.
DEDICATA All’ingegnere nato nel 1859 e morto nel 1931,
progettatore della prima linea ferroviaria della Liguria-Piemonte.
Come
descritto in via Buranello, nel 1840 re Carlo Alberto firmò una ‘Regie Lettere
Patenti’ con la quale dava autorizzazione ad una società privata affinché
intraprendesse gli studi necessari per la costruzione di una strada ferrata tra Genova ed il
Piemonte-confine lombardo. Questa società, fondata e composta da banchieri e
negozianti diede l’incarico all’ing. Porro perché studiasse un progetto di
massima: questi dopo il tempo necessario propose praticamente l’itinerario
ancora attuale: da ‘fuori le mura’ o dal porto o da San Pier d’Arena, lungo la valle Polcevera, iniziando a salire per piani inclinati da Pontedecimo-Riccò fino al
livello di 340m slm, dove iniziava un tunnel lungo 1800 metri sotto il colle
dei Giovi sino a Busalla, valle dello Scrivia, Serravalle, Novi, Bozzolo
Fornigaro: qui una biforcazione. Una linea verso Bassignana per attraversare il
Po e, attraverso la Lomellina raggiungere Pavia; l’altra arrivare ad
Alessandria e proseguire per Torino lungo la valle del Po o del Tanaro.
Nei pochi anni seguenti, sia il regio
governo che la società, ebbero modo di cambiare buona parte delle regole
iniziali .Non si suppone per sfiducia; anzi nelle clausole del contratto con la
società promotrice, si rileva fiducia della casa reale verso l’operato della
società stessa, ma più d’una e pesanti
appaiono le precauzioni e le sanzioni, per questi motivi io credo il progetto
iniziale del Porro fu sottoposto a consulenza del celebre ingegnere inglese
Brunel che contava allora il primariato
mondiale di esperienza in quel ramo (il padre Marco Isambard Brunel, 1769-1849
era francese: rimase famoso per essere stato capo ingegnere di NewYork, aver
costruito a Londra la galleria sotto il
Tamigi, aver firmato molti importanti progetti
portuali, navali e ferroviari. Più probabile quindi che il Nostro sia
stato il figlio Kingdom Isambard Brunel, 1806-1859, nato a Portmouth, famoso
per aver collaborato col padre alla progettazione della galleria sotto il
Tamigi, per aver progettato ponti, opere portuali, e soprattutto linee ferroviarie
divenendo ingegnere capo delle Great Western Railway per la quale progettò
opere di ogni genere; finì la carriera in costruzioni di colossali piroscafi di
stazza di molto superiore a quanto si riteneva sino ad allora possibile): dopo
alcune dilazioni, nel 1843 questi confermò il tracciato del Porro tranne
il punto di attraversamento del Po. Non si sa bene perché, ma anche la galleria
dei Giovi fu aperta con inclinazione e lunghezza diversa, risultando alla fine
quella attuale, lunga 3100 m..
Dopo di
ciò nulla più si conosce di questo ingegnere progettatore, divenuto importante
nell’ambito delle Ferrovie dello Stato: venne promosso Capo del compartimento
di Genova. E con questa veste, che studiò i progetti delle linee ferroviarie in
porto e nelle zone limitrofe al CAP specie nella nostra città (nell’interno del
porto esiste una sviluppata rete ferroviaria che nell’insieme supera i cento
km. E’ gestita da una Sovraintendenza specifica; San Pier d’Arena faceva parte
del gruppo di san Benigno e possedeva sia la gestione merci in arrivo-partenza
via mare con spedizioni a PV (piccola
velocità) ed a GV (grande velocità), oltre i parchi del Campasso (il più
importante di tutti) e quello di Piazza d’Armi).
In più,
forse progettò o comunque partecipò -in collaborazione con Vincenzo Capello-
alla creazione del ‘rione dei ferrovieri’ nella zona del Campasso ai limiti con
la via Campi, in un periodo in cui a San Pier d’Arena c’era ancora una “vorace
fame di alloggi”.
In
conseguenza, la strada di accesso alle
case dei ferrovieri fu dedicata a questo personaggio, pioniere delle
strade ferrate, quale ‘uno di loro’.
Potrebbe
essere suo figlio, il prefetto della Provincia nel 1929, grande ufficiale dr
Ettore Porro.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 3640
-AA.VV.-Annuario
guida Archidiocesi- ed./94-pag.432;
ed./02-pag.469
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Genova,
rivista municipale del dicembre 1932
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 151
-Michelucci
GC-125mo anniversario della ferrovia…-ALG.1978-pag.18
-Millefiore.Sborgi-Un’idea
di città.C.Civico SPdA 1986-pag. 54scheda18
-Pagano/1933-pag.248-
/40-pag. 379; /1961-pag.344
-Pastorino
Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag.1506
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova- Marsilio 1995-tav.10
Non
citato da Enciclopedia Sonzogno e Motta
POSTA piazza della Posta
è un nome popolare, dato all’attuale piazza L.Settembrini alla fine del 1800
quando la piazza era senza alcuna titolazione ed apparteneva a via N.Bixio.
Prima del 1901 circa fu ufficialmente intitolata a Felice Cavallotti .
Il nome proviene
dall’utilizzo del palazzo d’angolo verso la stazione, come sede di uffici
postali. Dopo l’unificazione nazionale, il primo ufficio fu aperto in via
Battista Agnese (che -nella numerazione provinciale- porta il n° 205), mentre la prima sede fu posta in piazza Modena (numero
207) da cui ben presto però gli uffici furono trasferiti nel palazzo di piazza
F.Cavallotti.
Dopo questa sede, la direzione
ebbe molti altri spostamenti prima di arrivare ai due grossi edifici di via
U.Rela ed infine di piazza Monastero.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale palazzo Ducale
-Gazzettino Sampierdarenese : 5/88.1
-Novella P.Strade di Genova-Manoscritto
bibl.Berio 1930circa-(pag.17)
POSTUMIA via Postumia

il tracciato, da Genova ad Aquileia
NB: ne ho scritto due versioni, che vanno fuse:
DEFINIZIONE Lunga strada consolare, trasversale rispetto la penisola, costruita
negli anni attorno al 148 a.C.. Ponendo
perno a Piacenza: caratterizzata da due tratti distinti, uno occidentale: di nostro interesse; ed uno
orientale sino ad Aquileia sull’Adriatico, testimoniato da un cippo migliare (vedi sotto).
L’itinerario
occidentale, appare storicamente il più complesso per le travolgenti modifiche
che ha subito nei secoli e per le notevoli incertezze che lo circondano.
IL CONSOLE incaricato da Roma di dirigere i lavori, fu il console
Postumio Albino. Dal quale, il nome della strada. Ma, tanti sono i consoli romani
che portano il nome di Postumio Albino.
A Verona è stato là trovato un cippo
molto rovinato, conservato nel museo Maffeiano che segna chiaramente «
S(purius) Postumius S(puri) f(ilius)
S(puri) n(epos) Albinus co(n)s(ul) CX(X)II Genua Cr(e)mo(nam) XXVII». Da esso, il nome del costruttore ed i due capisaldi
Genova e Cremona; la distanza di CXXII milia passuum.
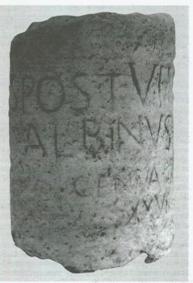
Sanguineti
(riportando la tesi dello storico Serra) presuppone che abbia iniziato la strada A. (che starebbe per Aullo,
detto il Losco e che fu console in un periodo non preciso e fissato tra il 574
ed il 180 aC.); e proseguita da
S. (che sta per Spurio e che fu console 32 anni dopo
il precedente).
LA DATA I lavori per aprire un tracciato che congiungesse
la pianura padana con la città di Genova, è concorde il parere degli studiosi (Strabonio
e Tacito) che fu
terminata nell’anno 148 avanti Cristo; facendo il conto –in
estremo difetto- dei 32 anni di differenza nell’operato dei due autori e non
esistendo atti sicuri e determinanti.

PREMESSE
A) Appare storicamente
ed in assoluto, anche se marginalmente,
che sia stata la seconda strada romana
tracciata sul nostro territorio.
La prima è misconosciuta, probabilmente perché non
fatta bene e rapidamente autodistrutta. Questo primo percorso, poi ovviamente
abbandonato per non uso, appare essere stato già tracciato nel 218, 197 e 154 a.C. per il passaggio di truppe da Genova
verso Piacenza e viceversa (episodio della seconda guerra punica e
romano-liguri-leggi sotto).
Non va sottovalutata poi la priorità di una rete di
comunicazione risalente ad epoca etrusca (testimoniata sia come
insediamento, in Genova, rappresentata da abbondante ricchezza di reperti nella
necropoli trovata -ove scorre via XX Settembre- a significato del porto quale
emporio centrale di scambi per via mare ma anche per via terra,; e sia lungo la
valle Polcevera avendo ritrovato tracce etrusche fino ai piedi della Alpi Cozie). A proposito, lo storico
Braduel F. cita: “i porti sono per natura all’incrocio delle vie terrestri e
acquee”.
B) esiste una consistente
frangia di studiosi che non accetta né la data né il percorso, né altri
particolari della storia seguente. Una gran confusione.
Infatti, tutti ovviamente, descrivono il percorso;
ma quando si tratta di scendere nei particolari specialmente da Pontedecimo al
mare, per quasi tutti i loro scritti ‘volano alti’ e scavalcano qualsiasi
dettaglio: saltano questi 11 chilometri -fino a Genova- in un sol colpo. Ciò,
in massima parte, è dovuto all’assenza di reperti tanginbili. Questo aspetto è
stato affrontato solo dalla prof. Praga la quale ha percorso a piedi le varie
possibilità, trovando uniche e molto vaghe vestigia, nessuna della strada ma di
impianti databili romani e preromani, attraverso i quali –forse- passava il
tracciato. Su questa base ella, alla fine, ha fatto le sue logiche deduzioni
che però -a loro volta- sono insufficienti per dire che “fu così” senza
lasciare spazio ad altre ragionevoli interpretazioni.
Un esempio della confusione è rilevabile nel
librettino edito dalla Provincia, intitolato “Le rotte terrestri del Porto di
Genova” nel quale, a pag 13 si presume -per
la Postumia - un tragitto passante per salita degli Angeli, ma da qui salire
verso Fregoso per arrivare a Begato; nella pagina seguente si accetta un’altra
via che percorreva la sponda destra del torrente (dal Boschetto); mentre la
foto grande espone salita al Forte Crocetta, senza spiegare che anch’essa portava -tutta in costa- sempre a Begato, ma
con passaggio non da Fregoso né da basso, ma alto sulla nostra spiaggia,
ignorando comunque salita Bersezio e il toponimo ‘Pietra’.
C) Ovvie
le successive frammentazioni della sua unitarietà di percorso variate nel tempo
per le cambiate necessità di destinazione merci, topografiche, politiche,
orografiche, ecc. (alcuni tratti vennero
totalmente esclusi forse perché pericolosi per brigantaggio o
impercorribilità; altri variati per temporanei disusi; altri trasformati ad uso
locale).
D) proponiamo una cronologia storica, mirata a capire
le premesse alla strada.
---fine del VI secolo aC sono sicuramente attestati
scambi commerciali ‘internazionali’ usando le vie marittime. Ma altrettanti,
usando la via terrestre, verso l’area padana. La cospicua presenza di materiali
artigianali (etruschi, fenici, cartaginesi, greco-tirrenici, nonché oggetti di
provenienza golasecchiana, evidenziano già in quest’epoca stretti rapporti
commerciali tra il nostro capoluogo e la
pianura padana con prevalente direttrice Valpolcevera (futura Postumia).
---fine III
secolo, e tutto il II secolo aC.-. è rappresentato
dalla fine della prima guerra punica e dall’espansionismo
romano nella Liguria di allora (dal Po al mare) e nella Gallia Cisalpina, mirato alla capillare penetrazione nelle
regioni del nord dove la frammentazione etnica dei Liguri costrinse Roma ad una serie di guerre
tutt’altro che facili:
---anno 238 aC : T.Sempronio Gracco contro gli
Insubri e altre tribù dell’interno
--- “
236 : L.Cornelio Lentulo celebrò il primo trionfo ‘de Liguribus’. Lamboglia
propone questa data come ‘fissazione’ di Genova quale porto ufficiale romano fortificato
(assieme a
Luni e Pisa).
--- “ 233
: Q.Fabio Masimo sottomette la Liguria orientale (quando Genua era già
‘civitas foederata’ che ospitò l’accampamento romano impegnato contro i Boi ed
Insubri).
--- “ 222 aC : inizia la seconda guerra punica
che vanifica i risultati =Boi ed Insubri si alleano con Annibale ed assaltano
Piacenza e Cremona. Forse, nel 218 C.Cornelio Scipione sbarcò a Genova
proveniente dalla Gallia (narrazione di Livio:”ipse cum admodum exiguis copiis
Genuam repetit eo, qui circa Padum erat exercitus, Italiam defensurus”), per
raggiungere la valle padana dove era Annibale. Genova (diventata non solo base
navale ma anche caposaldo militare) viene assalita da Magone (205 aC);
l’urgenza con cui dopo due anni Roma la fa ricostruire da Spurio Lucrezio con
lo scopo di renderla capoluogo, ne
dimostra l’importanza.
G.Cera (pag.23) pone in questi anni (200 aC) il
capolinea in Genova della ‘via Aurelia nova’; ed evidenzia come nel periodo
tardo imperiale, secondo l’Itinerarium Antonini, mancando un collegamento
diretto con Vado, l’Aurelia rifaceva un
tratto della Postumia: -dopo la città- la Valpolcevera ed un percorso interno
passante per Libarna ed arrivante a Tortona da dove, per scendere a Vado,
passava da Aquae Statiellae
--- “ 197
: Q.Minucio Rufo partendo da Genova occupa militarmente la direttrice occidentale
verso la pianura padana (previene così la nostra strada), assoggettando 15
tribù liguri dell’Appennino (tra i quali Litubium –forse Retorbido- e
Casteggio) garantendo sia una linea di difesa continua tra i tre caposaldi strategici militari (Genova e
Piacenza-Cremona nel frattempo –190 aC- liberate dai Galli Boi da P.Cornelio
ScipioneNasica) e sia la nascita della
via Emilia (187 aC). Prosegue così l’espansione verso il nordovest:
---anno 181 aC : vittoria sugli Ingauni
--- “ 180
: deportazione degli Apuani
--- “ 179
: sottomissione degli Statielli
--- “ 166
: vittoria sui Liguri Eleates, definitiva nell’anno 158.
--- “ 154 aC :
Q.Opimio partì da Piacenza verso Genova, per sedare la rivolta della
tribù degli Oxibii e dei Deciati.
--- “ 148
: Per collegare, e quindi
finalizzare, consolidare e far assimilare questo lento e difficile
processo di romanizzazione, ecco nascere la POSTUMIA.
-
117 :la tavola del
Polcevera
-
110 : la via Aurelia
- 100
ca, : Strabone definisce Genova
‘emporio’ per i Liguri dell’entroterra (ovvero oltre Appennino). Lamboglia
descrive un documento in cui a quella data Genova è definita ‘municipio di
diritto romano, iscritto alla tribù Galeria’
-
13 : apertura della via
Iulia
LO SCOPO accettato
da tutti gli Studiosi, quello determinante di strada militare ovvero spostamento di
truppe (con esse, definire il controllo delle popolazioni indigene da
assoggettare e stabilizzare la regione premiando
le tribù filoromane).
Se per Roma la stabilizzazione delle città costiere
non fu facile, ma con caposaldi di certa fiducia e fedeltà, assai meno facile
fu il riuscire a domare le varie tribù interne dell’Italia nord-occidentale, per
definizione di tutti, dei Liguri. Ci riuscì a prezzo di rinnovate battaglie,
quasi tutte vinte specie quelle in campo aperto –per un ottimale schieramento-,
ma ciascuna con decine di migliaia di morti per indicare il grosso apporto
umano che doveva essere ogni volta raccolto e trasferito: da ciò, per
Roma, la necessità di strade
Ma i romani non erano militari fine a se stessi: l’organizzazione
armata aveva dietro altri importanti scopi: uno, creare una specie di confine
con gli Insubri (che attraverso patti ‘foedera’,
dimostrarono preferire il mantenere l’autonomia), e non ultimo quello commerciale, anche se prevalente a
senso unico; cioè usufruire dei territori per esportare si cultura e sicurezza, ma importare gratis le
materie prime esistenti nella zona. Quest’ultimo
meccanismo si può applicare anche assalendo una nave, un borgo, una città,
saccheggiandoli; conquistare il territorio è uguale; ma significa la volontà di
stabilizzare il rapporto, crearlo duraturo e non fugace.
Quindi, raggiunse –una volta esistente- anche una
non poca importanza commerciale per Genova ed il suo interno, testimoniata
dalla Tavola del 117 a.C..che cita la strada ben tre volte a testimonianza di
punto di riferimento.
Per fortuna della Repubblica di Genova, questa
strada non fu mantenuta funzionante; cosicché in seguito se non fu mai sufficiente
a inserirci nella storia dell’Italia che si sviluppò -per 1800 anni, nel bene e
nel male- quasi solo e sempre al di là degli Appennini, ci preservò per molte
volte inopportune invasioni.
LA STRADA
a) il progetto
Il tracciato fu progettato trasversale rispetto le
strade che da Roma ascendevano al nord; e lo scopo era di collegarle tutte tra
loro per ovvio più rapido spostamento delle truppe e migliore controllo del
territorio.
Questo fa presupporre che
i romani già possedessero delle mappe per avere una visuale d’insieme di un
territorio così vasto. Comunque, localmente, il tracciato in genere doveva
ricalcare quello dei sentieri vicinali, specie quando si trattò di traversare
l’appennino.
b) schiavi il
lavoro fu fatto fare da schiavi e prigionieri. Le battaglie, ne procuravano a
sufficienza, quando ne saranno occorsi qualche migliaio; con tutta una
organizzazione dietro. Personalmente, proporrei questa osservazione come una delle basilari:
nell’aprire la strada, necessitarono molti operai e materiale; visto che le
battaglie vinte e con esse le terre conquistate contemplavano non le coste ma
l’interno, è più probabile che da
Libarna siano arrivati a Genova e non viceversa. Avvalorata dall’idea
dell’usuale utilizzo –secondo mentalità militare romana- di trasferimenti via
terra.
Probabilmente la strada fu
iniziata in più punti, come è in uso anche attuale con plurimi appalti. Pertanto,
a mio avviso, la massa di schiavi fu concentrata a Piacenza ed a Cremona, e da
là iniziò l’immane sforzo costruttivo, verso Genova, durato molti anni. Se tale
massa di gente fosse stata sbarcata a Genova, forse rimarrebbe traccia
mnemonica di questo esodo ed operazione di grosso respiro.
Ai lavoratori, i militari dovettero far fare degli
sforzi immensi e gravosi (possiamo immaginare l’Appennino con i suoi boschi e
pendici rocciose o franose e ripide, d’inverno con diluvi che distruggevano
tutto se non molto ben impiantato); lo dimostra che da alcuni studiosi fu
chiamata ‘Erculea o Eraclea’ perché somigliante al percorso dell’eroe durante la
decima fatica (vedi Aurelia); ma è più
saggio pensare che utilizzò i sentieri lungo costa già usati e che quindi non
attraversò l’Appennino sia in senso mare-Po, che inverso come suggerì Tito
Livio per un improbabile percorso risalente il Rodano, attraversante le Alpi
Graie (da lui, che era greco), ridiscendente al mare (il percorso della
Postumia) per scendere nel sud Italia e tornare in Grecia)
c) la direzione
Mille storici, mille ipotesi; nessuna certezza:
leggendo la bibliografia si desume che ciascun autore cerca di impersonarsi nel
console romano, e suggerisce dove ‘lui sarebbe passato’.
Non è quindi importante stabilire se Genova fu
punto di arrivo o di partenza della strada; anche se tutto fa optare per la
prima ipotesi. Perché erano già funzionanti le strade
oltreappennino Flaminia ed Emilia; perché i liguri ribelli erano
prevalentemente quelli dell’interno; e perché
per l’esercito romano - in caso di necessità di portare truppe in
Liguria - i metodi potevano essere due, o via nave (la migliore, ma occorreva
avere tante navi, e non sempre era facile averle libere e disponibili in
quantità necessaria); oppure da Piacenza ‘calare’ verso il mare.
Per la seconda ipotesi opta che ‘le miglia’ vengono
contate a partire da Genova (da Cipollina definita ‘umbilicus urbis
Ianue’) ed il primo
miglio fissato in località poi chiamata s.Limbania, ove sorse l’abbazia di
s.Tommaso. Secondo miglio è dove la definizione ‘Pietra’, posta alla fine del
Campasso (la zona è comprensibile dalla base del Torrente, alla sommità del
Colle omonimo se le merci transitavano in basso –d’estate- o a mezza-alta costa
nelle piogge d’ autunno e nevicate; e
prima di arrivare a Rivarolo dove esisteva un ponte che (tavola Peutingeriana)
portava ‘ad Figlinas’ ed al ponte del ‘Decimo Miliario’ (Pontedecimo= no essere
decimo ponte ma decimo miglio=pons ad decimus lapidem).
A) da Piacenza a Tortona.
Quindi, dal monte al mare, con brevissimo accenno (perché
poco interessa a questa ricerca tutto questo cammino,un lungo tratto e tutta
una storia che coinvolge i confini della Repubblica e l’entroterra).
Possiamo far cenno che nel procedere in
questa direzione, è ovvio che i vari cantieri aprirono punti di rifornimento e
concentrazione del materiale necessario;
alcuni acquisirono struttura di borgo con relativo nome
Tutti d’accordo, gli Storici per il tratto: Piacenza
→Camillomagnus→-Iria (Voghera)→Dertona (Tortona).
B)
da Tortona alla Bocchetta
Qui
iniziano le prime sostanziali varianti, tutte possibili, nessuna dimostrata. La
vera Postumia ebbe un solo tracciato. Ma
perduta qualsiasi traccia, ognuno dice la sua. Al lato pratico, tante e
diverse opportunità si offrivano a chi voleva arrivare al mare
Ma
poiché il passaggio attraverso la Bocchetta è sempre stato privilegiato nel
medioevo e rinascimento, sia nei viaggi dei quali rimane traccia (monaci,
ambasciatori, eserciti invasori; siè invogliati a pensare che anche in epoca
romana fu la via preferenziale, e corrisponda a quella della Postumia).
1) da Dertona, il percorso poteva seguire il fiume
Scrivia. Lungo il quale avrebbe trovavo -dopo Serravalle- Libarna. Sin qui, è
ragionevole. Ma, ma così seguendo, il
fiume avrebbe portato da Busalla ai Giovi (Puncuh).
O proseguendo,
da dopo Isorelle al passo della Vittoria.
O arrivare a Casella dalla quale scendere da Crocetta
d’Orero a Serra Riccò, e proseguire per s.Cipriano; Per Miscosi, l’Eraclea era quella che da
Libarna per la Valbrevenna (via breve) passava per Crocetta d’Orero (da Oeum),
scendeva a Torrazza (dal latino Tauricia), risaliva al Garbo. A Sarissola vantano una sosta di Liutprando
nel ritorno a piedi con le ceneri di s.Agostino.
O a Montoggio (da dove calare in val Bisagno).
2) Da
Dertona seguendo →fiume Lemme (oggi con Novi, Gavi,
Voltaggio): si sale direttamente →
fino ai 772 metri di quota della Bocchetta.
3) Da
Dertona seguendo in parte il fiume Scrivia lato destro fino a Libarna
(posta a XXXVI miglia dal caput viae) ed a Pietrabissara; qui deviare per → risalire
fino alla Bocchetta.
C)
dalla Bocchetta a Pontedecimo
Pressoché
tutti concordi nel trovare in Pontedecimo, il punto logico di stazione di posta
(Pons ad decimum lapidem=ponte sul torrente al decimo miglio romano=14 km da
Genova).
Dislivello enorme per quei tempi, forse mai
superato nelle altre strade romane: dai 772 m/slm del passo, fino a PonteX .
D’inverno doveva restare chiusa a lungo. D’estate era percorso da briganti.
Dal passo, gli itinerari di discesa sono più d’uno:
il più antico percorre dopo Libarna, Fraconalto e Bocchetta→ Reste (ex
postazione romana di controllo della strada)→ Pietralavezzara (marmo
verde)→tre possibilità: la più antica è →Campora (la Parascevi
della Tavola bronzea)→Cesino (alberi di ciliegio; Sexino è citata nel 996
dC)→PonteX (con castello romano, più volte distrutto fino all’ultimo nel
1920).
Altre, più tardive, da Pietralavezzara→Campomorone
(=albero di gelsi e/o castagne; toponimo trovato esistere dall’anno 1163);
oppure Pietralavezzara→Langasco (sede dei Viturii Langenses; rimenzionata
nel 993 dC); →Costagiutta→Paveto (XIII secolo); oppure Costagiutta→Fumeri
e borgo Malopasso (XV sec.).
D) Da Pontedecimo a .... Se multiple sono le tesi da Tortona a
Pontedecimo, molto più complicate e disponibili
-da questo borgo- a ventaglio, le
possibilità di approccio a Genova.
Non esistendo reperti romani aC, ma solo dC, ciascuna teoria appare possibile.
Per il nostro borgo, non ci sono tracce né anteC né
postC.
a) la maggior parte degli
Studiosi, saltano qualsiasi riferimento fino a Fassolo (la
chiesa di s.Tomaso-oggi distrutta- possedeva
tracce di epoca romana; anche a Prè sono state trovate tracce
dell’epoca; così come lungo l’asse della linea costiera, per toccare tutti i vari piccoli approdi e
relativi insediamenti suburbani del ponente, fin sotto la porta perimetrale a Banchi ed
all’attuale piazza s.Giorgio. Il tutto
relativamente confermato da necropoli cristiane,ma, dC..) e fanno arrivare la strada
a Genova tutta in un volo.
b) lo storico Cirnigliaro, da Pontedecimo
fa salire la strada a san Cipriano, passare per Morego, torrente Secca,
Cremeno, Begato, val Polcevera, Granarolo, Genova in piazza oggi san Giorgio. (Mi
sembra un inutile sali-scendi attraverso i monti quando la strada lungo il
Polcevera era molto più facile; forse, quando il torrente era in piena).
c)
alcuni altri, scendendo sul lato destro o di ponente del torrente, fanno
transito a Fegino (per riscontro di resti di un forno di cottura
(fornace?)con ceramiche etrusche e comunque preromane. La
tavola peutingeriana del 330 dC cita –e non a caso quindi- ad Figlinas (dal sostantivo latino ‘figulina’
ovvero argilla, e quindi o cava o fabbrica di vasi- riporta la distanza VII
miglia (=10,5 km, possibili corrispondenti alla Postumia).
Con
due pareri diversi: - c1) alcuni studiosi
negano poi un tratto verso Genova: secondo loro, essendo la strada a scopo
militare e dovendo le truppe portarsi nel ponente ligure, a Fegino piegava verso Sestri e proseguiva verso la Gallia. - c2) per altri appare sciocco non arrivasse a
Genova ( perché capoluogo, per
rifornimenti tramite il porto, per ordini e messaggi da e per Roma, per la
comodità dei consoli addetti alla strada; e quindi la fanno proseguire a T: verso la città e verso il ponente lungo il
mare.
Ma
anche qui, c2a) alcuni proseguono diritti
sino a Cornigliano restando sul lato destro; altri c2b) a Fegino attraversano
un ponte e passano sulla sponda sinistra;
e sino alla città aprono un tracciato che sarà ricalcato dall’Aurelia.
d)
Melli Piera (in Vie Romane in Liguria di Luccardini) propone: Pontedecimo-
Morego- Cremeno- Campora di Geminiano- Granarolo-salita Angeli.
e)Bassoli propone tracciato
sulla dx del torrente ma si ferma al Boschetto; sulla sinistra, da PonteX arriva
alla Certosa di s.Bartolomeo.
f) personalmente, propendo
per la teoria 2b); a testimonianza, la Tavola deporrebbe –nella stagione
favorevole- per una strada che scendeva col torrente Polcevera, almento sino al
Torbella, probabilmente sul lato destro. Qui la strada si biforcava: a destra si
poteva proseguire per la riviera di ponente (Fegino, Borzoli, Sestri)
oppure, a
sinistra passare con un ponte o un guado sul greto di
sinistra, sino a Certosa. Qui la zona diveniva paludosa se il tempo volgeva a
pioggia, pertanto –dovendo poi in ogni modo superare il colle di s.Benigno per
arrivare a Genova- non conveniva più
proseguire sul greto ed arrivare alla spiaggia, quanto invece risalire verso levante: o al Garbo (ed
arrivare dall’alto al nostro Belvedere, passando dall’attuale forte Crocetta); o alla Pietra (salendo per
l’attuale salita VBersezio e per incrociare –sulla cresta del colle del
Belvedere- la strada proveniente dal Garbo).
Il tempo –abbiamo scritto- faceva decidere il
percorso (d’inverno era meglio la via a mezza costa; d’estate o quelle sui
crinali o quella lungo il greto del torrente); ma anche altri interessi
giocavano sul percorso da farsi: dove portare le merci (al
porto o in una delle due riviere), a chi era indirizzata
la carovana (dove veniva ospitata allo scioglimento), le gabelle, le stazioni
di riposo, ecc..
Se così furono le cose,
il tratto da Genova al Torbella fu identico per tre strade successive: primo
per la prima Aurelia, (nata poco prima: nel 200 aC. per direttiva
di CAurelioCotta); secondo per la Postumia; terzo per l’Aurelia
rifatta poco dopo (110 a.C. da parte di EmilioScauri).

da Quilici L & S – sicuramente errato il
transito
‘entro’ il territorio del futuro borgo
TESTIMONIANZE IN EPOCA
ROMANA
--La tavola del Polcevera. La via viene menzionata
tre volte sebbene non influisca nella distribuzione dei territori tra le due
popolazioni i quali sembrerebbero quindi antecedenti alla colonizzazione
romana.
--Strabone. Storico che descrisse la posizione di
Dertona (Tortona) riscontrandola equidistante tra Genova e Piacenza: 400 stadi,
pari a 50 miglia romane. Purtroppo la sua descrizione non è contemporanea ma
posteriore, e fa riferimento a successive trasformazioni che il percorso ebbe a
subire specie la deviazione verso Aquae Statiellae che avvenne in epoca augustea
(via Aemilia Scauri, poi Iulia Augusta).
--Tacito. descrittore nelle sue ‘Historie’ delle
guerre civili tra Otoniani e Vitelliani della seconda metà del primo secolo dC.
La strada ebbe funzione determinante per interventi a partenza da Piacenza
(Placentia), Cremona, Bedriacum
TESTIMONIANZE IN EPOCA DOPO CRISTO:
anni 0-200 L’incremento economico portato
dai romani,
conseguente all’assoggettamento dei Liguri, durò fino al secondo secolo dC
quando iniziò un declino commerciale con il ponente relativo a un declassamento
iniziato con l’apertura della via Iulia (13 aC) che escludeva Genova a
vantaggio del tragitto da Acqui a Vado. In questi due secoli, la strada
mantenne efficienza inalterata nel settore periurbano fino all’intera
Valpolcevera ma quasi solo per interscambi locali (come testimoniano le
necropoli e gli oggetti ritrovati lungo il percorso; e fino al tardo medioevo
con l’erezioni delle chiese importanti sul tragitto: s.Giorgio, s.Fede, s.Siro,
s.Tomaso).
A questi ipotetici fatti commerciali corrisponde
una lacuna di documenti e notizie d’archivio che rimarranno sino ai tempi
di Costantino.
Forse tutti hanno una
ragione, perché occorre anche un minimo di distinguo per tempi successivi: sino
ai tempi medievali il tracciato verso nord era aperto prevalentemente in alta
mezzacosta se non addirittura sul crinale dei monti, sia per evitare il
torrente non arginato (se non –a tratti- dopo il secolo XV per le ville private), sia per
attraversare i centri abitati generalmente eretti sull’alto dei pendii.
Nel 312
dC Milano diventa capitale dell’Impero; la Postumia
viene riattivata per i rifornimenti (grano, olio) che dal porto erano destinati
a Milano dalla quale dipendevano Genova e le province sicule ed africane. Pare
che nell’occasione, molto più frequentato fu l’itinerario che da Morego e san
Cipriano passava per il passo –oggi della Vittoria- e scendesse a Savignone.
Nel secolo, gli Itinerarium Antonini+ tabula
peutingeriana+ itinerarium Burdingalense, in epoca tardo imperiale descrivono
il tracciato –specie quello orientale- che appare aver già perduto buona parte
della sua importanza, comparendo tratti di collegamento divenuti importanti e
vitali ed altri caduti in totale disuso: così nell’alta val Polvecera è
presumibile siano state create alternative multiple al tracciato ufficiale. La
assenza di particolari accenni alla strada in questa epoca, fa supporre che la
sua concezione unitaria sia divenuta già frammentaria; l’instabilità
idrogeologica condizionò non poco la continuità del percorso, facendo perdere
tracce ad esso pertinenti; ma anche ospizi e monasteri, dapprima eretti ‘fuori
via’, furono determinanti per variare il
percorso.
Nel 408
dC lo storico Zosimo
racconta di emissari eunuchi inviati da Roma, che accompagnavano la
moglie (era la seconda, si chiamava Termanzia ed era figlia di Stilicone)
ripudiata alla propria madre a Ravenna: preferirono far vela a Genova e
percorrere la Postumia.
Così, risulta che la
strada fu poi sfruttata nel 535-554 dC.
dai Bizantini
contro gli Ostrogoti: Procopio scrive
che nel 538 i Bizantini –comandati da
Mundila, inviato del generale Belisario, giunti a Genova via nave con mille
fanti- trasformarono le navi in carri, trainati con scivoli o ruote si
inoltrarono occupando Acqui (la più nota; principale sede di vettovagliamento e
concentrazione di eserciti) e Libarna (Già in declino), poi insediarono Tortona
(favorita perché posta all’incrocio tra la Postumia, la AEmiliaScauri e la
IuliaAugusta). Giunti al Po le ritrasformarono in barche ed attraversarono il
fiume conquistando Pavia (Ticinum).e Milano.
Nel frattempo -539
dC- il re d’Austrasia Teodeberto (figlio di Teodorico; morto poi in un
incidente di caccia nel 548) dal Gottardo scese a combattere sia Goti che
Bizantini: li sconfisse presso Tortona, li inseguì sulla Postumia passando per
Genova (che saccheggiò) e poi ancora per l’Aurelia sino a Vado; qui la peste lo
indusse a desistere l’inseguimento e tornare indietro.
Nel 569 Onorato,
vescovo di Milano, scappò a Genova percorrendo la Postumia, strada previlegiata
dai Bizantini che conservarono l’area a sud di essa, sino ai primi anni del VII secolo.
Nel 590,
la presenza dei Longobardi
è ormai dominante, malgrado vaghi tentativi di riscossa dei bizantini. Doventerà pressoché totale nel 603. Nel 590 Agilulfo –duca di Torino- alla morte di Autari (591)
sposandone la vedova Teodolinda –politicamente vicina al papa Gregorio Magno e
fautrice dell’espansione religiosa cattolica-
divenne re dei Longobardi. Subito
impose l’autorità regia sui duchi ribelli conquistando definitivamente Parma e
Piacenza (per una decina di anni, si alternavano i possedimenti di queste due
città) e così dilagando verso il mare usando strade già tracciate, in
particolare la Postumia ed una della val di Vara, travolgendo i vaghi tentativi
di difesa bizantini.
È legato a questo V secolo, il percorso
fatto dai santi Nazario e Celso, che in tre
giorni da Genova arrivarono a Milano.
Fu quando, Rotari
re dei Longobardi, nell’anno 636 dC. volendo por definitiva fine alla
dominazione bizantina, percorse la strada e –giunto al mare- distrusse la città
di Genova e la sua fascia costiera fino a Luni e Varigotti; progressivo
controllo amministrativo più che militare, fino all’integrazione graduale
favorita dalla alta religiosità dei longobardi con l’espansione monastica.
Ancora tutto da
risolvere, il viaggio di Liutprando con le
ceneri di s.Agostino dell’anno 725 circa,
che da San Pier d’Arena raggiunsero Morego, il passo della Vittoria e scesero a
Ponte di Savignone
La Postumia si incrocierà
-negli anni 1000- con la via Franchigena come percorso di 900 km. da
Gran s.Bernardo (a 2474 slm)
-Aosta-Ivrea-Vercelli-Pavia-Piacenza-Pontremoli-Aulla-Sarzana-Siena-Boilsena-Viterbo-Roma)
Se a partire dai secoli a cavallo del 1000 la
spiaggia di SPdA si arricchì di cantieri, lo si dovette allo sfruttamento dei
rigogliosi boschi dell’interno, specie di roveri molto adatti e pregiati per
fabbricare navi; e di abeti (bianco) per i pennoni. Si dovette creare questa
prima ‘via dei legni’, necessari anche per le capriate delle chiese, dei tetti
e saloni delle case. Per il trasporto non esistevano mezzi se non quelli
primitivi: dai colpi d’ascia, alle catene e puntoni per agganciare i tronchi e
trasportarli trainati da buoi messi a coppie multiple. Si
ebbe cura del selciato per permettere di far scorrere meglio le slitte o i
carri (esempio ponendo le pietre non a piatto ma a coltello, che evitava nelle
discese che il traino sfuggisse al controllo; e cercando le stagioni che
permettessero il non facile scorrere sulle vie d’acqua). Solo
l’esaurimento delle scorte dell’alta val Polcevera e la mancanza di una
programmazione colturale portarono -nel rinascimento- alla necessità di
rifornimenti più lontani, e recapitati sulla spiaggia via mare.

In questo secolo, sempre per dimostrare un
‘vivace’ transito stradale, inizia e si consolida il potere vescovile nei
territoiri oltre appennino: in cambio di protezione si fortificano con castelli
i villaggi, i quali giurano fedeltà al vescovo, e curano sia l’agricoltura che
i traffici commerciali (e con essi le strade) e le rendite (così Novi, Acqui,
Visone, e decine di altri siti ancor oggi eretti nel basso Piemonte).
Abbiamo nel XII
secolo l’inizio dell’espansione politica e militare
genovese nell’oltregiogo. Direttrice privilegiata dai genovesi fu la val Lemme
(Fiacone-odierna Fraconalto-, Voltaggio, Montaldo conquistati con la forza nel
terzo decennio di quel secolo. Lo stesso castello del marchese di Gavi pare fu acquisito non tramite regolare
acquisto –come descritto dall’annalista Caffaro- ma ‘manu militari’. Ed
altrettanto il castello di Parodi, che nel 1148 dal marchese Alberto Zuata fu
‘ceduto’ per metà (del castrum, della torre e della curia –quale territorio
attorno ad un castello-) ai genovesi).
Malgrado ciò ed in contrapposto, l’utilizzo
delle strade andò scemando fino al quasi totale disuso; lo stesso Barbarossa
negli anni 1152-62, senz’altro fu frenato dal venire a punire l’insolente
Genova, non solo per le fortificazione prontamente erette, ma anche per le difficoltà
di avvicinamento ed approvvigionamento.
Infatti la strada fu
praticamente sempre trascurata dal governo genovese anche se divenuta l’unica
carrettabile nei limitrofi verso nord della Repubblica, comprese Novi, Gavi ed
Alessandria.
Rimase così carrettabile locale (non
‘munita’ ovvero non lastricata né fortificata né servita da stazioni) per
arrivare ai confini della Repubblica o nei possedimenti dei nobili: rimangono
ancor oggi i vari Castelli (di Savignone,
della Pietra, ecc) dai quali pagare una tassa di passaggio. In effetti le
grosse città (Asti, Gavi, Alessandria) e le piccole, divennero sede di
pagamento di pedaggi a fronte di servizi di ospizio, cambio animali e ventaglio
di ulteriori diramazioni. Ma per questo forse
i tragitti si moltiplicarono formando un intricato groviglio di percorsi
secondari e alternativi. Così si spiega, che volutamente fu trascurata, essendo
prevalente fonte di innumerevoli grattacapi tra i quali, sia gli ostacoli
naturali (esondazioni, frane, crolli di ponti)
che umane (brigantaggio, pedaggi; ma peggio di tutti, che era altrettanto
l’unica percorribile dai troppo frequenti eserciti invasori, specialmente
piemontesi).
Giustiniani
visse la scoperta della Tavola del Polcevera (1506) e con essa un risveglio di
interesse sul tracciato, che si era mortificato per carenza di informazioni,
descrivendo sugli Annali (1537) il percorso sino alla valle Scrivia.
Con lui,
altri autori descrissero la strada sia con perlustrazione dei territori sia con
studi su manoscritti (Cluverio 1650 ca; Cellarius, Beretti.
Nel marzo 1507 vi passò anche re Luigi XII col suo esercito, contro Genova quando
era doge Paolo da Novi. Ma
in pratica, su quei sentieri, transitavano solo carovane di mercanti, soldati di ventura, diplomatici con
la scorta, religiosi in trasferimento di sede.
Nel 1584, il tragitto era ancora
percorribile solo da audaci avventurieri pari a quelli che traversavano
l’Oceano. Il Senato decise un ammodernamento passando a ponente di Fraconalto
(dove passava la precedente) in modo che fosse meno in salita e da renderla
carrettabile, e che calasse più dolcemente su Campomorone, dove nelle prime
decadi del 1600 fu eretta la ‘salea’ .
A doppio taglio sempre la conservazione
della transitabilità; il timore di accrescere le spese di mantenimento (frane,
impaludamenti, ponti marcescenti) -anche se venivano coinvolti i paesi
interessati-; e di facilitare gli
invasori.
L’impervietà del tracciato e la rudezza della
vita nell’entroterra, favorì non poco anche il brigantaggio
lungo il percorso ed il grave pericolo della diffusione della peste. E non
ultimo ma frequente lo spadroneggiare
delle stesse truppe genovesi mandate a difendere i confini e che passando per i
paesi commettevano suprusi di ogni tipo (Tuvo
Campagnol, propongono allo scopo
documenti sui quali si legge che
il Commissario, il nostro GioVincenzo Imperiale, segnala al Senato che i
paesi si spopolano causa i
danneggiamenti delle soldataglie di passaggio. E nel 1625 Antonio Durazzo,
scrive da Pontedecimo dell’identico problema: “...saccheggiate dalli soldati
che passano li quali hanno fracassate le porte delle case...et rubate le
biancherie, robe, denari et quello che hanno trovato in casa et quello che è
peggio hanno sforzate moltissime giovani di detti luoghi pubblicamente...la
valle è divenuta un bosco di ladri...”.)..
Solo con
grandi lavori di arginatura, nel 1585, fu realizzata una carrettabile sulla
riva sinistra del Polcevera; così gli itinerari si concentrarono spostandosi
più intensi in basso, lungo il greto, da Pontedecimo a Certosa
Nel 1625 il duca di Savoia si vide
costretto ad interrompere il tentativo di invasione e di occupare Genova,
perché “ritrovò impossibile il condurre per esse (strade) le artiglierie. E
molto arduo il bagaglio e le provvigioni…”.
1632.
L’erezione delle ultime mura e l’apertura di un limitato numero di porte (tre
verso il Bisagno: san Bernardino, san Bartolomeo e Chiappe; una verso nord, di
Granarolo; una verso ponente, la Murata poi gli Angeli), costrinsero molti
sentieri a confluire trasversalmente da/verso le porte stesse.
Riferiti al trienno 1637-9, la
differenza degli introiti della gabella, per il transito attraverso la Porta di
sTomaso e quella di sStefano, evidenzia: pedaggi per approvigionamento della
città (£.34.607 contro 612); vino (£. 23.306 contro 23.200); grano (£.3.412
contro 198); carne (£.348 contro 16.464=maggiore per bestiame proveniente dal
Piacentino).
Riassumendo, nel XVII secolo, verso Genova
di ponente, contiamo quindi quattro possibilità di percorso:
1)=
da Ovada-Asti, Rossiglione, Masone, Turchino, Voltri. 2)=
la antica via della Postumia, detta ora ‘della Bocchetta’ (Novi o
Serravalle-Voltaggio-Fraconalto, Campomorone-PonteX, valle Polcevera-Genova o
Sestri); 3)=oppure
la via detta ‘dei Feudi Imperiali’, o Cannellona (gestita in prevalenza dai
Fieschi, legati all’Impero ed a Vienna, percorreva da Ortona, Mongiardino,
Vobbia, Crocefieschi, Casella, Crocetta
d’Orero, Vicomorasso, Bolzaneto); 4)= oppure quella delle Capanne (Acqui, Benedicta Capanne di Marcarolo SMartino di
Paravanico, PonteX, Ceranesi- Lencisa- val Varenna, Pegli).
Ancora nel 1702 il re di Spagna, e
nel 1711 CarloIII, da Milano intendendo imbarcarsi dalla nostra spiaggia per
rientrare in patria, costrinsero il Senato a inutili ed effimere riparazioni.
Lo stesso nel 1713 quando la carrozza della regina Elisabetta Cristina di
Spagna (moglie di CarloIII), si riversò, mentre percorreva il greto del
Polcevera.
Gli austriaci dell’epoca balilliana, con a
capo il Botta Adorno, la percorsero nel 1746 nei due sensi, assai avvelenati nel rientro
per carenza di bottino (sicuramente cercarono, fuggendo, di rifarsi con i
locali).
Alla ‘pigrizia’ dei Padri del Comune, sopperì
l’impresa privata, quando nel 1773 il doge GB
Cambiaso fece aprire una strada carrozzabile (completata in tre anni e
chiamata popolarmente ‘cambiaggia’) che, seguendo il torrente per otto miglia,
arrivava sino a Campomorone (dove si allacciava la strada che saliva alla
Bocchetta) per arrivare a Cremeno dove aveva la villa..
Agli inizi
del 1800 il canonico Bottazzi individuò la posizione -sino ad allora
sconosciuta- di Libarna e di alcuni tratti lastricati nelle sue
vicinanze.
Possiamo definire, sino a queste date -anteriori
all’arrivo dei francesi- che il genovesato era tracciato quasi per intero solo
da mulattiere, con due caratteristiche: una di essere tendenzialmente a mezza
costa per evitare inondazioni in basso e nevicate in alto; l’altra di non avere
una gerarchia determinante nel senso che le direttrici potevano essere multiple
e –seguendo il ventaglio delle valli- ad andamento divergente, senza tappe obbligate.
Ancora all’epoca di
Napoleone, 1800, e poco oltre, la via tradizionale passava solo per la
Bocchetta; anni in cui si scrive che era oggetto di transito di oltre 350mila
muli all’anno.
In quello stesso anno, il ‘Dipartimento di
Genova’, nei progetti dell’amministrazione francese il tratto
Genova-Sampierdarena, si sovrapponeva alla strada n° 14 (Aurelia, inaugurata
quell’anno da permettere di proseguire in carrozza fino a Savona e Noli); e
nella direzione nord, era interessato con una sola ‘strada n° 210:
Genova-Alessandria’, per Campomorone-Bocchetta-Novi, ma con un certo interesse
a realizzare una via detta ‘dei Giovi’ verso Busalla (inaugurata nel 1821: da
Genova, venti ore per arrivare a Milano, venticinque a Torino).
Solo nel 1813 Parigi programmò un
piano regolatore della viabilità dell’Impero, comprendente l’apertura della via
dei Giovi, che saliva solo a 469m con pendenza massima del 7%; il progetto
prevedeva la partecipazione attiva dei comuni di vallata; il progetto però
rimase sulla carta per mancanza di fondi, quando già l’imprenditore Mannati si
era impegnato a realizzarla in due anni –a sue spese da Novi ai Giovi- pur di
avere la gestione della strada della Bocchetta ed un pedaggio ai due passi. Fu poi realizzato
dal Piemonte dopo l’annessione forzata.
Nel 1837 Giuseppe Vallardi editò un
libro di viaggi per l’Italia, indicando strade ed itinerari vari seppur non
facendo alcun accenno al nome antico del tragitto. Nel viaggio da Torino a
Genova, descrive completarlo in due giorni partendo di buon’ora ed arrivando
prima che ‘chiudano le porte’. Passava per Asti, Novi, Ronco, Voltaggio,
Bocchetta, Campomorone, Pontedecimo ove avveniva l’ultima posta prima di
percorrere «‘la nuova strada fatta a spese della famiglia Cambiaso…perché in
addietro si doveva passare a guado la Polcevera più di venti volte; ma ora si
passa una volta sola sul ponte presso Campo-Marone (sic)…»
Sono anni nei quali il tempo...vola
lentamente: le barche a vela, i muli, le notizie in genere, i pellegrini e
commercianti e gli eserciti, tutti misurano il tempo in giornate
di viaggio. E questo ritmo, condiziona la vita quotidiana di tutti: culturalmente, politicamente, economicamente,
nel lavoro: anche in questo, la via del mare è sempre la più veloce, se il
tempo è buono.
--Praticamente solo dal 1850 si ebbe la concezione
di un tracciato topograficamente
unitario dal mar Ligure all’Adriatico, anche se funzionalmente diverso.
BIBLIOGRAFIA
(vedere quella dell’Aurelia)
-Bassoli G.-Peregrinarrando-guida2 e 4-Libro Più
2003-pag. 5
-Bernardini E.-La preistoria in Liguria-Sagep
1978-pag.184. 218
-Bianchi-Poleggi-Una città portuale nel medioevo-Sagep
1980-pag.30
-Cera G.-La via Postumia da Genova a
Cremona-L’Erma.2000-
-Chiappe M.-Il Tigullio e il suo
entroterra...-IPS.1996-pag.23
-Grendi E.-Introduzione alla storia moderna della
R.DGe-Bozzi1976-p.21
-Lamboglia N.–Liguria Romana –vol.I-Pozzi 1939-pag.193.225
-Luccardini R-vie romane in Liguria-DeFerrari
2001-pag95
-Meriana&Ferrero-Le rotte terrestri del port di
Ge.-Sagep.04-pag.12
-Milanese M.-Scavi nell’oppidum preromano di
Ge-L’Erma 1987-
-MiscosiG.-Origini italiche-
testimonianze...-Marsano1934-pag.369
-Pinelli AM-Liguria-da Dizion.Epigrafico di
antichità romane-195_
-Praga C.-antica viabilità- conferenze.
-Presotto D-aspetti dell’economia
ligure-SLSPatria-v.81-f.I-pag.149
-Riccardini E.-l’incastellamento...-Riscoprire
Trisobbio-congresso’02-p.132
-Sanguineti A-Iscrizioni romane-Atti
SLSPatria-v.III-f.II-pag266
-TuvoCampagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.156
-Vallardi G.-Itinerario d’Italia-22a ediz.-f.lli
Vallardi .1837-pag.43
Recentissimi,
gli studi di Mannoni limitati all’area genovese (1983-5); e di Pasquinucci
(1987) sul territorio della Valpolcevera.
PRASIO via
Andrea Prasio
TARGHE:-
via - Andrea Prasio – caduto per la libertà – 1909 – 7-4-1944

 angolo via SPd’Arena
angolo via SPd’Arena

 angolo via G.Buranello
angolo via G.Buranello

 angolo via G.Buranello
angolo via G.Buranello
QUARTIERE ANTICO: Coscia
 da MVinzoni, 1757.
da MVinzoni, 1757.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2832
 Dal Pagano/1961
Dal Pagano/1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 51020
UNITÀ
URBANISTICA: 26 SAMPIERDARENA
 Da Google Earth, 2007- In
giallo.via Palazzo della Fortezza; fucsia via LDottesio.
Da Google Earth, 2007- In
giallo.via Palazzo della Fortezza; fucsia via LDottesio.
CAP: 16149
PARROCCHIA: (civ.1)=NS delle Grazie---(altri)=s.M.della
Cella
STRUTTURA: strada comunale carrabile, con senso unico
veicolare, da via G.Buranello a via San Pier d’Arena; è lunga 56,3 metri e
larga 4,7 con 2 marciapiedi larghi poco più di 1 metro.
 anno 2009
anno 2009
STORIA:
corrisponde alla parte a mare dell’antichissima via Larga.
Quando nel 1850 furono
costruite la “strada ferrata” e la via ad essa affiancata oggi G.Buranello, la
via Larga fu tagliata in due; e per completare “l’assassinio” storico, le
cambiarono nome dedicandola a Jacopo Ruffini.
Il 19 agosto 1935, per
evitare omonimie col centro, cambiarono il nome: con delibera del podestà
divenne tutta ‘via Pialazzo della Fortezza’.
Dopo l’ultima guerra, con
delibera della giunta comunale il 14 nov.1946 le hanno di nuovo cambiato nome:
cambiano i tempi e cambiano i miti: al tratto a monte hanno lasciato il nome precedente relativo
all’antica villa ‘via Palazzo della
Fortezza’; al tratto a mare diedero il nome del partigiano.


anni 70-80
CIVICI
2007= NERI = 1 e dal 2 al 4 compreso 2A.
ROSSI = da 1r
al 15r;
e dal 2r al 22r
Nel Pagano 1950 vengono citate tre osterie
al 1r di Lacqua Giuseppe (con bar detto Pinotto in via N.Barabino 15); 3.5r di
Demasello A.; 13r di Orsi C.
Nessun bar, né trattoria.
DEDICATA al sampierdarenese nato il 7 apr.1909,
operaio. Iniziò l’attività clandestina di ribellione frequentando i GAP (gruppi
di azione patriottica), col nome di battaglia “Balilla”, rifornendo di armi e
qualsiasi materiale potesse essere utile alle formazioni di montagna.
Riconosciuto in questa attività clandestina, entrò
nell’elenco dei ricercati per cui fu necessario scappare sui monti entrando a
far parte della III Brigata Liguria. Durante il rastrellamento della Benedicta,
fu intrappolato sui Piani di Praglia -in località Mezzano- e preso prigioniero:
dopo averlo costretto a scavarsi la fossa, lo fucilarono sul posto, il giorno
del suo 35° compleanno.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale - Toponomastica, scheda 3687
-AA.VV.Annuario guida
Archidiocesi- ed/94-pag.433; ed/02-pag.469
-AA.VV.-opuscolo 35°
Spd’A
-Gimelli G.-Cronache
militari della Resistenza-Carige 1985-v.III-pag.76
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.73
-Pagano/1933-pag.555;
1961-pag.445
-Pastorino
Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag.1527
-Poleggi E.
&C-Atlante di Genova-Marsilio 1995-tav.51
-non citato da Pagano1961
Pastorino.Vigliero
PRATO via
Prato
Prima
del 1850 e della ferrovia, la strada posta perpendicolare al mare (cioè
il tratto oggi via U.Rela) costeggiava a levante la proprietà della villa
Centurione Carpaneto (di piazza Montano) fatta di orti, vigneti e frutteti ma
in quel tratto lasciata a prato. Così prese questo nome popolare, e già lo
ritroviamo ufficiale nel 1867 in una
‘statistica dei colerosi morti a domicilio’ (2 casi su 68 decessi, su 107
contagiati) per una epidemia scoppiata in quell’anno nel periodo dal 7
agosto-al 7 ottobre.
Dopo la cessione dei
terreni e la costruzione dei caseggiati divenne strada assai frequentata,
centrale, e che sempre ospitò interessanti negozi di commercianti: antico è
quello dell’orologiaio.
Sotto l’archivolto n° 69 della ferrovia, ed al
civ. 10 della strada (di rimpetto al voltino, dalla parte a monte del
viadotto), da più generazioni fabbri
ferrai (materiale ferroso greggio e finito, tubi in barre e tagliato, anelli
pneumatici, nichelatura e smaltatura)
negli anni fine 1800 Roncagliolo Lorenzo fu tra i primi fabbricanti di velocipedi -poi biciclette,
poi anche motocicli, mentre dei tre figli Emilio, Colombo e Cesare, gli ultimi
due divennero attivi sportivi ciclisti e l’ultimo per più anni primeggiò a
livelli nazionali. Furono anche fondatori -di alta statura morale- della società sportiva Nicolò Barabino,
antagonista della Sampierdarenese nelle specialità di scherma, ginnastica,
atletica , bocce, ma senza rivali nella sezione velocipedisti. Alla loro chiusura per cessata attività, nel
posto fu eretto il Nuovo Cinema Splendor.
Nel maggio 1889 i fratelli Chiesa fu Francesco chiesero al Comune poter restaurare i
civv.N. 3 e 4 di loro proprietà, rifacendone anche la facciata; malgrado i
timbri di approvazione, l’operazione non fu attuata come da loro prospetto
allegato (vedi via U.Rela).

A fine secolo 1800, i proprietari delle case risultano essere stati: al civ.2
Barabino Giuseppe; 3, fratelli e sorelle Chiesa; 4 Morasso Salvatore; 5-6-8
Lagorara Carlo; 7e 10, Dellepiane Enrico; 9 eredi Tubino; 10a Serra Giacomo;
12, Figari Catterina in Ivaldi; 13 e 14 Casanova e C; 15-16-17 sorelle Fava; 18
Paulucci Augusto
Nel dicembre 1900, il regio Commissario
straordinario incaricato dalla giunta comunale di proporre dei nomi per le
nuove strade cittadine, segnalò la
possibilità di estendere il nome di “via Prato” alla strada a monte della
ferrovia, per tutto il tratto est-ovest che sfociava in piazza Felice
Cavallotti; mentre il tratto perpendicolare -che portava lo stesso nome- di
dedicarlo a Urbano Rela; questa seconda parte fu realizzata dopo, non si sa quando, senz’altro prima del
1910 quando aveva tre civici.
Così nel genn.1901, l’impresa Barabino, Calvi,
Rebora, appose la prima targa in marmo, aggiungendo l’antico nome di “via Prato” al tratto parallelo alla
ferrovia.
Il Pagano 1902 segnala questi esercizi commerciali: civ. 2 Barabino Agostino ha fino al 1912 negozio di foraggi ed
osteria;---10 il negozio di legnami da costruzione
di Serra Giacomo fu Nap. Ancora attivo nel 1919, tel. 5-99 (anche a Genova in
via Scurreria) ;--- l’unico veterinario dr. Capati Gius. (c’è nel 1912; non c’è
più nel 1919);--- 14 il negozio ‘Fotografia
Pisana’, del fotografo Frediani Vittorio sino al 1919;--
al 18 Pretto Antonio lavora nelle conserve alimentari;---18B la fabbrica
carrozze di Paolucci Augusto ‘successore Fava.

Era nato “in to Pròu”, all’incirca in questi
anni, Sommariva Giovanni, detto Elio. Dal 1925 al ’40 praticò da protagonista nuoto (ma anche
pallanuoto e calcio) nello stile dorso, rappresentando l’Italia anche in gare
internazionali. Ebbe una medaglia al valor civile per aver salvato pericolanti
in mare.
Nel Pagano 1908 vedi molti negozi segnati del 1902.
Eguale il nome nel 1910, con altre parole specificato “dalla
piazza Felice Cavallotti a Levante a
fianco della ferrovia”, sempre con civv. neri sino al 6.
Nel 1919 morì di influenza spagnola
in una casa della strada, a 33 anni, il pittore Arnaldo
Castrovillari (fiorentino,
nato nel 1886) amico di D.Conte.
DeLandolina/1922 scrive
si chiamasse ‘vico del Prato’.
Nella pubblicazione
comunale del 1927 inerente a tutte
le strade facenti parte delle delegazioni subentrate nella Grande Genova,
compare a SPd’Arena la ‘via del Prato’, di 5a categoria, eguale ad una del
Centro, di S.Quirico, di Struppa e di Voltri (nessuna sopravvissuta ai tempi
d’oggi).
Ancora così si chiamava
nel 1933 con due soli civici e
sempre di 5.a categoria.
Con
decreto podestarile del 19 ago.1935,
anch’essa fu cambiata divenendo via A.Orsolino, mentre rimase via Urbano Rela
il tratto mare-monte tra via Vittorio Emanuele (oggi piazza
Vittorio Veneto) e via Mercato (oggi inglobata
nell’ultimo tratto di via A.Cantore).
Nel tratto lungo la ferrovia,
fu aperto l’ingresso al cinema Splendor, di cui si parla in via A.Orsolino.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico
Comunale di palazzo Ducale
-Archivio Storico Com.
Toponomastica - scheda 3697 (la chiama :’ via del Prato’)
-DeLandolina GC. –
Sampierdarena -Rinascenza .1923 – pag.52
-Lamponi M.-Genova in
bicicletta-Valenti.1977-pag. 47.53-4
-Novella P.-Strade di
Ge.-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.18
-Pagano/1911– pag.990 --- /1922-pag. 1037-
--/1933-pag.248
PRATO prato dell’
Amore
Non fu una strada, ma un
zona del borgo: è citato per la prima
volta nella località della Fiumara, quando nel 1847 vi sorse lo stabilimento di
Taylor e Prandi (poi Ansaldo).
Non è dato sapere il
perché di questo nomignolo popolare che però era presente per indicare una zona
allibrata al catasto di Sampierdarena, ai numeri 176 e 178 nei quartieri del
Canto e della Fiumara (ogni tanto chiamata anche “spiumara, o lazzaretto, o prato d’amore”)
di 33.616 mq dei quali 1.156,9 occupati
da «una casa padronale e tre coloniche, un baraccone ad uso saponeria, una
piazzetta chiusa ed il resto era terreno ortivo, con canneto e vigna,
posto oltre la ‘Crosa dei buoi’ ,
nell’angolo tra il mare e la foce del torrente». La terra, allora era ricca di acqua sorgiva, di produzioni viticole ed orticole tra le
migliori (come oggi può vantare più solo la piana d’Albenga), di proprietà
della marchesa Maria Oriettina Lamba Doria, moglie del marchese Fabio
Pallavicini, ambasciatore del regno Sardo in Baviera.
Per il Taylor la zona appare l’ideale, sia per la
cantieristica navale che per uno stabilimento di locomotive (da fabbricare con un sistema perfezionato
rispetto l’ideatore Stephenson , ed a prezzo ridotto). Appena
l’Intendenza Generale di Genova pubblicò il manifesto di occupazione del
suolo affiggendolo nel municipio di San Pier d’Arena dal 20 al 27
ago.1846, scattarono le opposizioni dei
proprietari: della marchesa (che
oltre agli orti aveva affittati dei
poderi alle famiglie Piccaluga e Ferrari; degli appartamenti -tra cui uno ad un GB Derchi (non certo il
pittore); ed un capannone a Salvatore Tubino per una fabbrica di sapone), del sig. Pescetto proprietario di una
fabbrica di amido, di Giuseppe Torre e Francesco Carena proprietari dell’antica
e prospera corderia, forti di 50 operai e che temono le scintille; dei fratelli
Rolla proprietari di una tintoria. Il Consiglio di Stato esaminò domanda,
opposizioni e controricorso, e decise a favore di se stesso, cioè del Taylor
dichiarando la sua iniziativa di pubblica utilità (al
Cavour non era dispiaciuta l’idea di iniziare una produzione al servizio della
propria marina militare e delle strade ferrate, in quegli anni in via di forte
espansione; e degli inglesi si fidava più che degli italiani).
Gli espropri seguirono una lunga procedura, ma il 23 giu.1847 si dovette
firmare in palazzo Ducale. L’atto di cessione, destina 120mila lire al
Pallavicini.
BIBLIOGRAFIA
-Montarese M.Genova secolo XX-ERGA 1980-pag63
-Gazzo E.-I 100 anni
dell’Ansaldo-Ansaldo 1953-pag 76-80
PRETI via dei Preti
Nome popolare dato al
tratto trasversale a via Aurelio Saffi in proprietà Cristofoli, a cui nell’
anno 1900 fu ufficialmente proposto il
nome di Benedetto Cairoli.
Dopo disamina della giunta
comunale, fu invece intitolata “via Giovanni Bosco” (che solo dopo divenne ‘via san Giovanni
Bosco’).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale in palazzo Ducale
PROVINCIALE strada Provinciale
Una volta istituiti i comuni
negli anni attorno al 1800 sotto la guida del governo francese, divennero di
competenza provinciale tutte le strade che uscivano dall’abitato.
Fu chiamata nel 1815
“strada provinciale per Torino” quella che poi divenne via Vittorio Emanuele (
attuale via W.Fillak).
Nel 1846 viene chiamata
“strada provinciale di ponente” l’attuale via E.Degola.
E poi dopo anche per la
‘via di Francia’, aperta dopo aver fatto transazione col pio istituto del rev.
Morando Gerolamo, proprietario dei
terreni nella zona a ponente tra lo sbocco di via Dottesio e piazza N.Barabino.
BIBLIOGRAFIA
-Autore non
conosciuto-Dattiloscritto chiesa san Gaetano-vol.I-pag.83

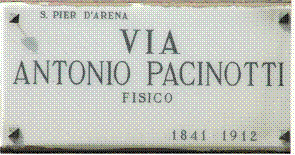

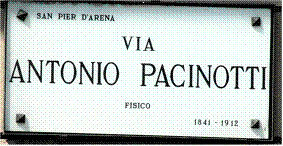
 da Google Earth 2007. In verde, ipotetico
tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via
Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.
da Google Earth 2007. In verde, ipotetico
tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via
Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.
 Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;
blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini
Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;
blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini 










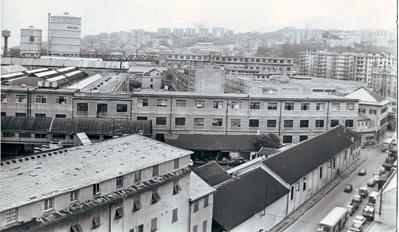























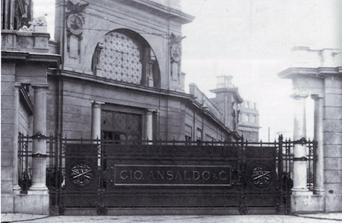
 Dagli anni
1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio
Dagli anni
1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio 





























































 È una
strada che dalla zona Fiumara (prima della demolizione degli stabilimenti
Ansaldo) sbucava in zona aeroporto, usufruendo di un ponte proprio -da allora
anche lui chiamato ‘
È una
strada che dalla zona Fiumara (prima della demolizione degli stabilimenti
Ansaldo) sbucava in zona aeroporto, usufruendo di un ponte proprio -da allora
anche lui chiamato ‘