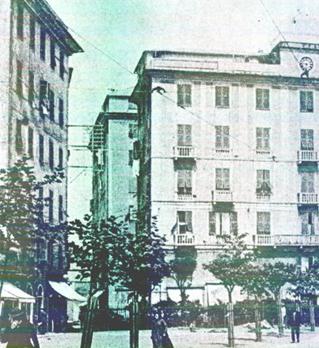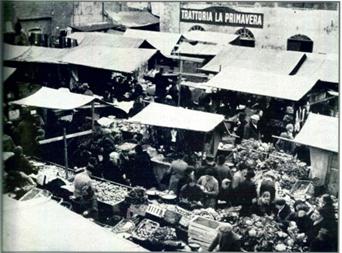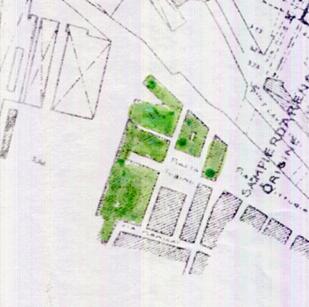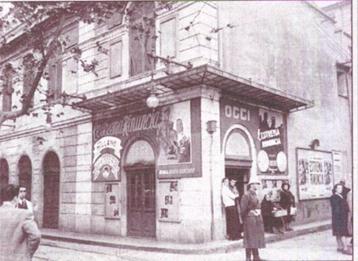organizzare
i moti popolari che accompagnarono nell’ott.1867 la spedizione garibaldina
nell’Agro Romano.
Fu dopo uno di questi tentativi che - a seguito di accordi con Garibaldi stesso
col fine di liberare Roma - una quarantina di patrioti –dei quali 22 romani
guidati dall’Arquati - si riunirono in un lanificio a Trastevere (in via Lungaretta n. 97) -di proprietà di Guido Ajani- col proposito di associarsi
e continuare a favorire il generale. Era prevista una insurrezione per il 27
prossimo, quando Garibaldi avrebbe dovuto arrivare a ponte Nomentano.
Gli zuavi, appoggiati dagli sbirri e squadriglieri (detti ‘zampitti’)
papalini, per tutta Roma si diedero a setacciare le località sospette, ponendo
la città in stato di assedio: scontri a fuoco e sommarie esecuzioni, ebbero
ragione dei vari insorti isolati che si erano riuniti in trattorie o domicili
vari.
Invece nell’opificio, assieme a Francesco Arquati e –forse
unica donna-, sua moglie Giuditta con i figli -tra i quali Antonio il più
grande quattordicenne- si ritrovarono in più numerosi; vengono citati il
colonnello Francesco Cucchi, capitano dell’insurrezione; Pietro Luzzi, Paolo Gioacchini
(capo fabbrica), Cesare Bertarelli, Angelo Marinelli, Giovanni Rizzo, Enrico Ferroli,
Rodolfo Donnaggio, Francesco Mauro, Augusto Domenicali, Luigi Domenicali,
Casimiro Cerroni, Piero Calcina (questi tre ultimi si salvarono).
Il
giorno 25 ottobre 1867, mentre nell’opificio si contavano tra loro e
preparavano le munizioni per eventuale conflitto a fuoco, non si sa se in
seguito a delazione (pare che monsignore Randi –capo della polizia pontificia-
nella mattinata aveva ricevuto un messaggio anonimo –firmato ‘un buon cristiano’
in cui si segnalava nel lanificio un banchetto a cui sarebbe seguito una
rivoluzione) o perché spiati da dei frati vicini appostati sul campanile della vicina
chiesuola di santa Rufina, furono intercettati da trecento gendarmi pontifici -chiamati
zuavi per il loro vestito- e circondati. Anche se arresi, sicura era la pena
capitale. Pertanto fu decisa la resistenza.
Gli
zuavi andarono all’attacco cercando di abbattere il portone (furono feriti il
sergente Riouz –spagnolo- da una bomba, e il soldato Chouteaux da una fucilata
al malleolo; ma furono più volte respinti da fucilate e bombe; finché gli asseragliati
non rimasero senza munizioni.
La
difesa divenne, così, sporadica, a focolai, all’arma bianca a corpo a corpo:
gli zuavi poterono fare irruzione e malgrado qualche singolo eroismo iniziarono
a fare strage dei presenti uccidendo tutti i patrioti che si opponevano. Una ventina di essi riuscirono a
fuggire passando da finestre di abbaini e usando delle scale per passare da una
finestrella all’altra delle misere casupole. Nove furono presi prigionieri
perché feriti o circondati, tra essi anche l’Ajani (medicati all’ospedale san
Galliano, poi trasferiti alle Carceri Nuove per essere giudicati dal Supremo
Tribunale della sacra Consulta. Le pene furono da condanna a morte per alcuni,
a galera perpetua o vari anni di carcere per altri). In uno stanzone più ricco di armi, morirono i due Arquati
ed una decina di altri. Singoli, rimasero intrappolati nelle varie stanze
dell’opificio, opponendo eroica resistenza: tra essi, nella perquisizione delle
case adiacenti, anche Giuditta venne scoperta, ma ella li affrontò a
pistolettate (erano le
armi che poco prima aveva offerto ricaricate al marito ed al figlio più grande)
per cui nella reazione fu colpita
assieme ai figli, uno che aveva in grembo, la piccola Ersilia che portava in
braccio ed il più grandicello Catullo che teneva per mano al fianco. Si
descrive che gli zuavi, infierirono sui loro corpi, con calci, il legno dei
fucili e baionettate inutili lasciando i vari cadaveri anche fratturati: essi
furono ammucchiati assieme e gettati in fossa comune del cimitero.
Un testimonio oculare, corrispondente del sig. D’Ideville,
descrive a quest’ultimo la scena, vista poco dopo la cessazione dello scontro:
sedie e tavole rovesciate, a terra bicchieri, bottiglie ed un ‘pantano di vino
e sangue’; aggiunge: «nel mezzo di queste rovine giacevano tre cadaveri e tra
gli altri quello di una donna di una cinquantina d’anni, la cui mano
rattrappita stringeva ancora un revolver. Avrò per tutta la vita davanti agli
occhi quell’orrenda visione. Oh caro amico, quanto è atroce la guerra civile!»
(DeLandolina scrive che era nata nel 1839; aveva un bimbo in
braccio ed era incinta di un altro; che dapprima fu ferita con una baionetta e
poi –persistendo la sua azione ribelle- colpita da una palla al petto).
Tutta l’organizzazione dell’insurrezione si concluse
tragicamente: due patrioti Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti furono condannati
a morte per decapitazione ‘a esemplarità’ –furono gli ultimi condannati a morte
da Pio IX: gli altri condannati a morte furono imprigionati a vita, ma poi
liberati il 20 settembre 1870.
Anche i fratelli Cairoli a Villa Glori, avevano offerto il
loro momentaneamente inutile ma glorioso sacrificio.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4359
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.448—ed./02-pag.485
-De
Jaco A.-Antistoria di Roma capitale-Ed.Riuniti 1970-pag.287
-DeLandolina
GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922 – pag. 56
-Enciclopedia
Motta
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese : 2/94.6 + 7/2011.
-Lamponi M.- Sampierdarena –
Libro Più.2002- pag. 164
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto
b.Berio.1900-pag.17
-Pagano 1933-pag.248;
/40-pag.418; ed./1961-pag.404.566
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1760
-Poleggi E. &C.-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.21
TEATRO piazza del Teatro
vico del Teatro
nomi non ufficiali, ma di uso
popolare; il primo per indicare l’attuale
piazza G.Modena al nascere dell’edificio.
Solo nel 1901 infatti,
nell’obbligo statale e desiderio civico di regolarizzare i nomi di tutte le
strade neoformate, in seguito alle costruzioni che avevano invaso tutti i
giardini delle varie ville cittadine, compreso il teatro eretto nel parco della
vicina villa Centurione del Monastero, si decise di confermare il nome,
precisando chiamarla “piazza Teatro Modena”, e - dopo il 1917 - “piazza Gustavo Modena”.
In contemporanea, fu proposto
anche cnfermare il nome di “vico del Teatro”, come già anche lui era chiamato
in uso popolare, al breve percorso che unisce la piazza del teatro alla vicina
piazza XX Settembre (oggi del
Monastero); ma gli fu preferita la dedica ad Arnaldo da Brescia.
In questa data di periodo
ancora bellico, al civ.1 era il teatro; al civ.2 una casa di proprietà
dell’ospedale Pammatone (che assieme ad eguale
di vico Mentana (vico
della Catena) e di via A. da Brescia (via del Monastero), e più anticamente tutta via Carzino, facevano
parte dell’eredità dell’ultimo nobile Centurione, sacerdote e proprietario dei
terreni, della villa del Monastero e della casa poi venduta ai Balbi)
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico del CAP- pag.36
cartina
-Archivio Storico Comunale
TOSA
via
Mario Tosa
TARGA: San Pier
d’Arena – via - Mario Tosa – carabiniere – vittima del terrorismo – medaglia
d’oro al valore civile – 1953-21.11.1979
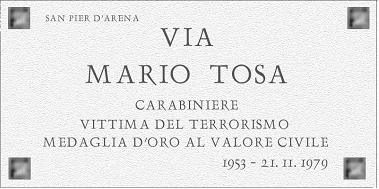
QUARTIERE
ANTICO: Belvedere
N°
IMMATRICOLAZIONE: posteriore
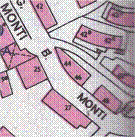

CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 62030
UNITÀ
URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO
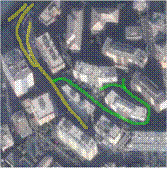 Da Google Earth, 2007. In giallo, via GBMonti
Da Google Earth, 2007. In giallo, via GBMonti
CAP: 16151
PARROCCHIA: NS del ss.Sacramento
STRUTTURA: Strada
privata, doppio senso viario, inizia da via G.B.Monti proprio nel retro del
grattacielo, di fronte allo sbocco della stessa in Quota 40; dapprima orientata
verso levante (dietro
il palazzo giallo), compie un tornante a
U finendo al piano più alto in un piazzale (dove nella foto vediamo l’auto rossa).
 foto dal grattacielo di via GB Monti
foto dal grattacielo di via GB Monti
STORIA: fu aperta
nel terreno già delle suore di don Daste, col primo dei vari palazzi, il civ.29,
nel 1950; e con l’erezione degli altri nel 1953, mantenendo inizialmente il
nome di ‘via GB Monti’.
Sopra
il muraglione che fiancheggia la strada all’inizio della salita, è stata
salvata una nicchia - ora vuota - che probabilmente racchiudeva una statua, e
Undici
bossoli di calibro 9, sparati da armi diverse, “annientarono” in un attimo i
due ignari militari intenti a bere un caffè prima di iniziare il servizio.
Infatti un allucinante comunicato pervenuto telefonicamente ad un giornale
cittadino, recitò “ qui colonna genovese Francesco Belardi (nota: brigatista catturato e trovato impiccato in un supercarcere
di Cuneo): pattugliando la zona
di Sampierdarena ha intercettato, attaccato ed annientato l’equipaggio di una
gazzella dei Carabinieri. Nei prossimi giorni avrete un altro comunicato. Onore
a tutti i caduti assassinati nei lager di stato
“.
In realtà l’azione non apparve occasionale ed a seguito di un ‘pattugliamento’,
ma studiata preventivamente conoscendo le mosse abituali delle due vittime
assalite a sorpresa; non con le caratteristiche di un combattimento ma della
vile esecuzione a freddo su ignari cittadini seppur dipendenti militari dello
Stato.
Erano gli “anni di piombo”, quando la morte dei carabinieri voleva simbolizzare
un attacco allo Stato e dimostrare la sua debolezza. Con questo gesto però, le
Brigate Rosse ottennero nella popolazione l’effetto contrario al desiderato,
generandosi in forma spontanea un violento senso di repulsione e sdegno verso
chi tentava con questi metodi di imporre le proprie idee; riccamente
partecipate dalla gente locale, furono le varie celebrazioni posteriori (con
conferimento di medaglia e dedica delle strade), che acquisirono il chiaro
significato di messaggio rivolto agli ignoti attentatori, della posizione che la
cittadinanza assumeva di fronte a simili minacce.
Il 28 mar.1980, scoperto in via Fracchia a Genova il covo in cui gli assassini
si erano rifugiati, nell’irruzione delle forze dell’ordine uno dei capi
esecutori rimase ucciso assieme ad altri tre affiliati alla colonna delle
Brigate Rosse genovese. Il capitolo si chiuse solo a fine febb.1983, quando un
processo comminò agli altri mandanti ed esecutori, dieci condanne all’
ergastolo e quattro a 7-28 anni di reclusione.
Non un eroe quindi il povero militare, ma un ben preciso simbolo dei valori che
il cittadino italiano vuole mantenere, senza ombre o dubbi; come punto di
riferimento di base, seppur nell’evoluzione dei tempi e dei costumi.
A
suo nome è stata titolata la sezione sampierdarenese dell’associazione naz.
Carabinieri, che ha sede dal 2010 nei locali della Croce d’Oro (e che è stata
fondata nel 1906 da Tirelli Torello che ne fu primo presidente, nonno della
farmacista di via C.Rolando).


BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4449A
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-èpag.450---ed./02-pag.486
-AA.VV.-1886.1996
oltre un secolo di Lig.-IlSecoloXIX-pag.584.592.610
-Gazzettino
Sampierdarenese : 9.1982.16 + 9.1988.22
-Lamponi M. -Sampierdarena –
Libro Più. 2002. pag. 208
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1780
TRAVERSO vico detto Traverso
via Traversa
Corrisponde al tratto
laterale, a tre quarti a levante dell’attuale via U.Rela, che finisce chiuso
con il civ. 6.
Nel regio decreto del 1857,
relativo all’ufficializzazione dei nomi di alcune strade della città, si fa
cenno ad una “ via Traverso” che sarebbe poi divenuta via del Prato.
All’anagrafe comunale del 1910 è citato il
‘vico detto Traverso’ che viene posto “da via Urbano Rela, verso levante”; ed
anche allora con civici sino al 3 e 6.
Il Pagano 1912 in ‘vico detto Traverso’ pone un forno per la produzione del pane, di Tutolino
Isidoro. Nel 1925 al civ. 1 c’era un garage di Visentini Remo¤
Quando nel 1926 il
Comune di SPd’Arena fu assorbito da quello della grande Genova, questa si trovò
una via omonima in più centri: a Voltri (dedicata
a Pietro Traverso, non esiste più); Bolzaneto (strada di Traverso di Lastrico, non esiste più); due in Centro (via Traverso, ancor
oggi esistente in Castelletto (un proprietario o lo scultore Nicola) assieme ad
una E.Traverso (partigiano) in Albaro); e da noi a SanPier d’Arena (descritto “vico detto Traverso”che non esiste più);
così fu deciso il cambiamento.
Anche il Novella nel suo manoscritto completato negli
anni fino al 1930, scrive chiaro “Traverso (vico) da via Urbano Rela”.
Ma nel 1933 era ancora
tale con il cambiamento non ancora effettuato; di 5.a categoria, con eguali
civici.
Si presume che il nostro
vicolo faccia riferimento alla famiglia Traverso, proprietaria di case nel
luogo; confermato da una proposta fatta dal regio Commissario A. De Benedetti
alla Giunta comunale il 31 dic.1900 di dare alla zona titolazioni diverse: il
nome di via Urbano Rela al tratto in direzione nord; “via Prato” al tratto
est-ovest; e “vico detto Traverso” al “vicolo case già Traverso” (che
corrisponde appunto alla trasversale esistente ancor oggi, diramazione di via U.Rela).
All’archivio della
Toponomastica, è chiamato ‘via Traversa’, quale diramazione chiusa da via U.Rela:
il che ovviamente cambia tutte le interpretazioni precedenti.
Più famosa e storica è la
presenza del fabbro Macciò , uno dei pochi artigiani del metallo, rimasti in
città.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4461
-DeLandolina GC- Sampierdarena
-Rinascenza.1922 –pag. 56
-Novella P.-strade di Genova-Manoscritto
b.Berio.1930-pag.19
-Pagano 1933-pag.248
TRENTASEIESIMO via 36° Battaglione CC.NN.
Questa titolazione di strada,
andò a sostituire con delibera del Commissario prefettizio (conte Antonio
Canevaro) del 20 aprile 1944 la precedente “via del Gran Consiglio”, subito
dopo che questa istituzione fascista cadde nella storica seduta del 24-25
lug.1943.
KIl Commissario Prefettizio, con
delibera n. 106c dell’aprile1944 apportò una ‘variazione alla Toponomastica Cittadina’
vito il seguente rapporto del Capo della Direzione civica di Antichità Belle
Arti e Storia: «al Commisario Prefettizio, la Direzione scrivente sottopone
alla Vostra approvazione il provvedimento che fa seguito teso a modificare, in
conformità delle disposizioni vigenti, la denominazione di due strade e
precisamente via del Gran Consiglio in San Pier d’Arena e della Passeggiata
Principessa di Piemonte in Nervi, intitolando tali vie rispettivamente al 36°
Battaglione Camicie Nere e alla Xa Flottiglia Mas» ‘’...le deliberazioni sovraestese....furono
pubblicate il 21 aprile 1944 e lasciate affisse nel tempo e modo consueto
all’albo pretorio, senza che siano state presentate opposizioni’’.
La Giunta comunale poi,
cancellò la titolazione il 19 luglio 1945, dedicando la strada al partigiano
Federico Avio.
DEDICATO A :
Fa riferimento ad un
battaglione delle Camicie Nere, distintosi in modo particolare sul fronte
greco albanese nel 1940. Dopo un anno di guerra, contavano 1528 morti e
3296 feriti (dati ufficiali pubblicati). In
quella occasione, il battaglione, comandato da un console (prima l’ufficiale
A.Galardo; poi -dal
febb.41- da Silato), viene descritto “36° battaglione
d’assalto”; ed in altro episodio enfatizzato con “mai morti”, essendosi
riempiti di gloria sui monti dell’Epiro.
Fu pure inviato sul fronte dalmato-giuliano: una
colonna, passata da Fiume, arrivò a Lubiana ed all’isola di Veglia, fino a
Ragusa.
Nel 1939, la 32a Legione
sampierdarenese generale Cantore (formata da 4 coorti, dislocate a SestriP,
Bolzaneto e Savona) + la 31a legione genovese s.Giorgio (di 4 coorti a Busalla
e Chiavari) + vari reduci da Cefalonia furono uniti ed accorpati nel 36°
battaglione CC.NN. chiamato C.Colombo.
Dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943 il battaglione scelse stare con l’alleato tedesco ed inviato in
Germania, dove fece parte della futura ‘divisione Italia’ della RSI.
Brizi&Cirnigliano,
scrivono che “le brigate nere sono suddivise in 39 battaglioni, uno per
ciascuna delle province dell’effimera ‘Repubblica di Salò’ o RSI = Repubblica
Sociale Italiana”.
Le CC.NN. erano un vero e proprio corpo militare, praticamente succeduto agli
Arditi: nel tempo del ventennio fascista, ebbero vero nome come ‘Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale’ (MVSN) ma, in breve e per il colore
della camicia, CC.NN (questa era stata
scelta daglòin Arditi della prima guerra mondiale; poi adottata dai legionari fiumani
ed infine dagli aerenti ai Fasci di combattimento fondati nel 1919. In quell’anno,
in Italia esistevano anche le Camicie Azzurre, paramilitari e nazionaliste:
furono assorbite nel PNF nel marzo 1923).
Furono politicizzate dal regime facendone
un surrogato delle Camicie Brune (membri d’assalto del P. Nazionalsocialista
tedesco; poi SS) ; diqueste ‘squadre d’azione’ (da cui il termine ‘squadrista’;
il cui grido era ‘eia eia alalà’, e la qualifica tra loro era ‘camerata’ visto
che in servizio dormivano in gruppi nella stessa stanza) ne dovettero far parte tutti i membri iscritti al
partito (PNF) nonché i dipendenti delle associazioni giovanili (che vi entravano col grado di semplice milite,
corrisponde al soldato semplice o all’allievo carabiniere).
Dopo l’8 sett.1943 nell’Italia del nord si costituirono vari corpi delle
CC.NN facenti parte del partito fascista repubblicano, assoggettato
all’invasore nazista; a Genova la sezione del PFR venne costituita il 19
settembre, e la targa della strada presumibilmente ebbe origine da questa data.
Gli
arruolamenti degli squadristi (vecchi personaggi estremisti della prima ora,
che per necessità di moderazione erano stati emarginati dal partito stesso),
vennero ‘riesumati per la ricostruzione del Partito Fascista nella RSI’ e per
ripulire il paese dalle bande, dai felloni e traditori. La loro condotta
biasimata dagli appartenenti dell’ordine, veniva da loro definita
inqualificabile perché privi di funzione giuridica ma nondimeno impuniti,
spesso determinate da rancori personali o razzismo, con atteggiamento
minaccioso e violento, con sistemi brutali fino alla tortura, sconfinamento nel
sadismo e prevaricazione specie del clero, dei ricchi, degli industriali.
Furono loro ad iniziare e creare la legalizzazione della precipitazione
pressoché totale della morale nella vita pubblica nonché discredito generale
verso il fascismo.
La
cellula base era la ‘squadra’; tre di esse formavano una compagnia. Tre
compagnie un battaglione. tre battaglioni una brigata nera. Dal luglio 1944
iniziò ad operare a Genova la Brigata Nera Silvio Parodi, affidata a Livio
Faloppa; erano 544 uomini a sett.; 1016 nell’apr.45.
Nella
lotta ai ribelli, da fine marzo 44 vennero selezionati 3mila volontari scelti,
per formare le ‘compagnie della morte’
A Sampierdarena avevano più caserme dislocate, ma le più note sono quelle di
via Carzino nella palazzina dell’Universale ed in via C.Dattilo (dove ha sede
la Telecom) ed in corso dei Colli (L.Martinetti). Pare una fosse in via
Vicenza, al civ.2 o 4, ivi succeduti ad una caserma di Carabinieri prima che
essi si concentrassero in corso Martinetti.
Fu un tetro periodo bellico, costituito da spedizioni punitive e ritorsioni con
arresti, torture, vendette e fucilazioni; applicò il richiamo obbligato dei
giovani anche ex militari sbandati; non si oppose, anzi collaborò alle
deportazioni degli operai in Germania;in un periodo storico senza notizie
precise se non quelle deformate dalla propaganda (radio e giornali) la sua fama
favorì indirettamente la fuga sui monti di molti giovani e la formazione delle
“bande partigiane” a cui poi dette la caccia, con eccidi anche di massa.
Finirono la loro legalizzata violenta esistenza, praticamente con l’uccisione
di Mussolini il 28 apr.1945.
D’Oria dice che il nome era ‘milizia volontaria di sicurezza nazionale’.
BIBLIOGRAFIA
-Antonini S.-La Liguria di
Salò-DeFerrari.2001-pag.72.
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4476
-AA.VV.-Contributo di SPd’A alla
Resistenza-PCGG.1997-pag.36.54
-Brizi&Cirnigliaro-Percorsi
‘resistenti’in v.plocevera-Brigati.06-p.194
-Enciclopedia Sonzogno
-Genova, rivista municipale :
2/41.51.78 + 3/41.71.78 + 4/41.1.44
-Internet-google-36° battaglione
CC.NN.
-Stradario del comune di Genova –
edizione 1953-pag.15
TREPONTI piazza Treponti
TARGA: San Pier d’Arena - piazza – Treponti
Piazza Treponti


lato ovest

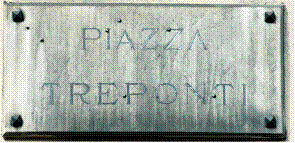
lato nord, angolo
via D.Pirlone
QUARTIERE
ANTICO: limite tra Coscia e Mercato
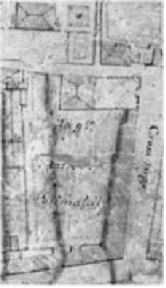 da MVinzoni, 1757. i terreni, fino a mare, della mag.ca fam.
Grimaldi col palazzo della Fortezza ed –a destra- la crosa Larga.
da MVinzoni, 1757. i terreni, fino a mare, della mag.ca fam.
Grimaldi col palazzo della Fortezza ed –a destra- la crosa Larga.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2858 CATEGORIA: 2
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 62360
UNITÀ
URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
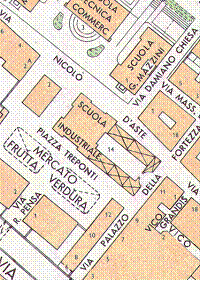

da
Pagano/1961 da Google Earth, 2007
CAP : 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella
STRUTTURA: piazza compresa tra via R.Pensa a sud (senso unico in uscita verso via
G.Buranello); via Palazzo della Fortezza
a levante (senso unico
in uscita verso via N.Daste); via N.Daste (in
senso unico verso ponente) e via D.Pirlone
a nord (in accesso e
senso unico con uscita nella piazza Treponti).
Piazza di 1968 mq ,
carrabile ad anello , con marciapiedi larghi m.1,1, di competenza comunale,
adibita a mercato ed anche ad uso parcheggio, con una fontanella in ghisa (ma
non funzionante).
È servita dall’acquedotto
DeFerrari Galliera
CIVICI:
2007= NERI = da 2 a
4
ROSSI = da 9r a 73r (compreso
65ABr; mancano 1r→7r, 33r)
e
da 10r a 76r (
“ 36ABr; “ 2r→8r, 36r)
STORIA: la piazza
faceva parte dei giardini della villa Grimaldi “la Fortezza”. La ferrovia,
tagliando a metà la proprietà nel 1850 circa, ed in un periodo di scarsa
disponibilità economica da parte dei proprietari e di forte espansione
edilizia da parte del nuovo ceto borghese arricchito, determinò la morte
dell’appezzamento come orto e giardino, e favorì la lottizzazione del terreno.
 foto 1921
foto 1921
si vede l’area dietro la villa, occupata da capannoni –
forse la ditta di legnami Forni
Nel
1926, ancora era in programma nel piano regolatore di “liberare
l’edificio de ‘la Fortezza’ dalle casupole che, in lungo volgere di tempo gli
si erano abbarbicate ai fianchi ...sistemare la viabilità nella zona
circostante alla sede del nuovo mercato, onde creare comodi accessi ad esso...e
meglio sfruttare le aree che venivano a trovarsi lungo le strade, per rendere
meno gravoso al Comune il costo del nuovo mercato”, e si pensò di adibire
queste aree alla “costruzione di abitazioni, riservando al mercato il
pianterreno...” oppure “formazione di un grande piazzale interno compreso tra
il palazzo ex Sauli ed il viadotto ferroviario avente quattro accessi...da
destinarsi alla costruzione di grandi tettoie per il mercato all’ingrosso della
frutta e verdura”. Non tutto fu realizzato come programma, venendo esso
variato e poi sospeso al momento dell’inglobamento della città nella grande
Genova .
Il 23 febbraio 1934 fu deliberato: «vista l’allegata relazione
dell’Ufficio Imposte Dirette – Catasto, (vedi allegato); \\ Su conforme parere
della Civica Commissione di Toponomastica; \\ Ritenuto che nel caso ricorrono
gli estremi di cui alla deliberazione podestarile 21 settembre 1933 n. 2190,
approvata dalla R.Prefettura il 30 settembre 1933, col n.39247 – div.2/1; \\
DELIBERA : \\ di nominare come segue i sottoindicati nuovi tronchi di strade
aperti al pubblico nel territorio della Grande Genova: \\ (omissis)\\ SAN PIER
D’ARENA \\ Nuova piazza tra la via Cantore e via Vittorio Emanuele: \\
«Piazza TREPONTI» \\ (segue omissis)». (ricordando che via Cantore era l’attuale inizio di via
N.Daste, verso ponente a partire dall’attuale via Palazzo della Fortezza).
Note su questa delibera: A) per tutte le strade del centro o altre
delegazioni la titolazione è accompagnata da un aggettivo significativo (“letterato”, “giurista”, “diplomatico”, “patriota”, “navigatore”); solo a strade di località, non fa seguito
alcuna spiegazione (Genova-Centro: via Monte Nero; via
Digione; Pegli: via Velletri). B) quando SAN PIER D’ARENA è scritta
separata, il nome TREPONTI è scritto tutto unito. Ambedue le osservazioni
portano ad indicare che fu dedicata ad una località: quindi come verrà spiegato
sotto, in ultima ipotesi della dedica. L’unica cosa che contrasta è che sulla
targa, le parole non è chiaro se siano staccate: TRE PONTI.
Sino alla dedica del piccolo tratto al partigiano R.Pensa effettuato nel
dopoguerra (delibera della Giunta del 29 settembre 1946), anche quello
era di competenza della piazza con i civv. 1 e 2.
Nel
1940 sul Pagano va “da via II Fascio d’Italia a v. Mercato”; ha civv.
neri di privati; senza civico Nuovo Mercato Pubblico;
e rossi: 1r macelleria;
2r commest.; 3r calzol.; 5r pesciv.; 7r commestib.; 8r tessuti; 13r polliv.,
14r sala di toeletta; 15r macelleria; 16r bottigli. 18 macell.; 19r bar; 20r
latteria; 23r macelleria; 41r off.mecc.; 46 legnami di Forni Figli di Enrico
Nel 1961 compare nella guida con il nome tutto unito di Treponti; vi è
già segnalato il “nuovo mercato pubblico” senza precisarne il civico, facente
parte dei mercati rionali coperti di vendita al minuto.
Non ho schemi spiegativi: deduco che fosse composto di
due padiglioni separati affiancati.
Nel 1971 si denominò nuovo il tratto dedicato a D. Pirlone e sottratto
alla piazza, compreso il suo nuovo civ. 1. Nello stesso anno si assegnò il
civ. 4 a nuova costruzione; ed uguale il civ. 2 nel 1982 .
La
piazza è interamente occupata dal mercato
Una prima struttura risale al 1938, con tetto tipico di altri mercati, aperta
ai lati e con banchi coperti e altri fuori, allo scoperto.
Nel
1970 la struttura fu rimaneggiata, coprendo
tutta l’area con tettoia unica in cemento, lasciandola sempre aperta ai lati.


 __
__ 

 foto 1981
foto 1981
Solo
nel dic.1980 fu inaugurato alla
presenza del Sindaco F.Cerofolini l’attuale complesso (la ristrutturazione previde la
chiusura perimetrale totale in cemento armato; aggiunta di lucernai sopra il tetto (ma essendo essi
in plastica, in realtà crearono un indesiderato effetto serra, bollente
d’estate); tettoia di
unione tra i due padiglioni, riordino del posto dei banchi, rifacimento della
linea fognaria bianca e nera ed impianto elettrico), occupante mille mq nel centro della piazza, aperto
tutti i giorni feriali con spesa congiunta del Comune e degli esercenti (gli abitanti attorno alla piazza
temevano problemi di viabilità); qui
ogni giorno al coperto si vendono nei 49 posti assegnati prodotti
ortofrutticoli freschi (27
banchi), e vi hanno sede altre attività
commerciali fisse (macellai,
polli, pesci, commestibili-salumeria, trippe, surgelati). Possiede solo civv. rossi.
Nel
febbraio/2005 si scrive che “la
struttura cade a pezzi e c’è il rischio amianto” Il CdC ha promesso una pulizia
ed il riordino dei servizi igienici e delle strisce pedonali.Il Comune invita
gli operatori a consorziarsi. Mancano gli accessi ai portatori di handicap e ci
piove dentro.
Nell’ottobre
2011 esistono 50 posti, dei quali 17
vuoti; i progetti, presentati dai vari assessori, non sono ancora realizzati.
Nella snervante, esasperante ed insicura attesa non solo delle ristrutturazioni
(che vanno dal completo
rifacimento con inserimento del mercato nei locali sotto (o sopra) il giardino
della villa a fianco, a rifacimento dei soli marciapiedi) ma anche di un miglioramento ambientale (lamentando il degrado conseguente
l’eccessiva frequenza di malviventi, bande di latinos, ubriachi e drogati).
Due volte la settimana la piazza tutta si riempie di bancarelle per la vendita
dei più svariati articoli di merce varia .
===civ.
2 è nel retro del palazzo Grimaldi, poi Rebora, corrispondente al 4-6 di
via Daste; è stato adottato come entrata usuale nel palazzo, la targa dice da
impiegati del ‘ESSETI Group’, lasciando chiusa ed inagibile l’entrata
principale anteriore.
===27-29r Ancora nel 1950
Traverso B. noleggiava carrette a mano.
DEDICA. Il Pagano,
la chiama sempre Treponti tutto attaccato; ed anche nella antica targa apposta
sul palazzo della Fortezza, appare tutto unito.
Quindi:
---Se,
(e scrivere se è pleonastico avendo accertato chiaramente che il nome è unito, come
appare anche dalla targa stradale) il nome è tutto
unito, si riferisce ad una delle numerose località, specie del trentino,
che sono omonime. Tra esse, una acquista importanza perché vicino ad essa si
distinsero in battaglia i Garibaldini durante la seconda guerra d’Indipendenza.
Tremila
Cacciatori delle Alpi, guidati da Garibaldi (col grado di Maggiore Generale dell’Armata Sarda), da Arona attraversarono il Ticino entrando in terra
nemica per primi, ed arrivarono a Varese dove avvenne una prima battaglia (ove morì Enrico Cairoli, il primo
dei 4 fratelli) contro le truppe
austriache comandate da Urban, venute loro incontro da Como e dove ritornarono
sconfitte.
Fu
allora che l’esercito Piemontese (coadiuvato dai francesi arrivati il 10
maggio) varcò il Ticino e sconfisse il resto degli Austriaci a Magenta. Ma
Garibaldi, da solo alla sinistra dello schieramento e sbilanciato in avanti,
non contento, inseguì il nemico a Como e il 14 a Brescia, sconfiggendolo, lo
costrinse a ritirarsi verso la Valtellina. Nell’inseguimento, il 15 giugno 1859
a Treponti (già sede di
altri scontri nel 1848) avvenne un
sanguinosissimo aggancio con la retroguardia in fuga. La battaglia ebbe a lungo
esito incerto: gli austriaci erano in numero enorme rispetto gli inseguitori, e
dovevano proteggere la ritirata del grosso, seppur aggrediti dai Cacciatori;
l’esito vittorioso fu duplice, aggiungendosi che gli Austriaci dovettero
ritirare più truppe del previsto oltre la Valtellina dove i Cacciatori fecero
da ‘tappo’ sotto lo Stelvio.
Quasi
alla fine, un largo fossato sormontato da un ponte divenne l’ostacolo insuperabile
per i Cacciatori per conquistare la piazza; essi però ingegnosamente armarono
dei barconi e discesero silenziosamente il fossato fino al ponte, dove
sbarcarono e sbaragliarono le postazioni nemiche. Si distinsero i soldati dei
cap. Cosenz e Turr; morirono con onore il cap. Bronzetti Narcisio (che alcuni giorni prima aveva
attaccato mille nemici con cento uomini, vincendo e ricevendo elogi enfatici
dallo stesso Garibaldi) ed il cap.
Gradenigo.
---da staccato, come adottato
da una azienda dimostrante con conoscere la storia del Risorgimento italiano (o
quantomeno di fregarsene).
Però così appare invece chiaramente nella scheda della
Toponomastica, a significato che anche in Comune...: non è sicuro ma molto
probabilmente l’impiegato ha fatto riferimento ad avvenimenti della prima
guerra mondiale. Per esempio allora, la dedica potrebbe riferirsi ai famosi tre
ponti, relativi ai tre fiumi sui quali si svolsero fatti determinanti della
guerra, e divenuti simboli del passaggio glorioso dei fanti nel ripiegamento
verso il Piave: il ponte di Bassano (caratteristicamente ligneo e coperto, detto ‘degli Alpini’,
sul fiume Brenta; ricostruito varie volte su disegno originale del Palladio;
passaggio verso le innumerevoli e travagliate battaglie, essendo posto nelle
immediate retrovie del fronte); quello sull’Isonzo (dall’inizio guerra, lungo il fiume
furono combattute ben 12 grandi e sanguinose battaglie, dette appunto
“dell’Isonzo”; l’ultima, più conosciuta come ‘Caporetto’ tra il 24 ottobre ed
il 9 novembre del 1917, vide gli austro-tedeschi arrivare sino a Cividale,
costringendo i nostri alla ritirata dapprima sul Tagliamento e poi sul Piave), e di Vidor sul Piave (fu teatro nel nov. 1917 di strenua
difesa col fine di far passare le nostre truppe in ritirata: distrutto il
vicino ponte di Fener, rimaneva l’unico aperto; gli alpini comandati a
difenderlo, guidati dal 22enne cap. Nino Curti (per molti anni visse a Genova
essendo il padre professore del liceo Doria; il suo nome è scolpito sulla
cripta dell’Arco in piazza della Vittoria), furono ostinatamente vessati dalle
sovrastanti artiglierie nemiche e pressati dall’armata tedesca spinta
all’attacco; in disperati assalti all’arma bianca la postazione fu difesa fino
allo stremo (la salma del capitano caduto nella battaglia, fu composta dai
tedeschi in una tomba provvisoria su cui piantarono una croce di legno con la
scritta “hier ruth ein tapferer italiener” (qui giace un valoroso italiano).
Alla fine di ottobre 1918, fu il punto iniziale della contro offensiva italiana
dell’8a armata , che condusse alla conquista di Vittorio Veneto).
---Altra ipotesi suggerita sull’origine del nome:
==la presenza di tre arcate ferroviarie quali accesso alla
zona, da via G.Buranello (da via Palazzo della Fortezza, da via R.Pensa e da
via Albini: quest’ultima da prima della costruzione del palazzo che la separa
dalla piazza).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda n. 4480
-AAVV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.450—ed./02-pag.486
-AA.VV.
SanPierd’Arena nella sua ammin.fasc.-Reale.1926-p.43.54cart+prog
-D’Oria
S. - Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.47
-Gazzettino
Sampierdarenese, 2/80.9 + 10/80.16 + 1/81.9 + 5/86.5
-Genova,
rivista municipale, n. 11/33 (XII) pag.946
-Pagano ed/1950–pag.509;
ed/61-pag.415.446.929
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1786
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio 1995-tav.51
-Stradario
del Comune di genova edizione 1953 –pag.177
non
citato ES + EM + EZanichelli+ Pagano/33 +
TRIARI via dei
Triari
Corrisponde all’attuale via Bruno Ghiglione.
Fu così denominata, con delibera del podestà di Genova
del 19 agosto1935, nella revisione generale dei nomi delle strade delle
delegazioni, onde evitare doppi nomi con le omologhe del centro, dopo
l’annessione a Genova (decreto del 14 gennaio 1926).Nel Pagano/40 la strada è
citata: da p.za Modena a via della Cella. Numeri neri 1-2 ed al 2 Raffetto A. farmac; e privati professionisti. Rossi:
1r parrucch.;
2r farmacia Bisio già Raffetto; 8r copmmestib.; 9r salum.; 10r mercer.; 12r pesciv
Argeri arlo; 14r divise fasciste di Ogliari Ubaldo; 13r cereali olii oliva; 17r
macelleria; 19r sartoria f.lli Conte; 20r latteria; 22r bar; 23r salumeria;
27r drogheria; 29r mercerie; 31r pollivend.; 33r pesciv.
Fu reintitolata a vantaggio del partigiano Ghiglione, dopo la guerra
del 1940-45, con delibera della Giunta comunale, il 26 aprile 1946 .
Ma il Pagano 1950
ancora la cita, quale sede del mercato di
vendita all’ingrosso locale (assieme a quello
chiamato ‘Fortezza’ in piazza Treponti)-.
DEDICATA Anticamente erano soldati legionari romani,
scelti tra i più anziani perché costituivano l’estrema risorsa sia d’attacco
che di difesa: la roccia su cui la legione intera basava la propria stabilità.
Posti in terza schiera e muniti di grande armatura (scudo, corazza, elmo;
armati di due lance, una da urto ed una da lancio), erano usati a colonne
serrate per la carica, o per la resistenza.
Nel ventennio fascista,
costituiti i Fasci di Combattimento, nacquero le Squadre d’azione (da cui
‘squadristi’). Furono dapprima inquadrate militarmente con divisione –- tra
‘principi’ (ovvero come nelle legioni quelli di
prima linea, gli squadristi per eccellenza) ed i ‘triari’ (ovvero quelli di terza linea). Quando
l’organizzazione separò la componente militare da quella civile, tutti
passarono ad essere o balilla (fino a 12 anni),
avanguardista (fino a 18), fascista (oltre i 19); la MVSC (MiliziaVolontaria per la SicurezzaNazionale) fu divisa -in
forma ternaria- in legioni(=3coorti);
coorti(=3centurie); centurie(=3 manipoli); manipoli(=3squadre); squadre(=15
fascisti).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica, scheda 4483
-Enciclopedia Motta
-Encilopedia Sonzogno
-Pagano ed/40-pag.425; /1950: pag.382
; ed/1961-pag.446
-Stradario del Comune di Genova
ed.1953-pag.177
TUBINO piazza
Tubino
Oggi la piazza, completamente
rimaneggiata, ha perso nome e dimensioni, ed è stata inglobata in piazza Vittorio Veneto.
Dei quattro lati che la
delimitavano, rimangono solo quello a sud, dietro agli alberi ancor oggi
esistenti (con il palazzo che ospita l’albergo ‘Primavera’) e la breve parte
della facciata a ponente del palazzo che ospita il negozio ‘l’ombrello per
tutti’ .
Era posta nell’immediato ponente di piazza Vittorio
Veneto, e da essa separata solo dal ‘mastodontico’ palazzo
detto “dell’orologio” (così chiamato perché in alto -sulla facciata
rivolta a levante- aveva un orologio ad uso arrivi e partenze del treno, degli
Omnibus che facevano transito e capolinea nella piazza sottostante, di tutti i
cittadini in epoca in cui pochi potevano concedersi una ‘cipolla’ da portare al
panciotto, legata con la catenella; a sua volta posto allineato a nord, con il
palazzo tutt’ora esistente popolarmente conosciuto col nome del negozio
suddetto dell’ “ombrello per tutti”); dove ora sono i giardinetti.
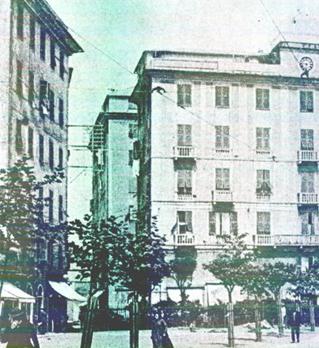
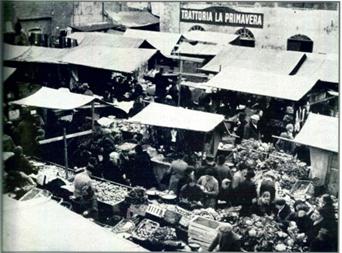
da piazza V.Veneto, dietro
il palazzo dell’orologio
Di interesse storico la presenza
del Politeama Sampierdarenese, che era posto nell’angolo e nella stessa posizione ove
ora sono gli uffici della Carige: in una palazzina ora abbattuta, e sostituita
dal palazzo attuale con portici, primo a mare di via Avio.
Terzo
importante teatro cittadino, inaugurato il 18 giu.1887 su disegni dell’arch.Ratto
e con la rappresentazione della “Lucia di Lamermoor” di Donizetti.
Con
750 posti per spettatori e con una attività predisposta alla lirica, settore in
cui superò in rappresentazioni lo stesso teatro Modena, esteticamente non era
bello come quello per cui fu anche definito in tono spregiativo -ed ovviamente
contestato- “una squallida baracca”. Il pubblico che frequentava i due teatri,
era espressione dei due strati sociali di allora: il popolino appoggiato alla
forza politica di sinistra, era principale frequentatore del Politeama (e per
loro fu organizzata una rappresentazione dell’opera in prosa di Pietro Chiesa,
intitolata “la vispa Teresa“ nell’ ago.1902); ed i neo ricchi ed alta borghesia, del Modena; anche se ambedue i
teatri, per sopravvivere dovevano far ricorso a sovvenzioni da parte del Comune
di San Pier d’Arena.
Il 1 maggio 1891, per la prima volta venne celebrata la festa dei lavoratori
(l’anno prima,Crispi l’aveva proibita emanando
un severo divieto): si riunirono nel
teatro gli operai e le operaie, dando vita ad un animato incontro e confronto
di idee, presente anche Chiesa; alla fine
prevalse l’invito dei più ‘ribelli’, di recarsi in corteo in via Mercato, a
liberare i compagni incarcerati nel palazzo Boccardo (oggi non più presente ma localizzabile quale ultimo
di via A.Cantore,angolo via GB Monti) per
fatti politici avvenuti a Teglia: in un attimo il teatro si vuotò. In realtà i prigionieri erano già stati trasferiti a
Genova: il corteo allora marciò verso Genova ma fu bloccato a san Benigno e
disperso da una compagnia di fanti, accorsi in largo Lanterna.
Agli inizi del 1900 le
opere più importanti ed applaudite si tenevano al ‘Sampierdarenese’ (il Modena
rimaneva privilegiato nella scelta, dai grandi nomi specie della prosa).
DeLandolina scrive che a
questo punto il teatro era però “una. squallida baracca che di teatro s’avea
solo il nome”
Fu
nel 1913, per iniziativa dei proprietari Riccardo Bo (parente del Bo del ‘cavagnino’di cui sopra?) ed i fratelli Aristide ed Alfredo Zucconi, che venne
completamente ristrutturato con più
attenzione al gusto estetico: tra tanti, vari medaglioni con raffigurati
artisti più noti, quattro palme dorate che tutt’intorno solcavano il soffitto,
ed allegorie, tutto dipinto dal pittore Nicola Mascialino (DeLandolina lo chiama Mosciallino e lo fa morire ‘poco
appresso’;il pittore, nato il 26 dic.1854 ad Alberobello, frequentò
l’Accademia di B.Arti napoletana ed approdò a Genova nel 1907 ove iniziò
decorando palazzi di via XX Settembre, palazzo della Borsa, Politeama Genovese
e collaborando con il Coppedé. Aprì uno studio in SPd’Arena dove decorò
dapprima il cinema Dante nel 1912, e l’anno dopo il rifatto nostro Politeama.
Morì in terra natale nel 1945); spiccava
scritto con caratteri d’oro in cartiglio posto sopra il palcoscenico il motto
“rinnovato per rinnovare”). La prima
opera rappresentata il 4 dic. (altri dice il 9) fu “il Conte di Lussemburgo”
dalla Compagnia di operette di Carmen Mariani, a cui seguirono con successo
strepitoso il cabarettista Romolo Bonino creatore di una brillante ”macchietta
genovese” ed il tenore Rubini, “iperbolicamente chiamato il Caruso della
varietà”.
Il Gazzettino scrive che
nel periodo bellico (più probabile
pre-bellico) ‘15-18, fu usato come
magazzino.
Nel dopoguerra ‘40-45
quando i grandi teatri genovesi risultarono pressoché tutti ridotti in macerie,
gli spettacoli si mantennero nei pochi rimasti nelle delegazioni; rinnovato
dall’imprenditore Renato Velati - personaggio
ricordato nell’ambiente perché oltre che datore di lavoro, era un amico per
queste compagnie che non brillavano certamente di opulenza e viaggiavano molto
spesso al limite economico della sopravvivenza quotidiana; vi ospitò le rappresentazioni dei grandi comici come
Macario, Dapporto(quest’ultimo visse i suoi esordi d’artista proprio in questo
teatro, ancora oscuro comico alla ricerca di una identità di barzellettiere che
ebbe solo dopo: viene ricordato una specie di addio dato al Velati di fronte al
pubblico, quando fu scritturato dalla Osiris,durante il quale rammentò i
cappuccini offertigli al bar Dogali e con i quali completava, piatto unico,
certe cene), A.Fabrizi, Tognazzi, Elena
Giusti ed Anna Fougez, e- per una indimenticabile serata nel 1948, anche il
tenore Tito Schipa che cantò gratis a vantaggio del 50° della Croce d’Oro.
Però ben presto fu
trasformato in cinematografo, abbandonando pressoché totalmente le attività
teatrali (per questo forse,lo stesso
rievocatore del Gazzettino riscrive ironicamente il motto: ‘rifatto per
rimanere chiuso’): praticamente perdette
il titolo di ‘politeama’ e rimase il ‘cinema Sampierdarenese’.
Nell’annuario Pagano del 1961, risulta ancora in attività come cinematografo,
sotto la gestione di Ida Giacobbe (uno
dei 7 allora esistenti in delegazione, assieme a: Astoria, Excelsior, Massimo,
Modena, Odeon, e Splendor; occorre comprendere i parrocchiali Cella e Don Bosco) .
In conclusione, nel 1960 il palazzotto del teatro fu demolito, e sostituito da
un moderno edificio per uffici ed abitazioni, costruito il vetro-cemento
dall’impresa Enzo Fossati.
Nel dic.1900, il
regio Commissario straordinario propose alla Giunta comunale il nome di
”piazza Tubino” alla “piazza e vicoli Tubino, posti a ponente della via
N.Barabino (via S.Canzio)“.
Nel genn.1901 un’impresa sampierdarenese (Calvi, Rebora, Barabino)
appose la targa in marmo ufficiale, e ad un censimento delle case esistenti al
fine di stabilire una numerazione, vi risultavano: al civ. 1 casa di Agostino
Bonnati e C; civ.4 casa Bò e Compagnia; civ.5 casa Castelli e Compagnia; civ. 6
casa Bianchi Stefano e C..
Il Pagano 1902
descrive: civ. 1 civ. 1 il negozio di frutta secca ed agrumi di Bruzzone
Davide (attivo dal1911 al 25);---al 6
identico di Pittaluga Luigi (vedi poi nel 1911);---e Pittaluga Andrea (1911-12) di Giacomo fa il mediatore in frutta
secca;--- cNP l’unica impresa Pompe funebri cittadina, di Rossi
Francesco (1911-12)(1919-25 passate a Rossi Bartolomeo), tel.
602---Lagorio Francesco ha una vaccheria
(genovese);---
Nel Pagano 1908
ha sede nella piazza la vaccheria di Lagorio Francesco (1911-12) (Genovese).
Compare inserita ufficialmente
nell’elenco delle strade comunali pubblicato nel 1910, “da via
Mamiani a via Cavour, con civv. fino al 3 e 4”.
Nel Pagano 1911-12 e 1919
1925 non ci sono variazioni ai precedenti
Nel 1926 alla
piazza fu cambiato nome, divenendo “piazza IV Novembre”.
Molto frequentati erano i
negozi alla base del palazzo dell’orologio e viciniori: vengono ricordati una
trattoria-osteria, non con i tavolini fuori ma gli sgabelli-, la drogheria
Pignattai con le sue vetrine, l’albergo Stella ed infine le stalle dei “Din”.
Dietro a mare, si aprivano i depositi di GB Carpaneto; ed a ponente, l’OEG
(Officine Elettriche Genovesi)
Contrastante con quello scritto
altrove, su documento ufficiale si legge che è da questa data che si previde
istituirvi il nuovo mercato con
bancarelle, spostato in quella sede da piazza XX Settembre (del Monastero) ove col frastuono dava fastidio
agli studenti ginnasiali; Fravega ricorda che la parte a nord vicino alla
ferrovia fu assegnata ai fruttivendoli ed ai loro banchi posti su cavalletti (tipici ortolani erano divenuti il Caroti, la ‘veggetta’,
il Beppe, il Pasquale; C.Banfo ricorda invece ‘a Grixia’ (sic) e
‘Rossiggiunn-e’e ‘Din’ il venditore di rane-oggi scomparse dalle campagne
vicine-, che da vive le decapitava all’ordinazione per rendere commestibili e
suscitando la morbosa attenzione vedendole muovere anche da morte ), e
quella a sud vicino all’albergo Primavera, per l’abbigliamento (primeggiavano mutandoni di lana, fazzoletti,
giarrettiere, camicie di flanella, canottiere con tre bottoni) e generi
casalinghi vari, in genere poggiati sui cassoni
con ruotine necessari per il trasporto e conservazione della merce che a fine
mercato veniva depositata in un capanno di piazza Galoppini (figure
caratteristiche erano ‘a Russa, a Benedetta, u Giuseppin ed u Munsu’); il tutto
coperto alle intemperie da tante tende a V, che dall’alto davano all’insieme un
aspetto caratteristico. Si trova
scritto sul Gazzettino (oltre che la
piazza vantava le origini del mercato all’ingrosso nel borgo: e questo non è
corretto) che qui giunti, i contadini
-affluiti con i carri a trazione animale e le merci alle ore antelucane e dalle
zone vicine quali Promontorio, Coronata, Voltri, finanche Arenzano e tutta la
valpolcevera; il mercato all’ingrosso apriva i cancelli alle cinque del
mattino- erano obbligati a pagare una tassa di occupazione suolo al
proprietario del terreno Giovanni Bo (detto ‘Giuanin d’a cavagninn-a’ perché
era uso passare dai singoli munito di una sporta appesa al braccio entro cui
riponeva la tassa riscossa) Alle nove, la piazza era tutta una animazione, sia
per i numerosi acquirenti, sia per le sovrastanti grida dei venditori che
richiamavano l’attenzione vantando la propria merce . Anche le strade vicino,
come via Imbriani, avevano banchetti (viene ricordato il solito banchetto di
giocattoli (allora ci si accontentava di poco: erano cavallini di legno,
tamburelli, automobiline a molla). Alle tredici, arrivavano i netturbini e
caricavano la spazzatura sui carretti a mano con due ante a basculla, lasciando
la piazza pulita, per i giochi dei ragazzi. (il pan-pan, il pallone, il giro
ciclistico con le agrette, la cavallina.
Nel Pagano 1908 si aprono nella piazza due negozi di frutta secca,
verdura ed agrumi, al civ.1 di Bruzzone Davide; ed al civ.6 di Pittaluga Luigi
(nel 1912 appare in via Vittorio Emanuele nel viadotto ferroviario), che appare
assieme a Pittaluga Andrea di Giacomo mediatore in frutta secca;
Alla sera, senza TV, la gente
trovava ristoro all’albergo Primavera,
al bar Italia (che alla distruzione della
piazza si ritroverà in piazza vittorio Veneto), al caffè Dogali (altro
punto di ritrovo nella piazza era questo bar; era costume uscire la sera
d’estate per andare nella piazza a prendere il gelato o ad ‘incontrarsi’
sedendosi all’aperto o –poiché esisteva la voglia di divertirsi- a preparare
burle a scapito di qualcuno. Nel 1950 lo ritroviamo in via del Mercato 73-75;
poi in via A.Cantore al civ.__dove fu continuato in gestione dalle figlie; e
dal 2001 in via N.Daste ) e sciamava
-specie d’estate- in cerca di aggregazione con la scusa del gelato, della
granita dello spettacolo al Politeama.
Per l’apertura negli anni ‘30
di via F.Avio e la sistemazione di via Cavour (viaS.Dondero), il Comune previde la ristrutturazione della
piazza presentando un progetto distruttivo, che verrà applicato nel 1934..
Nel Pagano 1933 permane
l’impresa pompe funebri di Rossi Bartolomeo (non
più unica ma in concorrenza con i Robba di via s.Antonio).
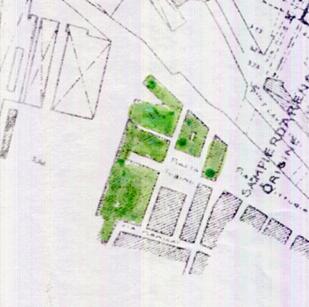
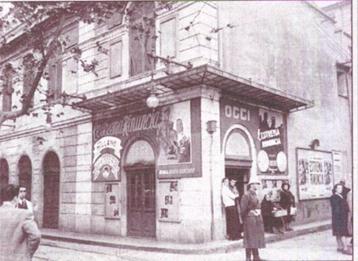
in
verde gli edifici abbattuti; a dx p.zza VVeneto ingresso del Politeama –
a destra l’attuale via Avio
Nell’anno 1934 in
pieno regime fascista, furono abbattuti ben quattro grossi caseggiati tra cui
il palazzo dell’orologio e gli altri due posti a ponente di esso ed uno
affiancato alla ferrovia (a via Cavour). Sono rimasti solo i palazzi che
delimitavano la parte a mare della piazza stessa, rappresentati dalla
costruzione ancor ora esistente, in cui aveva sede l’antica trattoria de “la
Primavera”, inizialmente anche albergo.
Un comitato presideuto dal cav.
Minelli tentò inutilmentente di opporsi; con rapidità il piano fu applicato
sfrattando i proprietari indennizzati con una somma di 6-7mila lire (che
riceveranno solo ben nove anni dopo, ovvero nel 1943, ovviamente senza
interessi).
In
una carta col progetto di una metropolitana da costruire, redatto nel 1934,
è ancora presente il nome di ‘piazza Tubino’.
DEDICATA alla famiglia Tubino; un
cognome molto vago e con una poliedrica possibilità di personaggi, nessuno ben
definito nella nomina alla piazza.
Tra tutti, il più qualificato
tra la borghesia industriale e mercantile cittadina (strato sociale che aveva sostituito al potere economico
l’aristocrazia), figurerebbe l’avvocato Tubino
GB fu Salvatore, divenuto anche consigliere comunale di San Pier
d’Arena, e poi due volte sindaco del nostro borgo (sicuramente nei bienni
1850-52 e 1852-54; (-ai quali successe un
intervallo di reggenza dell’avv.Bonanni - nel periodo 1854-56) e dal
febbraio 1857 non si sa per quanti anni a seguire.
Durante
la sua prima amministrazione fu approvato il “Regolamento piano d’ornato e di
abbellimento” uno dei primi Piano regolatore mirati a “far sorgere un nuovo
centro urbano più moderno e funzionale anche nell’aspetto igienico e
sanitario”. Le norme prevedevano strade più larghe; migliore aerazione; servizi
igienici adeguati (lavatoi ed urinatoi); eliminazione di casotti in legno sul
suolo pubblico (evidente sintomo del ‘fai
da te’, libero di sfruttare spazi necessari per la crescita della popolazione
ma poco rispettosi dell’ordine. A tal proposito, l’avv.Giovanni Gallarini nel 1850
(della Divisione amministrativa di Genova-Consiglio d’Intendenza), aveva
scritto: «il comune di Sampierdarena conta meglio di Novemila abitanti
agglomerati su una superficie territoriale di soli chilometri quadri DuemilaSettecento
novantotto, su cui la spiaggia, una strada ferrata coll’appendice della
stazione ed una strada reale si arrogano non ispregevole porzione; sicché la
densità di quella popolazione è veramente eccezionale e più di città che
altro;...il difetto di spazio nel concentrico vi si appalesa ad evidenza,
angustissime scorrendo le sue vie interne, sulle quali le case si addossano
appena intersecate a lunghi intervalli da qualche viottolo, che simula
piuttosto le dimensioni di una intercapedine». Fu aperta una galleria sotto san Benigno; dalle parole scritte :”…più
che strada galleria sotterranea, ferrata anch’essa a mestier di cavalli,
proposta nel 1851…”, si desume trattarsi di quella aperta per gli Omnibus.
A fine mandato (fu sostituito dal marzo 1854 dall’avv.cav.Bonanni Gerolamo) fu
approntato dall’arch.ing. Angelo Scaniglia un più pratico progetto urbanistico
“Piano di ornato e di abbellimento del paese” mirato al riassetto stradale e
che sarà attuato trent’anni dopo con l’ampliamento della Crosa dei Buoi e della
strada NS della Vista (via
G.Cassini), nonché dell’apertura della
strada poi dedicata ad A.Doria (via G.Giovanetti)
Fu quindi lui, quello che nel
1859 comperò la villa in piazza Montano dai Centurione (ma forse un altro quello che fu costretto a rivenderla ai Carpaneto nel
1875); che fu sottoscrittore per la realizzazione del teatro Modena nel
1857; che venne nominato cavaliere di s.Gregorio Magno; che oltre a solerte
amministratore fu anche ‘gentile poeta della Valbrevenna’ ove villeggiava; e
che infine fu munifico benefattore (per secondo,
donò un centinaio di libri alla biblioteca cittadina affinché nascesse –quando
la popolazione da 9mila anime del 1847 era passata a 14.008 nel 1861-; formulò
un voto religioso di aprire un ospizio per vecchi inabili al lavoro (per sciogliere il voto l’ospizio fu poi aperto dalla
sua vedova Caterina Scaniglia-Tubino nel 1900. Nel 1924 esso fu trasferito
nella attuale villa di Promontorio)).
Forse
–ascendente o semplicemente omonimo della prima decade del 1800- un Tubino fece
parte del consiglio comunale del borgo, e fu tra gli incaricati di studiare i
festeggiamenti per il prossimo arrivo a Genova -passando per San Pier
d’Arena- di Napoleone;
Oppure Tubino Onorato, ricordato quale artista di teatro ed
organizzatore –a nome della ‘Società dei Dilettanti’- di rappresentazioni
teatrali nel periodo carnevalesco a favore dell’ospedale, in crosa Larga nel
1803 (da poco finito l’assedio , sempre
sotto occupazione francese, la vita era appiattita e squallida, economicamente
miserevole e non in ripresa: commercio stagnante, leggi vessatorie, chiese
chiuse, ed ancora tanta fame):
Oppure scrive DeLandolina nel 1922 che nell’800 la famiglia ebbe un
poeta insigne
Non so se discendenti,
comunque omonimi meritevoli di ricordo furono Tubino GB grande ginnasta
sampierdarenese, oro olimpico ad Anversa nel 1920 , vincitore di innumerevoli
gare come atleta e come istruttore; e Tubino Stefano, partigiano,
onorato a Pegli con una strada.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Guida illustrativa per la città di Ge.-Sambolino.1875-pag.667
-AA.VV.-1886.1996
oltre un secolo di Lig.-SecoloXIX-pag.33
-AA.VV.-SPd’A.nella
sua amministrazione fascista-Reale.1926-pag.71
-BottaroPaternostro-st.del
teatro a Ge.-Esagraph.82-I-160fot.164n3,11,13,22.303n10
-DeLandolina
CG.-Sampierdarena-Rinascenza.1922- pag. 21.56
-Favretto
G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.165
-Gazzettino
S. : 7/80.7 + 4/84.11 + 8/85.10 + 5/86.11 + 1/89.8 + 8/89.10 +
2/90.7 + 7/90.6 + 3/91.7 + 5/91.3 +
10/96.19
-Il
Secolo XIX (R.Fravega) del 22/11.00 + 30/01/01
-Metropolitanacarta +
-Piersantelli
G-Storia delle biblioteche civiche genov-Olschki.1964-pag42
-Pagano/1908–pag.878----/1961-pag.588
-Pastorino.Vigliero-Diz.
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1188.1791
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Lig.-Sagep.1991-23nota 11.80.92.97nota 41.209
-Schmuckher
A.-Teatro e spettacolo a Genova..-Mondani.1976-pag.64.114
-Tuvo
T-Samp. come eravamo-Mondani.1983-p.25.32.37.52.60.84.87.88
-non
c’è in 4 + 61a +
TUNNEL
largo del Tunnel
nome popolarmente usato negli
anni d’inizio 1900, per indicare quello che poi fu ufficialmente chiamato
“largo Lanterna” (-vedi- e che oggi non esiste più come slargo, essendo stato
ristretto a strada di passaggio, integrata nel nome totale di via De Marini).
Secondo l’uso popolare di
denominare una località in rapporto al fattore più conosciuto, il tunnel era la
galleria del tram che bucando la collina di san Benigno, metteva Genova in
diretto contatto con la nostra via Vittorio Emanuele II .

il
tram procedeva sulle eculissi di sinistra, come i treni. Il militare del dazio
si affretta al controllo
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale

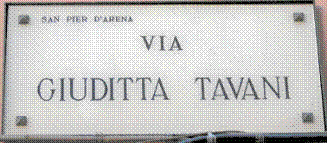

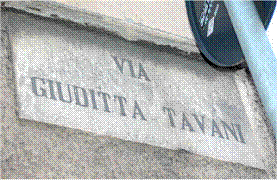

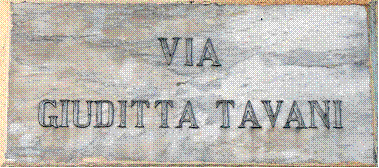
 da M.Vinzoni, 1757. In verde, via G.Tavani. In giallo via
san Martino (C.Rolando); rosso l’Abbazia e fucsia canonica e Oratorio di san
Martino.
da M.Vinzoni, 1757. In verde, via G.Tavani. In giallo via
san Martino (C.Rolando); rosso l’Abbazia e fucsia canonica e Oratorio di san
Martino. 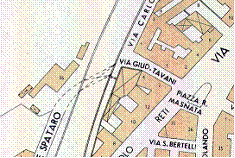 da Pagano/1961
da Pagano/1961 da Google earth, 2007
da Google earth, 2007


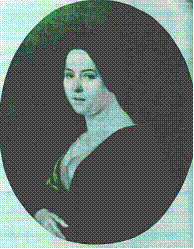
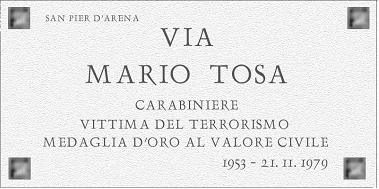
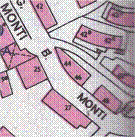
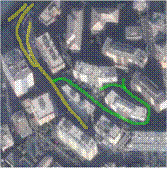








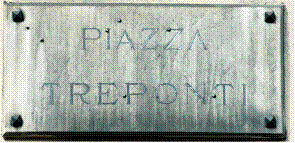
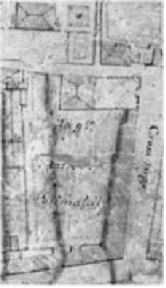
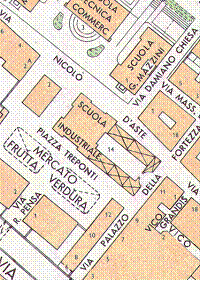




 __
__