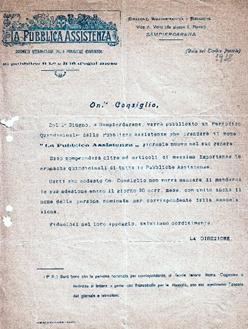VARESE via
Varese
È l’antico nome di via Bezzecca.
Nell’anno 1900 venne
proposto alla Giunta comunale questa titolazione, in cambio di “via detta
Copello” fino ad allora usata per la strada che “da via Vittorio Emanuele porta
verso il Polcevera, di fronte all’inizio di via Campasso”.
Anche il Novella (manoscritto
del 1900-1930) si limita a segnalarla come traversale di via Umberto I (via W.Fillak) .
Infatti nell’elenco pubblicato
dal Comune nel 1910, compare la ‘via Varese, da via Umberto I verso il
Polcevera’ con civici sino all’1 ed 8.
Il Pagano 1911, 12,
1920 vi segnalano il rappresentante al civ. 8-5 Clavenna Attilio attivo ancora nel 1920; al civ. 10 i marmai
(marmi artificiali) Peroni e Morelli (non più
nel 1919).
Dal 1919 vi si apriva una delle tre fabbriche di
carri e carrozze, di proprietà dapprima di Pereda e Ardini, dal 1925 solo di
Ardini Luigi e tale ancora nel 1933.
Il Costa1922 ed il Pagano/1925
pongono al civ. 8-2 la “IER” (Istituto Editoriale di Rinascenza) per lo sviluppo librario in Italia--- Direttore
generale DeLandolina GC.
Lo
stabilimento era multi produttivo: cromo-lyno-tipografia; legatoria; ufficio
d’Arte per schizzi e progetti di réclame; Periodici-opuscoli-libri (in particolare
la rivista mensile “Rinascenza” con interesse di arte sociale, con direttori il
DeLandolina e M.Mascardi. Questa società,
una delle dieci tipografie citate dal Costa, nel P/1919 non è citata; nel
P/1920-1 era in via Andrea Costa al 33r.
Ed altrettanto eguale il nome
stradale nel 1926 nell’elenco consegnato al Comune all’atto
dell’unificazione nella Grande Genova; ma anche il Centro possedeva una
titolazione eguale e fu giocoforza prepararci alla sostituzione.
L’applicazione tardò ad essere
adottata, tant’è vero che esisteva ancora eguale nel 1933, di 5.a
categoria con civv. sino all’8; laddove la precisazione che da via Umberto I si
collegava con via Calatafimi (via C.Orgiero),
permette allora farla corrispondere all’attuale via
Bezzecca.
Il nome attuale fu definitivamente ingiunto dal podestà di Genova, con
delibera del 19 agosto 1935.
DEDICA ovvio pensare sia
stata dedicata alla città lombarda, anche se non si conosce bene il motivo.
Ma, se dopo la data del 1935
la scelta dei nomi stradali mirava a ricordare eventi risorgimentali e della
prima guerra mondiale, prima di quella data erano prevalenti quelli in memoria
dell’epopea garibaldina: allora Varese ricorda una battaglia combattuta il 26
maggio 1859 tra i Volontari delle Alpi comandati personalmente da Garibaldi
contro gli austriaci comandati dal gen. Urban; con la vittoria dei primi, tutto
il varesotto fu unito indissolubilmente all’Italia. La vittoria però costò la
vita a Enrico Cairoli, il primo dei quattro fratelli. Nell’inseguimento delle
truppe austriache in ritirata, avvenne la battaglia di Treponti (vedi).
Alternativa è -come a Genova san Fruttuoso- la dedica a
Carlo Varese, ma avrebbero riportato il cognome completo del nome.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda n. 4558
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza .1922 – pag. 57
-Enciclopedia Sonzogno
-Novella P.-Strade di Genova-nanoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Pagano/1933-pag.249
VASCO via Vasco da Gama
TARGHE:
s. Pier d’Arena – 2865 - via
- Vasco da Gama – navigatore – 1469-1524

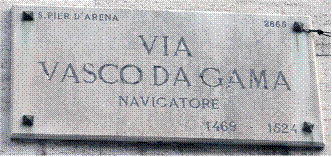

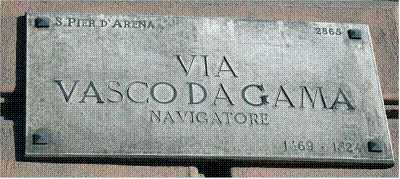
QUARTIERE MEDIEVALE:
Castello – Mercato

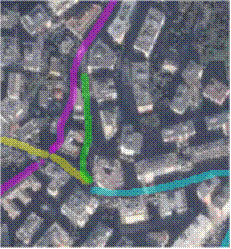
da MVinzoni, 1757. da
Google Earth, 2007. In fucsia c.so
Martinetti
Area nella quale si formerà la strada.
In verde sal. S.Rosa con il sifone del tratto sup.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2865
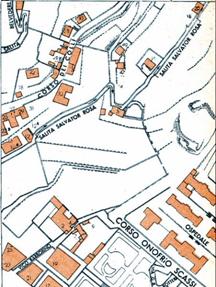
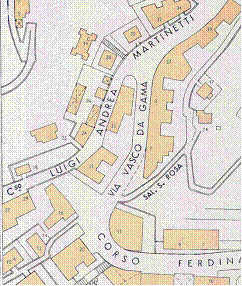
da
Pagano/1940- salita S.Rosa da Pagano/1961
ancora
tutta intera
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 63360
UNITÀ
URBANISTICA: 27 - BELVEDERE
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco
STRUTTURA: Breve
tracciato di cento metri, iniziando in basso dalla separazione da corso
L.Martinetti, per arrivare alla continuazione con corso Magellano quando,
andando verso il nosocomio, alla sommità si innesta la strada proveniente dal
ponte che passa sopra corso L.Martinetti .
Doppio senso viario e
pedonale
Ha posteggio per le auto solo dal lato dei negozi e davanti al civ.2
Un distributore di benzina, unico in zona, diversifica la strada; fu aperto
nel 1991.
CIVICI:
2007=
NERI = da 1 a 3 e 2
ROSSI = da 1r a 33r
e 2r
I
palazzi affiancati furono eretti un più tardi, risalendo i primi di essi al
1957 per i civv. 1 e 3; fino al 1970 per il civ.2.
STORIA:
Nella
carta Vinzoniana il territorio ove nacque la strada apparteneva -nel tratto a
nord, sino a Promontorio - al rev.do padre Augusto Negrone ed - a sud -
all’emin.mo cardinale Doria; le cui proprietà erano a ponente della stradina
che poi si chiamerà sal Inf-Sup SRosa.
La
strada nacque con la necessità di arrivare all’ospedale in modo alternativo,
visto che, per arrivarvi, fin dall’inizio (1915) era stata utilizzata solo le
strade a levante (Balbi Piovera e GB Botteri).
Però
per difficoltà varie e lungaggini soprattutto burocratiche-economiche, fu
aperta al traffico solo nel 1955.
DEDICATA
al
navigatore portoghese, nato a Sines vicino a Lisbona, nell’Estremadura, nel
1469.
Ritratto attribuito a G. Lopes - sec.XVI – Mus. Regional -
Lisbona
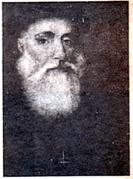
PORTOGALLO Dall’impero
romano –dopo un breve dei visigoti-, agli anni 1095 (la reconquista), le terre
portoghesi erano state occupate dagli arabi che insegnarono ad allargare gli
orizzonti; alla fine del 1300 iniziò la cura della flotta mercantile e –con
essa- l’espansione coloniale nelle quali si distinse il principe Enrico il
Navigatore: dalle Canarie, Azzorre, Capo Verde, Guinea ecc. egemonizzando i
traffici verso l’oriente; nel 1500 attraversarono l’Atlantico e si
interessarono del Brasile L’apice dell’espansionismo arrivò al 1600; dopo il
quale iniziò il declino; complicato l’impero portoghese (Compagnia delle Indie
portoghesi) dalle missioni dei gesuiti i cui metodi di colonizzazione crearono
gravi disaccordi interni ).
La storia della sua vita inizia con lui già esperto
navigatore: quindi presumibile – non essendo di nobile ascemdenza - scelta di
vita sul mare da ragazzo, e seguente carriera per vivace capacità
Secondo la versione più accreditata – appena
ipotizzata la possibilità di raggirare la punta meridionale dell’Africa (detta allora ‘ capo delle Tempeste’ e già raggiunta
da B.Diaz nel 1487 ma non doppiata)– ricevette incarico dal re Manoel I (Emanuele) del Portogallo di ritentare il
periplo e raggiungere le Indie
Salpò da Lisbona (8 lug.1497 –la Utet scrive il 25 marzo) con 4 caravelle – delle quali, la
ammiraglia san Gabriel stazzava appeva 120t ma, seppur piccola era stata
allestita con molta attenzione ai particolari, da armatori fiorentini (i
Sernigi) stabiliti a Lisbona.
Percorrendo l’oceano Atlantico, per primo, doppiò il
capo di Buona Speranza il 18-22 nov.1497. Il giorno di Natale, pose l’ancora
in una baia, alla quale diede il nome di Natal (rimase
regione storica della reg. SudAfricana, cambiando nome nel 1994 con Kwa Zulu.
Altra Natal è in Brasile ma fondata molto dopo, nel 1599). Aprì così la
via all’oceano Indiano che da molto tempo era ipotizzata come più veloce della
via terrestre per arrivare alle Indie ed all’oriente in genere.
Proseguendo nell’oceano Indiano, seguì l’itinerario concepito dal principe
Enrico il Navigatore, arrivò – passando per Mozambico, Mombasa e Melinde (dove
imbarcò un pilota arabo) – col favore del monsone - sino a Calicut nell’India
meridionale, ove gettò l’ancora il 20 mag.1498 (Utet scrive 18 maggio).
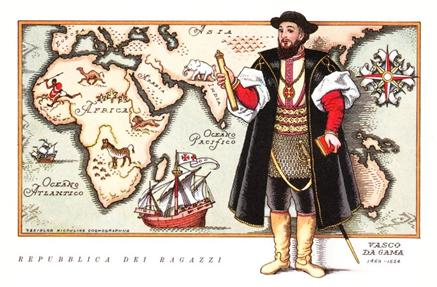
Localmente, trovò possibiltà commerciali assai ampie ma larga e manifesta
ostilità dei mercanti arabi e dal ragjà Samurin (probabilmente l’equipaggio
aveva combinato qualche incidente). Ripartito col nuovo monsone l’8 ottobre, il
viaggio fu funestato da incidenti, malattie e disagi vari che decimarono
l’equipaggio; ciononostante riuscì a rientrare a Lisbona col prezioso carico
alla fine nell’ago dell’anno successivo (altri scrivono settembre 1499), accolto trionfalmente (fu innalzato un tempio votivo a
Belem, per commemorare l’evento) ed ottenendo
personalmente larghi onori (il titolo di Ammiraglio delle Indie). L’impresa segnava l’inizio di successive fortunate spedizioni
commerciali portoghesi che ebbero l’acme quando la nazione formò l’Impero
coloniale. In questo primo viaggio era stato accompagnato dal fratello,
Cristoforo di Gama, che poi divenne valente capitano di mare (morì nel 1542).
In un secondo viaggio, iniziato nel 1502 ricircumnavigò l’Africa e, sulle sue
coste orientali fondò colonie a Mozambico ed a Sofale (la prima fattoria
fortificata portoghese fu insediata in India, a Malabar); al ritorno fu
nominato “ammiraglio delle Indie, Persia ed Arabia”.
Allora preferì ritirarsi a vita privata – anche perché, navigatori più giovani
venivano preferiti (come Alfonso de Albunquerque).
Ma, peggiorati i rapporti coloniali portoghesi, nel 1524 il re Giovanni III,
lo richiamò in sevizio nominandolo ‘viceré’: gli fornì una forte squadra navale
facendolo accompagnare da due figli (Estevao (Stefano) e
Paulo) e lo fece partire per il terzo viaggio. Arrivò sino a Cocin (oggi
Cochin, in India, poco più a sud di Calicut) ove però – pochi mesi dopo
l’arrivo - il 24 dic.1524 morì, senza aver potuto iniziare la progettata opera
di ricupero del potere portoghese.
L’impresa del navigatore, formò il soggetto di un poema di Camoens, intitolato
“le Lusiadi”.
Anche il figlio secondogenito Stefano (o Estevam
divenne grande esploratore; compì altro viaggio nel 1532 in una squadra
comandata da Per Vaz do Amaral; per un incidente rimase sbarcato a terra sulla
costa araba, ma riuscì a ricongiungersi poi agli altri; pochi anni dopo fu
nominato governatore della Malacca nel 1536 e poi di Goa (capitale dell’India portoghese) nel 1540, dieci anni prima della sua
morte).
Ed
altrettanto il figlio quartogenito Christovam nato a Evora nel 1516; era partito
nel 1532 col fratello e compì poi da solo numerosi altri viaggi: finché fu
posto a capo di una spedizione militare in soccorso di Claudio, negus
d’Etiopia: mentre avanzava all’attacco dei musulmani di Ahmad ibn Ibrahim, fu
da loro circondato, catturato ed ucciso nell’agosto 1542.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 4561
(Vasco da-)
-AA.VV.-Annuario-guida
archidiocesi—ed./94-pag.451—ed./02-pag.488
-Enciclopedia
Motta ( Vasco da- e ritratto )
-Enciclopedia
Sonzogno(Vasco di-)
-Enciclopedia
Zanichelli (Vasco da-)
-Grande
dizionario enciclopedico Utet-vol. VI (Gama-)
-Lamponi
M.- Sampierdarena – LibroPiù.2002- pag. 208
-Pastorino.Vigliero-Dizion.
delle strade di Ge.-Tolozzi.85-p. 1805Vasco de-
-Roscelli
D.-Cristoforo Colombo-Bastogi.2006-pag.87
VECCHIA strada
Vecchia
In una circolare pubblicitaria
dello stabilimento metallurgico meccanico Balleydier
Fratelli, viene posto questo nome nell’indirizzo: la carta intestata
riporta che la sede è “in San Pier d’Arena, sul principio della St.da Vecchia vicino alla Lanterna“. Si inteneva,
probabilmente, la via poi De Marini.
Lo stabilimento divenne attivo
dal 1832, quando le strade non avevano alcun nome, e quindi si procedeva per
“riferimento” a quello che più conosciuto potesse esserci nella zona. La
lettera non è datata ma necessariamente è antecedente al 1857 quando invece
iniziarono ad essere definite con nomi più diversificati le principali strade
della città (delle quali in zona vengono riconosciute solo lo “stradone piano
della Coscia, che poi divenne via del Ferro”; la “strada Superiore”, che
divenne via De Marini; e la “strada. della Marina” che divenne via Galata).
Quindi la “strada Vecchia”
corrisponde molto presumibilmente a via De Marini; dalla quale allo
stabilimento, intercorrevano massimo un centinaio di metri.
Questo nome è tuttora in atto
in altre delegazioni, come a Staglieno ed a Voltri; in ambedue usato per
indicare il diritto di antichità di origine.
BIBLIOGRAFIA
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1812
-Tuvo T.-Sampierdarena come
eravamo-Mondani 1983-pag. 251
-Tuvo.Campagnol-Storia di
Sampierdarena-D’Amore 1975-pag. 197
VENTI piazza
Venti Settembre
Corrisponde all’attuale
“piazza del Monastero” .
Come ricorda il Novella,
questa titolazione le fu imposta nel 1890, a sostituzione del primitivo
nome di ‘piazza del Monastero’ uguale a quello attuale; e, ad ufficializzare
quella scelta, nel 1901 le fu murata la targa in marmo dall’impresa
Rebora, Calvi, Barabino per ordine del Comune.


senza
monumento e diversa facciata/scalinata con monumento dopo 1905


Nel Pagano 1902 sono
segnalati: gli orefici orologiai Costa e
Pesso’; al civ. 1 il negozio calzature di
Michelini Luigi*°¨ (anche in via Mazzini).
Nel 1905 vi fu eretto
il monumento a Garibaldi (vedi a Monastero).
Nel Pagano 1908 (1911 e
1912) segnalano la presenza al civ. 1 del
negozio di merceria-tessuti della ditta Dasso Santo →1925; del libraio
Dellepiane Luigi →1925, e della trattoria di Domenico
Lombardo→1912.
Nel 1910 compare
nell’elenco delle strade e piazze cittadine, pubblicato dal Comune: localizzata
‘da via C.Colombo verso Nord’, con civici sino al 6.

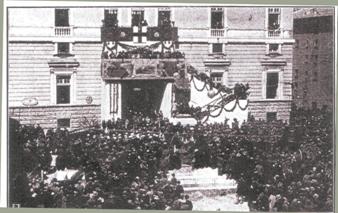
foto
1916 foto
1918
Da questi anni, la piazza
viene solitamente usata per le manifestazioni di tutti i tipi, dai comizi alle
cerimonie, fiere e dimostrazioni. La rivista
“L’illustrazione Italiana” riporta – datata 21 aprile 1918 (vedi foto sopra)
corredatata di fotografie che mostrano la piazza gremita-,“la consegna della Bandiera e di una medaglia d’oro
(incisa dallo scultore DeAlbertis, raffigurante
sul verso una ridondante testa di Medusa, sul retro una barriera composta da
quattro cannoni affiancati, visti dal dietro, a sbarramento contro il nemico;
più le solite frasi stentoree, in latino),
offerta dagli operai dello stabilimento-artiglieria Ansaldo, alla «Batteria
C.Battisti» (la cerimonia fu conclusa poi
in piazza Corvetto). In essa si
formavano le adunate del Carrosezzo nel
periodo di carnevale: manifestazione molto sentita ed attesa, con premi
semplici ma ambiti (gagliardetti di
‘primo classificato’; o semplici allori)
e con seguenti sfilate per le vie cittadine su carri (→v Vittorio Emanuele→Marina sino alla
Coscia. Ma anche al Campasso→vFillak sino a v.Bercilli, allora confine
con Rivarolo)
Il Pagano 1925 mette la soc. per costruzioni in ferro Storace f.lli fu
CarloAurelio tel 41392; al civ. 2 i f.lli Tobia hanno negozio di cereali.
Dopo il 1926 con
l’annessione di San Pier d’Arena nella Grande Genova, onde evitare doppioni col
centro cittadino, fu necessario modificare i nomi eguali, sacrificando quelli
della periferia: tutte le delegazioni dovettero cambiare titolazione a
vantaggio della omonima del Centro tutt’ora esistente: così capitò a SPd’Arena
(piazza), Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto, Rivarolo, Voltri (via).
Nel 1933 però la
variazione non era ancora entrata in vigore, cosicché ancora la troviamo in
documenti ufficiali con questo nome vecchio, di 3.a categoria, collegante via
C.Colombo (via San Pier
d’Arena) con via A. da Brescia (via del Monastero) e con vico Mentana (vico della Catena); ed ospitante al civ. 1 la
merceria di Dasso Sante e gli appaltatori edili f.lli Albertini; una delle 4
librerie locali, di Dellepiane Luigi; la scuola elementare N.Barabino;il
calzaturificio di Michelini Luigi.
In questo anno, in questa
piazza (non precisato dove ma si presume nel
palazzo del monastero) c’era il Comando della 2ª Coorte (della 36ª
Legione C.Colombo) della “Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale” (la Milizia era un
servizio di volontari agli ordini del Capo del governo, affiancato alle forze
militari dalle quali poteva essere ‘asorbito’ in caso di mobilitazione:
provvedeva alla pubblica sicurezza, a mantenere l’ordine ed a ‘conservare
inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell’Italia nel Mondo’).
Infatti la ufficializzazione
della modifica rientra nel vasto elenco delle vie di San Pier d’Arena con
firma del podestà il 19 agosto 1935 cancellate e ridenominate. Si tornò
all’antico nome riferito all’esistenza del monastero del santo Sepolcro già
dagli anni attorno al 1300, e sul quale poi sorse negli anni attorno al 1550
il palazzo Centurione.
DEDICATA alla storica data del
1870, in cui le truppe piemontesi del IV corpo, forti di 50mila uomini al
comando del generale Raffaele Cadorna, (padre
di Carlo, altrettanto condottiero nella guerra del 1915-18) fallite le
pacifiche trattative con la santa Sede di resa spontanea, dopo un breve
bombardamento di artiglieria che aprì un grosso varco di 30m nelle mura tra
porta Pia e porta Salaria, penetrarono in Roma superando le deboli difese
dei 15mila soldati pontifici comandati dal generale Kanzler: ne seguì
immediatamente la designazione di Roma capitale del
regno d’Italia.
Oggi appare una cosa ovvia, avere Roma capitale, e
poter girare lo stivale in piena libertà: però è una realtà che ha dovuto
essere duramente conquistata; corrisponde all’atto finale di ricostituzione di
uno stato unito d’Italia dopo quasi duemila anni di divisioni territoriali e di
governi diversi, assai spesso stranieri.
Come tutti i grandi avvenimenti
storici, la verità ha molti aspetti, molte facce; una che vola alta: la
realizzazione avvenne sotto la guida morale di Mazzini (due erano i messaggi del Maestro: Italia una e repubblicana. Per la
realizzazione del primo punto, specialmente a San Pier d’Arena, si collaborò
fattivamente; accettando non senza rammarico che fosse operata da un re,
consapevoli che poi avrebbe formato un regno e non una repubblica); con
la spada del genio delle rivoluzioni, Garibaldi; con la sagace maestria
politica internazionale del Cavour; con il tacito consenso delle altre nazioni
(soprattutti dell’Inghilterra
la quale ovviamente trovava un tornaconto politico non da poco nella formazione
di un nuovo stato –debole- ma cuscinetto nel Mediterraneo e avverso alle mire
espansionistiche di Francia ed Austria); nonché nella eliminazione del
potere temporale del Papa (troppo potere,
secondo gli inglesi, protestanti).
La seconda faccia è più
rasoterra: inimmaginabili lotte ed eroici sacrifici di molti patrioti fedeli
all’idea dell’Italia Una; tanti moti popolari soffocati nel sangue; pesanti
campagne militari per conquistare millimetricamente il territorio; gli
interessi e paure di molti, forse addirittura dei più (specie del clero, dei
conservatori e dei soliti tanti benpensanti).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4590
-DeLandolina GC- Sampierdarena
-Rinascenza .1922- pag.57
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-“L’illustrazione italiana”
numero del 05.05.1918-pag. 360
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19.20.25
-Pagano/1908 – pag.877-9
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1818
-Pescio A.-I nomi delle strade di
Genova-Forni.1986-pag.357
VENTO piazza del Vento
strada del Vento
Che San Pier d’Arena venga
comunemente chiamata anche Sampierdelvento è conosciuto, specie in alcuni
tratti dove la corrente è forte e tutto l’anno (caratteristici,
per il numero di ombrelli rotti, gli incroci via V.Alfieri-via A.Cantore e via
C.Rolando-via A. Stennio e l’attesa del bus in via Cantore civ.50).
I
VENTI Tre sono i venti che ci interessano. Sopratutti : la
tramontana. Non è una semplice brezza quella che dai monti soffia lungo il
Polcevera; quando è estate è anche piacevole, ma d’inverno è quel vento freddo
che frusta il volto, entra negli abiti e penetra nella carne arrivando fino
alle ossa; e non rispetta né cappotti né ombrelli. Ai tempi antichi, il vento
lungo il torrente poteva forse essere utile a muovere i vari mulini dislocati
in zona (ma erano per lo più molini ad acqua e
non a vento). Nel dopoguerra ci ripuliva il cielo dall’inquinamento
delle industrie e centrali; oggi dagli odori e dallo smog viaro.
Gli altri due vengono dal
mare, lo scirocco da sud est, ed il libeccio da sud ovest. Sono
forieri di “mare mosso, e tempo du belin”, ovvero dal luvego e maccaia, fino a
pesca impossibile, difficile attracco, mareggiate “in casa”.
Anche Petrucci ne parla, in particolare della
tramontana. Riconosce che essa aveva dei luoghi specifici, a lei deputati dalla
natura: a Voltri, a Cornigliano, da noi ed anche a Genova. Per quest’ultima (riassumo a memoria) descrive una
vecchia favola che racconta come la città nacque in funzione del vento,
necessario e vitale per il tipo di mestiere che i suoi abitanti avevano
prescelto per vivervi: la vita sul mare. Ma un giorno avvenne una violenta lite
tra lo scirocco che portava l’acqua e la tramontana che spingeva dai monti; la
lotta durò con l’uso di ciascuno del suo meglio: sollevare gonne, rovesciare
ombrelli, sbattere le finestre. L’accordo finale fu di alternarsi con
sorridente schermaglia: uno che lavava le strade, l’altra faceva da scopa. Ma
ahi Genova! da quando fu deciso la demolizione di san Benigno, il vento di San
Pier d’Arena si mischia al di là dei suoi canaloni, costringendo al Lagaccio di
accendere la stufa di inverno; è così, che lui –oggi teleguidato da tante
previsioni che gli fan fare una vita da cani- si vendica come può, ed ora
Genova vorrebbe divorziare dal vento. Ma non può.
IL
POSTO nelle carte compare e viene scritto essere in una area riferibile
a monte all’attuale via Antica Fiumara, la villa ‘Palazzo
del vento’ con, a ponente, il giardino ‘piazza
del Vento’; ed oggi poco a ponente
dell’attuale inizio di questa strada nella triforcazione con via Molteni, via Pacinotti,
via Bombrini.Nulla a che fare con ‘o gïo do vénto’ che è a Bolzaneto
Nell’anno 1819 venne
presentato dalla Giunta comunale un “quadro statistico territoriale della
comunità di San Pier d’Arena”: vi è citata una “strada del Palazzo del Vento al
torrente Polcevera”, giudicandola in stato mediocre.
Riguardo le costruzioni nella
zona, pur sapendo che nell’antico gli spazi ed il tempo erano concepiti in
termini più larghi e vaghi (la parrocchia a san
Martino, per esempio, un pò lontana per quelli della Coscia), non tutto
combacia alla perfezione per mia mancanza di documentazione: una villa è
ben visibile nelle carte dalla fine del 1700 ed in posizione chiara; ma la cappella
(forse sono le cappelle, ovvero più d’una in quanto che -in alcuni
scritti- si fa risalire al 1300, ed in altri si fa eretta da Rolla) e la torre
medievale ancor oggi presente. Appaiono decentrate l’una con l’altra come ad
interpretare che c’erano altre strutture a noi sconosciute, in quanto
risalenti a tempi prima del 1750.
Nel 1871, l’annuario Lossa
segnala in località (quindi vicino alla villa)
“piazza del Vento”, esserci il primo stabilimento fonderia di MacLaren e Wilson.
LE
CARTE : in esse si evidenzia solo la villa.
Nessuna accenna, né evidenzia, la
torre e le cappelle.
La cronologia della villa
sarebbe:
-prima, quella del Volckammer del 1708 ove la villa è attribuita al sig. Filippo Cattaneo;
-seconda, la carta nella
carta del Vinzoni del 1757, appare appartenere al magnifico Rainero Grimaldi (vedi sotto agli ‘scritti’).
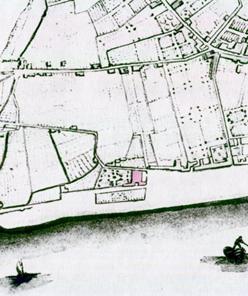
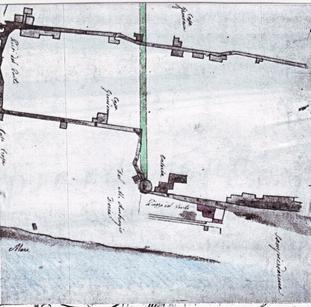
1773
con ‘Piazza del vento’; e, a ponente, terreni di Ambrogio
Doria;
la casa a scaletta la ‘Onteria’; poco sopra ‘casa Grondona’.
-terza, la
planimetria di Matteo Vinzoni del 1773, per l’atlante “il Dominio della Serenissima Repubblica
de Genova in Terraferma”, non appare alcun
nome;
-quarta, una carta non datata, probabilmente del Brusco, risalente ad un progetto stradale
della fine del 1700: non dice il nome
del proprietario (limitandosi a chiarire che la
zona ad ovest della villa è del m.co Ambrogio Doria).
-quinta (non sappiamo e
non abbiamo documentazione di quando divenne proprietà dei fratelli Savignone Infatti,
sappiamo solo che nel 1830 Lorenzo II Dufour, appena arrivato a Genova
da Torino, acquistò dai fratelli Savignone il “Palazzo del Vento” con annessi
orti e cortili, per farne sede di una raffineria di zucchero, iniziando le
attività industriali della famiglia) –sesta infine, nella carta del Porro del 1835-8, già è segnata come “raffineria da
zucchero” del Dufour -Poco si sa dell’acquisto dei Dufour del 1830. La raffineria produsse sino al 1840, quando
una modifica del dazio di importazione obbligò a chiuderla, e sostituire la
lavorazione con i sali di chinino -con i cui proventi, il Dufour riuscì a
diversificare con anche investimenti nell’immobiliare-. La fabbrica, nel
frattempo divenuta “ditta fratelli Dufour” fu proseguita da tre dei suoi
figli (Lorenzo III, Carlo, Luigi) ed ampliata producendo anche altre sostanze
come saponi, acido citrico e prevalentemente mannite. Nel 1853, la proprietà
subì la mutilazione forzata per la costruzione del tronco di strada ferrata
-dalla stazione delle merci al mare-; la famiglia acconsentì alla cessione e
fu indennizzata dal governo. Nel 1883, con l’arrivo in dirigenza dell’azienda
dei nipoti Lorenzo IV (laureato in chimica) e Gustavo (laureato in ingegneria
navale), si allargarono progressivamente gli interessi della famiglia
investendo nel settore armatoriale, conceria e legname. Ma già dagli anni 1860,
ferrovia ed Ansaldo in espansione, promossero che le attività della famiglia
fossero praticamente tutte spostate a Cornigliano. Qui a San pier d’Arena,
ancora nel 1926 si continuò la produzione di mannite, estrazione del tannino e
della liquirizia (con la quale iniziarono a produrre le prime caramelle); ma
nel 1928 le attività subirono un tracollo, mantenendosi la fabbrica chimica
solo per poche iniziative ed il possesso dell’immobile.
-settima, proprietà dell’Ansaldo. Il palazzo
fu distrutto non si conosce bene la data, nelle prime decadi del 1900; e il suo sedìme fu occupato dall’Ansaldo (nelle mappe del 1897 lo spazio della villa è ancora
conservato nell’angolo di nord-ovest tra via Operai e via Fiumara, ma
completamente circondato dagli edifici dello stabilimento).
GLI SCRITTI quasi mai
si scrive di una villa, ma più spesso della Cappella che – presumiamo noi - era
eretta vicino alla casa dei patroni (ma non è
detto, considerato che alla Coscia esisteva la villa Pallavicini, vicina alla
cappella –senza villa- dei Cibo).
Che la villa fosse più antica ancora delle carte che la
evidenziano, lo si può solo presupporre.
Cronologicamente:
-Nell’atto di una tassazione straordinaria firmato nel 1387 dall’Arcivescovo su ordinanza del papa Urbano
VI e mirato a rimpinguare le casse vaticane dopo guerre varie e lotta allo
scisma, si cita una «ecclesia de Ranucio lire 1»; giudichiamo possa essere la
cappella dell’Annunziata, qui fondata da Ranuccio
o Ranieri Grimaldi, segnalata
dall’Accinelli.
-Il mons. Bossio nel 1582
scrisse che in questa data la cappella era di proprietà di Pasquale Grimaldi.
-L’arciprete Borelli nel 1771
la descrisse appartenere ai Grimaldi, “uffiziata
dai Dottrinanti pel catechismo dei fanciulii” e dedicata alla SS.Annunziata.
I DUBBI questa
iniziale appartenenza di una cappella ai Grimaldi fa apparire strana o
impropria la sequenza delle carte topografiche che mostrano la proprietà della
villa –prima e dopo ai Cattaneo con nel mezzo i Grimaldi.
Diventa comunque difficile collocare nel contesto della
Fiumara la coesistenza della villa, della torre duecentesca, non
proprio attaccata ad essa ma vicina (Nella
facciata a nord dei vari capannoni dell’Ansaldo –gestione Perrone-, emergente
e ben conservata seppur inglobata nella palizzata lungo la via Bombrini è visibile la torre duecentesca usata per
avvistamento e difesa della villa nel tardo medioevo e come montacarichi nella
nuova struttura industriale. A mio avviso facente parte di altra costruzione di
un’epoca medievale e -nel tempo- scomparsa senza lasciare tracce, e sul cui
sedime fu eretta questa che citiamo); e sia la presenza nella località
della marina - allora pressoché deserta - della altrettanto famosa “cappella”
o forse delle cappelle, che non esistono più (sia
quella descritta sopra, di epoca medievale, e quella Rolla che pare la eresse
lui, e quindi ottocentesca e posizionata sulla strada principale che dal
Mercato va al Ponte –vedi cappella Rolla-).
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.100
-Ciliento B.-Gli scozzesi in
piazza d’Armi-DeFerrerari.1995-pag.37.51
-Belgrano LT-atti
SocLigStoriaPatria-1871-vol.I-parteI-fasc.II-pag.397
-Cevini-Torre-Architettura e industria-Sagep.1994-pag.116
-Doria G.-Investim. e sviluppo economico a
Ge-Giuffrè.1973-pag.771
-Costa B. - i Dufour - Erga 1999-pag.20.57.
-Gazzettino Sampierdarenese:
1/95.3
-Remondini A e M- parrocchie dell’archidiocesi-1897-
vol.11-.78
-Stringa P.-La Valpolcevera-Agis.1980-pag.91.93
-Petrucci VE.-Vocabolario genovese-Secolo XIX.
VERDI via Giuseppe Verdi
La proposta di titolare la
strada al musicista ( quella che attualmente è
dedicata a Stefano
Rivarola) è del 16 set.1914.
Infatti nell’elenco delle strade comunali pubblicato nel 1910 vi appare
aggiunta a penna, e localizzata come ‘1a traversa a destra di via De Amicis’ (via Malinverni).
Come oggi, era quindi una traversale
a levante, di via E.DeAmicis.
Quando nel 1926 fu creata la
Grande Genova, il comune si trovò a dover ridurre le strade dedicate al
musicista: oltre al Centro, ne esisteva una a Rivarolo (passo e piazza),
Cornigliano, Pegli, Apparizione, Borzoli e SPd’Arena. La decisione fu lenta a
maturare, e così ancora nel 1933 la nostra è ancora a San Pier d’Arena, di 5.a
categoria e con due civici, collegante sempre via DeAmicis con via G.Leopardi
La lentezza della burocrazia mirata ad evitate dannosi
doppioni, raggiunse l’apice il 19 agosto 1935 quando per decreto del podestà fu
cambiata col nome attuale, assieme alle altre.
DEDICATA al musicista nato il 10
ott.1813 a Roncole, presso Busseto-Parma, da poveri contadini; e divenuto il
più grande e famoso compositore della nostra lirica.
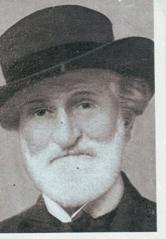
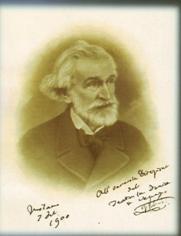
Il suo contributo all’unione nazionale, non è da legarsi alla presenza nelle
file dell’esercito o nelle battaglie, ma all’apporto psicologico enorme come
espresso nel coro del Nabucco - che infiammò le folle di tutta l’Italia,
divenendo uno dei fattori più potenti nello stimolare il desiderio di una terra
promessa, di libertà e di riscossa contro l’invasore -. VIVA VERDI era la
scritta sui muri , ovvio non cancellabile da parte della polizia, ma che in
realtà voleva significare Viva Vittorio Emanuele re d’Italia.
Lunghe e frequenti furono le
visite del maestro a Genova; se pur non amasse il mare, prediligeva venire a
svernare qui, per il clima e per la riservatezza degli abitanti; come ebbe lui
stesso a dire: “il genovese non ama esternare
clamorosamente i propri sentimenti; così ognuno è libero di lavorare senza
invadenze, con poche chiacchiere e badando ai fatti propri”.
La prima volta venne nel
gen.1841, andando ad alloggiare in un modesto albergo vicino a porta Soprana,
in una stretta viuzza del borgo Sacca, ora distrutto. Si sfamava con brodo di
trippa, reduce da un “fiasco” della sua prima opera, replicata solo sei volte
(il “Oberto, conte di san Bonifacio”) .
La capacità professionale ebbe
però il sopravvento, iniziando ad inallellare successi ed interesse. Sposatosi
con Giuseppina Strepponi fu inizialmente ospite dell’albergo Croce di Malta,
tra porta dei Vacca e Caricamento, assieme alla moglie. Poi nel mar.1867
traslocò da una iniziale residenza nel palazzo Mattei-Scudi, al piano nobile
della villa Sauli-Pallavicino in via san Giacomo, 13 a Carignano, ove si portò
ben tredici casse di mobili ed un biliardo.
Il 24 apr.1867 il sindaco
Andrea Podestà, gli conferì la cittadinanza genovese, riconosciuta in Consiglio
comunale per acclamazione.
Infastidito dal vento, dalla
salita, e dal rincaro dell’affitto, nel 1874, si ritrasferì nel palazzo Doria
in via san Benedetto, ove subì un furto che sdegnò, ma soprattutto ‘umiliò’,
la città. Qui rimase sino all’anno 1900, anche se la villa era in condizioni
scadenti, e per lui il traffico intorno sempre più caotico, il porto e la
ferrovia inquinanti. In quegli anni, il sindaco Castagnola voleva intestargli
la strada Nuovissima (attuale via Cairoli), ma lui per modestia impedì il
progetto.
Il Carlo Felice ospitò diverse “prime” (il Nabucco nel
1842; il Trovatore nel 1854; il Rigoletto nel 1852; la Traviata nel 1855;
l’Aida nel 1871), solo per citarne alcune. Ma contrasta questa retorica tesi
Claudio Tempo sul Secolo, quando scrive che il Carlo Felice non fu mai
considerato mèta della sua attività, e che dei 32 titoli verdiani, nessuno ebbe
il debutto a Genova; ed aggiunge che quando il municipio gli chiese un’opera
sul tema Cristoforo Colombo, declinò con disinvoltura l’impegno: secondo lo
scrittore la città era da lui usata quale posto per un isolamento, lontano dal
mondo musicale, ma capace di sollecitazioni creative. Infatti, da personaggio
ruvido schivo ma schietto, non amava l’adulazione, di essere al centro
dell’attenzione, le malignità del mondo artistico.
Rappresentata invece per
prima a Venezia, l’opera “Simon Boccanegra”, è praticamente ambientata in
Genova; malgrado la censura ravvisasse nel doge
dei riferimenti patriottici non graditi, lasciò andare in scena l’opera
cercando di sabotarla: infatti fu un grande insuccesso e solo dopo vent’anni, a
Genova fu ritentata una nuova versione ritoccata, ma ancora con flebile
successo e scarsità di pubblico.
Durante i soggiorni, lo
sappiamo ammirato visitatore di mostre (del Barabino); ed in piazza
Savonarola, per posare per un busto in marmo nello studio dello scultore
Saccomanno.
L’amore per Genova, è invece
sottolineato da numerosi scritti, ma soprattutto da gesti di grande generosità
a favore di istituzioni cittadine (ciechi,
asili, sordomuti, croce rossa, musicisti ammalati, ecc.), il tutto per
cifre elevatissime.
Quando nel novembre 1889 la
giunta comunale genovese progettò eseguire ricchi festeggiamenti per la
ricorrenza dei 50 anni di attività musicale del maestro, Verdi non solo bocciò
l’idea ma addirittura minacciò di non venire più a Genova se la giunta – e per
lei il sindaco Castagnola - non ritirava il progetto. Così avvenne, ed il
Comune si limitò a regalare una medaglia, che fu accettata.
Che si descriva, mai venne a
San Pier d’Arena, malgrado i suoi teatri.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda n. 4606
-AA.VV.-1886.1996 oltre un
secolo di liguria-Il SecoloXIX-pag.56
-AA.VV.-Oltre un secolo di
Liguria-1996-pag.56
-DeLandolina GC.-Sampierdarena-
Rinascenza .1922 – pag. 58
-Il Secolo XIX del 06.05.01 +
-Iovino R. -G.Verdi a Genova-La
Berio- 1/2001.pag. 39
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.17
-Pagano/1933-pag.249
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1826
-Pescio A.-I nomi delle strade di
Genova-Forni.1986-pag.168
-Sartoris L.-Verdi a Genova
1841-1901-Tolozzi ed.-
non citata sullo stradario del
Comune/35 e sul Pagano/33
VICENZA via
Vicenza
TARGHE. San Pier
d’Arena –via – Vicenza
Via – Vicenza – già via Ugo Bassi
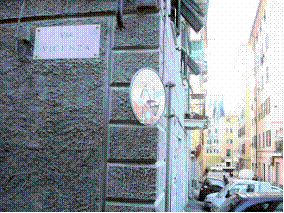

angolo con
via del Campasso
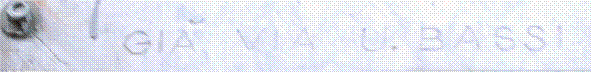



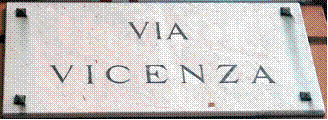
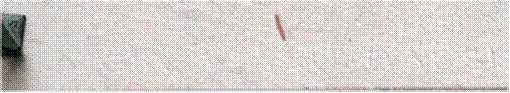
angolo nord
con via W.Fillak angolo sud
QUARTIERE
ANTICO: san Martino
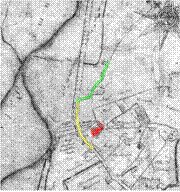 da MatteoVinzoni, 1757. In rosso l’abbazia di san Martino ed in giallo
la strada omonima.
da MatteoVinzoni, 1757. In rosso l’abbazia di san Martino ed in giallo
la strada omonima.
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2860 CATEGORIA: 3
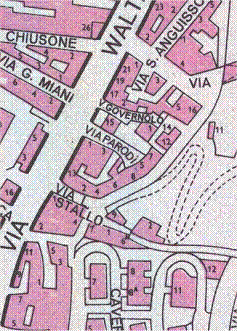 da Pagano 1967-8
da Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 64240
UNITÀ
URBANISTICA: 24 - CAMPASSO
 da Google Earth 2007.
da Google Earth 2007.
L’ombra
impedisce di vedere il tratto del sottopasso ed il terreno soprastante.
CAP: 16151
PARROCCHIA: san Gaetano- san Giovanni Bosco
STRUTTURA: senso unico viario, da via W.Fillak a via
Campasso.
Dopo poche decine di metri
di percorso, un limite viario in altezza per la presenza di un sottopasso. Ha
civici sino al 9 e 16.
È servita dall’acquedotto
DeFerrari Galliera
STORIA: per secoli
ha corrisposto allo storico inizio della strada per il Campasso; prima della
attuale apertura diretta tramite via W.Fillak.
In una carta di fine 1700, l’unica via - allora anonima - proveniente
dal centro del borgo e diretta verso il nord appare passare solo seguendo
l’itinerario dell’attuale via C.Rolando, alla cui fine piegava sovrapponendosi
a via Vicenza (entrando
dapprima nella proprietà Cicala (ove dopo pochi metri si trovava una grossa villa sotto la
quale passava la strada -come adesso- e, poco dopo in corrispondenza del
torrente proveniente da Belvedere c’era un mulino, probabile quello Tuo di vico
Governolo); per poi
entrare nei terreni del sig. Ponzio (primo tratto rettilineo di via del Campasso) seguiti da quelli del principe Santangelo (nella seconda
metà in rettilineo della stessa strada)).
Ancora agli inizi del secolo 1900, parlando di via Bezzecca, si precisò
essere “di fronte all’inizio di via Campasso”. In quegli anni le fu imposto il
nome di “via Ugo Bassi”, già via del Campasso; e poi via vecchia del Campasso.
Tale era ancora nel 1933, di 5.a categoria, quando l’attuale via del
Campasso si chiamava via Giordano Bruno.
Divenne
‘via Vicenza’ dopo delibera del podestà firmata il 19 agosto 1935, onde
evitare nomi doppi tra centro città e periferia.
Vi inizia l’erta salita GB.Millelire (a quei tempi si chiamava salita
Ugo Foscolo), ricordata come Rompicollo, che
sale sino al forte Belvedere, ora chiusa da due assurdi cancelli.
CIVICI Neri da 1
a 11 e da 2 a 16
Rossi da 1r a 17r e
da 2r a 12r
Nel
Pagano/40 via da via d.Corporazioni a v.Campasso. Segnala: neri da 1 a 7 e
2→8, con al 5 i Reali Carabinieri; rossi una osteria al 10n
Nel
Pagano/1961 si segnalano esistere: civ. 7n la fabbrica di cioccolato Melius (che io ricordo
negli anni ‘64-‘74 in via Marabotto); civ.9n soc. di trasporti f.lli Bruzzone; ===
civ.4r il carbonaio Bottura I.; civ.5r Curti, articoli casal.; al civ. 5Nr la
ALIG di lavori edili; al civ. 14r la ditta Porta E calzature.
Il
palazzo d’angolo a mare, ha la facciata con false finestre: per ogni piano, di
tre, solo quella centrale è vera, le due laterali sono chiuse.
===civ 13r Si ricorda altresì esservi stata -una delle
poche in delegazione- “casa dalle persiane chiuse”, prima che la Legge Merlin
le abrogasse il 20 settembre 1958. Valdemi ricorda che similare fosse solo in vico L.Stallo, e
sottolinea che qui ne fu solo richiesta l’apertura in un appartamento, ma fu
respinta l’autorizzazione, adibendo invece il locale a stazione dei
Carabinieri. Questa, - nell’ultimo
periodo bellico- corrispose ad una caserma della Guardia nazionale repubblicana
(GNR) fascista, ove fu rinchiuso appena arrestato il gapista Riccardo Masnata e
da dove lo stesso fu liberato il 12 giu.1944 con audace azione partigiana .
===civ.
4n e 7n Alla loro altezza, la strada sottopassa un palazzo tramite
un voltino il cui soffitto è a grosse travi di
legno, struttura antecedente all’uso del cemento armato e quindi probabilmente
ultracentenario. Anche il muro che delimita a levante la strada, appare
vecchissimo, opportunamente svasato in basso per maggiore sostegno (vedi foto sotto).
Nella carta del Vinzoni si legge
che la strada sottopassa una costruzione tipo abitativo: presumo quella che sul
Gazzettino, senza precisare a che civico, si scrive ‘alla sommità della via
esiste villa Stura’. Non è chiaro se è
questa, con il sottopasso o quella (al di là di
salita Millelire - però posizionata più in alto rispetto via Vicenza) occupata
dalla società di M.S. la cui proprietà terriera di estende verso nord est.
Se fosse quest’ultima, allora
in realtà ‘esisteva’, perché la casa (già degli
eredi Rocca, poi degli Stura ed infine dei Ravano, ed ancor ora curata da uno
dei Marchese) è stata spianata, mentre della proprietà rimangono vicino:
una casetta che ospitava i manenti e le mucche, e - poco più a nord -
l’edificio - ora in abbandono e fatiscente - per carrozze e carrozzieri rimane
un esempio di quello che sino al dopoguerra del 45, era “il mondo dei
trasporti locali”. I cavalli, e con loro i
maniscalchi, sellai, carradori erano l’indotto del traffico merci nel porto e
nelle stazioni ferroviarie. In una foto, si vede il sellaio F.Bruzzo, operante
in san Martino (non precisato) con i cavalli, la stalla, il ciottolato. Con lui
erano famosi a San Pier d’Arena i fratelli Civani e Natale Ferrando.
===civ.3
nel 1950 fu assegnato ad una porta che non aveva numero; e quello che era il 3
divenne l’attuale 5; ed il 5 divenne 13rosso.
===civ.11 la palestra del As.Buto
Ku Kai Ligurs (tel.010.415856)
===civ.12r c’è una uscita-retro del circolo Spataro che
ha ingresso in vico Stallo
===civ. 17r la palestra di karate “A.S.D. KarateTeam di Bruno
Da Boit” che è
il maestro - e la scuola è iscritta alla Fed. It. Arti Marziali del Coni: nata
nel 1973 (col nome di Butokukai con solo karate e judo), nel tempo (e così è
nel 2011) è stata ampliata la rosa di maestri per insegnare karate, kung-fu,
tai-chi, aikido, thai-boxe, difesa personale, ginnastica terza età.



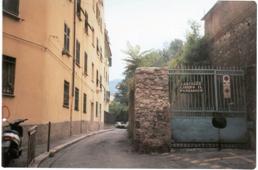


all’altezza di salita Millelire in discesa,
dal maneggio prato davanti la prima casa-maneggio
con muretto sopra lo sbocco della galleria
Dopo
il voltino, a ponente c’è una scala che scendendo, ci collega con vico Stallo;
dopo essa seguono solo ingressi di abitazioni. A levante c’è salita Millelire
con a fianco l’ingresso-cancello della villa soprastante; lungo il muraglione
una sola casa.

foto 2001 . la prima casa con stalle. A sinistra il muretto
corrisponde all’uscita della galleria.
Entrando
dal cancello (che una
volta era più arretrato di 50metri in alto, e viene ricordato che ancora più
anticamente iniziasse dalla cappelletta che è sulla strada) - dopo un
percorso a tornanti – si arriva ad uno spiazzo (ove era la villa)
e ad una casetta (foto
sopra): essa appare di più recente
costruzione - definita ex fioriera – e, nel 1999- era adibita a deposito di
materiale di un ortolano
e dove ancor ora si ospitano dei cavalli (essi –di vari proprietari- sono tenuti nella stalla, puliti, nutriti e
giornalmente portati ‘a passeggio’ nelle fasce soprastanti, a nord della salita
Millelire. Nel 2002 questo servizio è stato sospeso, ma si prevede poterlo
riattivare presto). La proprietà è
privata, e non accessibile alla gente. 
Questa
foto non appartiene a questa strada, ma non sapendo dove
erano,
è stata scelta quale esempio di maniscalchi con stalle.
La
zona è circondata da un ampio terreno verde a fasce (fa riferimento al terreno
soprastante il muraglione - a cui si appoggia la cappelletta della Madonna -
quando si è all’inizio di via Campasso; in quel punto, sopra, sbocca dalla
galleria la ferrovia che si apre al parco del Campasso
Su queste fasce avrebbe
dovuto passare, verso Certosa-Rivarolo, la prosecuzione della strada Quota 40 (che ora si interrompe davanti al cancello dell’asilo Andersen -ex
villa Currò).


la casa, abitata, sulla fascia superiore- davanti e retro


la terza casa, rudere sventrato, ex fienile facciata
a ovest
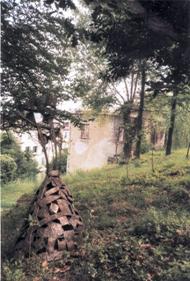

scultura metallica nel prato
DEDICATA alla città
veneta eroina del Risorgimento, il cui stemma è
crociato
come il genovese.
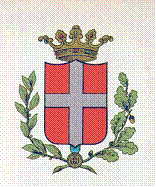
Storicamente è risaputo che alcuni vicentini, già nel
lontano finire il 1200 fossero uomini di mare e portassero navi in oriente (un
Pietro di Vicenza nel 1274 fu assalito da una galea bizantina al largo di
Yalta – allora chiamata Pagropoli - in Crimea).
La città, posta al centro di tutti i percorsi storici
dell’Italia nord orientale, dal tempo dei romani e dei veneziani fu epicentro
di commercio, di storia e di cultura.
È chiamata la ‘città del Palladio’.
Acquisì
particolare interesse, nelle guerre di insurrezione dal giogo austriaco; in
particolare nella prima guerra di Indipendenza del 1848, quando essa faceva parte del regno
Lombardo-veneto.
Nel febbraio 1848 Carlo Alberto aveva promulgato lo
Statuto, mentre anche in Francia, Germania ed Austria (13 marzo) scoppiarono
moti rivoluzionari: Milano, Venezia, Treviso ed altre città italiane ne
approfittarono, insorgendo e scacciando gli Austriaci.
Il 23 marzo iniziò la guerra contro l’Austria: era presente
anche Nino Bixio con un folto gruppo di volontari genovesi.
In
contemporanea, anche Vicenza –guidata da Valentino Pasini, membro del governo
provvisorio locale- insorse contro gli austriaci: combattendo con indomito
coraggio riuscì il 25 marzo a cacciarli dalla città. Il corpo dei volontari e
la guardia civica, armati da Venezia e Pio IX e guidati dal gen. Sanfermo si
mossero per aiutare Verona, ma a Sorio e Montebello, seppur rafforzati da
padovani e trevisani, vennero sconfitti e costretti a rientrare. La città si
preparò alla difesa –con barricate, pietre e masserizie- e chiedendo aiuto a
Carlo Alberto ed ai pontifici.
Il
20 maggio l’esercito croato iniziò l’attacco, ma dovette ritirarsi dopo cinque
ore. I vicentini ebbero 10 morti ed 80 feriti.
Il
21 arrivarono in aiuto mille uomini comandati dal gen. Antonini (con Daniele
Manin e Nicolò Tommaseo) ed il gen Durando (con 5mila svizzeri pontifici, sei
cannoni, due obici ed un gruppo di cavalleggeri). Nei due giorni successivi,
scaramucce e tiri di artiglieria preannunciarono l’attacco in forze.
Nella
notte del 23 maggio la città fu investita sia in forma diretta (verso la piazza
principale, di Castello; sia indirettamente tentando di raggirare il monte
Berico) ma la resistenza tenne, con l’appoggio di tutto il popolo, dei
volontari e dei soldati pontifici, costringendo l’austriaco a sospendere i
tentativi sino ai primi di giugno.
Ma
per poco perché il 10 giugno essi guidati dal Radetzky tornarono a circondare e
bombardare la città. Gli assalti reciproci, determinarono altrettanto
reciproche decimazioni (in una di queste battaglie, rimase ferito Massimo
D’Azeglio, partito come ufficiale), finché il 22 giugno, malgrado strenua
resistenza sul monte Berico (guidata da Massimo d’Azeglio e da Cialdini), la città fu costretta alla resa e di nuovo soggetta
all’invasore. Ciò avvenne quando il generale Durando considerò vana ogni
resistenza essendo state tutte le artiglierie ridotte al silenzio.
L’eroico
comportamento della popolazione determinò la concessione della resa con l’onore
delle armi e sufficienti buone garanzie verso la popolazione (trattarono la resa il gen. Albéri
ed il principe Ruspoli).
Attraversato il Ticino, ci fu poi la battaglia a Govèrnolo
(19 luglio 1848). Ma dopo essa, l’armistizio firmato dal generale piemontese
Salasco (che per ordine di Carlo Alberto il 4 agosto firmò a Milano la
sospensione delle ostilità con il maresciallo austriaco Hess) pose fine alle
trepide attese dei volontari.
Con
la guerra del 1866 Vicenza fu tolta
all’impero austriaco ed inserita nel regno d’Italia. A memoria del precedente
motivo eroico, il re Vittorio Emanuele II - il 19 ottobre 1866 - concesse una
medaglia d’oro al VM alla città: “Per la strenua difesa fatta dai cittadini
contro l’irruente nemico nel maggio e giugno 1848”; ed il 18 novembre
successivo, lo stesso re in piazza dei Signori, decorò personalmente la
bandiera cittadina con la suddetta medaglia.
Anche nella grande guerra del 1915-18 la
bandiera comunale fu insignita della “croce di guerra” al merito, sia italiana
che francese.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4631
-AA.VV.-Annuario
guida archidiocesi-ed.1994-pag.452; ed.2002-pag.489
-AA.VV.-Contributo
di SPd’A.alla Resistenza-PCGG.1997-pag.52
-AA.VV.-Il
lungo cammino della Libertà-Bertello 1975- pag.184
-AA.VV.-Storia
Ligure Illustrata-N.Bixio-Erga, vol. I
-Corti
M.AnnuarioLigureDelloSport-LoSprint 2008-pag..271
-Enciclopedia
Sonzogno
-Gazzettino
Sampierdarenese : 5/89.1 + 8/94.5 +
-Novella P:-Strade di
Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.19
-Pagano annuario genovese-
ed./1933-pag.244; /1961-pag.432
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1834
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova-Marsilio.1995-tav.9.10.21
-Stradario del Comune di
Genova-ediz.1953-pag.183
-Stringa P.-La
valpolcevera-Agis.1980-pag. 92carta.96carta
VINZONI via Matteo Vinzoni
TARGA:
via – Matteo Vinzoni –
ingegnere cartografo – 1690-1773
strada privata


in angolo con via G.Balbi Piovera
La targa fu posizionata nuova negli anni 2000. Prima ne
esisteva una in marmo, uguale alla attuale ma con in più la scritta in alto
“San Pier d’Arena - 2657”. Questo numero di immatricolazione era relativo
al rione di Staglieno: o fu un errore o fu riutilizzo della lastra quando –dopo
la unificazione- fu deciso dare a noi questa titolazione.
QUARTIERE ANTICO:
Promontorio
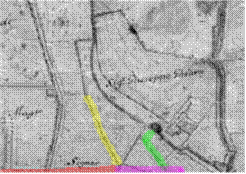 da
MVinzoni, 1757. Ipotetici tragitti: rosso, corso OScassi; fucsia, via BPiovera;
verde via MVinzoni. In verticale a destra, il torrente di san Bartolomeo
da
MVinzoni, 1757. Ipotetici tragitti: rosso, corso OScassi; fucsia, via BPiovera;
verde via MVinzoni. In verticale a destra, il torrente di san Bartolomeo
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2657 (ma scorretto, come dscritto sopra)
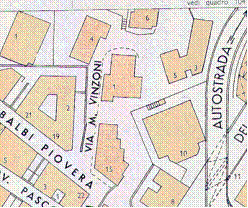 da Pagano/1961
da Pagano/1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 64800
UNITÀ
URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO
 da Google Earth 2007. In blu via BPiovera; giallo, via
MFnti; fucsia le scale che scendono in via sBdFossato.
da Google Earth 2007. In blu via BPiovera; giallo, via
MFnti; fucsia le scale che scendono in via sBdFossato.
CAP: 16149
PARROCCHIA: Cristo Re
STRUTTURA: Negli anni
del Pagano/61 esisteva da poco e non ancora completata; ma già si intravvedono
i civici dall’1 al 5 e dal 2 al 6.
Strada privata con doppio senso viario. Inizia da via
G.Balbi Piovera; in fondo è chiusa al traffico
veicolare ma si collega -tramite lunga scalinata,
che in discesa sottopassa l’autostrada- con via san Bartolomeo del Fossato.
La targa -precedente a
questa attuale plastificata- e posta negli anni 2005-6, recava scritto “San
Pier d’Arena – 2675 - via – Matteo Vinzoni – ingegnere-cartografo – 1690-1773”.
Corrisponde all’ennesimo “budello” risultante dalla
speculazione e sfruttamento dello spazio ad uso edilizio degli anni fine-post
1950 circa, senza aver conservato il minimo interesse alla viabilità ed alla
vivibilità di chi vi avrebbe abitato.
CIVICI
2007 = NERI = da 1→5 e
da 2→6
ROSSI = da 1r→21r 2r→44r (mancano 32r, 34r, 42r)
===Il civico 2, come visibile sulla carta del
Pagano, è separato dalla strada vera e propria da un largo marciapide che segue
(a V rovesciata) la separazione tra -sulla carta del Vinzoni- i terreni di
Ghiara e quelli del duca Spinola.
STORIA: Nella carta
del Vinzoni del 1757, i terreni - con villa - appaiono occupati dalla proprietà
del “sig.r Giuseppe Ghiara”; essa era
accessibile solo dal basso, da via sBartolomeo dF (vedi). Questa proprietà risulta
–sempre nella carta settecentesca- sottostante a quelli dell’”ecc.mo
Marcello Durazzi q. GioLuca”; ambedue tagliati a metà da un torrente
(Carbonara) proveniente da Promontorio e defluente nel Fossato, in un
avvallamento alla sommità dei lati –a ponente- era la salita Imperiale (oggi via Derchi); ed a levante era
una salita anonima –oggi D.Conte-. Quindi una proprietà estesa dal torrente
sottostante a via BPiovera e via Fanti.
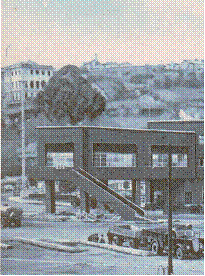

presumo questa sia la villa Ghiara 1926 – villa con le
suore e proprietà fino a sBdF
La
strada Balbi Piovera fu aperta per costruire l’ospedale. Quindi fu solo negli
anni 1910-15 che, aperta questa via, si poté usufruire di essa, forse più
comoda per l’accesso dalla parte superiore; al punto che con l’edificazione in
basso, divenne poi la più usata via di accesso alla villa Ghiara.
A
lungo, negli anni 1920-30 la villa fu ‘collegio-educandato delle suore Figlie di sant’Anna’ istituite da suor
MB Gattorno nella seconda metà del 1800, e che poi si traferirono nella villa
di via Currò (vedi a
via S.B.dFossato).
Nel gennaio1959 la delibera del Consiglio comunale
decise il nome per questo tratto di strada in cui esistevano già tre palazzi
con i civ. 15A, 15B, 15C di via Balbi Piovera. Ad aprile divennero i civv. 1,
2, 6 della nuova via. Invece i civv. 3 e 5 furono eretti dopo, nuovi nel
1959; il civ. 4 nel 1963.
DEDICATA al
cartografo nato a Levanto il 6 dic. 1690.
Famiglia Un Antonio, fu il capostipite (il primo oggi conosciuto della discendenza,
residente nella frazione di Bonassola chiamata Montaretto; nobile, risultando
la famiglia ascritta nel ‘Libro d’oro’ della nobiltà di Sarzana). Suo figlio GioFrancesco (nonno di Matteo, fu colonnello della
piazza militare di Sarzana nel 1648; scrisse un manoscritto sulle qualità da
osservarsi nei reggimenti italiani. Ovviamente fu il padre del capitano delle
milizie locali (stipendiato da Levanto) ingegner Panfilio Antonio Francesco. Questi, a sua
volta, generò due figli: uno GioTommaso (‘uomo di singolare virtù’: così appare sulla
epigrafe dettata dal fratello e scolpita su una lapide sepolcrale nella chiesa
dell’Annunziata a Levanto; fu protonotaro apostolico; divenne anche lui
colonnello; sostituì il fratello in alcuni rilievi in Val di Vara.) ed il nostro Matteo.
Matteo, sposando una Gentile (figlia di un ufficiale della
Repubblica, probabilmente corso) divenne padre di 5 figli: Panfilio (Levanto
25/12/1730-Levanto 13/04/1790. Chiamato jr. fu
l’ultimo dei cartografi. Iniziò con la trasferta a Nizza -1748- per la pace di
Aquisgrana, divenendo capitano-ingegnere nel 1755; maggiore nel 1769 cartografo
militare come la discendenza; collaboratore del padre, seguendolo costantemente
attraverso il territorio della Serenissima dipendendo dalla ‘Giunta dei
Confini’. Morì celibe);
Gio.Francesco (notaio,
divenne saltuario collaboratore del padre e preferì seguire l’arte della
cartografia); altre tre
figliole (tutte
divenute monache tra le quali Maria Rosa futura suor RosaCeleste nel convento
di Sarzana, le altre due nel monastero di s.Chiara).
Quindi, nipote, figlio e padre di militari, divenne
pure lui colonnello della Serenissima Repubblica Genovese, su tutti
qualificandosi il più bravo, famoso ed efficiente nel produrre carte
topografiche ricche di informazioni, precise e dettagliate, avvantaggiato solo
dalla vocazione naturale al disegno, dal carattere meticoloso, dall’esigenza
politica di simili opere in un’epoca in cui non era ancora uso definire e quindi
raffigurare in forma precisa i terreni, le località e le proprietà.
Già da secoli prima
della sua nascita, le continue invasioni oltregiogo di terreni normalmente
curati da Genova per il commercio con l’interno cittadino e della riviera di
ponente (comprendenti Novi, Alessandria, Monferrato, ed entroterra di Albenga)
-soprattutto espansionistici da parte dei Savoia-, più volte avevano imposto
conoscere “il mio dal loro”, e sapere quando spendere per andare a proteggere i
confini.
Ma molto più pressante
e prioritaria, a partire dagli inizi del 1600, fu la decisione di definire i
confini in rapporto a notizie che arrivavano -sempre più allarmanti- di
infezioni di peste; -di cui la più grave e di manzoniana memoria- del milanese
nel 1630.
Era ovvio che le mura,
appena ultimate, non bastavano di fronte a quel nemico.
Così, già nel 1643 il governo della Repubblica deliberò
una sistematica rilevazione del territorio dello stato, specie dei confini, con
prevalentemente fine di porre necessarie misure di difesa contro la peste; allo
scopo, creare punti di rilievo -oggi diremmo epidemiologici-. Nel 1656-7, il
lavoro era quasi pressoché ultimanto - mancando solo l’estremità della riviera
di levante- quando la violenta epidemia che sconvolse Genova, interruppe questo
programma di rilevazioni, bloccandolo quando era -per poco- incompleto.
Agli inizi del 1700, lo Stato riebbe necessità di
autocensirsi anche per riuscire a governare politicamente, destreggiandosi tra
le pressioni e le controversie di confine da parte dei vicini: Piemonte,
Asburgo, Borboni, Francesi; e non ultimo dalle ribellioni interne. Quindi dopo
aver tentato di farsi servire da architetti occasionali, ma con risultati non
fedeli né interessati alla sicurezza nazionale, apparve opportuno istituire una
scuola specifica, definita “corpo degli architetti-ingegneri militari
genovesi”.
Sono del 1707 i primi
segni della mano autodidatta del Vinzoni, inserita a relazione soprattutto
negli scritti del padre, relatvi a territorio del capitaneato di Levanto e di
alcune vertenze con le confinanti Parma e granducato di Toscana (sui confini con il ducato di Toscana, dovette recarsi
con 12 soldati ad ‘atterrar muraglia’ eretta in terra ligure e contesa ai
genovesi: ovviamente fu bandito dal Gran Duca.
Sono del 1709 le prime
vedute panoramiche giovanili di Matteo nei disegni paterni della Lunigiana.
Sempre sotto la guida del padre, è del 1711 il primo disegno con la sua firma “Matteo Vinzoni
Stipendiato”, primo scalino della carriera al servizio della Repubblica, l’ufficio
della ‘Giunta dei Confini’ ove vengono tracciati i confini di Zignago,
Brugnato, Suvero e Rocchetta;
Seguono -sicure altre due missioni ‘da solo’- che
forse servirono a candidarsi ad accedere alla professione -1712. Di esse, una nella val Trebbia dove, dal monte
Alfeo disegnò nella valle i corsi d’acqua, le vette e le pendici, ponendo
istintivamente da solo la base della rappresentazione zenitale del rilievo.
Questi lavori nel 1715 lo
fecero ammettere alla scuola di Architettura Militare della Repubblica. È di questo anno la delibera del Senato di
aumentargli lo stipendio e la concessione di ‘potersi assentare da Levanto per
6 mesi al fine di poter frequentare la scuola di Architettura militare’ tenuta
in Genova dall’ing. Giovanni Bassignani (eccellente
ingegnere già al servizio di Venezia e dell’Austria, e-in quegli anni- di
Genova; più volte onorato ed elogiato dal Vinzoni stesso; il Ratti ne fece
sperticato elogio) e dal sotto-ing. Gastone DeLanglade, ove iniziò a
fare severo tirocinio per imparare a usare gli strumenti topografici e come accertare
i confini delle varie terre, per sapere poi come difenderli: “conoscere per
governare”.
Nel 1719 fu inviato in Corsica, ove la scuola (agli inizi come struttura scolastica
vera e propria, ma già ben definita come carriera: da sottoingenere, a
ingegnere, parallela al grado militare che –come detto sopra, da stipendiato-
permetterà diventare capitano, colonnello, brigadiere) possedeva una importante sede idonea a completare
il tirocinio (tra
l’altro imparare le nuovissime tecniche di offesa e difesa, per sapere come
armare una fortezza , anche senza la necessaria esperienza sul luogo di una
campagna militare, giudicata sino ad allora insostituibile) ed imparare a tradurre la visione pittorica del
terreno in quella cartografica dall’alto (da una altitudine a quei tempi inimmaginabile): usando opportuni strumenti come astrolabio,
lancette, catene, associati a calcoli geometrici (angoli, distanze, livelli) si creava una proiezione verticale che solo con
l’invenzione delle curve di livello (in Liguria, nel periodo napoleonico da cartografi francesi) raggiungerà i migliori risultati.
Nel 1720 di fronte all’improvviso pericolo di
una ennesima epidemia (con
focolaio a Marsiglia; si era sviluppato quell’anno nella città francese ed il
cui focolaio durò due anni, dopo l’attracco di una nave infetta proveniente
dalla Siria, e che per fortuna non aveva potuto fermarsi nel nostro porto causa
un forte vento contrario), il governo
affidò al Vinzoni di stilare un “Atlante della Sanità” ovvero ‘pianta
delle due riviere della serenissima Repubblica di Genova’ divise ne’ Commissariati
di sanità’ necessari per porre le basi di una
seria organizzazione dei servizi di guardia, da Ventimiglia a La Spezia, con
vigilanza diurna e notturna su tutta la costa, onde impedire qualsiasi furtivo
accesso (da sanitario lo scopo poteva sconfinare col commerciale e militare
antipirateria).
32enne, iniziò il lavoro il 27 sett.1722. Con la
nomina iniziale (già
ottenuta nel 1721) di “capitano e
sotto-ingegnere”, con sede di riferimento a Levanto, imbarcato su una nave
della repubblica assieme a due aiutanti (GioBattista Mussa e Antonio
DellePiane) ed un servitore, fu costretto ad inventare il modo migliore per
soddisfare le esigenze del committente. Partendo da ponente, vi riportò tutti i
paesi disseminati sulla riviera, con relazione delle ‘casette di sanità’, corpi
di guardia con collocazione, percorso notturno e diurno e numero degli uomini e
graduati. Ogni località richiese il suo tempo: ad Arenzano ristette dal 16 al
19 dicembre; il 2 gennaio fu a San Pier d’Arena;
il 13 aprile ripartì per la riviera di levante. In capo a sei mesi, a fine
primavera del 1723, un po’ a cavallo, un po’ in
barca, finì l’incarico che forse è il suo capolavoro.
Nella decade successiva, fu inviato a porre
in chiaro facendone relazione, una controversia della Selva di Pertegara; e poi
e poi ancora i confini di Rezzo col re di Sardegna (rappresentato
da un suo pari ingegnere, Francesco Gallo il quale, nella controversia fece
intervenire l’infegnere del re di Francia Francesco De La Naverre Fleurigny,
con ovvie ‘grane’ di carattere internazionale).
Ma
la rilevazione cartografica – specie dell’interno - richiese oltre una trentina
di anni prima di assumere una veste presentabile ed essere consegnata (la conoscenza dei confini non era
quasi mai uniforme e necessitava interrrogare pastori, mulattieri, legnaioli
locali, non sempre sinceri o concordi, per includere o escludere punti fisici
del terreno a loro volta spesso mutevoli –come alberi, sentieri, dirupi e
pietre- soprattutto perché interrotto da continui invii nei più disparati posti
e missioni alcune delle quali richiesero anche sei sette anni per essere risolte:
“riesce di somma premura che senza ritardo vi portiate alla presente città
...onde, al ricevere della presente che vi mandiamo per espresso, doverete
(sic) partire per mare o per terra a questa volta”; ma anche perché se la vita
all’aperto giovò senz’altro alla sua salute, malattie varie lo afflissero più
volte tra cui una persistente sciatica (‘dolorosa flussione di nervi gelati
nella gamba sinistra, malanno riportato per i lavori stradali
Novi-Alessandria’); ambedue i motivi, gli concessero giustificarsi più volte
nell’andare a relazionare in città il suo lavoro). Quindi, è datato 3 marzo 1759 un decreto relativo:
“Fu proibito che il presente tipo delle Due Riviere potesse uscire dalla
cancelleria né essere mostrato ad alcuno fuorché ai soggetti del magistrato”.
Negli anni 1733 era in perlustrazione e per
descrizione particolareggiata (confini misurati geometricamente, boschi e corso
di torrenti, paesi misurati casa per casa a Cosio, Mendatica e Montegrosso; poi
nel territorio di Seborga (allora, Seborca), di Pietra, di Busalla ed Isola, di
Moneglia, fino a Zeri.
Nel marzo 1745 tutte le carte (escluso SanRemo e
Riva) furono consegnate; e già dalle prime rilevazioni, il governo aveva
recepito l’interesse che sconfinando dall’iniziale proponimento sanitario,
comprendeva il politico-militare, di assai maggiore interesse: dal Magistrato
le carte verranno subito chiuse nella Cancelleria, con il veto della
consultazione se non autorizzati direttamente dal Senato.
Il
Nostro dovette ripetutamente percorrere le due riviere, affrontare problemi di
alloggio, trasporto, alimentazione, rifornimenti, rapporti sociali con i nobili
locali non sempre disponibili, per raccogliere le informazioni e le misure più
varie sul terreno e sul popolo, affrontando le difficoltà più varie (andando a ledere gli interessi di
molti, come il diritto di pascolo, di taglio dei boschi, di portata delle acque
e fonti; odi campanilistici; false informazioni; paure più o meno motivate di
tasse o controlli); più volte fu
aggredito e minacciato con le armi; arrivò ad essere arrestato o coinvolto in
sommosse popolari (come
nel 1746 catturato dalle truppe austriache e
tradotto nel castello a Milano; ritornerà dopo l’episodio del Balilla e
la cacciata per volontà autonoma del popolo; in questo frangente scrisse dei
sonetti inneggianti Genova ed il suo amore per essa.
E poi a San Remo quando fu fatto prigioniero da
popolani sollevati –leggi sotto-).
Quando
arrivava in una località, munito di speciale mandato del Senato, entrava negli
archivi parrocchiali e signorili, esaminava, controllava e trascriveva
pignolescamente per intero ampi documenti; interrogava i vecchi del paese;
ordinava contradditori; misurava e disegnava le piante su più scale; valutava i
reali confini minacciato anche fisicamente dai vari proprietari (anche lo stato piemontese lo inquisì
e minacciò ripetutamente di arrestarlo accusandolo di aver detratto varie
miglia di suo territorio)
Nelle pagine riguardanti il “Commissariato di San Pier d’Arena”, comprendente anche Cornigliano,
descrive che la guardia si svolgeva per “due miglia e mezza circa” di spiaggia
(“dallo scoglio Garanga, al Rastello della Torre di Capo di Faro detta la
Lanterna”). Descrive dove sono le casette (in legno sulla riva , o in
“matteria” tutte le altre); per alloggiare le guardie (da una a cinque,
giorno e notte) preposte alle ronde di controllo della spiaggia (il “Rondino”
gira tutta la notte e visita tutti i posti fissi ove tre militi stanno a
riposo e a turno due stanno in servizio): 40 soldati ogni giorno, tra 1944
militi e 757 scelti nel Commissariato, forniti sia dagli otto quartieri (per
la militanza: Coscia, Crosa Larga, Cella, Bovi, Cinixiano, Ponte, san Martino,
Mercato; per gli scelti: Coscia, Borcagero, Comixiano, Ponte, Mercato) che dalle
altre “ville” quali Promontorio, Gagliano, Rivarolo, Garbo, Teglia, Morta,
Trasta, Livellato, sino a Pontedecimo.
Nel 1748 in concomitanza della sua presenza ad
un convegno a Nizza ove era stato convocato per il trattato di Acquisgrana, ebbe
commissioni di lavoro per privati, non sappiamo sino a che punto fuori dalla
committente governativa istituzionale; così lo sappiamo produrre lavori anche
per i Brignole, nel territorio di Albenga, nei feudi a confine tra Genova e
Piemonte e per nobili famiglie di Sanremo (giugno 1753)
A SanRemo fu partecipe di un grave fatto, durato 12 giorni,
narrato su un opuscolo manoscritto anonimo: La borgata di Colla (Col di Rodi,
nds) chiese al Serenissimo trono la separazione dalla Comunità di S.Remo; ed
il Governo inviò là il Vinzoni -6 giugno- per segnare i confini tra i due
paesi. Ciò irritò i sanremaschi i quali, dopo inconcludenti trattative col
Commissario Generale GM Doria, insorsero facendo prigioniero tutto il corpo di
guardia, il Doria, il Vinzoni ed altri Ufficiali; e fu tale il risentimento
contro la Repubblica, che il giorno dopo furono inviati quattro deputati a
Torino per offrire la loro sottomissione e vassallaggio al re di Sardegna. Dopo
pochi giorni comparve all’orizzone una piccola flotta genovese inviata per
ristabilire l’ordine; ma a quella vista il popolo si agitò di più
impadronendosi dei prigionieri e minacciando giustizia sommaria. Le donne in
particolare sembravano furie; tutte le parole più triviali, tutte le più
sanguinose ingiurie uscirono dalle bocche contro quei disgraziati che “in veste
da camera e pianelle” furono costretti ad attraversare la città tra due ali
fitte di popolo minaccioso ed armato di archibugi. Il Cancelliere Bassi, in
ginocchio e tremebondo domandò perdono in cambio della vita; solo il Vinzoni
procedette con la massima tranquillità, indifferente, dando così prova di
grande coraggio; ebbe anzi a scherzare invitando a ritardare un pochino perché
l’oste non gli aveva ancora offerto la cena. I marinai genovesi sbarcati dalle
navi riuscirono a riportare la calma cosicché dopo trattativa durata tre
giorni i prigionieri furono liberati (il 17 giugno) ed il Vinzoni potè
proseguire la pianta di Sanremo ed iniziare i disegni di un nuovo forte che
avrebbe dovuto stroncare nel popolo ogni velleità di ribellione.
Sempre nel 1753 (Quaini scrive che le due carte -2,5x1,8- sono datate
1748) ebbe incarico dal duca di
Richelieu (supremo
comandante delle truppe di Francia e Spagna al soccorso di Genova durante la
guerra di successione austriaca. Il suo nome per esteso, era: s.e. sig. Luiggi
Armando Duplessis, duca di Richelieu e di Fronsac, pari di Francia,...ed altri
sei-sette titoli) di stilare una carta
riportante le due riviere e tutti gli stati confinanti con la Repubblica; in
due grandi fogli, in totale 5m x 1,85, eseguì il lavoro che però non soddisfece
il duca anche se offriva una visione panoramica generale, con tanti particolari
artistici e geografici. Ne nacque un contenzioso che il Vinzoni risolvette
proponendo la “Pianta delle due Riviere...”, nel 1763 (Quaini scrive nel 1755) questa carta, perfezionata (ricca di tutte le città, i paesi con
castelli, villaggi e luoghi insigni, porti, golfi, spiagge, promontori ed
isole, fiumi e vie di transito, divisioni in Governo, commissariati,
capitanati, podesterie) al governo
genovese sempre in allerta per le controversie di confine. La carta però è oggi
andata perduta; ma allora, per essa, gli fu aumentata la paga e fu promosso
brigadiere, arrivando così al vertice dell’organico nel corpo divenuto “degli
ufficiali ingegneri”..
Nel 1757 aveva lavorato col francese Flobert
alla fortificazione di Vado; ma sicuramente negli anni aveva contattato con
reciproco scambio di esperienze, colleghi francesi (di diversa e progredita scuola, specie
nella tecnica del rilievo e nell’uso del colore fino alla policromia) o toscani (più rigorosi nei rapporti matematici).
Porta
questa data la grande “Pianta del borgo di San Pier d’Arena”, di grosse
dimensioni essendo di 2m²; molto intreressante perché vi sono minuziosamente
segnati le strade, i palazzi con i confini di proprietà, ma soprattutto i
torrentelli e corsi d’acqua (allora definiti “acquedotti”).

Nel
1767 si ritirò a Levanto, ma dovette
interrompere perché richiamato ad eseguire l’opera sottostante. Il minore
impegno però gli permise scrivere un “libro indicativo” con dettagliati tutti i
paesi della Repubblica (con vescovi, parrocchie, chiese, oratori, conventi) che
venne pubblicato con la dedica al Serenissimo Doge Marcello Durazzo e nel quale
è scritto che tre anni prima aveva stilato due carte del dominio della
terraferma (che non sono mai state trovate).
Nel
1773 ai primi di agosto firmò l’atlante “Jl
Dominio della Serenissima Repubblica de Genova in terraferma”; col
dettaglio della pacifica rappresentazione di tutti i confini (descritti senza l’incubo della
contestazione), strade (senza l’impegno degli interessi e
spazi doganali delle varie comunità),
diocesi, chiese, proprietà anche private.
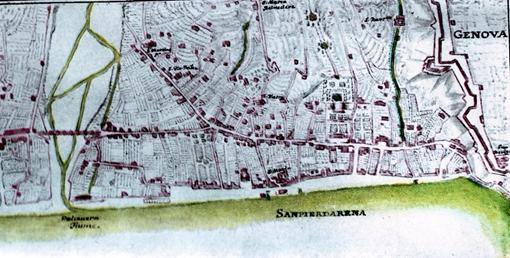
da “jl dominio della serenissima repubblica de Genoca – in
terraferma”
Ma
l’opera era ancora incompleta, e dieci giorni dopo morì lasciando il
completamento a Panfilio (che
probabilmente lo consegnò a Giacomo Brusco. Anche Panfilo morì a Levanto, a 64
anni, nel 1790). Il
borgo di San Pier d’Arena, sottoposto allora al
“governo di Rivarolo, ossia della Polcevera” è detto “valle amenissima per la
bellezza, e sontuosità degli Edificj, e Giardini, che vi si vedono, e
particolarm.te in Sanpierdarena, che non ve ne sono pari in Europa” e “al
Lido del Mare, che contiene più d’un miglio di spiaggia comodissima al varar
delle Navi. I cavaglieri, e Cittadini di Genova vi anno inalzato insino al
Colle un numero grande di superbi Palazzi con i loro deliziosi Giardini per
passarvi i più belli giorni dell’estate, e dell’autonno”.
In particolare la “pieve di Sanpierdarena viene distinta in
3 Quartieri cioè Della Pieve, Mercato e Capo di Faro”.
Tutti gli appunti presi in questo lungo e particolareggiato
(misurato palmo a palmo) viaggio, dovevano costituire un libro in tre tomi: il
manoscritto fu affidato all’avv.Enrico Bixio, nipote del Brusco
Negli ultimi anni aveva iniziato la collaborazione con
Panfilio jr, il quale ereditò quest’ultima opera ancora incompleta e che poi,
consegnerà definita a Giacomo Brusco. Il tratto pittorico di jr si evidenzia da
quello del padre nell’adottare con maggiore spontaneità le nuove tecniche
policromiche del colore.
Morì
a Levanto, 82enne, il 12 ago.1773 (Roggero scrive 10 agosto). Fu sepolto nella parrocchiale di s.Andrea, ove esiste
l’epigrafe scritta e fatta incidere dal cartografo stesso.
L’epigrafe scritta per la cacciata del Balilla è: «D.O.M.
- Germanica Natione Pressus - Sub Marchione Botta - Popolus Genuensis -
Æxtro Patriæ Libertatis Ebrius - Nullo Duce - Ducente Deo - Virginisque
Mariæ nomine invocato - Die Decima Decembris - Deiparæ Laurentanæ Sacrata
- Hostes ad Portas Occidentales - Multiplici Propugnaculo Stipatas - Igne,
Ferro, Cede, Captivitate - Terruit, Vicit, Dispersit, Fugavit --- Anno
Domini 1746.
Tutti
i carteggi e oltre 200 mappe, divennero proprietà dell’Archivio della
Repubblica. Alcune carte furono cedute alla biblioteca Berio.
All’Archivio
di Stato di Genova i
documenti giunsero per ingiunzione e requisizione da parte del Senato della
Repubblica, avvenuta nel 1755, valutando tutto di valore insostituibile per la
sicurezza e gli interessi dello Stato. Questa decisione non era stata gradita
da Matteo Vinzoni, giundicandola ‘mancanza di fiducia’ nei suoi confronti; ma
da buon militare, obbedì. Il figlio Panfilo consegnò alla morte del padre, il
rimanente della attività paterna. Gio Francesco consegnò invece tutto il
materiale del fratello -alla sua morte- a Giacomo Brusco). É dedicato a questi
documenti un intero fondo (’file Vinzoni’) costituito da 15 faldoni o filze,
numerati dal n° 99 al 114 contenenti in tutto 90 buste con relativi
manoscritti di tutti gli appunti ed il diario che redigeva nei vari viaggi (le
annotazioni per la “pianta di tutti li palazzi, case, ville e acquedotti di
Sampierdarena” del 1757, sono reperibili nel faldone 103-busta 1; e 111-busta
45).
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri
F.-Notizie dei professori del disegno...-Sambolino 1864-v.I-p.94
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica, scheda n. 4667
-AA.VV-Annuario
guida archidiocesi-/94-pag.453--/02-pag.489
-Bitossi
C.-Personale e strutture dell’ammin.-SocLiStPat.1987-pag.202
-Cerisola
N.-MVinzoni-su mensile Liguria n.4/1985-pag.3
-Comunità
diocesana-settimanale-Febb.1999.15
-DeNegri
TO- M.Vinzoni-La Casana, CassaRisp.Ge&Im-n°4/1971-pag.17
-Genova,
rivista municipale–M.V.-contributo alla storia...-dic./32.pag.1165
-Grendi
E.-la pratica dei confini fra comunità...-SocLiStPat.1987-pag139
-Lamponi
M. –Sampierdarena – Libro Più.2002- pag. 208
-Levrero
U-rivista assoc. A Compagna febbr/1931-pag.10
-Pagano
1933-pag. 722---/1961-pag. 437
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1845
-Poleggi
E -Iconografia di Genova- Sagep-1977 pag.202
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35
-Quaini
M.-Studi in memoria di T.O. DeNegri-Stringa.1986.III-pag.85
-Quaini
M.-per la storia della cartografia...-SocLiStPatr.1984 –pag217
-Quaini
M.& Rossi L.-Cartografi in Liguria-Brigati.2007-pag.135
-Roggero
G.-In cammino da duemila anni--- .1999-
-Vinzoni
M.-Pianta delle due riviere-Quaini-Sagep 1983.pag.84
-Vinzoni
M -Il dominio della Serenissima...-per CIELI-1955.carta 51.59
non
citato da Enciclopedia Motta + E.Sonzogno + E.Utet + Novella
VISTA strada
N.S. della Vista
È citata solo da Favretto e da
Tuvo. Il primo la riferisce in corrispondenza di via
G.D.Cassini e più precisamente, in considerazione della sua ubicazione e
dell’epoca anteriore alla erezione della attuale chiesa, in via Dottesio: a cui
si rimanda.
Il secondo autore solo la cita, avendola
trovata descritta in un documento dell’Archivio: prima, tra le strade comunali
(quindi un documento comunale relativo al censimento del 1819: in cattivo
stato) e poi in altro similare documento, tra le strade vicinali del borgo nel
1824, lunga 150 m.
Allora, essendo posizionata a
partire da poco a ponente della villa Spinola, potrebbe essere quella strada
che nella carta del Vinzoni del 1757 viene chiamata “strasetta Stretta” (in
contrapposizione dalla Strada Larga, posta più a ponente). Sappiamo infatti
che a ponente della villa c’era la chiesetta di
NS della Vista, descritta in via L.Dottesio.
BIBLIOGRAFIA
-Favretto G.-Sampierdarena
1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.165
-Tuvo T.—memorie storiche di
SanPierd’Arena-dattiloscr.inedito-pag. 87.107
VITTORIO piazza
Vittorio Emanuele II
Solo una cartolina, viaggiata nel 1923, cita questa piazza,
che oggi è piazza R. Masnata.
Pone questo nome come ad indicare che via UmbertoI iniziava
da lì; invece sappiamo che fin dalla prima titolazione iniziava da piazza Nicolò
Montano.
Quindi, è proprio una libera e fasulla interpretazione del
fotografo e tipografo.
VITTORIO via Vittorio Emanuele
una via con questa titolazione, in coda ad altre dedicate a
Vittorio Emanuele II (a GenovaCentro) e III (galleria in Centro), è citata
solo nel Pagano/1940. Delimitata ”da p.za N.Barabino a Largo Lanterna
(proprietà del Consorzio del Porto”.
Senza civici né altre indicazioni.
Ritengo sia un errore del compilatore del volume.
BIBLIOGRAFIA
-Pagano/40 – pag. 441
VITTORIO via Vittorio Emanuele II
LA
STRADA Era da poco finita nel sangue la repressione della rivolta
genovese contro i Savoia, nel 1849. Ai fautori monarchici genovesi, messi a
governare città e comuni attorno, presumibilmente seppur angosciati dal
comportamento di ‘loro altezze’, incombeva la necessità di ricucire gli strappi
cercando di rivalutare le figure dei reali invisi per le scelte fatte e le
parole dette; dovettero studiare come cercare di rendere facile nominare il
proprio re senza aggiungere improperi o peggio. Così, dare un nome ad una
strada importante, sopperiva a tutte queste necessità: ossequiare il potente e
farlo nominare ripetutamente senza irriverenza. Lui, ancora vivente (cosa che oggi è impossibile considerato che la prassi
vuole che siano passati almeno dieci anni dalla scomparsa della persona
promossa alla titolazione).
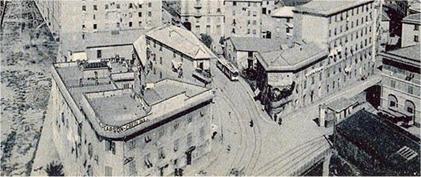
dove,
al centro è un tram: ha appena superato
Largo
Lanterna ed inizia via Vittorio Emanuele. Verso destra, via de Marini; a
sinistra in verticale, diverrà via Pietro Chiesa e porta alla galleria
Romairone.

la
lapide era affissa sotto la targa stradale, appena suoperato l’angolo della
casa con il terrazzo a forma di prua di nave

dove
a destra si vedono degli alberi, è Largo Lanterna. A destra la nostra strada
con sotto, alla sinistra, la linea ferroviaria che passava a piano terra
traversando via Balleydier e, in fondo entrava in galleria sotto le case, per
sbucare dove ci sono gli alberi più a destra.

ai
piedi della facciata più scura al centro della foto iniziava, da Largo
Lanterna, la via in oggetto; scorreva ai piedi della facciata biancastra verso
ponente. Foto 1980

La
foto è stata scattata dall’elicoidale nel 1999.
Mostra
la nostra strada, all’atto della demolizione delle case di via De Marini;
Le
ruspe sono proprio all’inizio strada; a destra la casa che nella foto
precedente ha la facciata biancastra; i tre vigili sono al limite di dove la
strada era stata tagliata sopra via Balleydier
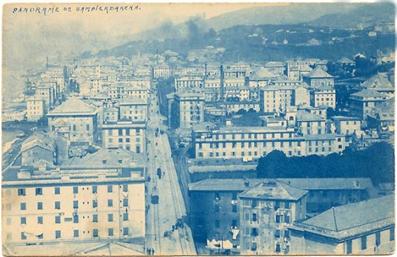

nell’angolo
destro-basso i tetti di via DeMarini (dal Toro); attuale via
G.Buranello, allora via
a
metà a sin. la villa Gardino: tutte le case da essa in giù, Vittorio
Emanuele
non
esistono più.
La strada era nata come parallela
a mare al lungo tracciato della ferrovia negli anni tra il 1850-4 (a scapito ed invasione dei giardini ed orti di tutte
le ville patrizie posti sul tracciato; dietro ordine di sequestro obbligato dei
terreni per ragioni di pubblica utilità; in ossequio alla casa reale torinese e
nel tentativo di instaurare un rapporto di dipendenza nella cittadinanza avendo
da poco Genova perduto l’autonomia repubblicana); la titolazione – probabilmente
per accordo tra i vari comuni confinanti - fu estesa a tutto il nuovo tracciato
che da Largo Lanterna portava a Rivarolo; dalla Lanterna a quella oggi piazza
N.Barabino, il percorso era tra giardini e case; poi sino a Rivarolo pressoché
tutto fiancheggiato dalla strada ferrata, e prima non esistente (sino ad allora il traffico da e per Genova, avveniva
usando – dopo il taglio dalla Lanterna - o l’antichissima via De Marini o la
regia strada della Marina).


allargamento
tunnel da piazza Omnibus foto 1910
Il regio decreto del 22 magg.1857
riconosce una “strada nuova provinciale”, chiamata via Vittorio Emanuele, che
dalle porte della città di Genova, arrivava oltre il confine sullo stradone
Palmetta (occorre una precisazione, meglio
descritta ai ‘confini’: Genova città, pur restando al di qua della collina di
san Benigno, considerava suo territorio la strada che dalla Porta della
Lanterna scendeva sino alla Coscia, ovvero sino alla piazzetta –poi chiamata
Largo Lanterna, ove fu fatto porre il casotto del dazio, dove fu aperto poi il
tunnel del tram e da dove iniziava questa nuova strada). Così si comprende la
definizione ‘dalle porte della città di Genova’: in realtà da Largo Lanterna. Da
qui, proseguiva parallela al mare per quella strada che poi, spezzettata,
diverrà via Chiusa, via
G.Buranello, via P.Reti, via W.Fillak).


foto
di fine 1800
INSEDIAMENTI
Ai lati del suo lungo percorso, sorsero case abitative, magazzini, e qualche
industria di media grandezza. A dimostrazione che fu presto circondata da
case che sorsero come funghi avendo messo in condizione di lottizzare tutti i
giardini ed orti che essa aveva tagliato, si porta che la lunga strada fu sede
di ben 15 decessi a domicilio (su 68 in totale), citati in una statistica dei
morti di colera nel periodo 7 agosto-7 ottobre 1867.
Degli opifici invece, molti
famosi fanno inizio in questa seconda metà del 1800, e proseguiti poi nel 1900:
====
lo stabilimento dell’ing. TORRIANI. L’officina, nata in quegli anni, occupò parte dei
giardini della soprastante villa Spinola (di via A.Saffi, oggi via C.Rolando) ormai soggetti a lottizzazione. A fianco c’era
un’altra fonderia, degli Storace-Roncallo (i
quali vennero dopo ed erano più piccoli; erano posizionati presumo a levante
del Torriani perché in via UmbertoI non sono segnalati; e perché -quando
cedettero all’UITE il terreno, forse trasferendosi in via Armitrotti- permisero
all’azienda del tram ‘sbucare’ in via A.Saffi).
Risulta
fornitore tra l’altro al CAP di tettoie metalliche per calata Zingari nel
periodo 1894-9.
Nel
1901, sulla strada già c’era il tram, al
civico 7-8 e Torriani al 9: quindi quest’ultimo era a nord (più vicino ai
giardini) rispetto la prima sede del deposito, comunque oggi facilmente
localizzabile dagli anelli infissi nel muraglione del treno, ove venivano
attaccati gli animali da tiro che trasportavano il materiale della fonderia. Una
cartolina postale (sotto) con prezzi in offerta (per apparecchi divisori per
fresatrice) datata 1 ottobre 1920, firmata “Ing D. Torriani & C. in
Liquidazione”.

Cessò
la sua attività -cedendo l’area all’UITE- poco prima del 1930 in seguito alla morte del titolare (il quale
possedeva una ‘filiale’ in via san Fermo –vedi, località di san Martino del
Campasso- la quale invece riuscì a sopravvivere ancora per vent’anni circa).
Tuvo
segnala -foto 5.16, alla Marina, in corrispondenza dell’attuale civico 95 di
via SPdA, a ovest del palazzo del Sale- il cantiere navale del Torriani (appare
una baracca-tettoia messa perpendicolare al mare, con sulla spiaggia una alta
gru (come poteva essere a quei tempi, fatta di 4 assi appoggiati al vertice, e
sotto una barca in costruzione. Probabilmente non fu ‘fagocitato’ dall’Ansaldo,
ormai orientato a Sestri; ma fu solo demolito). Nella foto 5.95 si nota sullo sfondo in alto una ciminiera, sembra
probabile fosse dello stabilimento di via Reti (ma non è facile stabilirlo):
vedi 5.93.95 e foto della biblioteca Gallino.
====
Risale al 1870 circa un secondo
insediamento industriale della zona. l’opificio di WILSON
& MACLAREN.
Questi furono due
scozzesi, arruolati dalla regia Marina sarda come macchinisti navali. Ambedue
pare fossero, in patria, già impiegati in officine meccaniche; e proprio considerato
le loro esperienze attive nel campo della meccanica e col fine di gestire i
motori delle navi furono assunti per la spedizione relativa alla guerra di
Crimea (sappiamo che Cavour doveva rifornirsi in Inghilterra di motori,
locomotive e naviglio, e quindi anche di personale qualificato per il quale
aveva tolto l’obbligo di possedere un passaporto; non solo perché quasi unico
fornitore ma anche per tessere e mantenere relazioni di commercio con la
GranBretagna la cui potenza era necessario fosse amica per le idee di
espansione che covava). John Wilson compare nei registri della Marina dal 1853
al 1856 come meccanico; Alexander Maclaren –la sua storia è meno nota- forse
era ingegnere).
Quando nel 1856-7 vennero congedati dalla regia Marina
sarda (ed abbondantemente liquidati
economicamente), è facile intuire perché
provarono ad investire i loro capitali guadagnati e si insediarono a San Pier
d’Arena alle dipendenze del già avviato connazionale T.Robertson (Wilson come capo tecnico e Maclaren forse impiegato,
visto il titolo; col proprietario condividevano patria e conoscenze tecniche
sui motori a vapore, probabilmente già da prima della guerra o comunque
dall’atto dello imbarco-sbarco nel porto di Genova).
Nel 1862
avviarono in proprio uno stabilimento nella zona della Fiumara prospiciente il
mare, divenendo ”costruttori di macchine e caldaie a vapore, molini a grano, ruote
idrauliche, turbine e materiali diversi per ferrovie”.
L’attività progredì fino a
quando, in piena espansione, non trovarono ulteriori spazi per allargarsi e
modernizzarsi; anzi, furono scalzati volenti o nolenti dal vicino Ansaldo,
evidentemente più forte.
Così, negli anni subito
dopo il 1870,
decisero un trasferimento in zona Campasso (forse
anche con previsione di minori commesse relative a imbarcazioni da varare, e
maggiori relative ai motori ed al vasto materiale della ferrovia): occuparono con facilità
un terreno di oltre 3mila mq (Cevini dice
13mila; che avevano comperato l’anno prima, pare dalla Carena e Torre; delimitato tra
la ferrovia e via Vittorio Emanuele (poi via UmbertoI, oggi via
WFillak) e che a lato-mare arrivava a piazza Palmetta ed a lato-monte sino
all’attuale via V.Capello che delimita la zona a quei tempi definita piazza
d’Armi). Pare che però riuscirono a
mantenere in zona Fiumara una fetta di spiaggia per il residuo cantiere navale
della società.
Sulla via
Provinciale V.Emanuele prospettava anche l’abitazione dei due proprietari;
sappiamo che Wilson si era sposato con Giuseppina Bottazzi e con essa aveva
avuto tre figlie.
Lo stabilimento
occupava circa 80 operai nel 1874 ed era
terzo d’importanza in città. 200
divennero gli addetti nel decennio 1880-90; nel 1884 la decisione governativa di rinunciare
all’importazione e favorire la produzione nazionale di materiale ferroviario e
marittimo, arrecò un notevole balzo in avanti con evidente aumento
dell’occupazione, dedicandosi anche alla produzione di beni strumentali per
l’industria alimentare (macchine agricole) ma soprattutto cantieristica (aveva la doppia caratteristica di stabilimento
metallurgico e fonderia, e di officina meccanica). Sintomo delle continue fluttuazioni del mercato, si
segnala invece la presenza di soli 150 operai nel 1892
quando produceva sempre macchine a
vapore, caldaie e tutti quei pezzi metallici necessari ai più svariati
macchinari compresi per piccoli navigli interamente preparati nella fabbrica
anche se non più in condizioni di essere varati direttamente (si stava passando
dagli scafi in legno a quelli in metallo);
per dimensioni era la sesta in Liguria.
Ambedue i fondatori
dell’impresa metallurgica morirono a breve distanza, nell’inverno del 1897: il giornale ‘Caffaro’ segnala nel
gennaio 1898 la tumulazione delle salme dei due. Tutti i componenti delle due
famiglie, sono ricordati in un caratteristico monumento posto nel novembre
1901 nel Cimitero della Castagna, scolpito in forma semplice dall’artista
locale Valsecchi Federico.

Con la loro scomparsa, si
interruppero anche le conoscenze necessarie per ottenere commesse, e proprio in
un periodo storico negativo per l’industria; questo determinò per la società
entrare in crisi parallela a quella dei
Balleydier ed essere posta in liquidazione gli
impianti da un valore di 1,5milioni, nel 1900
vennero valutati solo 460mila lire: fu rilevata dal banchiere Pietro Canzini
che la chiamò “Società Ligure di costruzioni meccaniche e navali Wilson e
Maclaren”.
Rientrò in crisi dopo due anni, e i 300 operai furono
prima ridotti, poi tutti licenziati (non esistevano ancora i sindacati ed era appena nata la
Camera del Lavoro sampierdarenese). Cosicché nel 1903
anche il banchiere dovette cedere tutto il manufatto alla società che già aveva
rilevato l’azienda Balleydier (ridivenuta potente con l’apporto di numerosi finanziatori
locali) divenendo parte della “Soc. F.lli Balleydier, soc.Ital.di Fonderie in
Ghisa e Costruzioni Meccaniche”: l’attività riprese, con 350 operai, con la
costruzione di alcuni rimorchiatori per la regia Marina. Nel 1907, giudicando l’impianto obsoleto e
divenuta la società “già f.lli Balleydier”, si ripeté l’opera del
licenziamento.
Così che ogni attività cessò completamente, non trovando
acquirenti; per valorizzare ed utilizzare ancora le attrezzature, esse furono
trasferite alla Tubi Ghisa di Cogoleto.
Una relazione
sull’opificio, datata 1913, specifica
che con un cancello d’ingresso di adiva ad uno stretto e lungo piazzale sul
quale si affacciavano gli uffici e, in fondo, la fonderia e le varie officine
(meccanici, fabbri, tornitori, calderai); il tutto in edifici a capannone “solidamente
costruiti ad uso industriale”, alti una diecina di metri. Poco discosto, erano
i “servizi igienici” (tra virgolette
perché definiti “una pozzanghera in un canto”) ed alcune stalle per i cavalli.
L’area fu affittata divenendo magazzino di cotone e
raccolta stracci, finché allo scoppio della guerra 1915-18
venne rilevata dall’Ansaldo per fabbricare motori per aerei militari: ”Fabbrica
Motori a combustione interna terrestri e marini - compressori d’aria” (nel periodo bellico vennero fabbricati aerei SVA e Balilla con motore
SPA6: fu con questi aerei che D’Annunzio fece la famosa ‘impresa trasvolata su
Vienna’).
Dopo un ulteriore tentativo di riconversione a macchine
agricole, l’Ansaldo rivendette tutto alla vicina società della Corderia
Nazionale, a cui il terreno rimase sino alla totale demolizione dell’opificio (credo che Lamponi faccia confusione tra piazza Palmetta e via
Bezzecca, quando scrive che l’area divenne sede della Cooperativa calderai in
rame (nata nell’anno 1900, ebbe onorificenze alle esposizioni di Milano del
1906-Bruxelles 1910-Torino 1911; nel 1915 si trasferì a Cornigliano e che-sul
Pagano/33- è solo a Genova).
====Quando
l’UITE il 1 ott.1895 acquistò dalla Compagnia Generale Francese
le concessioni e proprietà tranviarie, tra i beni acquisiti erano compresi lo
stabilimento detto “Centrale” (sito in via
Vittorio Emanuele -oggi via
P.Reti- al civ. 33B =nuovo civico
rispetto quello del 1901), e quello della “Coscia” (in largo Lanterna, a monte di dove iniziava la galleria sotto il colle);
nella contemporanea convenzione tra Azienda e Comune si incluse l’obbligo di
impiantare un doppio binario lungo tutta la via. Quindi
nell’anno 1900, la strada comprendeva
il lungo tragitto: dal tunnel (nord-sud) al bivio con via DeMarini (largo
Lanterna), al bivio con via C.Colombo (est-ovest), alla piazza Teatro Modena,
al sottopasso di via N.Barabino (dalla stazione ferroviaria), al bivio con via
A.Saffi (nord) (via
Rolando) , al Campasso, al Dazio presso
Rivarolo.
Il libro scritto dal dr.
Lorigliola Gualtiero (dottor Walter) intitolato “Cronistoria documentata
illustrata dei fatti di Genova marzo-aprile 1849”, fu stampato nel 1898 dall’editore G.Palmieri e figli
Tipografo, in via V.Emanuele, 15.


via
Vittorio Emanuele nel tratto tra la Lanterna e piazza N.Barabino
==== LAVORAZIONE
DELLA LATTA.
La latta nasce dall’unione dello stagno col ferro:
questo, portato a lamina, riceve successivi bagni di lavaggio e fissaggio in
stagno fuso. I vantaggi sono il basso costo, robustezza, leggerezza, velocità
di produzione, impermeabilità, capacità di conservazione naturale del contenuto.
Lo stagno è un minerale conosciuto fin dai tempi più
antichi, estratto dalla casserite, ovvero biossido di stagno; ed essendo la
regione del Wunsiedel tedesco particolarmente ricca del minerale grezzo - e quindi
anche produttrice - si pensa che essa sia stata il primo posto produttore,
seguita poi dalla G.Bretagna.
L’industria della latta nacque come ovvia conseguenza della
sempre più fiorente attività del mercato dell’olio, dall’importazione,
lavorazione ma sopratutto immagazzinamento e distribuzione al minuto. Il
repentino incremento di questa attività verificatosi nella prima metà del 1800
determinò la necessità di reperire recipienti adatti per forniture
all’ingrosso. Veniva usata una lega al 50% di stagno e piombo per saldare le
lattine.
In parallelo avveniva la scoperta della litografia
(=disegno su pietra). Essa nacque in Baviera agli inizi del 1800 per idea del boemo
Alois Senefelder il quale voleva stampare in forma economica le sue opere
letterarie e musicali: notò che la pietra delle costruzioni locali, pestata, si
può portare ad un impasto solido e duro, intaccabile però dall’acido nitrico
escluso sotto un eventuale disegno tracciato con sostanze grasse. Ottenne così
il disegno in rilievo netto, possibile di essere usato come stampo e di
ottenere molte riproduzioni tutte eguali. L’invenzione venne bloccata da leggi
locali mirate ad impedirne l’esportazione. Sbloccato il mercato nel 1820 il
francese Engelman ne derivò l’oleografia (uso di matite grasse) ottenendo
disegni di maggiore nitidezza.
A SpdA, primi in Ialia, arrivò a metà di quel
secolo portato dal giornalista Carlo Daste (espatriato in Francia nel 1830 per
motivi politico mazziniani e capace di intuirne l’applicazione nella
inscatolazione del pesce, già in atto) ed applicata dall’officina Clavenna di
via Calatafimi.
Pare fu DeAndreis figlio, che dall’Inghilterra
introdusse per primo la litografia su metallo. Importanti divennero sia i
tecnici cromisti, ovvero gli esperti nel miscelare i colori, sia i pittori (vengono ricordati i locali M.A.Canepa,
A.Bertorello, ErcoleDagnino, ErnestoMassiglio; ed anche Luigi Pasero,
Craffonara, Gentili, Bigliardi, DellaValle, PietroBarabino, FedericoPeschiera, RomoloR.Tessari.
Alcune fabbriche più importanti avevano i loro, altre si riferivano a
professionisti esterni; finché non vennero sostituiti dalle macchine stesse.
Gli industriali, vengono ricordati in ordine alfabetico
(con segno ^ se capaci di litografare la latta per illustrarla; alcune
avevano macchinari per la produzione completa del pesce in scatola - dalla
raccolta, a tutte le fasi di preparazione fino all’inscatolamento definitivo -;
altre si limitavano a produrre i contenitori, opportunamente litografati
nell’etichetta ed indicazioni; tra parentesi, dove trovare riferimenti più
specifici descritti in SpdAPuzzle:
Balestrino
v.VEmanuele 163r---; Bozzolo^, v.Ruffini poi c.so Martinetti 25r (
MA+PRO)—-; Canale Pietro (D)---; Casanova Giacomo^ v. Manin 5
(D)---; Conte (MA)---; Costa v. DeMarini 32r (D)—; DeAndreis
Gottardo (apr/1906-telef. 900 e telegrammi Dadre; e giu/1925;
soc.an.tabilimenti grafici; capitale L. 1.500.000) → poi DeAndreis&Casanova^
v.Cassini 6 (C,D,MA,SAN)—; Fabbrica Minuterie v. Cristofoli 1 (C)---; Falchi
A^ v CRota 8 (PRO)---; Fossati Giacomo v.GB Sasso 11r, v. Rela 35r, v gen.Cantore (C,SAN)—; Galoppini
f.lli^ v. SbdFossato 28 (B, BEN, C, G)—; Ligure (L-Emiliana) v. VEmanuele
1 (Ligure: BEN, C, G, MA)--- LigureEmiliana (BEN); la soc. Massardo-Diana
(data come importante anche perché Manlio Diana fu l’ultimo sindaco della città
di San Pier d’Arena prima dell’inglobamento nella Grande Genova. I Diana erano
due fratelli: uno interessato alla fabbrica di scatole in latta ubicata in via
Vittorio Emanuele ed ancora attiva nel 1942; produceva -assieme ad altre 10
officine similari in città- scatole per conservare il tonno o conserva di
pomodoro. L’altro fratello con officina ubicata in via A.Castelli, inscatolava
sott’olio il tonno cotto al vapore.)---; Molinari Eugenio (SA)--; Moro
v. Bottego 1 (B, C)—; Nasturzio^ v.VEmanuele 17 (vedi sotto lo
stabilimento; BEN,D)—--; Pretto E. e C. v. Larga 13 (G)---; Raffetto^
v.CColombo, v.d. Cella (C, PRO)---; Rottigni con la ditta RB---; Sanguineti
(G) ---; Savio^, poi l’Americana’ v. GAlessi (A)---; Solertia
vSBdFossato 1 (B, C)---; Tabacchi (C)---; f.lli Tardito^ v. GB
Monti 23 (MI)---; Tosetti (D)---; UVAL (BEN)---; Vicari &
Barazzone (B).
Più
d’uno poi, i lattai, piccoli artigiani, non citati, come Repetto, Firpo,
Gazzo, Gandolfo.
Tra
tutti, alcune centinaia di dipendenti.
Due
cartoline postali eguali, di ricevuta ordinazione, datate 1905 e 1906, sono
state spedite da “Società Anonima Conserve Alimentari e Lavorazione della
Latta / capitale statutario L.2.000.000 – emesso L.500.000 – versato L.
1.500.000 / sede in Genova – stabilmenti : Sampierdarena, Alghero” senza
spiegazione di indirizzo.
Una
cartiolina segnala nel 1890 l’esistenza dello stabilimento cromolitografico
sulla latta, di Gaspare Rossi, in via Demarini n. 8 “lavorazione
completa di scatole e casse per l’esportazione – di tutte le qualità e
dimensioni – per olio e conserve alimentari”.
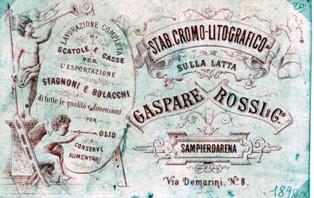
Un
opuscolo tipo Bignami, pubblicato nel 1918 ed indirizzato ai principianti
calderai, nello spiegare lo stagno riferisce che “fabbriche di tal genere
abbondano nel Nord America, Germania, Francia. In Italia a Sampierdarena, a
Torino, a Milano, a Forlì.”.
Il
Costa/1922. guida di Genova, a SPdArena cita come rimasti lavoratori
la latta, la presenza de: Bozzolo & C. (cromolitografia-via Ruffini,
16 tel 33399; Casanova G. via Manin 9 tel 1662; l’Americana
soc.an. via Alessi, 7; Solertia soc.an via sBartolomeo, 13r tel 1298; SocietàLigure
per la Lavorazione della Latta. Erano invece solo produttori di litografia
su latta, Nasturzio F. in via vittorio Emanuele; De Andreis
G. via Manin soc.an.
CIVICI
===civ.2: Crivelli scrive sul Gazzettino che – a SanPdA - E.Salgari abitava al piano terra delle ‘case Canepa, 96’
alla Coscia, senza precisare meglio. Da altre informazioni, apparirebbe che il
palazzo nel quale abitò non esiste più, sostituito da un edificio moderno –
probabilmente quello posto nell’angolo tra via Pietro Chiesa e piazza N.Barabino
(ove ora, di famoso, c’è il night club san Françisco).
Sappiamo che invece in casa Rebora di via V.Emanuele, assistito
dalla levatrice Carbone Maddalena alle ore 12 del 6 nov.1898 gli nacque Romero
il terzogenito (esiste il certificato di nascita di Romero: ebbe come testimoni un
cavalier Luigi Gottardi ed il signor
Amedeo Bertorello; parteciperà poi come soldato a gloriosa esperienza bellica;
ma anche lui ebbe breve esistenza perché morì suicida a 33 anni), e non a caso -nell’elenco proprietari
del 1901, vedi sotto -, al civ. 2 compare
un Rebora Augusto. Non conosciamo con precisione dove era la casa Rebora
– case omonime sono anche in via De Marini vicino a Largo Lanterna - trovatagli
dal procuratore dell’editore, Edoardo Spiotti: alcuni descrivono essere
nell’angolo tra via Galata (oggi via Pietro Chiesa) e via Vittorio
Emanuele (oggi via G.Buranello). Dove nella cartolina sotto è una carrozza, finiva via
CColombo (v.SPdArena, di spalle) ed iniziava via Galata (v.PChiesa); la casa
dietro alla carrozza potrebbe essere quella abititata da Salgari (di positivo,
è che corrisponde la comunicazione con via Emanuele, considerato che allora non
esisteva ancora piazza Barabino e giustificherebbe come posizione, la
mareggiata subita. Di negativo è che essendo al civ.2, sembra troppo ad ovest
rispetto l’inizio strada in largo Lanerna). Di
sicuro che divenne insufficiente per una famiglia di cinque persone, con una
bimba femmina tra essi; e forse era anche cara come affitto.

la
foto segnala la ‘casa Rebora’;
senza
però specificare dove era.
Allora
trentaseienne, Emilio Carlo Giuseppe
Maria Salgàri fu Luigi, aveva
in moglie Aida Peruzzi ventinovenne, attrice di teatro. Dei quattro figli,
Fatima e Nadir sono precedenti alla sua venuta a San Pier d’Arena; Romero
nacque qui; e Omar l’ultimo venne alla luce a Torino.
Wikipedia scrive che il nome va letto accentando la seconda a, perché deriva
dal nome dialettale di una pianta: ‘salgàr’ che in veneto corrisponde al salice
nero.
Emilio
era nato a Verona il 21 agosto 1862 (alcuni storici scrivono 1863) in vicolo San Marco al n.839; figlio di commerciante-negoziante
veronese di tessuti Luigi e da Luigia Gradara, casalinga veneziana. Poco si sa
della sua gioventù: fu mandato a balia da Maddalena Cinquetti, e crebbe nella
frazione Tomenighe di Sotto, del comune di Negràr in Valpolicella. Poi la
famiglia si trasferì all’attuale “ca’ Salgari”. Già da bambino, era chiamato
‘Salgarello’ per bassa statura; e da ragazzo; 13enne, iniziò le scuole tecniche
comunali (che non concluse): già animato dalle fantasie orientali, si scrive
che a Verona frequentava la biblioteca
per raccogliere i particolari che poi descrivà nei romanzi: infatti aveva 9 in
italiano e voti molto più modesti nelle altre materie. A sedici anni fu ospite
a Venezia da una zia –Filomena De Rossi – la quale lo iscrisse, prima come
uditore poi ai corsi regolari, al Regio Istituto Nautico al fine di conseguire
la licenza di capitano di gran cabotaggio (richiedeva anche 4 anni di
esperienza di navigazione e l’età di 22 anni); ma al secondo anno non si
presentò agli esami né si imbarcherà come programmato, quale mozzo su un
trabacco “Italia uno” che faceva la spola Venezia-Brindisi.
A 21 anni (1883) esordisce pubblicando su
un giornale illustrato di Milano “La valigia” il suo primo racconto in quattro
puntate e titolato ‘I selvaggi della Papuasia’ firmandosi con la sola sigla
S.E.
A
questo racconto seguono l’anno dopo, 150 puntate sul quotidiano veronese “La
Nuova Arena” del romanzo ‘La tire della Malesia’ (il quale, poi ristampato in
libro da Donath nel 1900, diverrà ‘Le tigri di Mompracen’).
Il
padre morì suicida il 27 novembe 1889, come poi faranno pure il nostro Emilio e
due suoi figli: Romero ed Omar, quest’ultimo per precipitazione dal secondo
piano nel 1963.
Dicorato racconta tre episodi: uno, che –frequentando nel 1878 a Venezia il regio Istituto nautico P.Sarpi-
era un promettente studente ma non riuscì mai a raggiungere il diploma come
avrebbe voluto, di capitano. Secondo, che dopo aver dato alle stampe due libri
fortunati (La tigre della Malesia e Le tigri di Mompracem- in realtà uno solo
romanzo) fu introdotto nel quotidiano veronese “L’Arena” dove lo chiamavano col
soprannome ‘capitano’ per i suoi trascorsi liceali. Terzo, che il giornalista
Biasioli Giovanni (o Giuseppe?) de “L’Adige”, volendo ridicolizzarlo prese a
nominarlo ‘mozzo’, oppure ‘Salgarello’, oppure ‘La tigre della magnesia’.
Salgari, sentendosi offeso sfidò a duello di sciabola il rivale e nella contesa
(a Chievo, 25 settembre, alle ore 14) lo ferì lievemente mandandolo però
all’ospedale. Ma dovette subire sei giorni di prigione da scontare nella
fortezza di Peschiera, più 30£ di ammenda. Il fatto ebbe una certa risonanza ed
accrebbe la conoscenza ed ammirazione verso il giovane autore.
L’Enciclopedia Zanichelli propone che collaborò ad altri giornali veronesi (‘La
nuova Arena’, e ‘La Valigia’), nonché un’altra cronologia: dapprima -1883=dei
racconti, accolti favorevolmente dai giovani (‘Tay-sea’, ed ‘I selvaggi della
Papuasia’, quest’ultimo pubblicato su un settimanale milanese); poi romanzi
d’avventura (1890=’La scimitarra di Buddha’; 1895=’I misteri della giungla
nera’ ed ‘Il Corsaro Nero’; 1897=’I pirati della Malesia’; 1901=’Le tigri di
Mompracem’; 1903=Jolanda la figlia del Corsaro Nero; 1907=’Sandokan alla
riscossa’. Tutti tradotti in molte lingue.
Si era trasferito a Torino
e –lui 30enne- si sposò il 30 gennaio 1892
con la 29enne Ida Peruzzi conosciuta in una compagnia di attori dilettanti; lui
la ribattezzò Aida, e sempre così la chiamerà.
A Torino lavorò per alcuni
anni (dal nov.1893 al 1898) sotto
contratto con l’editore Speirani che pubblicò una trentina di lavori, alcuni
firmati con psedonimi. (Lo scrittore
Piero Zanotto - sulla rivista “Prezzemolo” ed a conclusione di una rassegna
durata cinque mesi a Verona – non riconosce questi due anni torinesi e lo fa
legato a contratto -nello stesso 1892- a Milano con Treves – il quale gli
pubblica il romanzo ‘la scimitarra di Budda’, illustrato da Gaetano Colantuoni
e già pubblicato a puntate su un settimanale “Il giornale dei fanciulli”).
A fine anno, gli nasce la
primogenita Fatima (e poi chiamerà così anche l’eroina del romanzo “il Re della
Montagna”); e così, si trasferì a Milano.
Nel 1894 gli nasce il secondogenito, che verrà
battezzato Nadir (come era il protagonista del secondo libro pubblicato da Treves
‘il Pescatore di balene’ illustratro da Gennaro Amato = famoso illustratore che
per molti altri libri definirà graficamente gli eroi del Salgari)
Arrivò a SPd’Arena (con moglie incinta
di Romero), nella prima metà dell’anno 1898;
e vi abitò per alcuni anni.
Il figlio, come detto nacque qui nel 1898. Pino Boero dice esplicito ‘due anni;
dalla fine del 1897 alla fine del 1899’; Felice Pozzo è più preciso e
documentato. Finalmente a tu per tu con il ‘suo’ mare, ideale per produrre
il capolavoro del ‘Corsaro Nero’ ed altri titoli famosi. In quell’anno lo
scrittore era stato nominato cavaliere. E qui visse una parentesi
particolarmente felice e serena, reduce di un grave esaurimento sofferto
negli anni precedenti, travagliati da un seguirsi di disgrazie, compreso la
vista che ebbe un calo significativamente pauroso.
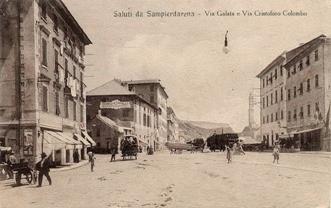
Minnella scrive che era
conosciuto ed apprezzato dalla gente come scrittore di libri di avventure,
forse già il più noto d’Italia. Ma si racconta che lui, grande scrittore di
avventure di mare, a parte un unico viaggio in nave da Venezia a Brindisi nel
periodo scolastico, ebbe riscontro di esso solo quando per una mareggiata ebbe
-come un vero marinaio- la casa allagata, con conseguente rovina di molti
manoscritti e dell’enciclopedia da cui traeva notizie dei luoghi d’oriente.
Dalla
Coscia, frequente era la passeggiata in barca o a piedi fino alle osterie di
Sottoripa ed angiporto a raccogliere testimonianze dirette dai marinai.
Boero
riprende ricordi di Emilio Firpo, il quale descriveva Salgari in via Luccoli ed
il suo desiderio di accompagnarlo fino a Caricamento – ove prendeva il tram a
cavalli per tornare a SanPdA - per ascoltare le idee di nuove trame
fantastiche, le quali – ricorda Firpo - lo attiravano tanto da spesso
inciampare nelle buche perché ammirato ad ascoltarlo.
A Genova, suo editore dal febbraio 1897 a
giugno 190 fu il bibliotecario berlinese Julius Anton
Donath di via Luccoli 33r (nato 28
febb.1857, battezzato cattolico; arrivò a Ge all’età di 40 anni, il 22 nov.1897
quando sposò Ester Giordano nata 1873. In attività dal 1886-7, nel 1890 assunse
la cittadinanza italiana -con giuramento al re ed al regno, e con diritto al
voto ed iscritto alla Camera di Commercio-; non ebbe particolari difficoltà
–anche se le temette- durante il conflitto contro la Germania nel 1915-18 ed è
documentato fosse ancora in città nel 1917; non si sa dove e quando morì) (; più
di tutti pubblicò libri dell’autore. Arrivato a Genova nel 1886 per fare il
libraio ed editore –gran fornitore della Bkiblioteca Universitaria ed iscritto
alla Soc.Lig. di St.Patria-. Voleva essere editore di libri di pregio; e
quindi, le storielle di quel finto marinaio lo squalificavano: lo giudicava
capitano di mare seduto su una sedia, che però riusciva a far navigare la
fantasia come mai altri. Infatti – libri di questo ‘navigante’ ne vendeva tanti,
il che faceva trovar posto ad un compromesso morale con se stesso, sfruttandolo:
iniziò convincendolo con un contratto scritto –che non prevedeva diritti
d’autore-, a trasferirsi da Cuorgné con la famigla –allora composta dalla
moglie Ida Peruzzi, da Fathima (nata 1892) e da Nadir (1894)- .
Per
‘colpa’ di Salgari, Donath era passato da editore di cultura e di portata
europea, a editore di romanzi; gli intellettuali genovesi lo ignorarono
preferendo altre pubblicazioni. L’editore teneva legato lo scrittore con un
contratto di esclusiva, con minimo tre libri annui. Malgrado tirature che
arrivavano a 100mila copie per enorme – a quel tempo- successo di pubblico, per
lo scrittore non corrispose una agiatezza economica adeguata, per abile
sfruttamento delle sue capacità da parte di tutti gli editori.
NB=La legge sui 'diritti d'autore' era nata nel 1840 (sino ad
allora, essi erano furbescamente trascurati dagli editori che si sentivano
autorizzati a 'usare' gli scritti di data antecedente; il povero Salgari è
posteriore a questa data però si può pensare che essa era non obbligatoriamente
applicabile o poco chiara, visto i tempi lunghi e le scarse possibilità di
comunicazione).
I
rapporti con l’editore genovese Anton Donath vedono una relazione (che, altra
fonte pone nel periodo 1895-1907); ma
negli ultimi anni era tornato a Torino; nel 1895 aveva iniziato con ‘I misteri
della Jungla nera’, modificato nel 1903 con l’aggiunta di altri otto capitoli.
Seguirono editi con lui ben 34 libri, alcuni (almeno tre) firmati con lo
pseudonimo Enrico Bertolini, oppure Romero S., quasi tutti illustrati da Pipein
Gamba (su un totale di 82 romanzi e oltre cento racconti). Di essi, 5
corrispondono al periodo di soggiorno qui.
Con Donath, in ordine cronologico: 1896=‘i pirati della Malesia’ e ‘i Robinson
italiani’; 1897=’Il capitano della Djumna’; 1898=‘al Polo nord’,’Il Corsaro
nero’, ‘Le stragi delle Filippine’, La Costa d’Avorio’; 1899=‘la Capitana
dello Yucatan’, ‘Avventure straordinarie di un marinaio in Africa’, ‘Le caverne
dei diamanti’; 1900=‘i minatori dell’Alaska’, ‘Le tigri di Mompracem’, ‘gli
orrori della Siberia’, ‘gli scorridori del mare’; 1901=’La stella polare e il
suo viaggio avventuroso’ , ‘la regina dei Caraibi’e ’il fiore delle perle’;
1902=‘i naviganti della Meloria’ e ‘la montagna di luce’; 1903=’i predoni del
Sahara’ e ‘le pantere di Algeri’; 1904=‘le due Tigri’,’i figli dell’aria’, la
città del re lebbroso’, ‘l’uomo e il fuoco’, ‘i solitari dell’oceano’; 1905=’Jolanda
la figlia del Corsaro Nero’, ‘La sovrana del Campo d’oro’, ‘La perla sanguinosa’,
‘il Capitan Tempesta’; 1906=‘le figlie dei faraoni’, ‘il re del mare’; 1907=‘le
aquile della steppa’, ‘alla conquista di un impero’; 1908= ‘Cartagine in
fiamme’.
Con
Donath, dal febbraio 1904 pubblicò il periodico ‘Per terra e per Mare’, che uscirà
per 31 numeri fino al 1906 (non citata da Beccaria).
Ed
a stimolare la fantasia, famosi sono i disegni di Giuseppe Garuti (firmati
Pepein Gamba, capace caricaturista e disegnatore di costumi anche per il Carlo
Felice), e di Alberto DellaValle che in cromolitografia a otto colori, prima
fotografava amici e parenti nelle posizioni che voleva rappresentare.
Nell’anno
1900 gli nacque il quartogenito, terzo
maschio, che sarà chiamato Omar. È un periodo positivo: popolarità alle stelle
e vendita ‘come il pane’; ma lo scfrittore scivola in uno stato depressivo e
tenta di uccidersi con la spada.
La
burrascosa collaborazione con Donath era finita con una lettera datata 20
ottobre 1906 in cui l’editore scrisse
“stando così le cose, V.S. si persuaderà facilmente che la casa Donath non è
verso di Lei contabile per somma alcuna. Ciò per di Lei norma onde mettere le
cose nei veri termini ed a scanso di equivoci”. In quell’anno tornò a Torino
(in corso Casale, 298 del borgo Madonna del Pilone), e passò all’editore
Bemporad.
A causa della sua ingenuità, distratto dalla sua fantasia e da un paventato
calo di vista, dalle bizzarrie della moglie (peggiorata da quando lui aveva
tentato il suicidio una prima volta, ma venne salvato); e dovette ricoverarla
l’anno dopo. Non meno, i doveri di padre, accompagnato solo da cento sigarette
e da una bottiglia di marsala al giorno le difficoiltà economiche con debiti
che divennero una costante della sua vita. Sciocco poteva essere ribellarsi,
ma non tanto da non accorgersene se, nella lettera testamento che lasciò prima
di precipitarsi, scrisse amaramente 13 lettere di addio, tra le quali una per
l’editore: “a voi che vi siete arricchiti con la mia pelle mantenendo me e la
mia famiglia in una continua semi-miseria od anche più, chiede solo che per
compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto
spezzaundo la penna”.
Anche
lui come il figlio, morì il 25 aprile 1911,
quarantanovenne, suicida (alcuni scrivono per precipitazione in un burrone del
bosco della Madonna del Pilone a Torino; Wikipedia scrive per karakiri col
rasoio di casa; Zanotto scrive ‘a colpi di rasoio’).
Ai figli lasciò scritto: «sono un vinto. Non vi lascio che 150 lire più un
credito di altre 600 che incasserete dalla signora...». Il corpo fu trovato per
caso da una lavandaia.L’11 febbraio il suo corpo venne traslato in treno a
Verona, salutato fino al cimitero da una straripante folla commossa.
Sono
conosciuti numerosi apocrifi (più di un centinaio) che editori privi di
scrupoli, gli attribuivano
Dai
suoi libri sono stati tratti i soggetti per oltre 45 film.
Gli
è stata intitolata la scuola elementare di salita san Barborino.
CRONOLOGIA
& CIVICI
Nel 1901 dal tunnel di largo Lanterna sino al sottopasso
ferroviario dell’attuale piazza V.Veneto, vi abitavano : civ. 1 caserma guardie di Finanza;
civ.1a casa Carpaneto Giuseppe ed 1b Carpaneto Giacomo; civ.2 Rebora Augusto;
civ. 2a casa Ballejdier eredi; 4 casa Croce; civ.5,5b casa Carrozzino ; 6,8
casa Pittaluga Antonio; 7,7a casa Cassa Invrea; civ. 9,10 casa Durante e
Roncallo e C; civ.11 casa Podestà Tobia e C; civ. 12 casa Sommaria; civ.12a
magazzeno legnami Casanova; civ.13 Casanova Bianca; civ.14 Scaniglia eredi;
civ.14 magazzeno legnami Canotti e C; 14a Garibaldi Luigi; 14b Queirolo
Giuseppe; 15 Arata e C; 15a Costa Giacomo C; 16,16a,17 casa Natini già
Pallavicini; 18 Tubino Arturo; 19 e 20 Balbi e C (il palazzo d’angolo con piazza Modena?); 21 vedova Parodi; 22 Masnata e C già Morando; 23 Chiesa e C già
Leanghi; 25 ospedale Pammatone; 26 Galliano e Ratto; 27 Galliano Pietro; 28
Fava (l’albergo
Centro)– Tuo già Aronne; 29 Campi
e C. già Borzino
Si nota che tutti questi insediamenti, vanno dal tunnel al
volto ferroviario; o perché ce ne erano pochi progredendo verso il Campasso; o
perché il Pagano non era ancora ben organizzato; o perché nel 1901 il tratto
finale (via P.Reti e via W.Fillak) fu dedicato al figlio del re, UmbertoI, assassinato
a luglio dell’anno prima (quest’ultima spiegazione che sembrerebbe la più
logica, invece non regge perché nel 1902 il Pagano non si aggiorna sul nuovo
nome di UmbertoI e continua a descrivere in via VEmanuele anche dalla stazione
al Campasso.


Il Pagano 1902 « segnala (la
data dopo →, significa che l’esercizio è presente nei Pagano successivi)
al ---2 Savio Angelo, tel 590, litografo e fabbrica casse in legno;---
Dellepiane Davide (→1912) ha negozio di cereali e carrube;---4 assieme ai depositi di
Carpaneto, c’erano quelli di Garibaldi e
Copello, tel 758;--- 8 spedizioniere Pittaluga Antonio fu Andrea
(→1919);--12 p.p. f.lli
Frassinetti sarti---13 Malfettani e Burlando fabbricano
liquori;---nell’archi.ferr. Cavaglione Giuseppe vende stracci;--- 14 Svicher
G. «(→1919, il fotografo:--- 14A Ditta Sanguineti Antonio (→1919): deposito di birra
e fabbrica di acque gassose;--- 14B/4 l’appaltatore di costruzioni Carrena Carlo (→1912);---14B Bagnara Ermillo ha un cappellificio;--- 15 Canepa e
soci grossisti di olio d’oliva;--- Boccardo Giuseppe (→1912; 1925, eredi)
tornitore;--- Plateo cav. A. e Ferrari sono appaltatori di
costruzioni;---Palmieri Gius. e Figli tipografi (→1912; 1925 in via
C.Colombo);--- 16 Sanguinetti Policarpo fa l’ebanista e Sanguinetti
Michele i mobili;--- verniciatore Burlando Luigi (→1919);--- civ.17
0steria dei f.lli Tacchini (→1912);--- 18 negoz. cappelli di Glorio
Gius.;---negozio di calzature di AghinaFrancesco (anche in via Mazzini)--- 19 un
albergo ‘del Commercio’ gestito da Crespi Giovanni;---trattoria ‘Leon d’Oro’ di
Gruna Anna (→1912);--- Grazioli Biagio
«(→1912) vende apparecchiature per gaz;--- 20 e 21 negozio di
macchine da cucire, rispettivamente di Brolis Cesare «→1925; compare
anche come negozio di mobili e tappezziere ed orologiaio; nel 1925 è al 42n,
163r,214r, tel.5906, ed anche in pza G.Bovio,);--- la compagnia Singer;--- 21
ombrellaio Motta Quirico;---22 succursale
della sartoria genovese dei f,lli Conte;---negoz cappelli di Carrera
Pietro;---abit del pittore Orgero Carlo;--- 23 i f.lli
Chiesa fu Francesco vendono chincaglierie e di ferramenta;--- l’osteria
(mescita vini)-trattoria di Rivara Franc.(→1912), diventerà dal 1919→’25
ristorante il ‘BRILLÈ’’
sempre di Rivaro, ma al civ. 56);


---25
un Peri Carlo con negoz. pellami ed art. per
calzature; nel 1911 il figlio continuerà l’attività;---Arnolfi Antonio è
droghiere e confettiere;--- 26 l’orefice (fabbr.) Noli Angelo (→1925);
ed 27 Rebora
Giuseppe ha negozio di cereali;---28 ristorante del Centro (di Podestà Rosa ved.
Fava (→1912; dal 1919 al 25 di Frassinetti Adriano), tel 3337 poi 41-004);---29 (d’angolo
con v.N.Barabino 8) il pasticciere Muller e C.(→1912);--- e negozio di
stoffe di Villa Giuseppe (→1912);---31B selleria di Pagella luigi fu
Carlo;--- 31c fabbrica di cinghie di pelo di cammello, di A.Massoni
e Moroni, tel.910--- f.lli Trucchi rappresentanti, vendono filtri per olio---32
brillatori di riso F.Franchini e C.;---33A l’eserc. UITE
(trasporto viaggiatori telef.n.901);--- 34 Morando succ. si interessano di macine per
molini;---commestibili di Bagnasco Maria;--- 34L f.lli SASSO fabbrica pallini da caccia;---35r Garibaldi
Salvatore (→1912) ha mescita di vini;-35 i Monticelli Bartolomeo e figli
di via s.Antonio hanno una fabbrica di pasta alim.;---41 archi
Ferrovia negozio di vetrami di Meirana Bartolomeo (→1912);--- 48 la Corderia Nazionale Carrena e Torre ha un deposito
aperto;
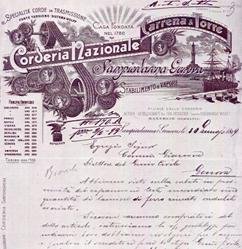
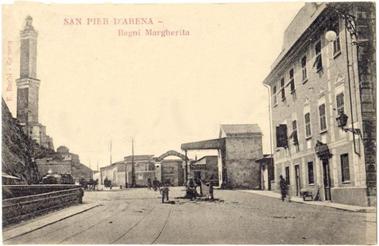
Bagni r.Margherita e l’inizio strada (davanti essi, e dietro
casetta con tettoia). A destra, palazzo di via De Marini
---56-A
al Campasso le ‘Fabbriche Riunite Glucosio Destrina
e affini;--- 50B fabbriche di turaccioli, di Canessa & Spanio
(→1912) e di Ondano Emanuele (→1912);
---Con civico non specificato:Rolla Vittorio (un omonimo nel 1911 con differente
attività) vende carbone minerale;--- Spanò e Solari negozio di mobili--- f.lli
Chiesa fu Francesco sono armaiuoli (sic)—vicino al tunnel tramway, i ‘bagni Regina Margherita’ di Bonifacini Lagorara e
Cabella;--- Canepa Ernesto (archi Ferrovia→1912),
intagliatore in legno, ha una segheria a vapore e fabbrica cornici;---negozio
vetrami di Canepa Ernesta;---f.lli Puppo ortocoltori;---
Una cartolina (collez.
Canepa) viaggiata il 29 maggio 1904 (con l’immagine del Nuovo Ponte di
Cornigliano, porta scritto a penna «Grazie della
sua gentilissima lettera. Presto le scriverò a lungo. Quando scrive a Mamma
prego mettere “Corso V. Emanuele n. 30” oppure “presso il Pretore”». Negli
elenchi sopra, precedenti a quella data non c’è il civ. 30 e sembrerebbe che i
civici non siano ancora ancora suddivisi in pari/dispari altrimenti sarebbe
stato sotto le arcate della ferravia.
È nella cronaca cittadina del 22 gennaio 1903,
che nella mattina mentre si recava a Cornigliano per il varo di uno yacht da
diporto privato, Luigi Amedeo Savoia, duca degli
Abruzzi nella via ebbe un pneumatico forato all’auto che lo trasportava,
proprio all’altezza di via della Cella. Ovvio il capannello di curiosi ed
entusiasti, trattenuti da un tenente dei carabinieri prontamente intervenuto
con le guardie comunali, ai quali per mezz’ora il Duca rispose amabilmente fino
alla sostituzione della ruota bucata.
Una ricevuta delle Imposte Dirette relative all’esercizio 1904 è della ‘Esattoria di SAMPIERDARENA’ -
Assunta dalla Banca Popolare di San Pier d’Arena
– L’Ufficio esattoriale trovasi in via Urbano Rela n. 1, ed è aperto.... (nel
1909 invece trovasi in ‘vico Mentana, 16’, telef. 456). Nell’agosto 1915 manda
un avviso scritto segnalando che causa il richiamo alle armi di molti
dipendenti, è costratte a chiudere la filiale di Pontedecimo; mantenendo quelle
di Bolzaneto, Busalla, SestriPon., Voltri.
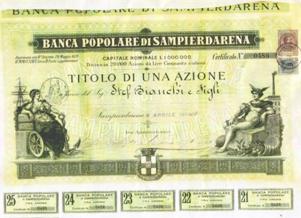

Nel 1904, al civico 48/1 esisteva
un Poliambulatorio medico, chiamato ‘Policlinico Generale - istituzione fondata da medici
specialisti, ed ha per iscopo la cura in singole Sezioni delle malattie
riguardanti le specialità medico-chirurgiche. Tale cura è gratuite per le classi
povere’: sez. 1: sistema nervoso-dirigente dott.Emilio Greco; sez 2: cuore
e polmoni-dirig. dott. Peone Gandolfo; sez. 3: stomaco e intestini-dirig. dott.
GB Ramino; sez. 4: bambini-dirigente dott. Giorgio Rotondi; sez. 5: chirurgia
in generale-dirig. dott.MarioOberti; sez. 6: Donne ed Ostetricie: dott-Italo
Benso; sez. 7: genito urinarie-dott. Metello Sacco; sez. 8: pelle e
sifilitiche-dott.S.Artom; sez. 9: occhi- dott. Edoardo Besio; sez. 10:
ORL-dott.Achille Torretta; sez. 11: bocca e denti-dott. Vittorio Marcori
Nel 1910 compare scritta
nell’elenco delle strade pubblicato dal Comune “dal bivio con via DeMarini al
sotto passaggio Umberto I (quest’ultimo riferimento appare poi cancellato a
penna e sostituito con ‘alla piazza F.sco Ferrer’)”, con civici sino al 66 ed
al 21A.
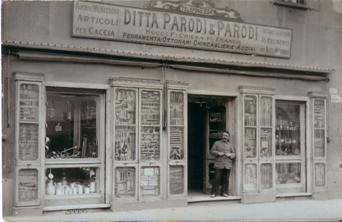
Nel Pagano 1908, 1911, 1912, 1919,
1925-6)
si rilevano di più appariscenti attività: al 3 ed al civ.23
i Parodi e Parodi (→1912; si reclamizzano come armaiuoli - aggiunge:’success.’.
Invece come ferramenta e chincaglieria ‘succ. f.lli Chiesa’ (come scritto
nella foto sopram, ”succ. f.lli Chiesa fu Franco”. Nel ‘19 sono ai civv.
288.290.292, tel.294; nel ‘25 ai civv. 312-4-6r tel. 41313);--- al civ.4 i magazzini per depositi
(docks, anche in via C.Colombo 96) di Carpaneto GB (→1925);--- civ.5
Sanguineti Antonio (→1919) fabbrica acque gassose:--- 8r sotto
il viadotto ferroviario, la “Coop. tra muratori ed
affini”;--- 13 (archi. ferrovia.) negozio di stracci di
Cavaglione Giuseppe (1908; forse
Caviglione Giuseppe);--- 14
fratelli Grasso (1908→1912) fabbricano casse di legno;--- al 14-44 c’era
la Camera del Lavoro a cui aderivano
innumerevoli categorie di lavoratori e cooperative (tra esse la grande coop di
Consumo “Alleanza Coop. Ligure Avanti” di via Saffi);--- 15,
Caprile Antonio →1912, tappezziere e fabbricante di mobili in legno;--
Vaiatica Felicita (1908) con negozio di mode (diventa poi di Biocchi);--- al n.20
del viadotto ferrov. l’armaiolo Masnata Giuseppe →1919;--- 22,
ing. Scaniglia Angelo
(→1919);--- ed al p.3 l’ambulatorio dell’oculista dr Staderini Carlo (1908→1919);--- 25
coesistono un negozio di legnami da costruzione Molinari Diego (1908→1912)
e idem di Giuseppe, distinti;--- il confettiere Molinari Ettore;--- e Peri
Francesco (1908→1912) che ha negozio di pellami;--- civ.26 (PIAZZA
OMNIBUS) il ferramenta chincagliere Serra Raffaele 1908→1912 (nel ‘19
al civ.64, tel.1204)---, ed all’int.1 Cattaneo Bartolomeo mediatore in grano e
cereali;--- 27r fabbrica di pettini di Giovanni Galli fu Lorenzo
telef. 2372;--- civ.28 albergo e ristorante ‘del CENTRO’;--- ed una fabbrica di turaccioli di
Scibilia C. (→1912);--- civ. 29, CAFFE’
ELVETICO e pasticceri;--- al 29r Rosso Omero e C vendita
di velocipedi;--- 31 assicurazioni Ausonia (→1919;
telef.910) infortuni, agenzia di Sampierdarena; e fabbrica di cinghie di pelo
di cammello di Massoni e Maroni con telef.n. 910;--- 31B, Alberti
Luigi →1912; di ‘istrumenti musicali’;--- e Pagella Luigi fu Carlo
→1912 di selleria;--- al civ. 31C i f.lli Trucchi →1912
(n.telef.: 29) hanno rilevato (vedi nella categoria dei rappresentanti)
fabbrica articoli tecnici e negozio di filtri per olio e cinghie per
trasmissione nonché rappresentanti di oli e saponi;--- come identica di
A.Domange e f.gli →1912, che nel 1912 avrà telef. 910 (telefono uguale alla ditta
FoltzerEmilio che vedi in civ. non specif.
ha fabbr. olio minerale);--- civ.32, ancora i fratelli
Trucchi; e la Wacuum Oil Company →1912, fabbriche di olio minerale;--- civ.32A
fr.lli Galoppini (→1912, tel.821)
fabbr.casse in legno e litografia (uffici a Ge.); al civ. 33
ditta di costruzioni meccaniche e navali nonché fonderia in bronzo e ghisa
ing.D. TORRIANI e C. Nel 1912, ha telef. n. 849;
poi telef. 598);--- civ.33 TRATTORIA
‘del tramway’ di Parodi Andrea →1912; il meccanico Repetto GB (→1912
è al 33-D, oppure al 34D) tel 849 e fonderia in bronzo e costruttore
meccanico;--- e F.Franchini e C. brillatori di riso;--- civ. 33A di
nuovo la Galoppini→1912, ma per Litografie per illustrazioni casse e
latte per conserve alimentari;--- civ.34 la Farmacia Sibelli Clemente (oggi Mauro; in essa avevano reperibilità quasi tutti i medici
locali: Bonanni Carlo→1912, Botteri GB →1912, Bruno →1912,
Canessa Lazzaro 1908, Canevari Pietro 1908, Danovaro →1912, Gras 1908,
Viglione →1912); ---ed i ‘succ.
Morando →1912 di macine per molini;--- 34D Guiducci Luigi lavorava
il crine per fare cavi e corde;--- 34L fabbrica
pallini da caccia, tubi e lastre di piombo fr.lli Sasso (dalla TORRE DEI
PALLINI);--- civ.35 pastificio Monticelli
Bartolomeo e figli →1912 (anche
in via s.Antonio);--- al 42
fabbrica mobili in legno Sanguinetti Michele (1912) (citato essere anche al civ.16); al 42/11 l’appaltatore di costruzioni Piano
Agostino (1919);--- al civ.44 Pastorino Giovanni
→1912 rappresentante di oli e saponi; e vi coesiste il negozio di art.
per calzature di Cavanna Ernesto→1912 divenuto (1919) Nicolò;--- civ.52
neg.calzature di Rapallo Raffaele→1912);- al 52-1 Galliano Lorenzo
e fratello nel 1919 con casella postale n.30, tel.64-31, vendono acciai inglesi
fusi al crogiuolo per utensili);--- civ.
54 fabbrica di liquori e deposito c.te Chazalettes e C.→1925;
il rappresentante DeAmici Enrico; e le levatrici Boltaro Caterina →1908 e
Moretti Teresa, 1925;- civ.58 Banca
Popolare →1912, telef.n. 456;- civ.83 Bodio e
C. →1925, rappresentanti della Casa “Peugeot di Parigi”;- 117r
l’asfaltista Cavo Zaccaria, 1919, tel 30-25;- 121r altra fabbrica
di liquoridi DeAmici Enrico (→1925) tel 30-25; 142r
Roccatagliata e C.→1912, di articoli tecnici, olio minerale e fabbrica
di cinghie per trasmissione (nel 1925, telef.32-18).
---In
civv. non specif.: il cinematografo Dante (dal 1921, dei
f.lli Queirolo); caffè ROMA (1908→1912 di
Frassinetti Adriano; 1925, di Trevisan Serafino);--- fabbrica carrozze e carri Tortarolo Giacomo «1912, archivolto
ferrovia;--- i f.lli Rolla Vittorio (da
solo « con negozio di metalli ed impresa trasporti) ed Edoardo→1912 con articoli tecnici, cinghie per trasmissione ed olii (sic) minerali
lubrificanti tel.n.813 (1925, saranno stessa via, al civ.251, tel 41341);--- le
assicurazioni generali Venezia (1908-12) (agenti Brignole e Lagorio, telef 19-23; nel 1919-25
solo Lagorio Silvio);--- fabbrica di olio minerale di Foltzer Emilio
1908-12, con telef. n. 910;--- il
confettiere Coppo Federico;--- Rastrelli
Adolfo →1912, e C. che nell’archiv.ferroviario
vende legnami da costruzione ed ha telef. n.304;--- Luigi Gallotti →1912, di
stoffe;--- f.lli Puppo orticoltori;----
Conte Emanuele macchine per cucire;--- Vernazza Ettore →1919 mediatore in grano, cereali e foraggi;--- Mainetti negozio
moda;--- Spanò e Solari negozio mobili;---
la società Anonima Coop. di Produzione costruzioni meccaniche e navali, fonderia in ghisa e
bronzo (anche in via Saffi);--- trattoria della Gina →1925 (s.Martino, Campasso);--- fr.lli Massa cartolai;--- il merciaio Polacco (1908-12)---Soc. Servizio
Automobili di piazza, 1919, di Dodi e C, tel. 5976 (tariffa per percorsi – Per i primi 1200 metri L. 1,20.
Per ogni 300 metri successivi L.0,20. Per ogni bagaglio da collocarsi
all’esterno della vettura L.0,25. Aumento durante la notte L. 0,25 % senza
contare le frazioni. Nei percorsi fuori comune il ritorno a vuoto va retribuito
in ragione del 50%)—



foto
1921
1928 1930
=Pagano 1911 e 1912 civ.2 Dellepiane Davide vende carrube e
cereali;- 7 (archiv.ferrovia) il negozio di cappelli di Pieragostini
Alessandro (nel 1925 è al civ.35r);--- 16 negozio mobili di Sanguinetti
Michele;--- 21 l’ombrellaio Motta Quirico;--- 22r commestibili di
Marzocchi Francesco;--- 23 brillatori di riso F.Franchini e C.;--- 25
Verardo Eugenio 1908 confettiere (1912, è
solo pasticciere);--- 27 Rebora
Giuseppe con negozio di cereali;--- 27r forno per produzione di pane di
Bozzone Domenico; e fabbrica di pesi e misure di Ferrari Gatti e C. (anche in via s.Antonio);--- 29r vende velocipedi Rosso Omero;--- civ. 30 Castello
Jole levatrice;--- 34 negozio commestibili di Bagnasco Maria;--- 38 dentista
Odino Filippo;--- 41r commestibili di Marchese Angela;--- 42.11
appaltatore di costruzioni Piano Agostino, →1912, (oppure Domenico);--- 52
il droghiere Coppo Rinaldo;--- 52-4 Masnata Silvio tel 1889 fa filetti
per macchine e rappresentante ‘di macchine in genere’;--- 56 levatrice
Moretti Teresa;--- 59r un ufficio commerciale e rappresentanze di Adené
Ferdinando;--- 60 elettricista Orsi Angelo;--- 68r commestibili
di Multedo Giuseppe;--- 118r commestibili di Grasso Agostino;--- 132r
commestibili di Bruzzone GB;--- 166r commestibili di Cuneo
Oreste;--- 178r impresa trasporti di Mattioli T.;- 184r
commestibili di Monteverde Giovanni;--- 201r l’orologiaio Carlevaro
Lindo.→1912;- 223r negozio di pellame di Mignone Tomaso;--- 254r
commestibili di Dagnino Agostino;- 286r commestibili di Parodi
Angela;- 304r commestibili di Oneto Filippina.
---Non
specificato il civico: Canessa Ernesto→1912 fabbrica di casse;---
Pittaluga Luigi con negozio di frutta secca ed agrumi nell’archivolto
ferroviario;--- impermeabili fratelli Conte fu Lazzaro →1912 (nel 1925 è anche in via Mazzini 10-2: sartoria civile
e militare per ufficiali con drapperie inglesi finissime e nazionali. Forniture
per Municipi, collegi. Fabbrica di beretti (sic. ma altrove, berretti),
specialità per forniture e ufficiali-fornitore del Municipio di Genova e
Ferrovie dello Stato);--- farmacia Della Ferrera Francesco →1912
(nel 1919 è al civ. 202r tel.2975; non
c’è nel 1919,’21,’25; il proprietario appare nel 1919 lo stesso della
farmacia di via Marabotto,25);--- lo
straccivendolo Veardo che ritroveremo nel
1925 e 1933 in vico Stretto dove ora c’è con lo stesso mestiere Frontali
Socrate;--- impresa trasporti fratelli Bagnasco
(nel 1925¨ è solo Giacomo al civ.44-7);--- società’ Cooperativa
tra spazzaturai’ 1912;--- Dotto cav. Federico, scultore;--- Ivaldi,
1912, fa il confettiere nella via quando essa inizia a chiamarsi Pza
Ferrer);--- Cavo Zaccaria asfaltista;--- Bagnasco Giacomo impresa trasporti;---
Spanò e Solari negozio mobili;--- Mainetto V, negozio di mode;--- l’ebanista
Policarpo Sanguinetti;--- Canepa Ernesta con negozio di vetrami;--- Ivaldi
Bartolomeo fu Carlo salumiere---.
===civ.54 dal 1920 ed attiva ancora nel 1933 vi
operava una “società di Mutuo Soccorso di impiegati
civili” di Sampierdarena.
Negli anni trenta, vi aveva sede all’interno 6 una soc.an.
Ateneo musicale intestato a G.Monteverdi. (Già
erano aperti lungo la strada, la farmacia della Ferrera ed il cinema Dante).
Nel marzo 1921, dal Comune
vengono sottoposte ad aumento delle tasse una
serie di società aperte nella strada: al civ.19 la soc.Ligure Lavorazioni Latta e Fabbrica conserva (vedi via G.Buranello, Centro Civico);--- al civ. 104 Santamaria
Carlo , ferramenti d’acciaio;--
Nel Pagano/1925 compaiono nuovi: al 9 il sarto Bonatti
Achille;---al 17 Nasturzio Silvestro¨ è: (a) produzione di casse di legno (nel 1920 aveva una delle sei
fabbriche locali di conserve alimentari, in
via C.Colombo; nel 1921 appare in via Vitt.Em. al civ.32A; nel 1925 ha qui - al
17, con tel.41207 - uno dei nove stabilimenti similari locali); b) al 17 la
fabbrica e negozio di conserve alimentari,
tel.41353; c) al 17 lavorazione della latta e litografie tel 41-207);--- al 17r
ha sede una “soc. Ligure per la lavorazione della latta
e la fabbricazione delle conserve, Anonima”, (sic),”telef. interc. 41453”;--- al
19 la “soc.an.R.D.Diana & C. (industria e commercio della latta”);--- e Costa Giacomo fu A. negoziante di olio d’oliva e di seme;--- al 22 negozio di sale e tabacchi di Platone Carlo;--- al 25
il tabacchino Cipollina Carlo;--- 27r
il fornaio Borzone Domenico;---
36 l’abitazione del prof. Skultecki E.
grande protagonista dell’Ospedale cittadino;--- 36-2 l’esportatore
Burlando dott. Francesco;--- 38 p.p. ha il suo gabinetto dentistico il
dr. Rasia dal Polo Remo;--- 42n e 163r
e 214r Traverso Luigi tappezziere ha
una segheria e mobilificio; e lavora con
Canepa come falegname ( anche in
v.Gioberti);---; al 48 il sarto
Cardillo Antonio;--- al 60 Taricco & C.si impegnano sia per lo
sfruttamento dei brevetti, sia per la e
gestione della “ELASTIT (copertura elastica impermeabile brevetto G.Fava);---
al 87-89r archivolti ferroviari la fabbrica di soda
di Carretta A.F.;--- al 127r i f.lli Cavo asfaltisti;---145
la tintoria di Cardinale Carlo;--- civ.
163r l’officina meccanica f.lli Balestrino fu G. per “lavoraz. stampi per
la lavorazione della latta”:--- civ.186-8r
Nicelli Arturo¨ negozio di merceria,
biancheria, maglieria specialità per bambini;---civ. 188-190 Vedorato
Luigi vende forniture industriali di materiali elettrici;---
205r negozio di mobili di Ambrosini
Annibale¨ (con fabbrica in v.ACairoli)--223r negozio pollame
di Mignone Tomaso;--- al 238r la ‘Sartoria
Internazionale’ di Vitale Angelo, tel. 34-96;---262 tessuti di Robotti & Lusuardi presente ancora
nel ‘33;--- al civ. 298 il calzaturificio di
Lanzini & Tegoni;---292r la fabbrica profumi di Comotto Achille
& Cornelia;--- a 306-8r Taborelli Giuseppe ha una succursale delle
‘seterie di Como’;--- 314r Parodi e Parodi hanno negozio di ferramenta;---
cc.NP = Ristorante-trattoria ‘TESTIN’
posta all’angolo con via Gioberti;---Vaggi Onorato¨ confettiere
pasticciere;--- Bagnasco Emanuele, trasporti;---
agenzia della Banca Commerciale Italiana (dal 1919);--- Banca Popolare (Sampierdarena), istituto di credito
ed esattoria;---- eredi Forni Enrico legnami (via Buranello lato
mare altezza via
Gioberti);--- Galoppini
Fratelli¨ lavorazione latta (a monte in via A.Castelli);--- Homberger Walther (¨civ.32, & C.o), articoli tecnici, fornitura industriale;---
Massardo Diana & C , conserve alimentari (a levante di via A.Castelli. Nel 1926, una carta intestata alla ‘litografia e
lavorazione della latta soc.an. R.D.Diana & C’., ubicata al civ.19 di
questa via e con numero telefonico 11.472, fatturava una ordinazione di
‘creolina Pearson’, da essere ‘consegnata a ½ Vs/carro’. Nel 1961 risulta
ancora presente (ma spa, in via G.Buranello, 85r));--- Ottone Giorgio negoziante
in olio;--- Repossi Adolfo , titolare
cinematografo Dante.
Nel 1926 quando avvenne
l’unificazione comunale nella Grande Genova, la via esisteva a SPd’Arena (dalla Lanterna a piazza Bovio, da questa a piazza
V.Veneto ed anche una piazza), a Nervi (piazza
e viale), Rivarolo, Sestri, Borzoli, Centro, Pegli, Pontedecimo, Prà,
Quarto, S.Quirico, Voltri.
Nel 1931 era già percorsa da intenso traffico giornaliero, con
4861 veicoli così suddivisi, 1695 auto, 994
camion dei quali 480 a grande portata, 1756 tram dei quali 700 con rimorchio,
370 autobus, 75 moto, 12 carri a trazione animale, 13 biciclette, 9 carretti a
mano.
La titolazione stradale ancora
c’era nel 1933, da largo Lanterna al sottopasso di piazza V.Veneto, di
2.a categoria. In questi anni vengono ricordati alcuni esercizi aperti sulla
strada: una fabbrica di cappelli Bellini (non unica in città: in una foto del 1910 troneggia una
grossa insegna murale nei pressi di piazza Barabino, di un’altra fabbrica di
cappelli di Donato Fanfani, nonché il vasto cappellificio di via A.Doria (v.Giovanetti); l’Ateneo Musicale ‘G.Monteverdi’ con sede principale a Genova in via Ettore Vernazza.
Nel Pagano/1933 (già dal 1925=¨) sono descritti: al civ.2, dal 1925, il negozio di cereali e carrube di Dellepiane Davide;--- al civ.
5 una fabbrica di acque gassate di
Sanguinetti Antonio con, al 14-a un deposito di birra
(quest’ultimo civ., era la fabbrica);
---
sempre al 5 fabbrica di colori e vernici Lechner & Muratori
(casa italo svizzera-, con uffici in via
Mameli – a destra, cartolina usata per ordinazioni: a Vado vengono ordinati in
data 7 settembre 1923, 4 fusti di ossido ferro rosso v);---

---16
il verniciatore Burlando Luigi¨ (dal 1925; vedi al 105);---16r l’ottonaio con
saldature autogene Volta Luigi presente
dal 1925;--- 19 i tornitori eredi
di Boccardo Giuseppe in attività dal 1925;---
21 i f.lli Galoppini con ‘casse in legno, e
litografie per illustrazioni casse
e latte per conserve alimentari. Telef.41.224’;--- «civ.22, all’angolo con
v.della Cella il negozio di ombrelli di
Prini Francesco;---23 il negoz. vini di Rivara
Francesco (dal 1925)¨;--- 26 i magazzini dei figli di Enrico Forni negozianti in legnami;--- 30.p.t
il fotografo Svicher Alfredo
(uno dei primi a fissare Genova con
immagini artistiche, e punto di riferimento locale per ogni ritratto, da quello
tombale ai matrimoni e di ricordo. Proveniva da Amburgo nel 1890; divenne
cavaliere e sposò una Storace con la quale fece nascere Michele, che aveva
l’hobby della poesia e dello studio della Liguria e che prosegì l’attività nel
negozio vicino al cinema;--- 32 (pal.De
FRANCHI, oggi civ.14) la Assicurazioni
“Liguria”, sindacato di mutua contro infortuni
del Lavoro, tel. 41262;--- 36-2 e 40 gli importatore, esportatore dr
Burlando Francesco ed Ottone Giorgio & figli;--- 42-11 l’appaltatore Piano
Agostino e costruttore
edile Piano Domenico (ambedue dal 1925);--- al 44 Cavanna
Nicolò, già dal 1925 con negozio di calzature ed articoli per
calzolai ed al 44-4 l’accordatore di pianoforti
Rovegno Luigi (dal ’25); 48, il floricoltore Magnanego
Dionisio (dal ’25);--- 51 il droghiere Coppo
Rinaldo (dal ’25); 54 negozio di ferramenta di
Masnata Silvio (anche rappresentante macchine in genere, ritagliatura meccanica
e lime, tel. 304);--- 68r commestibili di
Multedo Giuseppe (dal ’25); 85r Picagli A.F. offre impianti elettrici;--- 105-6 arcate
ferroviarie, impresa di coloritura e verniciatura di Burlando Edoardo (vedi al civ.16¨);--- 118r commestibili di Grasso
Agostino¨;--- 121r DeAmici Enrico¨ importatore ed esportatore, è
rappresentante di conserve alimentari;--- 129r
i f.lli Rossi sono incisori;--- 132r commestibili di Bruzzone GB¨;---
134r negozio di biacca e vernici di Ruffini Ennio¨ (anche in via C.Colombo);--- 151 floricoltore (sic) Franco Margherita¨;---
163A il fotografo Roasio Virginio;---
al 164 il “Gran Caffé Dante” di Falciola Francesco;--- 164r l’officina meccanica di Grillo Andrea¨;---
169r il vetraio Meirana Bartolomeo¨;--- 171r negozio e grossista di olio
d’oliva e di semi Ferrua Salvatore
ed il salumiere
Parodi Giuseppe¨ fu Luca;--- al 184r i commestibili
di Morasso Coronata¨;--- 187r deposito
ed ufficio di Gatti Epifanio¨ fu L. succ. Gatti G. e E. f.lli fu L. (Fabbr.Lig. strumenti per pesare
e costruz.metalliche, con officina (nel ¨
in via A.Doria 60r) in v.C.Colombo;--- 195r
Masnata Salvatore¨ vende armi e munizioni;---
198r negozio di materiale elettrico di Vedovato Luigi¨;---
201r l’orologiaio Toselli Oreste; 203r il caffè Delfrate Ferruccio¨ poi Baldini-Podestà;--- 206r il ristorante “Umberto”;--- (al 207r
–non citato dal Pagano- è invece una fattura del 1934 dei Parodi e Parodi ferramenta,-ottonai/utensili
ed attrezzi/articoli casalinghi/armi e munizioni, tel.41-313; ---209r tintoria Alfieri Antonietta;---
256r il salumiere ditta GalloA¨. in Galliano Costantino¨ vende anche funghi
secchi;--- 260r negoz. di macchine per cucire, di Conte Cesare (dal 1912 rappr. “Naumann);--- 262r
fabbrica impermeabili e negoz. tessuti Robotti & Lusuardi¨;--- 304r gli eredi
Sciaccaluga Emanuele¨ vendono ricco assortimento di apparecchi fotografici,
pellicole, articoli ottici, binoccoli (sic) per teatro, marina e campagna,
ecc.;--- mentre Oneto Filippina¨ vende commestibili;--- 312.4.6 r, di nuovo i Parodi e Parodi come al 207r
Non
specificato dove, l’orologiaio Bonacini
Ezio;- il pasticciere
Savelli Umberto¨;- 3 pizzicagnoli Alpa Ferdinando¨ , Ferrando A.¨, Lanfranconi¨;- un quarto salumiere
Ivaldi Amedeo¨ fu Bartolomeo;- il tappezziere Morando Emilio (nel ¨ in via Gioberti);- il neg. tessuti f.lli Conte fu Lazzaro¨ (anche in v.Mazzini, tel41140,
grande assortimento drapperie nazionali ed inglesi finissime-panni finissimi per
livree ed uniformi e colorati per mostreggi- tessuti gommati e loden in pezza
per impermeabili, fustagni, tele, velluti, foderami. Vendita a metro);- il droghiere Attilio Bottaro¨;- Pedemonte Nunzio¨ che in un archiv.ferrovia vende
frutta, agrumi e verdure.
Ma proprio in quegli anni,
dopo iniziati (nel 1928) i primi espropri
per erigere l’elicoidale e formare la nuova via di Francia (su cui fu spostato il traffico tranviario rinunciando
alla galleria), il tratto iniziale fu inglobato in largo Lanterna, la
cui targa si sovrappose alla precedente; nacque la via Chiusa (il nome ufficiale fu dato il 18
gennaio 1954 per delibera del Consiglio comunale, col cambio alla pari di tutti
i civici 1, 3, 5, 7 e 2, 4 che erano divenuti tali dopo revisione della
numerazione effettuata nel 1951) per il tratto sino a piazza Bovio (N.Barabino): via Vittorio Emanuele rimase al
solo tratto tra le due piazze.
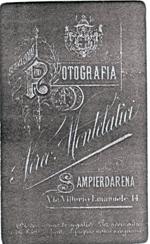
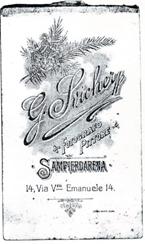
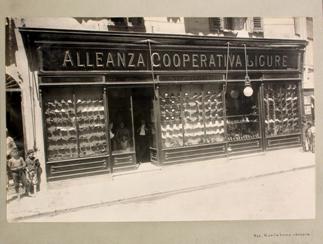
foto di proprietà biblioteca Gallino – rivendita scarpe
Il 19 agosto 1935 divenne ‘via 2° Fascio d’Italia’ ed il
12 maggio 1945 -fino ad oggi- ‘via
G.Buranello’.
===Al
civ 17 si apriva lo stabilimento Nasturzio Silvestro, acciaieria e fabbricante
di bande stagnate.
Allo
stesso 17r si apriva nel 1933 la soc.Ligure per la lavorazione della latta e
la fabbricazione di conserve
===Al
19 aveva sede sempre nel 1933 la soc. anon. R.D.Diana & C., industria e
commercio della latta
===
Al 26 era la ‘Nova Spes’, società di armatori.
===civ.30
Nel 1923 vi abitò un abilissimo incisore falsario di nome Pollastri Attilio
sedicente commerciante di vini ma in realtà ‘produttore’ in proprio di carta
moneta. Furbo, pur perdendo tutto il materiale era riuscito a fuggire alla
cattura avendo nascosto la sua attività dietro svariati nomi ed utilizzando più
sedi (via Chiusone 1r, via Gioberti 12r, via R.Parodi 7/2). Fu catturato poi
nel 1948 quando 65enne non falsificava più le cento lire ma le diecimila. Di
lui inteso come ‘il più abile’, si è fatta memoria nel 2004 ai primi euro falsi
trovati sul mercato.
===Al
civ.32 si apriva negli anni 1933 una azienda, la ‘Pearson Guglielmo’ col n° telefonico 41-346. (Dal
Pagano/1912 è descritta, per la prima volta, in via G.Alessi, tel 599; dal
Pagano/1919-1926 è in largo Lanterna 8 tel 5310). Produttrice di prodotti
chimici industriali e farmaceutici, era l’unica fabbrica del disinfettante
‘creolina’ con marchio brevettato: minacciava “procederò in via legale contro
chiunque imita od abusa in qualunque maniera la parola ‘creolina’; il creosolo
era un disinfettante impiegato anche per sciroppi anticatarrali e disinfettanti
in genere molto usato allora”; con essa produceva direttamente altri farmaci
chiamati Medol (un linimento, anche lui marchio brevettato) e Pacolol (creosolo
saponato) nonché in apposite grandi vasche e caldaie lavorava il sego importato
puro per fare saponi di toilette ed inscatolare il famigerato per i bambini di
allora olio di fegato di merluzzo, la vaselina borica, la soda caustica, la
pece greca. Fu il primo importatore locale del famoso ddt . Nel Pagano 1950
risulta ancora in attività, in via Buranello 14, telef. 41-316.
=== civ. 90 il cinema Dante, poi Odeon, oggi Eldorado. Locale sempre
molto popolare, e per lungo tempo il preferito dai bambini.
Degli attori concittadini di
allora, vengono ricordati solo i fratelli Aldo ed Enrico Poggi.
DEDICATA
a
Vittorio Emanuele II di Savoia,
ultimo re di Sardegna e primo re d’Italia; fu chiamato il “padre della Patria ”o
“il re galantuomo”.
Nato a Torino il
14.3.1820, primogenito di Carlo Alberto e
di Maria Teresa d’Asburgo-Lorena.
Fu cresciuto con educazione
rigida militaresca; ostile fin dalla giovinezza alle tendenze liberaleggianti
(elezione Pio IX- 1846- e quindi contrario alla Costituzione concessa dal
padre) ed alla presenza austriaca in Italia.
Aveva sposato nel 1842 la cugina austriaca Maria Adelaide
d’Asburgo, figlia dell’arciduca Ranieri e di Elisabetta Savoi;, dalla quale
ebbe sei figli (altri scrivono otto figli; ella morì nel 1855).

Ebbe il battesimo di fuoco alla battaglia di Pastrengo,
meritando una medaglia d’argento al VM; poi a 28 anni a Goito (30 maggio 1848), meritò quella d’oro perché in un momento
di grande difficoltà, si lanciò contro il nemico gridando “a me le guardie” e
capovolgendo così le sorti dello scontro; e poi a Custoza (23 luglio).
D’altronde lui, figura esuberante, di carattere rude,
più quasi un rozzo militare che un raffinato uomo di corte, riuscì a
guadagnarsi la più ampia simpatia popolare.
Successe ventottenne - il 23
mar.1849 - al padre Carlo Alberto, che abdicò andando in esilio ad Oporto nel
Portogallo, proprio nel triste giorno della sconfitta di Novara (1ª guerra di
Indipendenza, con itt.Eman comandante di divisione, con modesti risultati
militari); mossa ritenuta necessaria per contenere le ovvie pretese
dell’Austria vincitrice proprio in un momento cruciale legato alle casse
vuote, la guerra perduta, critiche aspre dai repubblicani, gli operai in
fermento.
Divenne così re di Sardegna dovendo
per primo atto negoziare l’armistizio a Vignale (Novara) e successiva, 10.8.49,
pace di Milano (la Camera respinse per due volte
la ratifica di questa pace, mentre era primo ministro M.D’Azeglio; a qesta
scelta fece seguito a novembre il “proclama di Moncalieri” con il quale
chiedeva che i parlamentari fossero più razionali e consapevoli della
responsabilità di fronte alla reale situazione: il nuovo parlamento ratificò la
pace).
Fu in questo contesto che,
divenuto re, dovette dimostrare subito avere polso, fermezza ed equilibrio,
facendo prevalere l’idea - radicata nell’educazione – decisamente
antiliberaleggiante. Ed a riceverne i danni fu proprio Genova che in quel
mometo osò rivendicare dei propri diritti che il re ritenne inopportuni e
meritevoli di essere soffocati anche usando violenza e versando sangue del suo
popolo. Poca potè sembrare da allora in poi la differenza tra regno, regime e
dittatura: chi non condivideva o addirittura era contro, era classificato un
bandito e quindi da eliminare –politicamente e fisicamente-.
Già
per Genova, l’annessione era avvenuta in un contesto irregolare, in virtù di
equilibi internazionali dove l’Inghilterra giocava dall’alto delle carte a suo
favore mirate a creare situazioni che potessero sfavorire la Francia e
l’Austria: l’annessione della Liguria al Piemonte era il frutto di un lungo
maturare di eventi: dall’essere stati pro Napoleone anche se da sottomessi,
dall’essere ricchi e pieni di crediti internazionali (da azzerare così),
dall’essere Repubblica di fronte ai Regni.
In
più, Genova aveva altri diritti che non erano stati riconosciuti fin dalla
sottomissione forzata al governo torinese: da subito aveva ricevuto che
l’inclusione era avvenuta per mero interesse economico (tasse ed obblighi, compreso il servizio militare),
di prestigio (allargamento
di territorio), di sbocco al mare (tenuto inutilizzato nel potenziamento, ma non per
pagare gabelle), senza corrispondente
ammissione di fiducia (nei suoi
imprenditori, nelle sue industrie, nel suo porto, nella sua marina), di fratellanza (né
economica, né amministrativa, né sociale), di
doveroso riconoscimento (gli innumerevoli
volontari al servizio di Garibaldi, perché venivano ritenuti infidi in quanto
seppur miravano all’unità della patria, conservavano non celato lo spirito
repubblicano di Mazzini).
La
ribellione popolare subì la dura repressione del generale LaMarmora, con le
ciliegine dell’offesa (‘vil razza dannata’),
della simbolica sottomissione delle code dei
leoni nello stemma, della taciuta verità nei testi di storia nei quali gli
eventi neanche sono descritti e storici, come l’Abba, messi in condizioni di
negare che fossero accaduti.
Per sua fortuna,
dall’insediamento, fu aiutato da valenti uomini politici che generalmente gli
fecero fare scelte opportune, tanto da meritare dal D’Azeglio la definizione di
“re galantuomo”.
Fu dapprima il ministro Siccardi
che gli propose il passaggio dallo stato feudale a quello moderno (iniziando
con l’eliminazione dei tribunali ecclesiastici, la limitazione dei loro beni e
del diritto d’asilo: ovvero liberarsi dell’ingombrante ed assillante influenza
del clero)
Dal 1852
fu coadiuvato dal Cavour, con i risultati fortunati, frutto dell’abbinamento
impulsività di uno, fredda e scaltra capacità di decisione dell’altro: così a
seguire, le varie coalizioni internazionali risultate vincenti; la spedizione
in Crimea nel 1855; i rapporti col Papa con
il quale si stabilì il rapporto “libera chiesa in libero stato”; l’alleanza con
la Francia con la quale conseguirono le vittoriose battaglie della 2ª guerra
d’Indipendenza (pace di Villafranca) e 3ª
(respinto l’ultimatum di Francesco Giuseppe e
forte dell’alleanza francese, volle il comando supremo, con battaglie finali di
Solferino e san Martino alle quali seguì il forzato armistizio per il ritiro di
Napoleone dall’alleanza); i delicati, invisi ma ricercati rapporti con i
garibaldini specie durante la spedizione in Sicilia; i problemi del Veneto; non
sempre tutto filava liscio tra i due: disaccordi, dimissioni, scontri aperti su
temi calamitosi (la questione romana, la pace di
Villafranca, la dolorosa decisione di Aspromonte, le tristi ore di Custoza e Mentana).
Importante ricordare, del 1859 inaugurando la sessione parlamentare, la
famsa frase “non essere insensibile al grido di dolore che si leva da tutta
l’Italia”. Nel 1860 invase l’Umbria e le Marche e dall’Abruzzo scese in
Campania incontrando Garibaldio a Teano
Divenne re d’Italia nel 1861 (anno della morte del Cavour, al quale
successe prima Ricasoli poi Rattazzi).

Nel 1869 sposò morganicamente la bella Rosina (Rosa Vercellana
Guerrieri, che divenne contessa di Mirafiori e Fontanafredda e dalla quale ebbe
un figlio).
L’apice della gloria fu raggiunto
– in concomitanza della caduta di Napoleone III - con la conquista di Roma il
20 sett.1870 e l’insediamento nel Quirinale; di nuovo a memoria, le parole
dette alla prima convocazione del parlamento, “l’opera a cui consacrammo la
vita, è compiuta“ dimostrano la forza di uno spirito avventuroso e decisionale.
Morì a Roma il 9 gennaio 1878.
Gli successe il figlio Umberto
I
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri F.-Guida illustrativa
per la città...-Sambolino.1875-pag.656 che
sbaglia affermando di percorrere via V.Emanuele mentre indicando trovarvi il
teatro Ristori e la chiesa della Cella, in realtà percorreva via reale della
Marina –poi via C.Colombo- più a mare
-A.sconosciuto-Storia del trasporto
pubblico a Ge.-Sagep.’80-152.157.232
-Archivio Storico Comunale
-Archivio S.Comunale,
Toponomastica - scheda 4692
-AA.VV.-1886-1996 Oltre un secolo
di Lig.-Il SecoloXIX-pag. 109.235.392
-AA.VV.-Le ville del
genovesato-Valenti.1984-pag.65
-Boero P.-Scuola educazionbe
immaginario-Brigati.1999-pag.47
-Ciliento B.-gli scozzesi in
piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.55
-DeLandolina GC
-Sampierdarena-Rinascenza .1922- pag. 58
-Dicorato G-Domenica Quiz-n.29
del 17 luglio 2008-pag.23
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Enciclopedia Zanichelli
-Gazzettino
Sampierdarenese:7/80.7 + 5/83.5 + 8/85.3+ 4/02.8+ 04/04.7
-Genova, rivista municipale :
3/31.222
-Google-Wikipedia-Emilio Salgari-
agosto2008
-Il Secolo XIX –quotidiano- 09.05.98
+ 24.09.03 + 02.02.04
-Lauria D.-Emigrazione speranza
di..-banda stagna-Algraphy2005-pag.132
-Lorigiola dr.G.-Cronistoria
documentata...-Palmieri.1898-frontespizio
-Novella P.-Strade di
Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.19
-Minnella M.F.-Genova dei
viaggiatori e dei poeti-E.Riuniti.2003-pg.169
-Morabito.Costa-Universo della
solidarietà-Priamar.1995-pag.438.489
-N.N.-Raccolta di nozioni
generali per l’uso del calderaio...-Tosi.1918-
-Pagano/1908–pagg.873-879---/33-pag.249.825.839.1179---/61-pag.588
-Pozzo F.-L’editore genovese
Anton Donath-La Berio n.2/2010-pag.56
-Stradario del Comune di Genova
edito 1953- pag. 185
-Tuvo T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani.1983-pag. 30 foto
-Tuvo&Campagnol-Storia di
SPd’Arena-D’Amore.’75-pag.201foto. 237.327
-Zanotto P.-E.Salgari- su ‘Prezzemolo’ periodico mensile-anno
1.n.2-pag6
VITTORIO
piazza Vittorio Emanuele III
Una nuova piazza creatasi alla
congiunzione tra via Umberto I (via Reti-W.Fillak) e via A. Saffi (via C.Rolando), dichiarata pubblica dalla giunta
comunale (considerato che prima era terreno patrimoniale ed in carte vecchie vi
appare costruito), fu dedicata al nuovo re , nel 1906.
Corrisponde all’attuale piazza R.Masnata.
Già dai primi anni del 1900
vi si teneva un mercato; appare però che nel 1926 l’ufficio di Polizia urbana
l’aveva già spostato in piazza dei Mille (piazza
Ghiglione).
Con questo nome
ufficializzato, appare la piazza nell’elenco delle vie pubblicato nel 1910 dal
comune; posta ‘al bivio delle vie Umberto I ed A. Saffi’, senza civici.
 piazza V.Emanuele
III
piazza V.Emanuele
III
Nel 1926 SPd’Arena fu
unificata nella Grande Genova: nel 1927 il nuovo comune stilò l’elenco delle
vie esistenti nel nuovo grande complesso e con questo titolo compaiono solo Pra
e Quinto; la nostra piazza evidentemente non fu omologata e fu proposta per
cambiamento.
Nel 1933 era ancora alla
congiunzione tra via Milite Ignoto (v.P.Reti)
, via Umberto I e via A.Saffi ; di 3.a categoria.
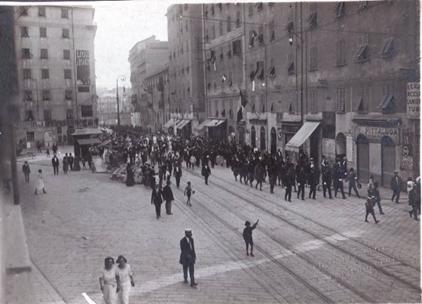 sfilata anni
1922- collez.Canepa
sfilata anni
1922- collez.Canepa
Ma con decreto del podestà del
19 agosto 1935 l’annullamento della titolazione fu finalmente ufficializzata e
divenne dapprima parte di via delle Corporazioni, poi –dal 5 luglio 1945- parte
di via P.Reti.
Solo per delibera della giunta
comunale del 26 aprile 1946, riassunse nome proprio, dedicata al partigiano.
DEDICATA al re Vittorio
Emanuele III di Savoia, figlio di Umberto I e di Margherita di Savoia. Nato a
Napoli l’11 nov.1869 , e morto in esilio il 28 dic.1947.
Da giovane fu sottoposto ad
una disciplina scolastica assieme umanitaria e militare assai rigorosa, sotto
la guida del generale Osio: acquisì così sia una cultura generale vasta e
profonda, nonché quella militare che percorse da sottotenente di fanteria a
generale di corpo d’armata. Pubblicò un libro di numismatica, di alto valore
scientifico.
Il 24 ott.1896 sposò Elena
Petrovic Niegos, principessa del Montenegro, dalla quale ebbe cinque figli.
Alla morte del padre ucciso dall’anarchico Bresci il 29 lug.1900, gli successe
al trono, proclamando di seguirne i consigli ed imitare le virtù. Inizialmente
dimostrò saper tenere fede ai patti giurati, dando adeguate disposizioni al
governo, presenziando i soccorsi in Calabria devastata dal terremoto (1905 e
1908), ed a Napoli flagellata dal Vesuvio (1906); accettò il riconoscimento di
sovranità sulla Libia (1912); partecipò in primo piano (affidò la luogotenenza del regno, allo zio Tommaso, duca di Genova; e
seguì nelle retrovie, le vari operazioni di guerra senza esercitare il comando)
alla titanica lotta conclusiva dell’unificazione, nella prima guerra mondiale (1915-18),
acquisendo il titolo confidenziale di “re soldato” e, nell’apologia anche di
“re gentile”, e “re vittorioso”. Nella satira era “re nano”.
Nel 1922, esercitò
ambiguamente con il potere che aveva, sino alla lenta ma effettiva connivenza
col fascismo dopo la marcia su Roma: rifiutò firmare il decreto Facta (una
specie di stato di assedio); però dovette dare fiducia a Mussolini da cui non
riuscì più a svincolarsi neppure dopo il delitto Matteotti.
Così, seppur apparentemente
riluttante alla politica fascista, non seppe dimostrare mai effettiva autorità
né autonomia; anzi, sottoponendosi alla lenta ma corrosiva invadenza del
partito, accettando le blandizie espansionistiche che lo fecero divenire
imperatore di Etiopia nel 1936 e re di Albania nel 1939; ma soprattutto non
opponendosi alla guerra del 1940, anche se ne rifiutò il comando.
L’acme degli errori arrivò
quando, di fronte alla sconfitta militare, seppur favorevole all’armistizio con
gli Alleati affidando a Badoglio l’incarico della firma, perse le redini della
nazione: temendo la reazione dei tedeschi, abbandonò fuggendo (da Brindisi, l’8
sett.1943) il posto di responsabilità che il suo rango gli imponeva, rifugiandosi
all’estero presso gli angloamericani, rinunciando alle corone coloniali,
nominando luogotenente del regno il figlio, ed infine abdicando (9 maggio 1946)
nell’imminenza del plebiscito istituzionale.
Portò così nello squallore più
basso l’immagine della casa regnante.
Col semplice titolo di conte
di Pollenzo, si ritirò ad Alessandria d’Egitto, ove morì l’anno successivo.
Il figlio, più capace ed
equilibrato, riuscì a fare il cosiddetto colpo di coda all’onore della propria
casata in occasione del plebiscito regno-repubblica, non sufficiente però per
vincere.
BIBLIOGRAFIA
-AA.VV.-SPd’Arena nella sua
amministrazione fascista-Reale.26-pag.71
-DeLandolina GC.-Sampierdarena
-Rinascenza.1922 – pag. 58
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4697
-Enciclopedia Sonzogno
-Novella P.-Strade di Genova-Manosctritto
b.Berio.1900-pag.19
-Pagano 1933-pag.249
VITTORIO VENETO piazza Vittorio Veneto
TARGHE: piazza –
Vittorio Veneto
S.Pier d’Arena – Piazza – Vittorio Veneto


in angolo
con v.S.Dondero. Nel 2007 unica di plastica


in angolo
con p.za G.Modena – palazzo Balbi


angolo con
via Bombrini, palazzo Hotel Primavera

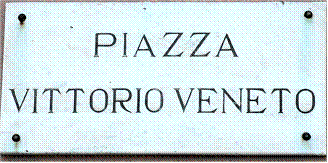
in angolo
con v.S.Canzio


dal
sottopasso ferroviario, nascosta dietro gabbiotto AMT
QUARTIERE
ANTICO: Mercato
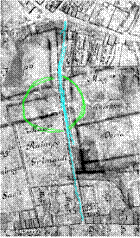 da MVinzoni 1757. Ipotetica zona ove si aprirà la piazza. In
celeste, la crosa dei Buoi
da MVinzoni 1757. Ipotetica zona ove si aprirà la piazza. In
celeste, la crosa dei Buoi
N°
IMMATRICOLAZIONE: 2862 CATEGORIA: 1
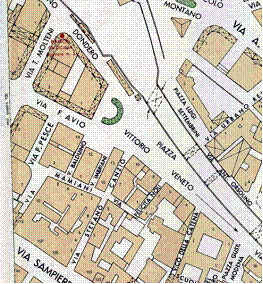 Da Pagano 1961
Da Pagano 1961
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA -n°: 64960
UNITÀ
URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA
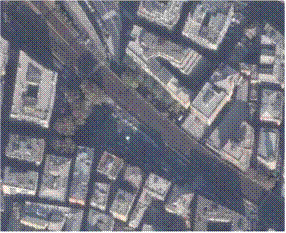 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16149
PARROCCHIA: s.Maria della Cella.
STRUTTURA: piazza
ad altissima intensità di traffico (più di 15mila veicoli al giorno) sviluppato
con doppio senso veicolare; collega via G.Buranello con via S.Dondero, via
F.Avio, e sottopasso ferroviario. Lunga 185m.; larga da 16 a 65m. circa;
piatta.
Roncagliolo fa notare che ancora nel 1920 la piazza era
quasi mezzo metro più bassa come livello, rispetto l’attuale e quindi assai
soggetta ad alluvionarsi (essendo la crosa dei Buoi lievemente in salita),
obbligando ad attraversare la piazza, in barca (10 cent./persona, 5 ragazzi);
fu rialzata nel 1935 con i lavori di via A.Cantore
STORIA: Nella
carta vinzoniana del 1757, i Doria ed i Grimaldi erano i più vasti
proprietari del terreno corrispondente. Prima del 1840, il terreno
faceva parte del giardino, o della villa Carpaneto che, dall’attuale piazza
Montano si estendeva sino al mare (almeno la parte più a ovest); o della villa
Centurione del Monastero (almeno la parte più a est della piazza, dal Modena).
Piazza OMNIBUS (vedi) Fu Raffaele Rubattino, intraprendente impresario genovese – che aveva già tentato sia
l’impresa arduissima di collegare Genova con Milano tramite un servizio di
diligenze, postale e passeggeri, sia quella amatoriale; copiò l’idea che era
stata messa in atto prima a New York e poi estesa positivamente a Parigi,
Praga, Amsterdam - che nel 1841 costituì assieme ad Ignazio Venturini la prima
impresa genovese di SERVIZIO TRASPORTO con traino a cavalli, da San Pier
d’Arena (da questa piazza in particolare; poiché in quegli anni ancora non
erano stati fissati i nomi delle strade, ed una zona veniva chiamata in
funzione della maggiore rappresentatività locale, la piazza fu popolarmente
battezzata “piazza Omnibus”) a Porta Pila ogni mezz’ora, per
collegare -in coincidenza- l’arrivo dei suoi piroscafi dal Mediterraneo con la
diligenza per Milano. Il ‘Corriere Mercantile’ del 4 luglio e l’ “Espero” del
10 luglio annunciano la prima corsa iniziante dal nostro borgo “a ponente della
casa Pittaluga”, del servizio che verrà chiamato Omnibus (cioè “a tutti, per
tutti”).
La costruzione della ferrovia Torino Genova, inaugurata domenica 18 dic.1853,
da san Benigno al torrente spezzò la serie di lunghi parchi privati,
tagliandoli trasversalmente a metà (evidentemente in contemporanea perdette di valore tutta la
proprietà di terreno a mare del viadotto, limitando così le ville al giardino
circostante); l’apertura della strada
affiancata la ferrovia (via Vittorio Emanuele, oggi G. Buranello) favorì l’utilizzo degli slarghi -iniziale e
finale- come piazza, (inizialmente
percorsa solo dai pedoni, rari cavalli a sella o carrozze private e carretti di
lavoro, con traffico non legato a particolari regole se non l’intraprendenza,
la frusta o il censo).


foto di fine 1800 – piazza Omnibus
Via Vittorio EMANUELE II – fu questo il primo
titolo ufficiale, che assunse la piazza non ancora riconoscita come tale ma
come tratto della lunga strada; per questo forse in contemporanea, popolarmente,
rimaneva ‘piazza Omnibus’.
Solo dopo il 1870, si provvide a creare
miglioria di questa prima rete, con vetture trainate da uno o due cavalli e
sempre senza eculissi.
In accordo con la Giunta comunale locale (e genovese, retta dal barone Andrea Podestà, quello che nel
1873 annetterà i primi sei comuni viciniori), il nuovo servizio fu affidato ed inaugurato nel mar.1873 dalla
“società LIGURE di TRASPORTI” finanziata con capitale belga/francese; la
piazza Vittorio Veneto, già più ben strutturata, fu scelta come cambio delle
pariglie e capolinea per le vetture provenienti ogni 5 minuti da porta Pila.
Il folklore dell’arrivo e partenza assunse via via tinte sempre più forti, da
semplice curiosità a viaggi pratici e di affari, cosicché la piazza divenne
centro di attività e di incontro, di intenditori di cavalli (balzani, forti, matti o solo vivaci;
gli zoccoli, le orecchie, i garretti, il dorso, il pelo, i finimenti, ecc), di rivenditori di ogni genere, curiosi,
viaggiatori (all’inizio,
non più di otto per vettura),
trasbordati in attesa di una ‘coincidenza’.
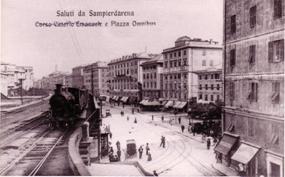
In
quegli anni di più grande fervore e rinnovamento sociale industriale ed
edilizio, e con una incalzante espansione demografica, il nuovo servizio fu
accolto favorevolmente anche perché finalmente tolto agli abusi dei singoli
trasporti privati (ovvio
il frequente litigio nelle strette e polverose vie cittadine dei mezzi privati
delle classi sociali più abbienti che dovevano ‘segnare il passo’ dietro ai
lenti carrozzoni dei mezzi pubblici. In un secondo tempo questi ultimi
proseguirono per Voltri o Bolzaneto, ma non arrivarono ancora a Pontedecimo; i
cavalli , erano bardati con lussuosi finimenti, adorni di cimieri e sonagliere;
le vetture arricchite di bandierine e fronzoli erano sia di tipo aperto sui
lati, o chiuse; queste ultime avevano 12 posti a sedere nell’interno, ed altri
10 sul terrazzo; provenivano da Genova raggirando san Benigno dalla nuova porta della Lanterna -costruita nel 1828 su disegno del gen.A.Chiodo ,e
proseguendo per via Vittorio Emanuele.
Il 10
mar. 1878 (sulla
base di precedente proposta del francese Adolfo Otlet al sindaco genovese
Ellena), avvenne il viaggio inaugurale
degli omnibus le cui vetture – erano sempre trainate da due-tre cavalli - ma
su guide d’acciaio a rotaia, per evitare le irregolarità del terreno. Il nuovo
servizio era gestito dalla “COMPAGNIA GENERALE FRANCESE di Tramways” (Otlet aveva stipulato un contratto
con il Sindaco genovese Negrotto Cambiaso il 13 gennaio 1877); fu chiamato ufficialmente ‘dei tramway’, o popolarmente “e rebellea” o
spregiativamente “treggia” o “tranvaietti”, a scartamento ridotto causa la
ristrettezza delle vie, guidati da conduttore in divisa: camiciotto blu e
foulard al collo rosso, bardatura dei cavalli nera per ‘fuori mura’, bianca
entro le mura.
Rapidissimi – in pochi mesi- da Genova si scavò un apposito tunnel di 256 metri sotto
san Benigno, sopra le
linee ferroviarie, che sbucasse in Largo Lanterna a cui le vetture arrivavano
attraversando un ponte –dapprima in legno e ferro, poi ricoperto- posto sopra un fosso difensivo,
affiancato da un posto di guardia e dal casotto per gli agenti del dazio) e mettendo in atto le rotaie, nel ponente sino a Bolzaneto e
Pegli.
La convivenza tra i due servizi finì con la sconfitta
della ‘Ligure’ che cedette (per 360mila lire di cui 132 in contanti ed il resto
in obbligazioni) lo stabilimento della Coscia, 199 cavalli, una giovane mula,
32 vetture chiuse, 13 giardiniere ed un carro funebre.
Nel ponente cittadino,
l’impianto a trazione elettrica su nuovo scartamento (portato a un metro, con
sostituzione delle rotaie) avvenne nel genn.1900 da parte dell’ UITE
(Unione Italiana Tramways Elettrici, nata nel settembre 1895) che aveva preso
in carico monopolistico il servizio. Il personale venne riassunto o si adattò a
condurre vetture per servizi vari; i cavalli vennero trasferiti in porto per il
traino dei vagoni ferroviari (il tutto non senza rimpianti e ribellioni : un
certo Grimaldi, per dimostrare che i cavalli erano meglio dei tram, dopo
un’ampia bevuta si lanciò a corsa sfrenata per le vie cittadine seminando
panico e confusione, finché ribaltatosi perdette la vita nell’incidente. Fu il
canto del cigno).
Nell’anno 1893 il viadotto ferroviario che
collegava piazza Omnibus a via N.Bixio, fu allargato alle dimensioni attuali.
La piazza, portava sempre il nome del sovrano, come tutta la strada dalla
Lanterna a Rivarolo.
Nell’intenzione delle giunte municipali gerenti dopo il 1900, la piazza
doveva abbellirsi modificando strutturalmente le vie di arrivo e deflusso,
decorare il sottopasso ferroviario secondo i disegni dei Coppedè; e doveva
ospitare un monumento ai caduti, di grosse proporzioni (il progetto approvato e finanziato
dalla Giunta sampierdarenese , non fu messo in atto dalla Giunta genovese dopo
l’assorbimento nella Grande Genova, probabilmente per distrazione della somma
ad altre opere, lasciando in memoria di chi aveva dato la vita in guerra, il
misero e squallido cippo posto nei giardini Pavanello). La piazza, limitata a lato mare da -per allora-
lussuosi e decorosi palazzi con spaziosi e belli negozi alla base, divenne così
il nuovo cuore della città, sede di comizi e raduni politici; luogo di
appuntamento per le compere (negozi delle Venchi Unica, l’ombrellaio Motta, oreficeria) e serale per teatri (Excelsior, Splendor, Politeama , ed i vicini Modena,
e Mameli); e centro -nei vari bar-
di riunione di tutti gli appassionati di competizioni sportive (con accese rivalità tra i
frequentatori dei vari bar-caffè diventati famosi).
Piazza
Francesco FERRER (vedi) Solo nel
1909-10, alla piazza fu dato un altro nome ufficiale, dello spagnolo morto
l’anno prima. Da questa
titolazione è chiaro il colore politico della Giunta comunale locale; quando al
governo centrale c’era il re, qui a SPd’Arena invece, a fianco dei
tradizionali repubblicani crescevano i socialisti ancora commisti ai radicali (questi ultimi autori della scelta del nome, in
buona parte massoni e quindi in barba ai Savoia, alla religione ed alla
sospirata repubblica).

piazza Ferrer
Piazza VITTORIO VENETO. Dopo la grande guerra del 1915-1918, il nome titolare fu
sostituito con la località veneta, simbolo di tutti i luoghi di battaglia e d
sofferta vittoria; e tale è rimasto sino ad oggi
immutato.
Ma
ancora nel Pagano/1921 certi
esercizi sono indifferentemente in v.VEman. e p.Ferrer.
Negli
anni 1915-40 era diventato il “salotto” di San Pier d’Arena o -meglio-
il “centro”; possedervi un negozio era sinonimo di punto di riferimento preciso
per tutti, e di essi, qualcuno è aperto ancora oggi.
Dopo
l’unificazione nella Grande Genova del 1926, uno degli impegni
dell’amministrazione subentrante, fu quello di investire nelle delegazioni
assorbite quanto di meglio era in atto di programmazione del Comune autonomo:
come sempre in politica, le promesse del singolo decadono di fronte agli
interessi del centro: per San Pier d’Arena, problema primario era la viabilità,
estensibile a tutto il ponente, ed il progetto era del 1925.
Quando fu creata la Grande Genova, il nuovo comune si trovò a scegliere tra
varie delegazioni a chi lasciare la titolazione della città veneta: se la
contendevano Bolzaneto, Voltri, Borzoli, Pegli, Rivarolo, Sestri e noi. Rimase
da noi definitivamente.
Negli
anni 1930, prima quindi dell’ultima guerra, per aderire ad un migliore
arredo, la piazza fu divisa longitudinalmente da un filare di platani, che
delimitavano la zona pedonale da quella viaria; sotto questi alberi, vicino
alla fermata del tram, iniziò il servizio taxi. Le piante furono fatte tagliare negli anni ‘42-’45
dal comando tedesco, installato nell’albergo Centro, per ragioni di loro
sicurezza .
Nel
1933, la piazza era classificata di 1.a categoria, e sempre collegava
via V.Emanuele (v.Buranello) con via Cavour
(v.Dondero) e via N.Barabino
(S.Canzio). In quell’anno fu ripreso il problema viabilità, ma
delle tre arterie previste, dopo altri 4 anni se ne realizzò solo una parte;
in particolare nella zona del Canto, una delibera comunale dell’ott.1934
accettò il progetto studiato dall’ing. Carlo Montano e presentato dalla
“società Ligure Immobiliare San Pier d’Arena” divenuta proprietaria dell’area
dell’ex-stabilimento Carpaneto ed intenzionata a sfruttare l’intera zona ad uso
edilizio di pregio (erezione
di fabbricati eleganti, muniti di portici e capaci di dare un aspetto degno al
centro cittadino); accompagnava la
proposta anche un ampio intervento di miglioramento della viabilità che venne
ceduta al Comune già spianata e dotata di marciapiedi con bordi di arenaria.
Iniziò a realizzarsi un anno dopo, con la creazione dell’attuale zona attorno a
via F.Avio.


Nell’operazione
si realizzò da parte del Comune sia l’esproprio (dopo un contenzioso con i proprietari, per nulla
contenti essendo la zona centrale e comoda; fu raggiunto un generoso accordo
dopo svariate riunioni e sopralluoghi)
che l’abbattimento del “palazzo dell’orologio
(palasso dö relêuio)” posto al limite occidentale della piazza, ove ora ci
sono alcuni alberi d’alto fusto, e del palazzo retrostante (l’ampia
facciata del primo, alto 5 piani, faceva da riferimento a chi proveniva da
levante chiudendo la visuale ed offrendo sulla torretta in alto un orologio
indicante l’ora ai molti che non ne possedevano; al secondo piano troneggiava
l’insegna del dentista Zunino, primo di una generazione di identici
professionisti; nei negozi alla base aveva la primitiva sede la Farmacia
Pizzorni, poi divenuta Operaia -ora in via Molteni). Così la piazza Vittorio Veneto si allungò a ponente (divenendo da 4950
mq a 7220 mq), inglobando quella che - dietro al palazzo - era piazza
Tubino (che scomparve dalla toponomastica cittadina, e con lei la trattoria Primavera di Viani Ottavia ed il Politeama Sampierdarenese (vedi piazza Tubino) inaugurato nel 1887, ricostruito ex-novo nel 1913, e che
poi divenne il cinema omonimo, gestito negli anni 60 da Ida Giacobbe. Nel 1973
riaprì i battenti dopo completa revisione e vari intoppi burocratici, offrendo
più di 500 posti).

Anche
l’UITE ne approfittò per doppiare i binari per il servizio verso ponente e per
eliminare l’incomoda manovra di dover mandare le vetture provenienti da ponente
sino a Barabino per invertire marcia e recarsi in val Polcevera . Fu
pavimentata con masselli di granito; fu arricchita (sino alla foce del
Polcevera) di una deviazione verso il mare della rete idrica di spurgo, che
prima scaricava solo in quella che proseguiva in via S.Canzio. Tutti i lavori
vennero eseguiti sotto il controllo del direttore della divisione strade, ing.
G.Luigi Connio.
Nel dopoguerra, in epoca definibile ‘Salatti’ dal nome
del sindaco, la piazza fu scelta come sede dell’albero natalizio del Comune;
spesso proveniente dalla val d’Aveto e trasportato con grosso articolato (mentre quello eretto in piazza DeFerrari a Genova il
Gazzettino scrive nel 2002 che è da dieci anni che proviene dalla val di
Fiemme, quale segno di amicizia). Probabilmente la spesa comportata,
fece ridurre gradatamente sia la grandezza sia la bellezza della pianta, sino
alla totale eliminazione.
La piazza fu scelta negli anni 1970-90 per issarvi un abete nel periodo
natalizio: questa cerimonia fu protratta per molti anni fino a raggiungere
dimensioni dell’albero sempre più striminzite (per ragioni economiche e di
trasporto) ed infine fino alla eliminazione del progetto.
Nel 1996, al centro fu installato un alto
lampione, che dai suoi 30 m illumina tutta la piazza con lampade ai vapori di
sodio della potenza di 4800 watt.
Nell’autunno-inverno 2008 la piazza è soggetta a
completa ristrutturazione, prevedendosi una rotonda alla francese (per smistare
l’intenso traffico: ma pare che non funzioni), marciapiedi nuovi,
pavimentazione, ecc.; infatti, completata a fine 2008 è stata oggetto di
numerosi interventi ‘contro’ causa il caos da imbuto: rallentamenti, code,
congestione e smog, in via Buranello e via Avio-Molteni
CIVICI
2007=
NERI = da 2 a 12
ROSSI = da 1r a 41r
(compreso 1Ar) sono sotto il viadotto, in “nicchie” di prorpietà delle FFSS
(gestita nell’anno 2010 dalla spa Metropolis).
da 2r
a 96r (mancano 80r, 82r).
1=lato mare
BAR: dal lato mare: il caffé Roma ( civ.26r. Nel 1908 ancora localizzato in via Vittorio Emanuele, fu di proprietà Adriano Frassinetti, nei locali del
primo ex-cinema Splendor. Nel 1911 fu decorato ‘in corretto stile floreale’ dal
pittore locale GB Derchi). Divenuto proprietà Trevisan Serafino nel 1925, nel
1933 fu sede dell’ “associazione calcio Sampierdarenese” gestita dal
commissario straordinario on. Cinzio Storace divenendo così “covo” di sportivi
locali (tra i cui frequentatori abituali viene ricordato Colantuoni della
Sampdoria). Nel 1950 era ‘caffé Roma di Paleari S.’.
Il caffé Excelsior, (civ.34-36. Affiancato al cinema; era del cav Curti. Nel 1950 era
soc.an.Excelsior.).
Il caffé Elvetico
(civ. 52-54r; presente
già da prima ancora del 1889, fu fondato da una società svizzera; nel 1908-12
locato in via Vittorio Emanuele 29 era caffè ed offelleria gestito da
Muller e C.; nel 19-25 era di Fossati Benedetto (Petrucci spiega che offelê-offelliere –termini
arcaici (dal latino offa focaccia di farro, ed offella pasta dolce) sia
genovese che italiano: erano il pastaio che fabbricava dolciumi di pasta secca
e dolce, come gli amaretti).
Seduti su poltrone di velluto rosso, si mangiava il gelato mantecato e si
godeva il passeggio essendo in angolo del palazzo collegato con via Carzino (allora via N.Barabino tramite i
locali dove ora è un negozio di radio e luci). Durante la guerra e fino ben oltre il 1950 venne gestito
da Irmo Tortonese (uno
dei tre, assieme a Vittorio dell’albergo Centro e Pietro come
aiutante.tuttofare sia in albergo che bar. Assieme misero in piedi uno dei
primi servizi taxi esistente in città -pubblico e privato-, con auto come la
Balilla, le prime Lancia ed OM, e con garage in via Leon Pancaldo). Recentemente era stato chiamato
“gran bar Veneto”, poi ‘City Clubs’. Oggi 2002 si chiama ‘Trittico bar’. Questa
carambola di nomi, significa solo inutile presunzione e poca stima per la
tradizione).
Il caffè Italia (al 74.76r. Così era nel 1950).
2=Sotto i fornici della ferrovia,
nel 2010 –dopo il tunnel di via Carzino - il
civ. 1r cè una edicola di giornalaio,
attualmente chiusa; segue una vetrina senza numero attualmente di Pittaluga,
tende e piumini; al civ.3r con due fornici, dei
quali uno senza numero, il trattoria-pizzeria-ristorante La Marinella; civ. 5r un negozio di abiti femminile Lynesi; civ. 9r macellaio Oreste; civ.
11r intestato a ‘La carica’, appare chiuso; civ.
13r formaggiaio “Vittoria”; civ 15r
Tabacchino; 17r bar Splendor (antico bar Bertola; nel 1919 era
dei ‘f.lli Bertola’; nel 1925 era anche liquoreria dei f.lli, e caffè di
Bertola Giovanni, al civ. 223r di pza F.Ferrer, tel.41-932; fu poi di Gallia
Francesco. Negli anni 1950 divenne bar Splendor di Ottonello Silvio. Fu uno dei
primi ad occupare i fornici sotto il trenodotto quello dove poi si aprì il
caffè Bertola, oggi Splendor); - tunnel per box exSplendor
- 21-23r solo vetrine di Genova immobiliare; 25r pasticceria Rebora; 27r caffé Dream (nel
1950 era caffè Beccaria; nel 2010 è diventato ‘I tre shakerati’); - tunnel
di via U.Rela – 29-31r libreria Frilli;
33r bar ‘la Piazza’ (antico bar Margherita; fu di Squillari, e dopo ancora di
un Bruno; poi Crona N. (nel 1950, un tipo facilmente irritabile con figlia
gibbosa); 35r ricambi elettrodomestici; 37r
coltelleria e casalinghi Dossi; 39r Tardito
orologiaio (nel 1950
c’era il bar di Montanari Renzo); 41r chiostro giornalaio.
Non
localizzabile, negli anni 1911 e 12 in piazza Omnibus un ‘Caffè Cosmos’ di
Piaggio Domenico.
Altri
LOCALI COMMERCIALI (in ordine di data di rilevamento) degni di
memoria furono negli anni attorno al 1890 Luigi Guiducci vi aprì la
prima ‘agenzia giornalistica e
libraria’; lo stesso nel 1893 iniziò la vendita di un settimanale (al
sabato) titolato ‘il Sole nascente’ (dallo stemma locale del 1865) con intenti
‘alieni dai partititi estremi, ma sinceramente liberali’, e quindi il solo
libero di ‘dire di tutto e di tutti l’intiera verità non essendo vincolato a
persone o partiti’. Gli articoli erano raramente firmati. Dopo due anni di
pubblicazione, al n° 40, il giornale si fuse con un altro e cessò la stampa. L’attuale coltellificio
Dossi, nell’<Archivolto Ferrovia 7 di via V.Em. p. Omnibus>.
Nel
1908*° compare la ‘cappelleria
Alessandrina’ di Pieragostini Alessandro (considerato che si scrive
–Gazzettino 10/2002- che furono i Bagnara ad aprire il negozio qui, o è un
refuso legato superficialmente alla stessa merce o il Pieragostini fu un
portanome). I più vecchi
ricordano il negozio di Alessandro Pieragostini, di cappelli e berretti,
delle pagliette e dei panama a larga tesa, da molti chiamato genericamente ‘da
Borsalino’; il dottor Borghi quando si levava il cappello, sottolineava
sogghignando ‘è un borsalino’.
Nel Pagano 1919 (non
ho i precedenti, dopo 1912) compare non specificato il civ., il cinematografo Splendor di S.Frugone;
Nel
Pagano 1925 al 12-3 lavora il dentista
Zunino GB;- 56r (“Palazzo dell’Orologio”, Parodi Giuseppe vende camicie,
colli e cravatte; e il cinema Splendor. è in via Vittorio Eman., p.Vittorio
Veneto, tel 41129; compare (non c’è nel P/1921) la libreria di Gaggiolo
Mario.
Roncagliolo, uno ‘storico del Gazzettino’, ricordando
quei tempi (1925-30) cita: il palazzo dell’orologio
(maestoso, con torretta per l’orologio e la grossa targa ‘Zunino dentista’;
sotto i negozi Cagnolaro orafo, ippo Sosso parrucchiere dei vip; Parodi
valigeria). Sui marciapiedi a mare, in ordine: il bar Elvetico (dei
f.lli Fossati dove le famigliole gustavano il matecato mentre invece i ‘fedeli’
aspettavano fino alla sera); l’albergo Centro gestito dai coniugi
Frassinetti –Gemma ed Adriano- che dal poggiolo della veranda sbirciavano sotto
il ristorante e lo chef Alberto); il negozio Serra (ferramenta, detto
‘dai prezzi fissi’: dove ora è il Banco di Roma); Noli (oreficeria); Bagnara
(cappelleria); caffè Roma (prima sede; anch’esso con il capanno estivo e
discussioni sportive); il vecchio cinema Splendor; Fenzi
(biancheria); Durando bar; Venchi Unica (all’angolo con vico Catena); Rossi calzature; Motta,
prima Rocco, poi le figlie, di pelletterie; Latteria ‘Buona fede’; le ‘Filippe’
(con vetrina zeppa di pasta così ben allineata da sembrare filigrana).
Di fronte, sotto la ferrovia,
Barbano (bottoni, cravatte e distintivi); Camoi vendeva uova e
polli; Ferrando formaggiaio; Cipollina sigaraio; Parodi pitture
(in due generazioni ha pitturato mezza SpdA); caffè Cosma (ora
Splendor); l’osteria Carolina (ora Beccaria); Gaggiolo con
accanto i militiu della Croce d’Oro e le loro mano-lettighe; Salvatore
bottiglieria; Pieragostini; Rolla; Montanari (con il bar,
cocco d’estate e rostie d’inverno). Sotto i taxi (di
Taricco, Polibio, Crosa, Baiardi e ‘primizia nazionale’i f.lli Riccò con
servizio in sidecar. Passava il tram n.4 sempre affollatissimo, con l’asta
dietro, da girare al capolinea. Caratteristici i soggetti del Gin (che
predicava togliere le rotaie); Marietto (appena scorto nella Crosa dei
Buoi, veniva segnalato con un fischio modulato che lo imbestialiva e lo faceva
entrare in crisi isterica, con scongiuri, maledizioni, esorcismi ed
imprecazioni); Gioanin (il cantoniere che con la mole di 140 kg ed il
simpatico viso rubicondo ‘a bignè’ stava a discutere con Bacocco
(fattorino della banca Popolare di SpdA, alto poco più di un metro); Padella
(fissato con la sua cavalla, e terminava i suoi discorsi con una solenne gnaera); o carrettê di Robba, fiacre dei carri funebri dell’azienda
(ubriaco tutte le sere, si sedeva sui gradini del bar Campodonico di piazza
Modena –dove ora ‘la Botte’- e come litania ripeteva “Maria!; oh!; voglio
morire!” (forse conscio del suo torto e che la moglie non gli avrebbe certo
rimboccato le coperte. Allora la moglie Maria e la cognata Gildun –che vendeva
noccioline e angurie, caratterizzata da un lungo scorsâ con due tasche ove
infilava i soldi- lo andavano a prendere e tenendolo sotto le ascelle lo
riportavano a casa); o Mürta (un clochard che girava scalzo, dormiva nei
vagoni in stazione ed al mercato si prestava per portare ceste; un topo gli
aveva rosicchiato un piede e quindi claudicava vistosamente); o Giggi
era il cameriere del bar Roma (capelli tinti sempre neri, gipponetto nero con
farfallina; aveva le orecchie a sventola per cui gli dicevano che sua madre
aveva avuto un flirt con Clark Gable; una volta dopo servito un caffè ad uno
che aveva richiesto un ristretto, ne bevve metà e rimise l’altra metà sul
piattino presentandolo come ‘eccolo, adesso è ristretto’); Sciò Freguggia
faceva il commesso ed aveva il vizio delle bugie troppo grosse, ma dette serio
serio: un giorno raccontò che a militare fu chiamato dal generale a giocare a
carte e come compagno gli toccò il re: all’ultima mano praticamente perdenti,
si rivolse al compagno e gli grido ‘belin Vittorio, che carte mi giochi?’;
un’altra era che richiamato nell’ufficio del direttore generale, si stufò
essere redarguito e così dette un pugno sulla scrivania dicendo che lui era
stufo e che la sapeva lunga… al ché il ditrettore generale gli si mise in
ginocchio davanti pregandolo piangendo ‘non mi rovinare!’); Gimmi detto o
Camera, si vantava aver portato addosso ben sette divise, da quella del fascio
a quella del coloniale in Africa, da quella tedesca, all’ americana, o di
vigile, o di pompiere, ecc.); o Merda inglese, era definito così perché
indossava solo abiti inglesi, amava musica inglese, ecc.); buon ultimo o Carletto,
il pesciaio Argieri, simpatico e scherzoso seppur ingenuo quando investendo i
soldi nell’edilizia ebbe a perderne molti in attività fallite in conseguenza
delle quali da abitare nell’attico in via Cantore sopra Quaglia, dovette
trasferirsi prima in corso Magellano all’1 e poi in via Giovanetti).
Nel Costa/1928-29 l’albergo
Centro, al civ.8. Rimangono una serie di esercizi commerciali come: la
cristalleria, profumeria, copisteria, giocattoli di Benasso Dario all’ 1r; pelletterie
di Motta Rocco all’8r; salumiere Ferrando Antonio al 13r; cartoleria
Cipollina Carlo al 15r; negozio di biancheria di Fenzi Enrico al 22r; orologeria
di Carlevaro Giuseppe al 23r; l’edicola di giornali Giaggiolo al civ.29, che
vende anche giocattoli, e –come libreria ha pure un recapito in piazza
Cavallotti 13; commestibili delle sorelle Rebora al 32r; liquori dei f.lli
Bertola al 17r, e di Ferrero Antonio al 33r; maglieria di Parodi Giuseppe al
56r; la farmacia Pizzorni Giuseppe al 58r; l’arrotino f.lli Albertini al civ.
60; oreficeria e argenteria e gioiellerie di Cagnolaro Enrico al 66r e di
Pavese Cristoforo (orologeria di propria fabbricazione) al 10. Non precisato il
civ. di articoli casalinghi Lugani Carlo; il cinematografo di Frugone Stefano.
Nel Pagano/33 viene segnalato, nel palazzo dell’orologio, il negozio di
floricoltore di Anageri Luigi e non specificato dove il pastificio di Rebora
Paolo. Sono inoltre segnalati: l’hotel ristorante del Centro;
10r l’orefice Pavese
Cristoforo; 35r negozio e fabbrica di cappelli di Pieragostini Alessandro (vedi già dall’anno 1908) ; al 37r il negozio di articoli
tecnici dei rag. Rivali
& Ratto; al 52r il caffè Elvetico;
non specificato il caffè Roma di Paleari & C..
Nel Pagano/40 vene descritta: “da via II Fascio d’Italia alle vie Stef.Canzio
e dell’Industria”. Con civici= senza numero: Politeama Sampierdarenese; edicola giornali di Bigatti Settimo;
Civici neri: al 2
pt=Cassa di Risparmio di Ge.; 2/1 assic.Venezia e dentista Levrero; 4/1
dentLevrero; 4/2 Bisio Anita medico; 6/1 Banca Pop.Novara; 8 Ristorante e
Albergo Centro; più altri privati e profess.
Civici rossi dispari: 1r
cromatura ‘Duran’; 3r genepesca di Giolfo e Calcagno; 7r polliv.; 9r macell.;
11r colori e vernici; 13r rosticc.;15 tabacch.; 17r bar Bertola f.lli Gallia;
19r Cinema Splendor; 23 calze; 25r commesti. Rebora; 27r caffè bottigl. della Posta;
29r ag.giornal. Mario Gaggiolo; 31r articoli casal. Perucca M.; 33 bar Margher.
di Ferrero Ant.; 35r cappelleria Pieragostini A.; 37r arrotino coltell.
Albertini; 39r bar BergiantiA.; pari: 2r gioiell.; 6r commestib.; 8r
cappell.Motta; 10r tessuti; 12-14r calzoleria; 16r Dory profumi; 18-20r Unica
soc.an.pastcc.; 22r camic.biancheria; 24 panif.; 26r caffé Roma di Paleari S.;
28r Cinema Excelsior soc.an.; 32r cravatt.bianch.; 36 soc.an.bar Excelsior;
38-40r Banco di Roma; 42-46r bar Centro; 48-50r macell.; 52-4 caffè Elvetico;
70-2 trattoruia Antonietti G.; 74-6 latteria.
Negli anni 1950 c’erano: al 2-4r l’orefice Gazzulino; al civ.16r la profumeria Dory; al civ.8
l’albergo Centro, di
terza categoria e di proprietà ved.Frassinetti; al 15r il
tabaccaio Caviglia M.; al 18r la Venchi Unica; due negozi di calze: 23r Quargnenti, ed al 48-50 la ‘Bottega della calza’; al 29r il giornalaio-libreria Gaggiolo M. (vedi 1925 e sotto ai civv; come libreria è anche in p.za L.Settembrini al 13r); civ.35r il cappellificio Tortarolo (che probabilmente rilevò
dal Pieragostini che vendeva dal 1908); civ.42-44-46r
il ristorante, gestito
da Scarnera Franca; civv. 64.66.68r ‘all’Ombrello per tutti’; e non precisato dove Tortarolo Bice giornalaia, presumo
il casottino vicino al sottopasso;
Nel 2003 a monte e verso ponente, ci sono,
tutti rossi, dal civ. 1 (il giornalaio) una serie di attività commerciali (ristorante, moda,
formaggiaio, ecc) fino al 17 il bar
Splendor; voltino per sottopasso; 19.21 soc.
immobiliare; 25 pasticceria Rebora; 27
coffee Dream di Elisa DiVendra; voltino per
sottotasso di via U.Rela; 29 libreria la
Bottega del Lettore (con appese fuori due antiche targhette reclamizzanti “il
Secolo XIX ‘nuovo’ “ e “Milano sera”); 31 chiuso
e vuoto (ex dischi; poi dal 2004 concesso a ‘Lo sportello del cittadino’ di
iniziativa regionale; 33 bar La Piazza; 35
ricambi elettrodomestici; 37 coltelleria Dossi; 39 orologiaio Tardito; l’edicola di giornali, di Enrico Pennati;
sottopasso ferroviario per piazza Montano.
invece a mare, verso ponente nel palazzo civ.2 calzature; vendita-affitto cassete TV; Sacks
calzature; Crosa profumi – vico Catena – civ. 4, con 26 bar Roma – il
28r con ex Excelsior, ora ‘supersconto’ – civ. 6 con 30r il SecoloXIX;
pub LongWay - v F.Noli – civ.8 con la Finanza e 38r Banco di Roma – civ.
10 con al 52.54r bar il Trittico – v.SCanzio – L’ombrello per tutti – civ.
12 con al 72r hotel Albergo Primavera.
Nel 2005 c’è un bar ‘La piazza’; vedere dove è.
_______________________________________________________________
3= ESERCIZI COMMERCIALI in ordine di civico
===civ. 2: La
grossa e pomposa costruzione, detta ‘Palazzo dei
Balbi’, famiglia che comperò l’immobile agli inizi del 1900
direttamente dal marchese GioBatta Centurione proprietario dell’intera zona
attorno alla villa, che a sua volta l’aveva fatta erigere (“…nella sua
proprietà e retro al suo palazzo in Sampierdarena una nuova casa con facciata
prospiciente sulla nuova strada…” dopo richiesta presentata al sindaco datata
24 maggio 1853: ne era testimonianza scritta su una targa di metallo, oggi
scomparsa ma esistente ancora negli anni ‘30 (‘proprietà principe Centurione’),
murata per terra davanti al portone che si apre in via del Monastero.
In vico della Catena, ove
è il fianco di ponente del palazzo, nel 2010, un negozio porta scritto
all’esterno essere stato “chiuso per ordinanza fallimentare su richiesta della
‘Fondazione Balbi’”.
Una leggenda popolare collegò l’acquisto del palazzo
fatto da Balbi (che era un operaio, e che -mi è stato detto- lavorava come
facchino alla stazione (un Balbi Francesco appare però gestore della trattoria
della stazione negli anni 1911-12), con la scomparsa di una borsa contenente
molto denaro denunciata qualche anno prima da delle suore di passaggio; e nella
nemesi popolare ‘i soldi della chiesa tornano alla chiesa’ pare in effetti che
gli attuali proprietari, senza eredi, abbiano l’intenzione di farne una
donazione alla chiesa della Cella.
Decorato con severa eleganza, appare un tutt’uno fino a
vico della Catena, con tre accessi separati: dal vicolo, dalla piazza VVeneto e
da via del Monastero; il portone principale sulla piazza è lavorato in ferro
battuto, con soggetto i fiori di girasole di stile tardo liberty. Appare
lavoro di alto pregio e qualità.
De Landolina/1923 lo chiama ‘palazzo rosso’ citando che al
piano terreno in quegli anni c’era la Banca
Popolare di Sampierdarena (tel.41-064) fondata il 29 maggio 1876, era molto attiva negli anni a cavallo del secolo
(vedi nei Pagano).
Negli anni 1885-1914 uno dei maggiori azionisti
fu la famiglia Gambaro Giuseppe (e figli) importatore e commerciante di cereali
ed industriale tessile. Viene inclusa nelle ‘modeste banche popolari e di
cooperative’, avendo nel 1886 un capitale di
L.50mila (elevato a L.100mila nel 1887, e 250mila nel 1889;
a confronto con i 4-5milioni di £. delle maggiori concorrenti. Con un basso
(4-5%) incremento annuo dei risparmi contro il 15-20% delle banche italiane,
negli anni 1906-9).
Ancora nel 1909 era in via
Vitt. Emanuele al civ. 58, telef. 456; ove aveva anche funzione di esattoria
delle imposte dirette. Si presume che il civ. 58 era il vecchio civico del
‘palazzo rosso’ perché la esattoria in quell’anno era aperta sul fianco del
palazzo, in vico Mentana 16 e con identico numero telefonico della banca). Il
quell’anno, già aveva agenzie a SestriP ed a Bolzaneto. Venne inglobata dalla
Cassa di Risparmio di Genova (altri scrivono dal Banco di Novara) quando la
nostra città -1926- fu inglobata nella Grande
Genova; in quegli anni era figura caratteristica locale era un fattorino,
perché nano (alto non oltre il metro) dal nome Bacocco. Nel genn/2010 è tornata alla memoria perché due eredi hanno
scoperto un versamento di cento lire fatto nel 1907 in un libretto di risparmio
da una loro ava contessa; vissuta sino al 1984 all’età di 103 anni; e
–calcolati gli interessi allora promessi del 3,5% - attualmente sommano a quasi
370mila euro.
===civ. 16r la profumeria Dory,
presente nel dopoguerra fino ancora negli anni ‘60. Era negozio gestito dalla
sorella di Mario Sbarbori (un profumiere che lavorava in via Scurreria - morto
1985; negozio ed officina artigianale, in tre piani del palazzo; definito il
‘naso d’oro’ o comunque uno dei migliori in campo internazionale capace più di
tutti a selezionare gli odori di numerose essenze, per trarne diversi profumi,
sino ai più rari: per esempio si ricorda il profumo ‘mitsouko’ la cui formula
complicata era conservata a Parigi -in ricetta spezzata- in tre cassaforti
diverse, onde evitare furti, e che lui riprodusse nel suo retrobottega ‘a
naso’, ricevendone un particolare riconoscimento).
===18r In questo locale entrò a commerciare pasticceria,
anche la Venchi Unica, cioccolatai, negli anni
1970. Il marchio era Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, soc. an.
Con sede madre a Torino, locale a Genova e numerosi negozi vendita nelle
delegazioni. Famosi erano i pupazzetti e bamboline di pelùche – i primi in
commercio – entro i quali porre i cioccolatini da regalare
===civ.4.
===civ.
6: il palazzo, detto Noli
dal primitivo proprietario (presente nei Pagano, da/02 a quello /1925, potrebbe essere il Noli
Angelo, orefice), fu
rimodernato nel 1921 in occasione dell’apertura-inaugurazione (il 2 dic.dello stesso anno, con
incasso devoluto a beneficio dell’ospedale)
del cinema teatro varietà Excelsior:
Quando ormai si stava smorzando lo stile
liberty, l’architetto ferrarese Venceslao Borzani, nel 1921 propose nella
nostra città, l’applicazione dello stile che venne definitio “post-liberty”, o
“precursore del modernismo” (un professionista, nato nel 1873, venuto a Genova per
diplomarsi architetto alla scuola genovese di Camillo Boito, divenne uno tra i
più significativi in merito al Liberty ed all’“art nouveau”. In un particolare
momento storico locale, determinato dall’espansione economica della nuova
borghesia –industriale e imprenditoriale, comunque alla ricerca di
autoincensazione, anche cimiteriale- il giovanissimo artista nel 1902 (con un
anno di anticipo rispetto l’esposizione di Arti Decorative di Torino che ne
consacrò lo stile), seppe proporre all’attenzione generale e con creatività
propria quello che in Europa stava nascendo in maniera slegata (linearismo in
Belgio, florealismo in Francia, ‘jugenstil’ austriaco): un’arte allora
provocatoria, specie a Genova tipicamente conservatrice e refrattaria alle
novità.
Ispirato
al suo stile, il palazzo in via NDaste che ha i portoni in via D.Chiesa e
Palazzo della Fortezza; Una morte precoce, a 53 anni, spense il genio di questo
talentuoso artista il 30 nov.1926, riconosciuto precursore e cultore del
Liberty ed anticipatore dell’architettiura moderna).
La
raffinata decorazione esterna rimane eguale tutt’oggi, con piccole modifiche
rispetto i progetti originari (sostanzialmente mantenuti i pilastri con
mascheroni, grotteschi e figure femminili decorative poste sedute nell’atto di
sorreggere delle ghirlande di fiori -che ora sono scomparse , come anche
l’insegna del teatro-).
Aveva due ingressi (uno per il loggione ed uno per
le poltrone: ovvero uno dalla piazza ed uno da vico della Catena));
internamente era ricco di stucchi, plastici, vetrate, luminarie, allegorie in
piccole proporzioni al sommo del palcoscenico dove invece le statue ai fianchi
erano in grandezza naturale; il soffitto a cassettoni era decorato con pitture
raffiguranti l’arte, ed ai quattro lati i ritratti di altrettanto insigni
maestri (opera del pittore romano Calcagnadoro); la balconata tutta in giro era
in ferro battuto.
Il
tutto è andato perduto; forse solo nella sala da biliardo del vicino bar Roma,
esistono ancora dei protomi femminili .
Positivamente fu definito un “piccolo gioiello”; da altri “la bomboniera”; ed
anche “il pigheuggin”. In negativo altri ancora commentavano che tanta arte in
così piccolo posto finiva per renderlo pesante e farraginoso (definita
“superfetazione plastica”): ma i tempi allora preferivano così.
Anteguerra
fu gestito dal cav. Curti (che aveva fatto fortuna in America), ospitando
ancora varietà, operette, cinema). Con la guerra iniziò il degrado, venendo
preferito il soprannome “il pidocchietto”. Sino al degrado dell’uso delle “luci
rosse” necessarie per sopravvivere. Ultima, architettonicamente sconvolgente,
la trasformazione in un supermarket con la scomparsa definitiva della maggior
parte delle strutture interne. I vecchi ricordano l’epoca dei films: con prezzo
ridotto, se ne vedevano di seconda visione ma adatti a ragazzi, la serie di
‘Maciste’; i western cosiddetti ‘cavalli e pu-a’; oppure due film al prezzo
di uno.
Nel 1982 il Consiglio di circoscrizione bocciò il
progetto di trasformazione del locale in un supermercato ma... negli anni 90,
il supermercato aveva addirittura coperto con vistoso cartello queste
decorazioni; ora fortunatamente è stato rimosso. L’interno è totalmente distrutto,
appiattito, senza decorazioni.
All’int.2 è ospitata una casa di risposo per anziani
che prima si chiamava ‘casa Massima’ ed ora ‘Mic.Cos –casa Carlotta’
===civ.8: rendeva importante la piazza, l’unico allora
bell’albergo cittadino chiamato “Centro” ( affiancato dal ristorante omonimo che gestito per
anni da Vittorio Tortonese, rimase aperto sino al 1976 quando nei locali vi
subentrò il banco di Roma). L’albergo, inaugurato nel 1844 , era tra i più noti e
frequentati ristoranti locali , di alta qualità; tra gli ospiti delle
industrie, letterati, politici, attori e sportivi come i calciatori delle
squadre del massimo campionato ; vengono ricordati D’Annunzio, Giolitti,
Agnelli, Valletta, le sorelle Grammatica, DePrà, Callegari, Levratto). Rimase semidistrutto
durante l’ultimo conflitto perché sequestrato ed utilizzato dai tedeschi qui
accasermati con un comando di zona (viene riferito che nell’ambito genovese
furono gli ultimi ad arrendersi (26 apr.1945) perché i meno persuasi di doverlo
fare: per questo gli alti graduati morirono suicidi prima della consegna delle
armi) ; sostituiti dopo la loro resa dal comando della brigata partigiana Pio
(una delle 5 brigate facenti parte della divis. Mingo), comandata da Alessio
Franzone ‘Arrigo’, in attività bellica posta a controllo del territorio di
Molini di Voltaggio ed il 25 aprile dislocata a Sampierdarena . Di proprietà
privata, nel 1908 –ancora in via V.Emanuele 28- era di Podestà Rosa ved. Fava;
nel 1919-33, era “hotel prim’ordine,Adriano Frassinetti” (quando la piazza era
dedicata a F.Ferrer, tel. 33.37, poi 41-004); nel 1935 di Adriano e Gemma
Frassinetti. Nel periodo bellico fu occupato dalle forze armate tedesche. Nel
1950 appare di terza categoria e di proprietà della vedova Frassinetti. Dopo questi
eventi fu ripristinato , risultando però sempre nel 1961 di terza categoria. Negli anni 1991-2, fu ristrutturato completamente sia in facciata che
internamente dall’impresa G.Pagano, diretta dal geom. Somaglia, per essere
affittato alla Guardia di Finanza, gruppo investigativo contro la criminalità
organizzata.
Sulla facciata del palazzo è stata opportunamente conservata
la scritta in rilievo del nome.
===civ.
17r Si aprì, prima fra tutti, l’attività di
maniscalco di Ferrando Vincenzo, detto ‘il
balla’; uno dei tanti che trattavano, soprattutto ferravano i cavalli, allora
unico metodo di locomozione veloce (ce ne erano ovunque: più ricordati in piazza Tubino, via Garibaldi=Pacinotti-,
via Solferino). Il punto era strategico per il passaggio continuo dei
carichi dal porto al ponente ed al nord, nonché dei primi tram omnibus. Dovette
traslocare in piazza Cavallotti (oggi Settembrini). Gli succedette nell’attività il
figlio Natale che negli anni trenta dovette
–prima di cedere all’incalzante avvento del motore- tentare di riunire tutti i
‘calzolai dei cavalli’ in cooperativa (scelsero come sede via SanPierd’Arena,
presso la ‘corte di san Giovanni Battista’; presidente Celestino Civani, e soci
sia i suoi fratelli Emilio e LuigiAgostino, anche i fratelli Guarnieri Armando
e Luigi e Natale Ferrando).
===Dopo
il civ.17r del bar Splendor, c’è un voltino che
portava al teatro Splendor che si aqpriva in via Orsolino Ne furono aperti due: 1) il più
vecchio, inaugurato nei primi anni del 1900 da Stefano Frugone, sul lato a mare
della piazza, dove ora è il bar Roma, con una entrata anche da vico
della Catena; ospitò spettacoli d’arte varia e poi anche cinema (all’epoca erano famosi attori Alberto Collo, Bartolomeo Pagano detto
Maciste, Marta Abba, Maria Iacobini, ed un certo Saetta), lavorando a pieno ritmo sino al dopoguerra (tra gli anni 20 e la guerra, San Pier d’Arena era il vero centro del
cinema : nei giorni festivi vi arrivava gente da tutte le delegazioni vicine
proiettandosi i migliori film sulla piazza. Questo rendeva orgogliosi i
sampierdarenesi, per aver saputo raggiungere mete di cultura, sportive,
ricreative ed artistiche che potevano far concorrenza con Genova
matrigna; da questo spirito viene il famoso detto locale
”gh’emmu tutto, cumme a Zena” . Nel 1945 aveva ancora in
cartellone una stagione operistica).
2) Lo stesso
proprietario, il 24 ott.1921 abbandonò quella sede ed inaugurò sul lato opposto
a monte della piazza, con ingresso in via
del Prato (via
A.Orsolino) tramite sottopasso ferroviario, il “cinema-teatro-Nuovo Splendor”.
Ben illuminato, vasto, ampia galleria con ringhiera in muratura, decorato a
fogliame in stucco bianco; nel vestibolo un dipinto di una figura muliebre
radiosa, raffigurante la luce che fuga l’oscurantismo personificato da due
maschi proni, opera di Antonio M.Canepa, giovane pittore locale (una
locandina del 1923 segnala: “lunedì e martedì 4 e 5 giugno, 6ª ed ultima serie de I MISTERI DI
PARIGI; mercoledì e giovedi 6 e 7 giugno LA DONNA DELLA MONTAGNA dramma a fortissime
tinte, protagonista la celebre –attrice Pearl White…” e concludeva: “ad ogni rappresentazione seguirà un
attraente SPETTACOLO DI VARIETA’ “). Nel 1935 ospitò anche Renato Rascel
, detto il piccoletto , allora “piccolo” attore d’avanspettacolo : fu ben
accetto, e questa sede gli portò la fortuna di un continuo ‘crescendo’
professionale. Nel dopoguerra fece praticamente solo cinematografo, resistendo
alla fine il più possibile alle proiezioni di spettacoli a “luci rosse”,
finché, approvato dal 1986, negli anni attorno al 1990 fu svuotato e
riedificato per ospitare box per auto.
===civ. 29r : la
agenzia giornalistica Gaggiolo Mario che (forse rilevando quella precedente di Luigi Guiducci
descritta sopra) dalla fine del 1800
(sul Pagano il nome compare dopo il 1921)
distribuiva giornali ed era sia libreria che
rappresentante di case editoriali. Aperta anche sul retro in piazza
F.Cavallotti è stata poi gestita fino ad oggi da tre generazioni di Gaggiolo). Ultimo,
Mario, nel 1995 abbandonò l’agenzia giornalistica e nel 1998 la chiamò -come
attualmente- libreria ‘la Bottega del lettore’ ma trovò difficoltà per la
contemporanea apertura di una grossa libreria alla Fiumara; allora –pur
lavorando nella sala- cedette l’attività ad un altro imprenditore, che però
abbandonò l’impresa nel marzo 2004. In questa data ambedue i soci lasciarono i
locali (Mario facendo il giornalaio dapprima in piazza Verdi a Ge e poi a
Sestri) cedendola ad uno dei fratelli
Frilli editori, che vi risiedono ancora nel 2008.
Subentrando,
andò a sostituire un fornice dell’ antica e primitiva sede della Croce
d’Oro (la quale utilizzava il locale quale dormitorio dei volontari, e
quello a ponente quale ambulatorio; quest’ultimo era nato per primo, quale
sede secondaria e solo diurna della Pubblica Assistenza e quando la sede
centrale era in via C.Colombo ove il servizio durava tutta la notte. Erano
tempi di ‘trazione a braccia’ delle barelle (una delle quali aveva le ruote compatibili con le eculissi del tram per
evitare le scosse quando il servizio era in zone coperte da quella rete: ovvio
il campanello da bici, su un bracciolo). Permangono
dietro gli scaffali dei libri, le pareti piastrellate bianche tipiche degli
ambienti sanitari (a sua volta su esse cola abbondante
l’acqua piovana filtrata dall’alto e che si riversa in buona
parte sull’impiantito prima di scomparire, in parte riassorbita in parte tolta)
===civ. 39r (per le FFSS ‘nicchia 39r’) dove ora (2011) l’orologiaio Carlo Tardito, negli anni dopo guerra ed ancor
rivestito con piastrelle colorate.
Nel
minuscolo locale, ci lavorava un rivenditore di bibite e di cocco fresco, tamarindo, gazzose –quelle con la
biglia-, anice e limoni da spremere; e caldarroste d’inverno. Un antesignano
dei break-fast di oggi.
;
la valigeria ‘ditta Giuseppe Parodi fu D’, sino alla demolizione ospitata nel
palazzo dell’orologio.
Lavorano
ancora l’antico arrotino Dossi subentrato al suocero Albertini Guido (che negli anni 1930 –coltellinaio e
articoli casalinghi- era in via N.Barbino
(via S.Canzio) al
civ.14a), famoso per tutte le pentole e
le lame, compresi i rasoi da barba, un tempo unico metodo per radersi e da
affilare su apposita striscia di cuoio; ---il negozio d’angolo con via S.Canzio
‘l’ombrello per tutti’, negli anni 1960
di proprietà Rossi E..
===Al
18r c’era il negozio della soc.an. Venchi Unica (nel 1933 già presente a Ge. come
soc.an. Venchi S&C; poi unito alla sigla dell’Unione naz.ind.comm.alim),
con la golosa cioccolata messa in evidenza assieme a bambolotti di
tessuto Lenci.
===civ.
14 fu demolito nel 1969 ; nel 1972 fu assegnato il civ.78rosso a nuova costruzione eretta dove era il 14***
===civ. 30r dagli
anni 1950 è sede di un ufficio pubblicità de Il Secolo XIX.
==== Impossibile ed un po’ sterile elencare i
nomi dei cento e cento negozi che in un secolo hanno abbellito la piazza; ogni
generazione ha nostalgia dei suoi tempi che giudica giustamente irripetibili.
===civ. 42r era il ‘ristorante Centro’ di negli anni ’70, proprietà
Franca Scarnera (che sostituiva Tortonese Vittorio).
===civ. 72r l’albergo Trattoria Primavera, negli anni ’70 di Antoniotti
Bianco; e in quelli ’90 ‘albergo ristorante’ di
Antoniotti & Icardi sdf
_______________________________________________________________
====
La parte ovest della piazza è delimitata da una piazzetta adibita a posteggi
auto, con alberi d’alto fusto a contorno; e dalla facciata a levante del
palazzo anche liui detto ‘DeFranchi’ che si apre sia in via Dondero che in via
Avio, eretto negli anni 1920 circa
===
Il centro piazza, nel 2009 è stato occupato da una ‘rotonda’
che dovrebbe snellire il traffico eliminando semafori e vigili. Era stata
arricchita di numerose piantine di rosmarino con altre a cespuglio; molte hanno
attechito, altre no; ma la non manutenzione ha determinato in breve essere
ricettacolo di cicche (buttate nell’attesa del transito!), pacchetti di
sigarette e sterpaglie varie. Forse l’aiuola è troppo grossa ed il ‘tappo’ veicolare persiste anche
perché il regolamento dice che in una rotonda ha diritto di precedenza non chi
proviene da destra ma chi è già dentro il giro; ma essendo il flusso
ininterrotto – sia quello proveniente da via Avio che quello da via Buranello,
la fa da padrone il più intrapprendente e sfacciato, con eguale risultato.

foto 2010-10-10
DEDICATA alla città
veneta (nella Venezia
Euganea, in provincia di Treviso), che così fu battezzata nel 1866 in onore di Vittorio
Emanuele II; allo scopo furono riuniti in unica amministrazione due comuni
distinti e vicini: Céneda a sud -antico castrum romano- e Serravalle a nord.
Dal 24 ottobre al 4
novembre 1918 si svolse l’ultima grande battaglia che costrinse l’Austria alla
resa, con la conclusione vittoriosa della guerra mondiale.
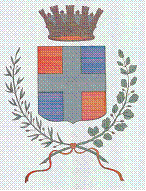 Prima della data
risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2
francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;
sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio
attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e
psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette
e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono
l’olocausto generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure
lui eroico ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.
Prima della data
risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2
francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;
sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio
attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e
psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette
e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono
l’olocausto generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure
lui eroico ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.
Colonne celeri, il 29 ottobre, passato il Piave, occuparono Vittorio Veneto
obbligando gli austriaci a ritirarsi sulla loro terza linea difensiva; da qui
ulteriormente attaccati, dovettero disordinatamente abbandonare il Veneto,
perdendo complessivamente 400mila uomini (tra morti, feriti, dispersi e
prigionieri). Il 3 nov. fu liberata Trento; e l’Austria stremata, chiese
l’armistizio. Questo fu firmato quel giorno stesso a villa Giusti, ed il 4
novembre cessarono le ostilità sul nostro fronte, costringendo così la Germania
a firmare anch’essa la pace. Alla città fu concesso la “Croce al Merito di
Guerra” il 29 ott.1919.
Anche
durante la seconda guerra mondiale, la città fu ulteriormente travagliata in
considerazione della sua posizione geografica e strategica. Le fu assegnata la
“Medaglia d’oro al valor militare” per il periodo settembre 1943-aprile 1945 (Per quest’ultima, la motivazione
dice «Amore di Patria, spronando l’antica volontà di
vittoria a piegare il destino, risuscita Vittorio Veneto. Per venti mesi di
guerriglia atrocissima, soila ed indoma, organizza, sostiene ed alimenta i
cittadini compatti nella rivolta contro il duplice servaggio e cinquemila partigiani
che – scolta insonne – lottano sulla sinistra del Piave e sui valichi montani a
difesa della dignità d’Italia. Contro la rabbia nemina i volontari della
Libertà, donando ai vivi l’anima dei Morti, confermano fieramente la
nobilissima tradizione a conservare la libertà piegando la ferocia e la
distruzione. Domata la tracotanza avversaria, costretto alla resa il nemico in
ritirata, la città libera per la tenacia dei figli, consacra all’epopea del
nuovo riscatto il suo sacrificio di sangue e di mezzi»).
Tutti i combattenti superstiti della guerra, dalla data del 1967 furono
insigniti della medaglia dell’”Ordine di Vittorio Veneto”.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale
-Archivio
St. Comun. Toponomastica - scheda n 4700
-A.sconosciuto-Storia
del trasporto pubb.co a Ge.-Sagep.’80-p.196.236.fig.29
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi-ed./94-pag.453—ed./02-pag.489
-AA.VV:-Comuni
italiani decorati al valor militare-Saga 1957-
-AA.VV.-Contributo
di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1997-pag.96.101
-AA.VV.-1886-1996
oltre un secolo di Li-SecoloXIX-pag.33
-AA.VV.-Scultura
a Ge e Lig.-Carige-vol.II-pag. 407foto.410
-AA.VV.-Vecchia
SPd’A e Cornigliano-Valenti.1976-pag. 23foto
-Balletti.Giontoni-Una
città fra due guerre-DeFerrari.1990-pag. 76foto. 77
-Beccaria
R.-I periodici genovesi dal 1473 al 1899-AIB.1994-pag.542
-Bottaro-Paternostro-Storia
del teatro a Ge.-Esagraph.1982-p. 160-6n22.303
-Cappelli.Gimelli.Pedemonte-Trasporto
pubblico a G.-DeFerrari.’91-p.20
-DeLandolina
GC- Sampierdarena-Rinascenza.1922 – pag.22.23.59.63
-Doria
G.-Investimenti e sviluppo econom.a Genova-Giuffrè.1973.pag.748
-D’Oria
S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.50
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Fravega Lorenzo-il Secolo
XIX, rubrica ‘Radici’-
-Gazzettino
Sampierdarenese : 2/72.2 + 3/72.2 + 1/73.9 + 4/76.8 + 7/80.7 + 6/82.3 +
7/83.10 + 9/86.10 + 1/91.10 + 4/91.4 + 4/92.8 + 3/94.8 + 6/94.4 foto :dice Croce
d’oro “vicino”a Gaggiolo + 4/96.8 +
10/02.9.11 + 04/04.3 +
-Genova,
rivista municipale, ottobre/34.1 + agosto/1940.XVIII.49
-Guida
genovese Costa 1928-29
-Il
Secolo XIX (RenzoFravega): 7/5/2000 + 17.08.2000 + 22/10/2000
-Montefiore.Sborgi-Un’idea
di città-C.Civico SPdA.’86-p. 13.14foto.69f.72.78.100
-Lamponi
M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002.pag.90
-Novella
P.-Strade di Genova.-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Ogliari
e Sapi-Signori, in vettura.Liguria-ed. Autori 1965-pag.17.47
-Pagano/1933-pag.249.852.1094.1690---/1961-pag.588
-Pastorino.Vigliero-Dizion.
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p. 1188. 1850
-Petrucci
VE- Dizionarietto – su Secolo XIX
-Poleggi
E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.33.34
-Ragazzi
F.-Teatri storici in Lig.-Sagep.1991-p.23.92.219.228-31
-Regina-Lunario
del signor - anno 1889–pag.540
-Ricchiero
V.-GB Derchi-Fassicomo.1987xFenespart-pag.28
-Tuvo T.-SPdA come
erav.-Mondani.83-p.19.24.30.32.37.39.69.83-4.87-8
VOLTA vico
Alessandro Volta
Il nome fu proposto all’inizio
dell’anno 1900, e già nel 1901 fu posta la prima targa in marmo ad
ufficializzazione del nome.
Il vicolo, unendo la via dei
Buoi alla piazza Vittorio Veneto, corrisponde all’attuale via Felicita Noli.
Nel lontano 1901 vi abitavano, al civ. 1 casa
Tuo; al 2 e 4 casa Galleano Pietro; 3, casa Bertorello e Parodi Michele; 6
eredi Tubino.
Il Pagano 1902 e 08 pongono al civ. 5 lo
scultore Dotto cav. Federico.
Nel 1910 era già “via”, con civici sino al 3
e 6 , da via Vitt.Emanuele a via N.Barabino.
Il Pagano 1912 segnala
il meccanico Roncagliolo Lorenzo, unico esercente nella via (nel 1921 sarà in
via U.Rela).
Nel 1918, nel vico (con indicato “da piazza F.Ferrer”, ma senza specificare
il civico) viene annunciata la stampa di un giornale “La pubblica
Assistenza”; da giugno, quindicinale.
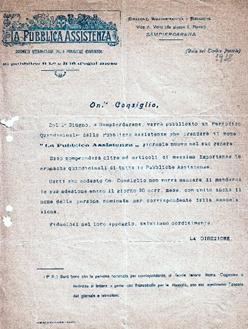
Nel Pagano 1925 al civ.10
compare Galliano Giuseppe & Fratello che vendono carte fotografiche e
riproducono disegni.
Nel 1926 quattro centri
si contesero la titolazione: Centro, Prà, Sestri e SPd’Arena, essendo da poco
avvenuta l’annessione nella Grande Genova vennero decise delle variazioni nelle
titolazioni stradali, soprattutto per evitare dei doppioni con le vie genovesi
Nel 1933 era ancora
uguale, di 4.a categoria, con civici sino al 1 e 4. Nella strada si apriva il
banco del lotto n° 193.
Ma negli anni immediatamente
dopo, il 19 agosto 1935 per l’esattezza, da delibera firmata dal podestà
genovese, via Alessandro Volta scomparve da San Pier d’Arena, e fu sostituita
con vico dei Marinai (come via dei Buoi era
divenuta dapprima via Nicolò Barabino e poi in successione via Stefano Canzio;
nella scheda dalla Toponomastica sta scritto che si chiamava ‘via del
Marinaio’). Diventerà via F.Noli, dopo il 7/3/46
La
famosa trattoria Giacinto, negli anni 30 non appare ancora aperta .
DEDICATA al fisico comasco,
inventore della pila elettrica, nato il 18.2.1745 a Camnago di Como; e morto a
Como il 5.3.1827.
È universalmente riconosciuto il
fondatore dell’elettrologia.
Nato da nobile ma impoverita
famiglia (da Filippo V, dei conti Inzaghi), ultimo di numerosi figli, mutolo
sino a sette anni. Fu allevato da uno zio canonico, riuscì in forma di
autodidatta a compiere tali progressi negli anni dopo, da stupire tutti; e
quindi decidere mandarlo a perfezionarsi dai Gesuiti, in tutto lo scibile di
allora (umanità, retorica, filosofia, teologia, scienze).
Appassionatosi agli studin
naturalistici, in particolare alla nuova scienza dell’elettricità; tenne
rapporti epistolari di interpretazione dei fenomeni con tutti i ricercatori nel
ramo (GB Beccaria, JA Nollet) e - viaggiando per l’Europa - andò alla loro
conoscenza; iniziò da giovane a pubblicare memorie sulle forze elettriche e sui
fenomeni connessi, proponendo idee basilari di quella branca, come -1769- il
potenziale elettrico di tutti i corpi.
Nel 1775 realizzò l’elettroforo
(che porta il suo nome) e che preconizza alle macchine elettrostatiche a
induzione. Nel 1778 divenne docente a Pavia introducendo parole nuove che
rimangono di base nella moderna elettrologia: ‘carica’, ‘tensione’, ‘capacità’,
ecc.
Partendo dagli studi di Galvani,
nel 1799 riuscì a concepire i principi (diversi da quelli proposti dal Galvani
stesso all’università di Bologna), che lo portarono a costruire la famosa pila:
dischi di rame, di zinco e di panno acidulato, sovrapposti incolonnati più
volte in tale ordine: fornivano corrente elettrica fluente ed in modo continuo.
La scoperta, chiamata “effetto Volta”, segnalata alla Royal Society, gli
procurò fama mondiale.
E poiché all’inizio la pila
andava esaurendosi in modo eccessivamente rapido, ottenne miglioramento
eliminando il panno ed immergendo i due dischi metallici in acqua acidulata.
Il fortunato esperimento, aprì
la strada ad enormi risultati pratici; già allora Napoleone gli conferì una
medaglia d’oro, ricevendolo con onori trionfali nominandolo senatore e
conferendogli il titolo nobiliare di conte (che non aveva ricevuto
ereditariamente dal genitore perché era l’ultimogenito; nel nuovo stemma,
scelse la figura della sua pila).
Sempre in campo elettrico e
nello studio dei gas (formulò la legge di dilatazione dei gas), produsse altre
invenzioni le quali, anche se di minore praticità ed evidenza, furono tali da
farlo mantenere effettivo professore docente all’Università di Pavia sino alla
fine della carriera.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale-
-Archivio storico Comunale
Toponomastica - scheda 4716
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.60
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzogno
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.16
-Pagano/1933-pag.249.1697---/1961-pag.566
VOLTURNO
via Volturno
Corrisponde all’attuale via G.Salinero.
Nell’anno 1900 viene proposta
alla Giunta comunale la titolazione di via Volturno, per ufficializzare quel vicolo
popolarmente chiamato “via alla piazza detta della Palmetta”, posto ad ovest di
via Vittorio Emanuele (via W.Fillak). In
contemporanea anche lo slargo interno, assunse il nome ufficiale di piazza Palmetta.
Nell’anno 1910, appare con un
unico civico nero, dipartente dalla strada divenuta ‘via Umberto I a piazza
Palmetta’ , con unico civico 1.
Il Centro, Pegli, Rivarolo e
SPd’Arena, tutte avevano nel 1926 una strada intestata alla famosa battaglia.
Il nuovo Comune della Grande Genova si propose di eliminarne alcune per evitare
doppioni.
Nell’anno 1933, era ancora
così, di 5.a categoria .
Il nome fu cambiato con firma
del podestà, il 19 agosto 1935.
DEDICATA alla battaglia del 1 e 2
ott.1860, avvenuta lungo le rive del fiume campano, vicino a Capua: 25mila
garibaldini si scontrarono con 40mila soldati borbonici, comandati dallo stesso
re Francesco II, e forti oltreché del numero, anche di artiglierie e
cavalleria.
Sulla piana del fiume vicino alla
foce nel Tirreno (nasce dalle Mainarde molisane e scorre in Campania), all’inizio
dello scontro, i borbonici riuscirono a sgominare facilmente la prima linea
comandata dal generale Medici; ma Garibaldi stesso, al comando della riserva,
piombò al centro dello schieramento avversario, costringendolo a desistere
dall’avanzare l’offensiva. Non solo, ma unendosi alle truppe dirette dal
generale Turr e Bixio, ci fu un contrattacco irruente e capace di chiudere in
una sacca l’avversario costringendolo alla resa.
Re Francesco, sconfitto,
dovette ritirarsi a Capua pur avendo combattuto con eroismo (perdendo 3mila
soldati, contro 2mila garibaldini).
Di tutta l’impresa dei Mille,
questa battaglia fu il fatto d’armi più importante perché decisivo: Napoli era
liberata dai Borboni, ed aspettava Vittorio Emanuele II.
Questi arrivò al comando delle
sue truppe piemontesi, che vollero assumere le redini di tutte le operazioni
militari, esautorando Garibaldi e sciogliendo il corpo garibaldino. Questo
provvedimento, seppur legato alle necessità politiche di legalizzare
l’annessione, lasciò fiele in bocca ai volontari, che dovettero abbandonare la
zona senza riconoscimento dei meriti acquisiti sul campo; Garibaldi stesso, il
9 novembre, salpò da Napoli rifiutando tutte le offerte che il re aveva proposto solo a lui (titolo nobiliare,
un castello con tenuta, onorificenze).
Il 21 ottobre ci fu il
plebiscito di annessione che si concluse con 1.302.064 si, e 10.312 no tra la
popolazione del continente; e 432.053 si contro 667 no in Sicilia.
La resa di Capua avvenne
ufficialmente il 2 novembre (mentre Gaeta fu ceduta solo nel febb.1861);
cosicché l’8 novembre, scomparso il regno delle Due Sicilie, re Vittorio
Emanuele II divenne re di Napoli e della Sicilia, unendo il territorio
all’Italia.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4728
-Ciliento B.-gli scozzesi in
piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.55
-DeLandolina
GC.-Sampierdarena.Rinascenza.1922-pag.60
-Novella P.-Strade di
Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Pagano/1933-pag. 249---

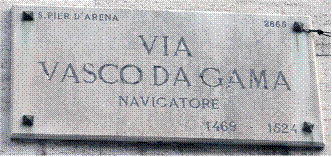

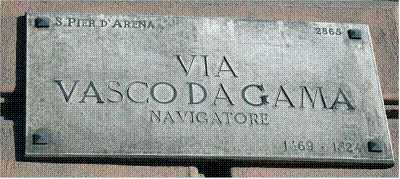

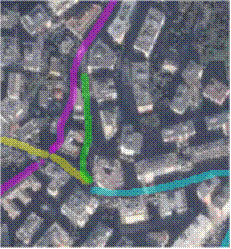
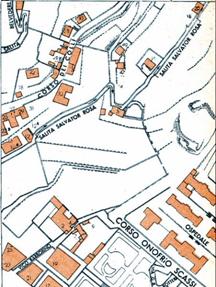
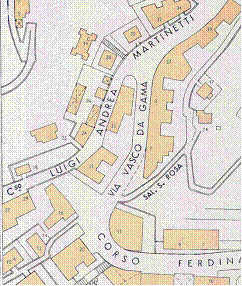
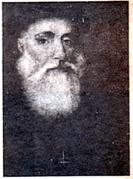
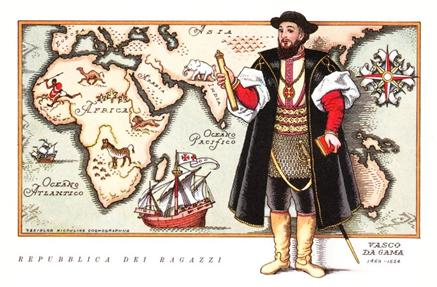





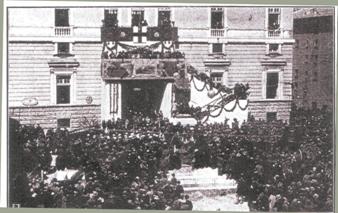
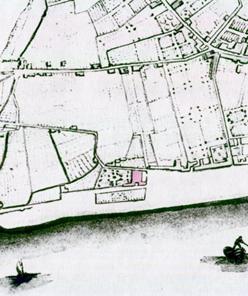
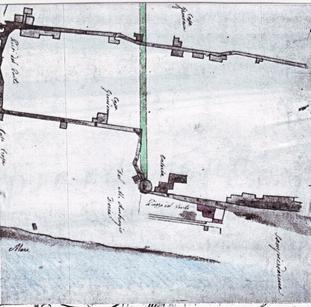
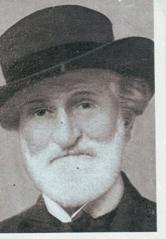
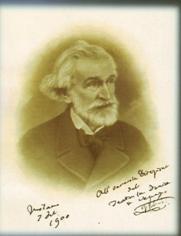
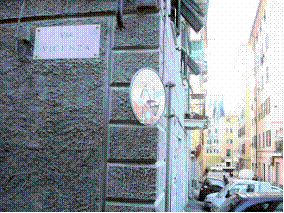

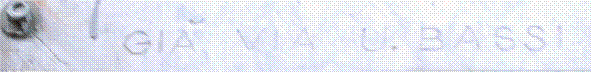



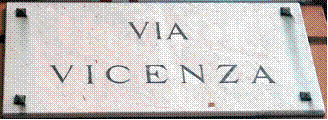
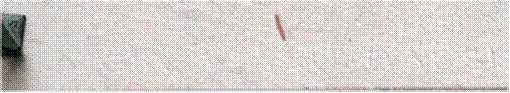
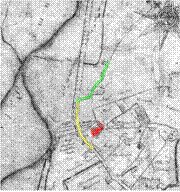
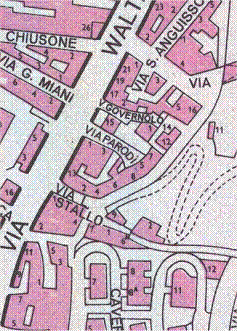




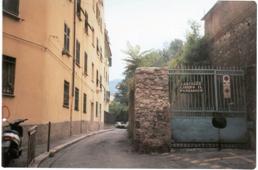








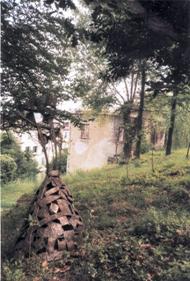

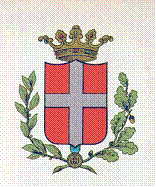


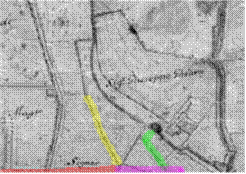
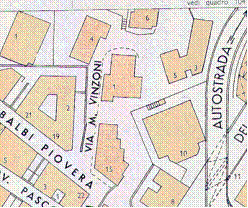

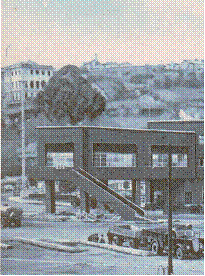


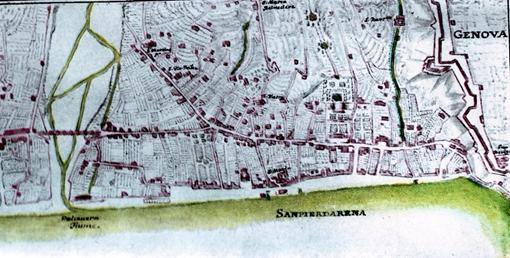
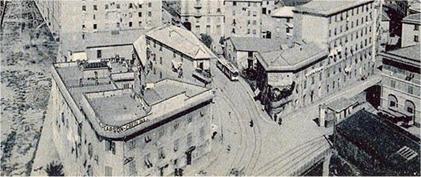




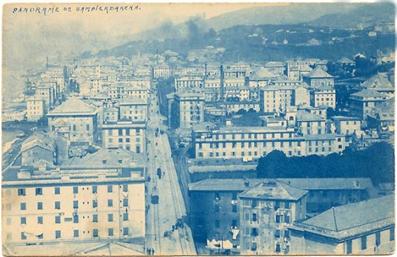









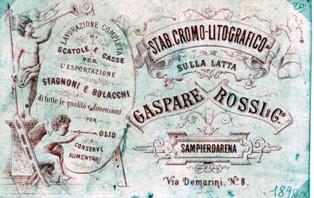

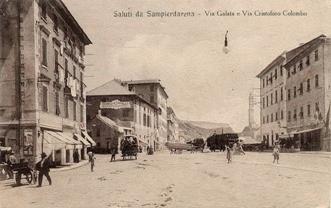




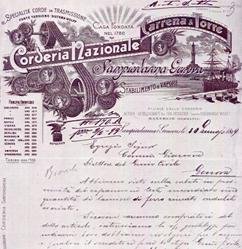
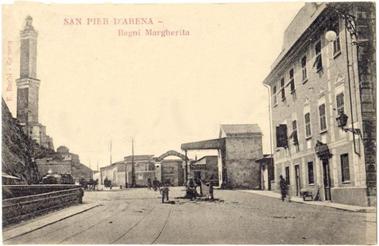
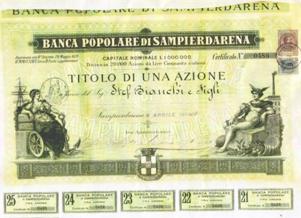

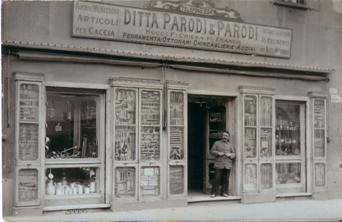




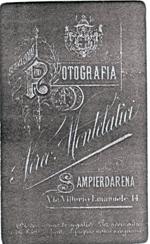
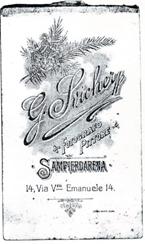
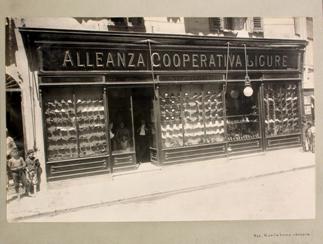



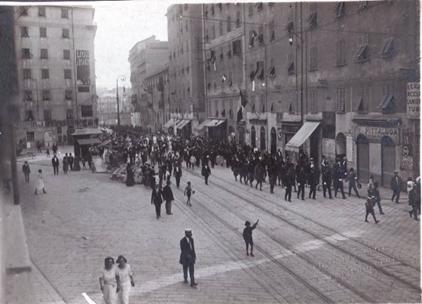







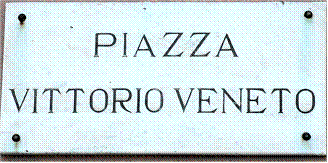


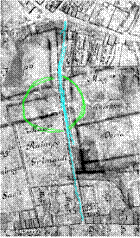
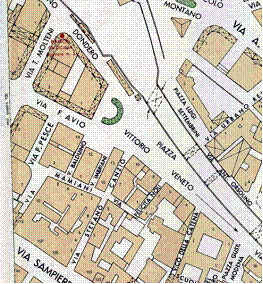
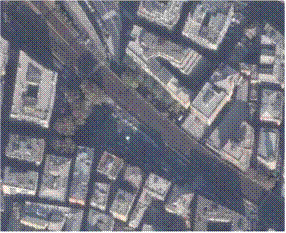


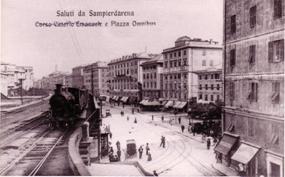





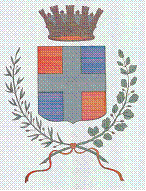 Prima della data
risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2
francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;
sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio
attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e
psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette
e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono
l’olocausto generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure
lui eroico ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.
Prima della data
risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2
francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;
sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio
attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e
psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette
e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono
l’olocausto generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure
lui eroico ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.